15 Giugno 2018 | Tags: fumetto, Winsor McCay | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Winsor McCay, “Little Nemo in Slumberland”, 24 febbraio 1907 Stavolta ritorniamo agli inizi, non solo perché Winsor McCay è stato un autore straordinario, ma perché la tavola qui a fianco (24 febbraio 1907) ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra pagina e racconto, o – se preferite – tra dimensione tabulare e dimensione sequenziale.
Quando uscì stampata per la prima volta, questa pagina era molto più grande di questa riproduzione, ma il tipo di esperienza vissuta del lettore non deve essere stata molto diversa da quella appena vissuta da voi (e sulla differenza torneremo tra poco). Quando siete entrati in questa doppia pagina, il vostro sguardo è certamente corso sulla grande immagine complessiva della pagina di destra, e l’ha colta nel suo insieme. Solo in un secondo momento – ammesso che l’abbiate già fatto – avete esplorato sequenzialmente le singole vignette, leggendo i testi, e cogliendo nel dettaglio la storia. Oppure (e comunque in un secondo momento) avete scorso la sequenza senza leggere i testi, e avete in ogni caso colto qualcosa della sequenza narrativa: l’arrivo al palazzo di Jack Frost, la preparazione, l’ingresso al grandioso interno (e il risveglio, come sempre in una vignetta piuttosto separata, alla fine, poco influente sull’effetto d’insieme).
Questa pagina è stata progettata da McCay per questo percorso visivo: deve prima colpire nel suo insieme, in modo che l’effetto prodotto dalla visione complessiva influisca sul modo in cui poi leggerete i dettagli. Se scorrete le annate di Little Nemo, vi accorgerete che questa strategia viene utilizzata, in maniera più o meno radicale, in tutte le tavole.
La pagina mostra al primo sguardo due strutture visive simili, in alto e in basso, separate da una striscia abbastanza omogenea dove dominano le linee verticali. Osservate, nella loro differenza, le analogie tra la figura del palazzo e quella del gigante di ghiaccio affiancato dagli orsi: sono entrambe forme a simmetria centrale, con un corpo di mezzo più alto, sottolineato da una retrostante figura semicircolare (l’alone luminoso di sopra, l’aureola e gli archi di ghiaccio di sotto). I colori non sono molto diversi, e in tutti e due i casi c’è una base all’incirca orizzontale sottostante, con figure umane in leggero squilibrio. Nella striscia di mezzo le linee verticali del fondo (di colori simili alle due immagini in alto e in basso) si sommano alle linee bianche tra le vignette; e su questa base si stagliano i colori più vivaci delle figure dei personaggi, che creano un ritmo visivo variato ma ugualmente coglibile.
Se sfocate un po’ la vista, potrete cogliere nella pagina una struttura complessiva a cupola: basamenti, pareti con accenni di colonne o nervature verticali, chiusura rotondeggiante in alto. Non c’è bisogno che ne siate consapevoli: l’effetto di architettura favolosa, di luogo straordinario, viene comunque impostato nel lettore ancora prima che inizi la lettura vera e propria. E naturalmente poi, quando la lettura sequenziale ha luogo, il lettore è certamente influenzata da quello che è già stato colto.
Ora pensate alla differenza che esiste tra vedere un paesaggio dal vivo e vederlo in fotografia. Parlo di un paesaggio degno di questo nome, naturale o urbano, quelli che non possiamo fare a meno di fermarci almeno per un attimo (e se possiamo, anche di più) in contemplazione; sapendo benissimo che nemmeno la migliore riproduzione, anche a 360 gradi, potrebbe restituirci quella stessa emozione. La differenza sta nel fatto che nel paesaggio ci entriamo, ne facciamo parte; alla fotografia stiamo invece semplicemente di fronte: un’esperienza immersiva è certamente più coinvolgente di una semplicemente frontale! Notate che non è un problema di dettagli: una buona foto ci può rendere gli stessi dettagli che vedremmo al naturale. Ma sappiamo benissimo che non ne facciamo parte, e che le stiamo di fronte, e non dentro: il coinvolgimento nei suoi confronti è inevitabilmente minore.
Tuttavia l’essere umano possiede l’immaginazione. A certe condizioni, un’immagine può essere vissuta in maniera più immersiva di altre. Non arriverà probabilmente all’emozione di un’immersione reale, ma potrà evocare comunque in qualche misura un’esperienza immersiva. Una di queste condizione, probabilmente la principale, è che l’immagine sia grande a sufficienza da poter riempire il campo visivo, o almeno da avvicinarsi a questa condizione.
Da questo punto di vista, l’edizione originale di questa pagina di Little Nemo aveva dei vantaggi rispetto a quella che vedete qui, e l’immersione evocata nel lettore poteva essere quindi ancora più forte. Notate che un’altra condizione è la presenza del colore, ma si tratta di una condizione molto più debole: diciamo che in bianco e nero la costruzione di un effetto immersivo è più difficile, ma ci sono autori (come Sergio Toppi) che ci riescono benissimo lo stesso.
Ora lasciamo un attimo da parte McCay, e pensiamo all’uso delle splash page (singole, o doppie) da parte di autori più vicini a noi: Jack Kirby o Jim Steranko per il fumetto USA, Philippe Druillet o Moebius per quello francese. Cosa succede quando, nel flusso del racconto, improvvisamente voltiamo pagina e ci troviamo di fronte a un’immagine unica, grande?
Be’ in verità succedono molte cose, anche dal punto di vista degli effetti di tensione e di ritmo, e di sottolineatura narrativa. Ma qui mi preme far notare come in presenza di quella immagine improvvisamente più grande, molto grande, la dimensione immersiva si manifesti e indicativamente ci porti, noi lettori, all’interno del mondo della storia. Lo fa magari per un attimo, e non sarà proprio come essere lì di persona: ma lo è molto di più di quanto non succeda in tutte le altre vignette della sequenza, sempre fruite in maniera decisamente più frontale.
Se poi l’immagine è al vivo, senza margini bianchi, tagliata solo dal bordo della carta, l’effetto potrà essere ancora più forte, perché viene cancellata una cornice, ovvero un dispositivo di distanza. Andatevi a rileggere The Dark Knight di Miller alla luce di queste riflessioni, e vedrete come una buona parte della strategia di coinvolgimento messa in atto dal bravissimo Frank si fondi proprio su un calibrato ritmo di situazioni immersive, basate sia su singole grandi immagini sia su architetture di pagina unitarie (nonostante la pluralità delle vignette) proprio come in questa tavola di McCay.
Roman Jakobson ebbe a dire, parlando della poesia, anzi della funzione poetica, che ”la funzione poetica proietta il principio d’equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione” (Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli 2002, p. 189). Che sarebbe come dire che, nella costruzione del linguaggio poetico l’equivalenza o la similarità tra gli elementi – parole o sintagmi che siano – possono prevalere sulle regole stesse della successione dettate dalle esigenze sintattiche e narrative. Per cui, ancora in Jakobson, “in poesia l’equazione serve a costruire la successione” (ibidem, p. 192). Per esempio, una parola può essere scelta più per esigenze di rima che per esigenze di chiarezza espositiva e questo può andare benissimo perché la chiarezza espositiva è al massimo un fine marginale della poesia, mentre molto più centrale è il tentativo di creare una rete di rimandi (fonetici, prosodici, semantici…) che si sovrapponga alla sequenza lineare del discorso narrativo o espositivo, sovradeterminandola, ovvero caricandola di ulteriore e ulteriore senso. Certo la condizione ideale è quella in cui la parola-rima viene scelta così magistralmente da apparire anche come la parola migliore per esprimere il senso – ma a volte anche l’evidenza di una leggera forzatura può aggiungere interessanti sfumature di senso.
Perché parlo di funzione poetica proprio qui? Guardate questa tavola dal Little Nemo di Winsor McCay:

oppure quest’altra (famosissima):

Non è difficile accorgersi che la forma complessiva della tavola non dipende soltanto dalle esigenze espressive della narrazione. Nella tavola del 1907, per esempio, la coincidenza di posizione e forma tra le colonne della seconda striscia e gli alberi della terza è narrativamente irrilevante; cioè, per quanto riguarda le esigenze di un’efficace narrazione, non ve ne sarebbe alcun bisogno. In quella, sopra, del 1906, c’è una prima striscia in cui dominano le orizzontali, una seconda le diagonali discendenti verso destra, e una terza in cui dominano le diagonali discendenti verso sinistra (linee prospettiche incluse): anche qui questa articolata costruzione non sarebbe necessaria all’efficacia del racconto…
Prosegue qui, su Fumettologica.
Nel febbraio 1905, quando il cinema era ancora una specie di teatro su pellicola, uscito fresco fresco dalla testa di Méliès, e ancora qualche anno prima di diventare lui stesso uno dei protagonisti di quella rivoluzione narrativa, Winsor McCay si permise di anticipare una delle sue grandi potenzialità. C’è infatti una tavola del Dream of the Rarebit Fiend (Sogno del patito di fonduta al formaggio) interamente in soggettiva. Eccola qui:

Il cinema era ancora lontano da questa intuizione. In quegli anni era ancora lontano persino dall’alternanza di inquadrature come principio narrativo fondamentale. Il fumetto era ancora (e per molti anni sarebbe sostanzialmente rimasto) fumetto comico, a cui l’inquadratura a figura intera (o giù di lì) è in generale sufficiente. In pittura erano certamente presenti mezzibusti e facce, ma il tema del punto di vista dell’immagine non era tra quelli caldi e particolarmente discussi. Era semmai in fotografia che la tematica dell’inquadratura aveva già un senso forte….
Prosegue qui, su Fumettologica.
24 Settembre 2012 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, poetry comics, semiotica, Winsor McCay | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, semiotica |  Winsor McCay, Little Nemo, tavola del 22.10.1905 Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire.
Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano.
Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è.
Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è.
In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato.
Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio.
La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono.
Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto.
Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto.
Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa.
Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale.
(prosegue, spero)
Il genere musicale del Notturno fu inventato da John Field (1782-1837), ma fu il “plagiario” Frederik Chopin (1810-1849) a passare alla storia per i suoi Notturni. Basta ascoltarli e non è difficile capire il perché: davvero plagio?
Harold Bloom ha scritto nel 1973 un bellissimo libro (The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry) sul difficile rapporto che ogni autore ha con gli autori che lo hanno ispirato: e, ovviamente, degli ispiratori ci sono sempre.
 Job vs McCay (da Fumettologicamente) Riallacciandosi alla polemica di qualche giorno fa sull’origine del fumetto, Matteo Stefanelli rende nota una scoperta sul plagio operato da Winsor McCay nei confronti di (almeno) due autori francesi di qualche anno prima: Rip e Job. Le immagini che vengono mostrate sul suo blog esibiscono una somiglianza che non si può contestare: penso che non ci siano dubbi sul fatto che McCay si sia fortemente ispirato a quelle pagine. Tanto più che, sul suolo americano, le probabilità che qualcuno si accorgesse della somiglianza con una pagina di giornale francese di venti anni prima erano davvero irrilevanti.
Ma fa bene Stefanelli a insistere sul fatto che nulla di tutto questo sminuisce il valore di McCay. Basta osservare la comparazione stessa di immagini che ci dimostra il plagio, per rendersi conto perché McCay sia passato alla storia e Job no.
Continua a essere dominante la convinzione che il cuore di un testo narrativo sia la storia raccontata, e che chi copia la storia copia il testo stesso. A partire da Shakespeare, dunque, gran parte degli scrittori e commediografi di tutte le epoche sarebbero dei plagiari. In verità, la storia raccontata è solo uno degli elementi che contribuiscono al fascino di un’opera, e spesso nemmeno il principale. La medesima storia è interessante nella pagina di Job e favolosa in quella di McCay. E la differenza sta in una concezione radicalmente diversa del rapporto tra sequenza di vignette e spazio della pagina, del tutto tradizionale in Job, ed estremamente innovativo in McCay. (Meglio, da questo punto di vista, il lavoro di Rip: ma l’abisso rimane)
Puntualizzato questo, l’influenza c’è, indubbiamente. E McCay ha indubbiamente visto quei lavori e li ha utilizzati come punto di partenza dei suoi. Il che non sposta di una virgola i termini della polemica sulla nascita del fumetto.
Anzi, forse li sposta. Mi viene voglia di proporre di posticipare di 10 anni la data convenzionale di origine del fumetto, dal 1895 (o ’96) al 1905, anno dell’uscita di Little Nemo. Lì sì che succede qualcosa di nuovo, e non solo nel sistema di produzione e consumo!
1 Marzo 2010 | Tags: Antonio Rubino, Caran d'Ache, cinema, comunicazione visiva, fumetto, Little Nemo, narrazione per immagini, nascita del fumetto, Richard Felton Outcault, Sergio Tofano, Winsor McCay, Yellow Kid | Category: comunicazione visiva, fumetto | Rispondo a Matteo Stefanelli che commenta il mio post del 26 febbraio (che a sua volta commentava il suo del 3 febbraio).
Direi che tra la situazione dell’origine del cinema e quella dell’origine del fumetto c’è una differenza cruciale, che cambia tutto il modo in cui si possono considerare le cose. Il cinema deve la sua esistenza a un’invenzione tecnica, quella dei fratelli Lumière. Prima non poteva proprio esistere, per banali ed evidenti ragioni tecniche. Non c’è dunque problema a posizionare l’origine del cinema. E tutto quello che è accaduto prima e che in qualche modo lo anticipa ne è chiaramente preistoria.
Ma il fumetto non si basa sostanzialmente su nessuna invenzione tecnica. Tutti gli elementi che lo costituiscono sono già comparsi prima che compaia Yellow Kid. È un poco come cercare di decidere quando nasce il jazz: il periodo lo sappiamo, ma qualsiasi anno di nascita preciso si possa proporre è facilmente e legittimamente contestabile. L’origine del jazz è un fatto sfumato.
A meno che non si possa decidere, con una certa dose di convenzionalità, un evento particolare e particolarmente importante che faccia da spartiacque. È ovvio che la vita di un cittadino romano non è cambiata gran che dopo quel fatidico 476 d.C., e non sono stati in molti ad accorgersi di quel venerdì 12 ottobre 1492: sono date simboliche, per le quali si è scelto un evento le cui conseguenze avrebbero poi, col tempo, mutato la storia.
Il 1895 o 1896 (a seconda che prendiamo la data di pubblicazione di Hogan’s Alley, oppure il momento in cui Outcault si mette a usare il balloon e la sequenza) è dunque una data simbolica. Poiché non possiamo adagiarci sulla sponda tranquilla di un’invenzione tecnica, la più turbinosa e discutibile subitanea diffusione di massa che avviene negli USA in quel momento può essere una buona data per posizionare lo spartiacque.
Non che in Francia e Inghilterra e Germania non fosse già successo niente: era successo un sacco di roba, lo sappiamo! Ma Caran d’Ache, poniamo, era davvero consapevole di stare utilizzando un linguaggio nuovo? Sapeva di essere bravo, quello sì. Ma in fondo non faceva che realizzare (moolto brillantemente) dei racconti illustrati che potevano fare a meno delle parole.
Io ho la sensazione che il successo industriale del fumetto negli USA, proprio perché così improvviso e dilagante, dia da subito la sensazione agli autori dell’epoca di avere per le mani qualcosa di nuovo. E magari si sbagliavano (perché gli Americani, di solito, non sono particolarmente colti, e amano pensare di aver inventato qualcosa di nuovo, in barba alla vecchia Europa), ma, anche sbagliandosi, si sbagliavano tutti insieme: e in questa (forse) illusione collettiva l’espressione comics è passata ad essere un sostantivo dall’aggettivo che era.
Se non ci fossero stati gli americani, gli eleganti autori europei avrebbero continuato – come già facevano – a realizzare raccontini per immagini senza balloon e senza invenzioni di messa in pagina: non avremmo cioè avuto McCay, per esempio. Di fatto, è proprio questo che è successo in Europa sino a tutti gli anni Venti; e solo le spinte innovative provenienti dall’America hanno cambiato la situazione.
Poi, Rubino e Tofano sono ugualmente dei maestri, e io li amo molto entrambi; ma non dimentichiamo che fine facevano le tavole di Little Nemo quando diventavano il Bubu del Corriere dei Piccoli! È un po’ come quando, studiando la preistoria, si scopre che c’erano regioni in cui si era già all’età del ferro, mentre altre, poco distanti, magari stavano ancora scoprendo il bronzo. Ecco, rispetto al fumetto è andata un po’ così: il bronzo l’abbiamo scoperto noi, e l’abbiamo insegnato agli americani, poi loro hanno capito come si faceva il ferro e noi no.
Per questo, finché qualcuno non mi propone uno spartiacque altrettanto forte, io continuo a metterlo lì, tra il 1895 e il (meglio) 1896. Non è cambiata molto la narrazione per immagini tra poco prima e poco dopo quel momento; ma senza quel momento non so se avremmo la narrazione a fumetti oggi.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|



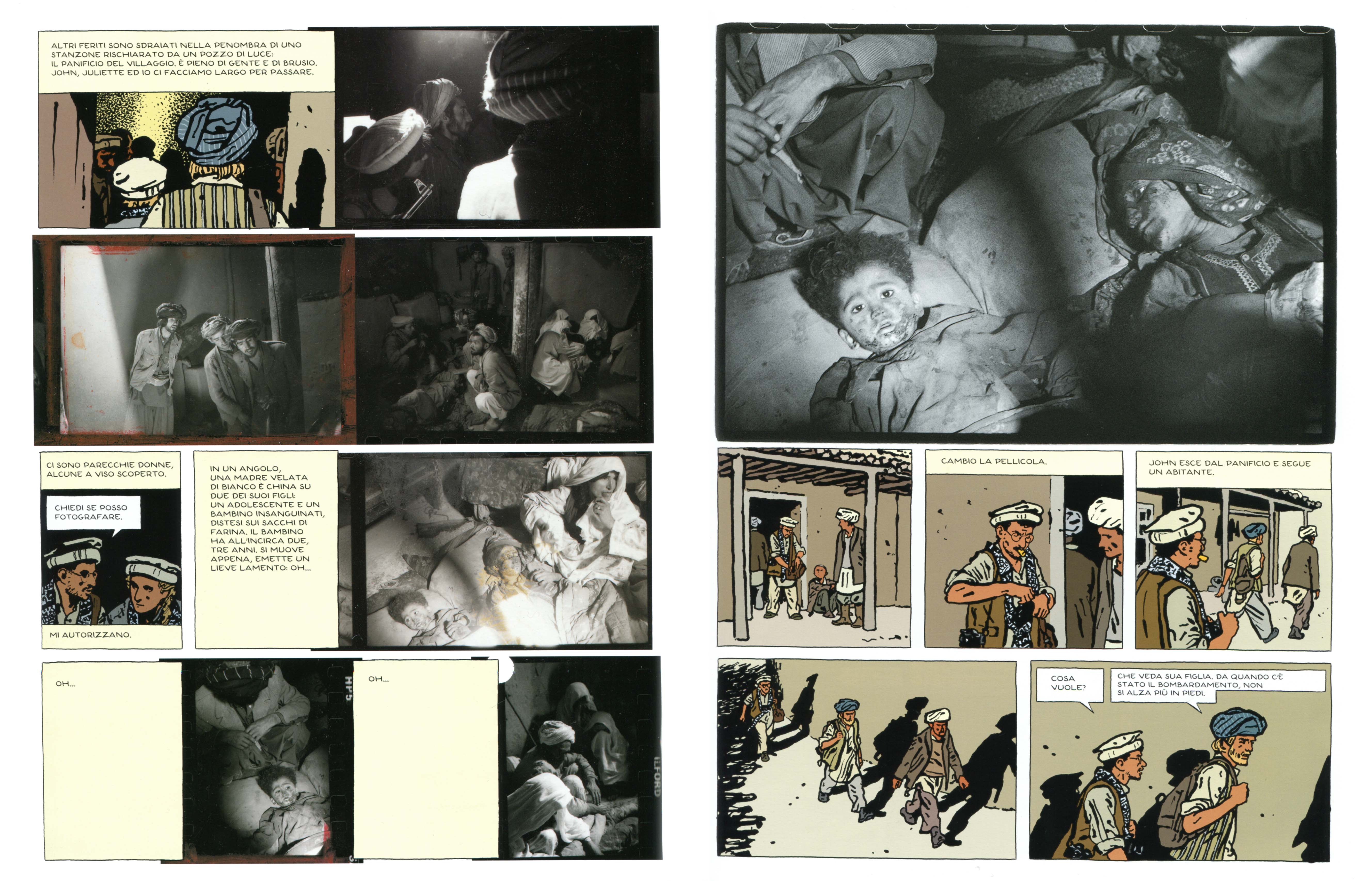








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email

























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco



Commenti recenti