Watchmen
Inedito per Il Sole 24 Ore, scritto il 23 gennaio 1994
Nella storia di una forma espressiva, i testi che segnano dei veri punti di svolta sono ovviamente pochi. Le rivoluzioni non sono cose di tutti i giorni, e ancora più rare sono quelle che riescono davvero a cambiare qualcosa nel campo in cui avvengono. A metà degli anni Ottanta il fumetto americano ha assistito alla comparsa di ben due di questi testi cruciali: The Dark Knight Returns di Frank Miller, di cui già abbiamo avuto occasione di parlare su queste pagine, e Watchmen, di Alan Moore e Dave Gibbons. Il primo è un esempio senza precedenti di fumetto del genere supereroi rivolto a un pubblico adulto e attento, con lo spessore di un grande film d’azione, un po’ alla Ridley Scott, attento a problematizzare quello che era sempre stato ovvio e a acutizzare quello che era sempre stato smorzato: un vero gioiello americano, insomma.
Di tutt’altra pasta è invece Watchmen, un testo molto meno spettacolare e graficamente assai meno invitante dell’altro. E a dispetto di questo, un racconto indimenticabile. L’autore, Alan Moore, è inglese, e inglese è la concezione ed è il ritmo di questa storia, lento, scandito, ma inarrestabile. Si incomincia a leggere questa vicenda di eroi mancati e frustrati, oppure riusciti, ma inesorabili figli di puttana, soffermandosi sull’omicidio di uno di loro. Dopo la morte ci sono gli eventi di rito, il compianto, il funerale, la riunione dopo tanto tempo dei colleghi del vecchio gruppo, le indagini della polizia e di un collega irriducibile. La storia si snoda con ingannevole lentezza, soffermandosi, uno dopo l’altro, su tutti i componenti del vecchio gruppo di eroi, scavando nella personalità di ciascuno, nelle piccole manie, nei desideri, nei ricordi. Ci vogliono molte pagine per incominciare a capire che qualcosa di grande e atroce sta nascostamente succedendo e coinvolgendo tutti, assai più di quanto si possa immaginare.
Il testo supera abbondantemente le 300 pagine, e comprende anche sezioni solamente verbali, nella forma di appendici ai vari episodi, presentate con il ruolo di documentazioni sul contesto degli eventi raccontati. La lettura richiede comunque l’impegno di un buon romanzo, e per quanto appassionante essa sia già dalla prima volta, continua a fornire sorprese al lettore che vi faccia ritorno per una seconda o una terza. Watchmen è un testo da leggere e rileggere, come un grande romanzo. Talmente fitto è l’insieme dei rimandi, interni ed esterni, spesso non essenziali alla comprensione della storia ma funzionali a un continuo approfondimento della grande metafora che Moore costruisce, che il lettore si perde con piacere nel labirinto delle simmetrie e delle citazioni.
“Watchmen” significa “guardiani”, ma anche, in modo più lato, “uomini dell’orologio”, e la metafora dell’orologio, del meccanismo complesso in cui tutti i pezzi hanno un’esatta ragione di essere, è sottesa all’intera storia e alla struttura stessa del testo. Moore ci conduce con sottile abilità attraverso questo meccanismo inflessibile e inarrestabile, messo in movimento dal mito stesso dell’eroe, ma anche del salvatore e del redentore, per mostrarci, passo dopo passo, come la catastrofe ne sia l’esito finale. Il miglior superuomo, con le migliori intenzioni nei confronti dell’umanità, sembra dirci Moore, è destinato a compiere azioni che a noi non possono che apparire mostruose. Non è solo il sonno della ragione a produrre mostri, ma anche la sua insonnia, l’incapacità di fermare il susseguirsi delle conseguenze anche quando esse contravvengano ai nostri più elementari principi morali.
In questo senso il romanzo di Moore si pone con una certa rilevanza all’interno di un dibattito sui limiti della ragione e sul pensiero debole, che in America vede un filosofo come Richard Rorty al centro di aspre polemiche. Da buon romanziere, Moore non ci propone soluzioni, ma espone con chiarezza problemi, senza tuttavia che il sottofondo argomentativo del suo testo prenda mai direttamente il sopravvento sul fascino e sul dramma della vicenda umana dei protagonisti.
Pubblicato in Italia a puntate su Corto Maltese già qualche anno fa, ora Watchmen è finalmente in libreria anche per i lettori italiani. Peccato che non sia successo prima.
Alan Moore, Dave Gibbons. Watchmen. Milano, Rizzoli 1993.
5 Aprile 2010 | Tags: Alan Moore, Algirdas J. Greimas, ermeneutica, estetica, fumetto, poesia, principio del parallelismo, Roman Jakobson, semiotica, Watchmen | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Sia riflettendo sul testo poetico che su quello fumettistico mi ritrovo ricorrentemente di fronte a quel principio formulato da Roman Jakobson che va sotto il nome di principio del parallelismo. Jakobson afferma al proposito che la funzione poetica “proietta il principio di equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa al grado di elemento costitutivo della sequenza”. In parole più povere, per Jakobson quelle relazioni di equivalenza e somiglianza che nell’uso normale del discorso agiscono soltanto come substrato di riferimento delle nostre scelte (ovvero si ritrovano solo a livello paradigmatico), si ritroverebbero in poesia anche a livello del discorso stesso, che sarebbe in parte organizzato secondo queste stesse relazioni (che quindi si ritroverebbero anche al livello sintagmatico). Le equivalenze fonetiche o prosodiche (rime e ritmi) sarebbero dunque parallele a equivalenze semantiche, e andrebbero interpretate in questo senso, riempiendo la poesia di una straordinaria densità di sensi allusivi. E ancora: “La concezione che Valéry ha della poesia come hésitation prolongée entre le son e le sens, è molto più realistica e scientifica di tutte le forme d’isolazionismo fonetico”.
L’idea di Jakobson è cruciale, e si manifesta magistralmente, per esempio, nell’analisi realizzata insieme a Claude Lévi-Strauss del sonetto Les Chats di Charles Baudelaire, dove si espone bene la grande complessità di rimandi che l’organizzazione dei suoni produce. Nonostante questo, anche nel leggere le pagine di quell’articolo mi rimane la sensazione che Jakobson (o, forse, i suoi esegeti) abbia generalizzato troppo, e che si possa continuare a prendere per buone le parole di Valéry anche senza dover cogliere continuamente una relazione tra i parallelismi (prosodici, fonetici, lessicali, semantici…) e il senso di quello che viene detto là dove il parallelismo si manifesta.
La poesia è più antica della prosa. Lo è per le ragioni ben spiegate da Eric Havelock di migliore memorizzabilità in un mondo in cui la scrittura non esiste o è comunque troppo poco diffusa. Ma questa maggiore antichità mal si concilia con la sua maggiore complessità – e non è che Omero sia particolarmente più elementare di Baudelaire, nonostante i duemilacinquecento anni e passa che li separano.
Voglio provare a vedere le cose in un modo un poco diverso, un modo che giustifichi un’applicazione meno compulsiva di un principio comunque importante come quello del parallelismo.
Supponiamo di trovarci in un ambiente naturale, per esempio in montagna, di fronte a un’ampia veduta. Si tratta di qualcosa che di solito apprezziamo, anche se non pensiamo che quello che vediamo e in generale percepiamo debba avere per forza un significato. Naturalmente la dimensione del significato rimane lo stesso profondamente in gioco, ed è proprio per questo che ciò che stiamo percependo ci appare bello: osserviamo le cose e le relazioni tra loro, vi sono cose simili che avvicinano luoghi diversi, vi sono cose che ricordano altre cose viste altrove, vi sono cose che rinviano a discorsi fatti, ad altre esperienze vissute, vi sono relazioni di somiglianza o dissomiglianza tra cose che a loro volte rinviano a discorsi fatti o a esperienze vissute. E così via, in una rete inesauribile di significati, senza che tutto questo debba per forza coagularsi in una dimensione unitaria di discorso, cioè in un significato unitario, in un “messaggio”.
Se questo medesimo paesaggio fosse dipinto, o anche solo fotografato, avremmo invece ragione di pensare che un discorso, e quindi un senso unitario, ci sia; perché anche solo la scelta di dipingere (o fotografare) quel pezzetto di mondo è già un inizio di discorso, per non dire di tutte le altre scelte che il pittore (o il fotografo) fa. Tuttavia, io credo che sbaglieremmo nel risolvere tutta la ricchezza semantica della fruizione ambientale nella strumentalità al discorso da parte del pittore (o del fotografo). Certo, non c’è dubbio che l’artista abbia utilizzato strumentalmente il paesaggio per trasmettere il proprio discorso, e che dunque sia possibile anche interpretarlo così, ma in molti casi la nostra ammirazione per l’artista (in particolare se si tratta di un fotografo) sta soprattutto nel suo aver saputo cogliere un dettaglio di mondo così di per sé significativo, e di averci detto: eccolo! A volte, il discorso dell’autore si può risolvere semplicemente in quell’eccolo!
Se interpretiamo in quest’ultimo modo, stiamo considerando il testo un po’ come un ambiente, e non solo come uno strumento. Non che l’autore scompaia, ma è sicuramente un po’ meno ingombrante, e il suo ruolo non è quello di chi ci trasmette un profondo messaggio, ma semplicemente quello di chi ci dice: guarda qui, questo sembra interessante!
Noi siamo abituati a pensare al linguaggio in maniera strumentale, come un modo per trasmettere messaggi. Ma questa razionalità funzionalista presuppone un contesto in cui gli scopi comunicativi siano già chiari; e, certo, nella misura in cui gli scopi sono chiari, il linguaggio può davvero essere utilizzato funzionalmente, come uno strumento per raggiungerli. Tuttavia, a monte di qualsiasi altro scopo, il linguaggio ne ha uno che di solito, pur onnipresente, non ha alcun bisogno di essere chiaro: si tratta di uno scopo fatico, di contatto. A questo scopo, il guarda lì è già sufficiente, nella misura in cui chi parla e chi ascolta vengono avvicinati dalla comune attenzione.
E il guarda lì può anche essere semplicemente un guarda qui, ovvero guarda (o meglio, ascolta) come questa successione di suoni è armoniosa, come quello rimanda a questo, come quello ricorda quell’altra cosa là, e come il rapporto tra questo e quello ne ricordi un’altra ancora. Il testo può essere fruito come un ambiente, ancor prima che nella sua funzione strumentale, e anche indipendentemente da quella.
La poesia è ovviamente il luogo tradizionale in cui fenomeni di questo genere accadono, il luogo in cui chi parla (o scrive) non sta solo dicendo qualcosa, ma anche dicendo guarda qui: le mie parole non sono interessanti solo per quello che dicono, ma anche perché sono interessanti di per loro, come gli aspetti di un paesaggio. Va bene che se ne cerchi un significato complessivo unitario, ma va anche bene che agiscano come un semplice ambiente, al di là di qualsiasi funzionalità espressiva. Solo il lettore che entri in sintonia con questo paesaggio verbale coglie davvero il fascino di quello che c’è dentro, e allora l’ammirazione per il poeta non sarà per colui che dice cose straordinarie, ma per quella persona che mi sa indicare le cose giuste, le quali significano poi per conto proprio, a dispetto del fatto che un significato complessivo e unitario magari non ci sia, o che sia così difficile da trovare da lasciarci perplessi.
Una versione debole (e per me accettabile) del principio di Jakobson è che tutte le relazioni presenti in un testo poetico siano significative. Quello che trovo problematico è che tutte siano da ricondurre a un nucleo semantico fondamentale – ma questo è forse già più Greimas che Jakobson, e magari proietto la lettura dell’uno sulle parole dell’altro.
Pensare i testi come ambienti non ci impedisce di vederne la natura strumentale (di strumenti comunicativi) ma ci aiuta a non risolverli in quella. Ci invita a visitarli più che a farne un’ermeneutica, ma anche a capire i limiti stessi dell’ermeneutica.
In termini diversi, questo discorso vale anche per il romanzo. Trascuriamo, per semplicità, la rilevanza degli aspetti fonetici e prosodici (che comunque ci sono anche lì), e facciamo finta che la parola, nel romanzo, abbia davvero una funzione puramente strumentale, come veicolo del racconto. Si potrà osservare che, in un romanzo ben costruito, la fruizione ambientale, esclusa dal livello del significante, si ripresenta al livello del racconto. In altre parole, nel leggere un buon romanzo non ci domandiamo continuamente cosa stia volendo dire l’autore con quelle vicende narrate: sostanzialmente vi ci immergiamo, proprio come nel paesaggio, e diamo all’autore il ruolo di colui che ce le ha messe sotto gli occhi, essendogliene grati.
La differenza tra poesia e prosa narrativa è dunque una differenza di livello; ovvero sino a che punto è possibile considerare come ambiente quello che abbiamo sotto gli occhi: sino al livello del racconto o sino a quello della sequenza delle singole parole?
Nel campo del fumetto non c’è una distinzione di genere così netta come quella che esiste tra poesia e prosa, ma possiamo trovare ugualmente queste differenze tra testi leggibili come ambienti a livelli differenti. In gran parte del fumetto popolare, per esempio, il disegno e l’articolazione delle parti grafiche e verbali sono del tutto (o quasi) funzionali al racconto, e solo a questo livello il lettore può avere (e di solito ha) una fruizione di tipo ambientale.
Ma ci sono anche testi a fumetti in cui le cose funzionano nel modo opposto. Prendiamo Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons, per esempio. Sappiamo tutti benissimo quanto questo testo sia costruito, fitto di riferimenti interni, di rime grafiche e narrative, di riferimenti esterni. Tutti aspetti che contribuiscono radicalmente al fascino straordinario che ne promana.
Certo, potremmo ricondurre tutti questi aspetti al racconto, e vederli come efficacissimi condimenti di una storia che è una metafora amara del potere, persino quando questo potere sia utilizzato con le migliori intenzioni del mondo. Questo si può fare, e va fatto.
Però potremmo anche seguire la strategia inversa e immergerci nel testo, lasciandoci attraversare da questa rete inesauribile di rimandi, e considerare che il racconto nel suo insieme non sia che uno di questi elementi – magari più grande e importante degli altri, ma non quello a cui tutto va ricondotto! Se leggiamo Watchmen così, ne perdiamo forse la morale, però lo stiamo percorrendo da dentro, abitando, vivendo come un’esperienza condotta dal suo autore, che ci indica, via via, che cosa è significativo: ci dice, continuamente, guarda qui!
Non per questo, è ovvio, Watchmen va considerata come un’opera di poesia. La poesia è un genere di scrittura verbale. Non esiste la poesia a fumetti. Esiste però un modo di fare fumetti che esibisce lo stesso livello di complessità e di ambientalità della poesia.
14 Marzo 2010 | Tags: Alan Moore, episodi, fumetto, graphic novel, Hugo Pratt, romanzo, semiotica, serialità, Una ballata del mare salato, Watchmen | Category: fumetto, semiotica | Evidentemente non è la stessa cosa leggere una storia tutta di un fiato (come di solito facciamo guardando un film), o al massimo con pause che siamo noi a scegliere, anziché leggerla a episodi con cadenza mensile, settimanale, o magari quotidiana. La scansione periodica impone alla lettura una serie di iati, e richiede quindi al lettore che inizia a percorrere un nuovo episodio di ricordare per quanto possibile gli episodi precedenti.
Di conseguenza, evidentemente, non è la stessa cosa scrivere una storia che debba essere letta tutta di un fiato (o con le pause che il lettore stesso si sceglie), e scrivere una storia che debba essere fruita a episodi. Per quanto inserito nel percorso narrativo sia un episodio, esso deve avere anche elementi di autonomia: non deve magari racchiudere un’intera storia, ma deve però racchiuderne una fase che il lettore percepisca come dotata di senso. In altre parole, una buona organizzazione in episodi a uscita periodica non può tagliare il racconto a caso, ma solo in certi tipi di momenti, corrispondenti alla chiusura di fasi narrative: il lettore deve comunque uscire dalla lettura di un episodio con un certo senso di compiutezza – anche se la compiutezza completa richiede la fine della storia.
Questo requisito può valere anche per i capitoli di un romanzo a lettura continuata; ma solo in misura più debole. La divisione in capitoli è infatti solo un suggerimento di interruzione che viene proposto al lettore, il quale può seguirlo oppure no – mentre quando la pubblicazione stessa è a episodi, il lettore non ha scelta.
Sappiamo che la pubblicazione di storie a episodi ha ragioni editoriali e storiche. Dall’epoca del romanzo d’appendice ottocentesco, ogni editore sa che il lettore è spesso più disposto a pagare una cifra minima periodicamente che non una cifra più considerevole una volta tanto. E l’editore sa anche che il medesimo romanzo pubblicato a episodi può poi essere ristampato in volume per raggiungere anche un diverso tipo di pubblico.
Così l’autore di un romanzo a episodi sa che deve rivolgersi a due pubblici diversi, caratterizzati da due modalità di fruizione differenti: periodica l’uno, unitaria l’altro. Dev’essere molto bravo per riuscire a costruire una narrazione in cui gli elementi che servono al primo tipo di pubblico (che ha bisogno di ripetizioni all’inizio di ogni episodio che gli rammentino il già accaduto, e che si attende un qualche tipo di chiusura a ogni fine di episodio) non infastidiscano il secondo (che invece chiede al racconto di fluire, e non ha bisogno di enfatizzare le conclusioni di capitolo). Il bravo narratore, in situazioni di questo genere, è quello che riesce a costruire un ritmo narrativo che regga entrambe le possibili letture.
In subordine, è possibile decidere di privilegiare una situazione rispetto all’altra. Prima che venisse di moda la graphic novel, il fumetto di supereroi americano ha tranquillamente privilegiato la lettura periodica. D’altra parte, tanto per restare nell’universo del fumetto, tante storie pubblicate a suo tempo con scansione settimanale o mensile sono ormai da molti anni fruite solo in modalità unitaria, ed è quasi impossibile dire dove si trovassero le cesure originarie: valga per tutte l’esempio della Ballata del mare salato di Hugo Pratt.
Il migliore esempio a fumetti, però, di scansione a episodi riciclabile in romanzo unitario è sicuramente Watchmen, di Alan Moore. Lo cito anche per inserirmi in una polemica che ho incrociato andando per blog non lontano da qui. Non c’è dubbio infatti che Watchmen sia una miniserie di dodici episodi a scansione mensile, che rispetta pienamente i requisiti del raccontare per episodi. Ma è proprio l’argomento del racconto a permettere a Moore di far sì che il pubblico possa reinterpretare e accettare positivamente la scansione anche in una lettura continuata. “Watchmen” non vuol dire solo “guardiani”, ma anche “uomini dell’orologio”, e la scansione del tempo è il vero leitmotiv, o tormentone, del racconto di Alan Moore. La scansione degli episodi diventa scansione delle fasi narrative nella versione graphic novel, e il ripercorrere continuamente, da diversi punti di vista, i medesimi episodi del passato dei personaggi, assolve alla funzione mnemonica per i lettori periodici, ma introduce comunque continuamente elementi di novità, in modo da essere appassionante anche per il lettore unitario. Il fatto di avere non un protagonista, bensì un gruppo di protagonisti, permette ad ogni episodio di avere una sua unità, essendo centrato su un personaggio specifico – ma questo continua ad avere senso anche quando gli episodi vengono letti di seguito.
Magari proprio lavorando su Watchmen, ci si potrebbe rendere conto che il fascino di questo testo non sta solo nel racconto che contiene, ma anche (e soprattutto) nel modo in cui questo racconto viene disvelato ai lettori (dell’un tipo come dell’altro). Rendersi conto di questo significa già rendersi conto che, per quanto importante il racconto sia, non è che un mezzo, e che il fascino e il senso complessivo di un romanzo si trovano altrove. A parità di racconto, dunque, le diverse modalità di lettura possono produrre effetti di senso molto differenti. Magari ugualmente validi, come nel caso del nostro esempio, ma nondimeno differenti.
In risposta a Marco D., che mi ha mandato un commento al post precedente sollevando il tema di cui si parla qui, posso dire che sì, certo, la natura del formato incide, e come. E bisognerebbe studiarlo di più. Un po’ l’avevo fatto anch’io per il tema della temporalità nel comic book di supereroi, nella mia tesi di dottorato Tempo, immagine, ritmo e racconto, che si può comunque scaricare da qui.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|



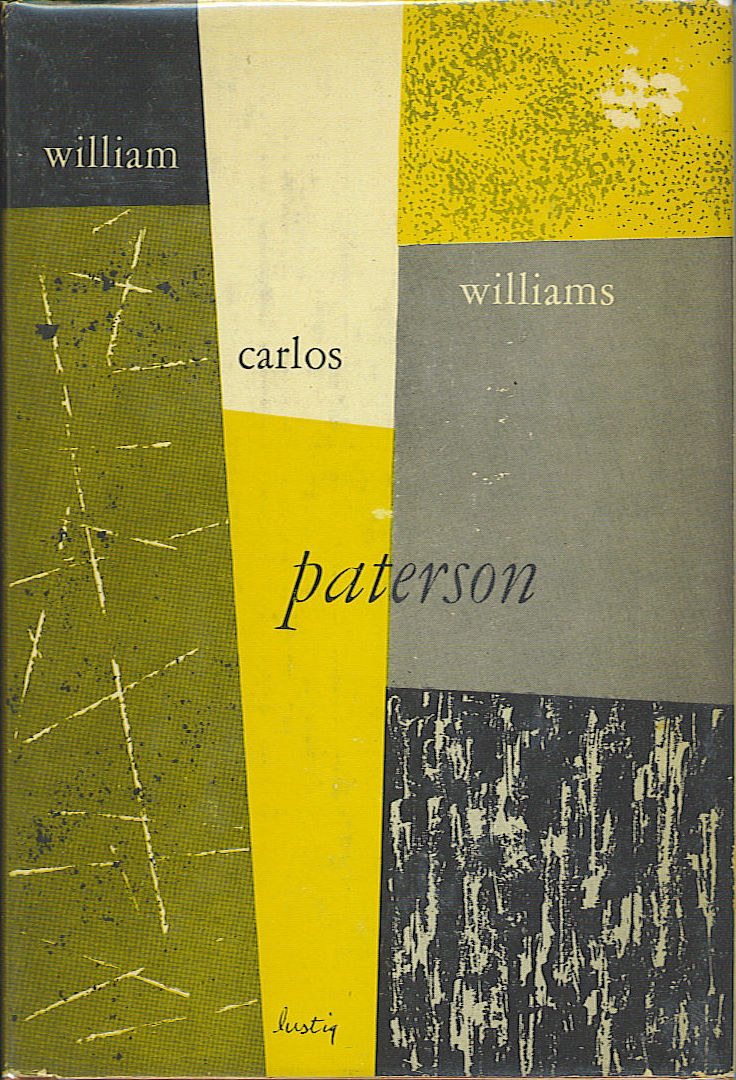

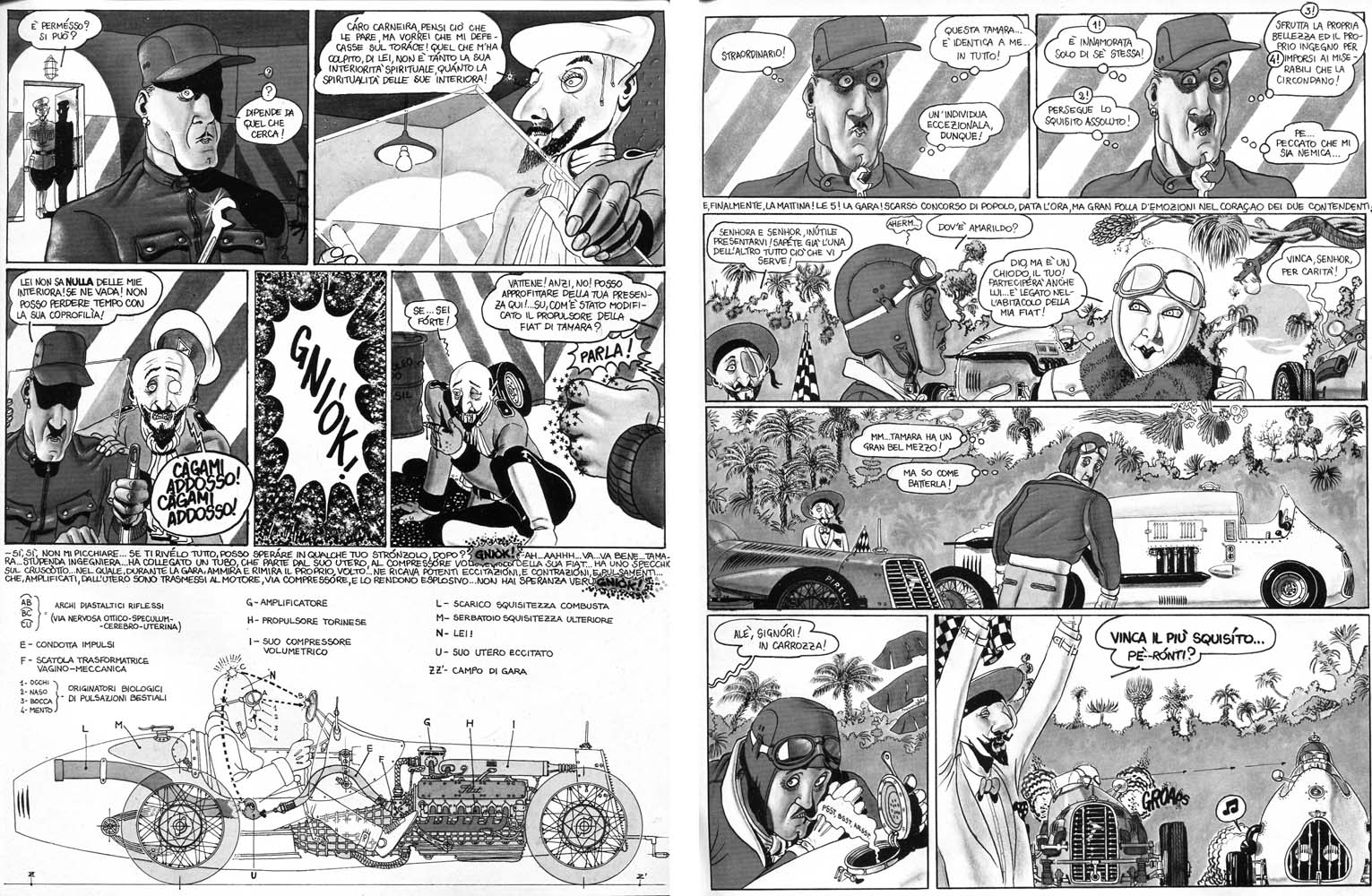




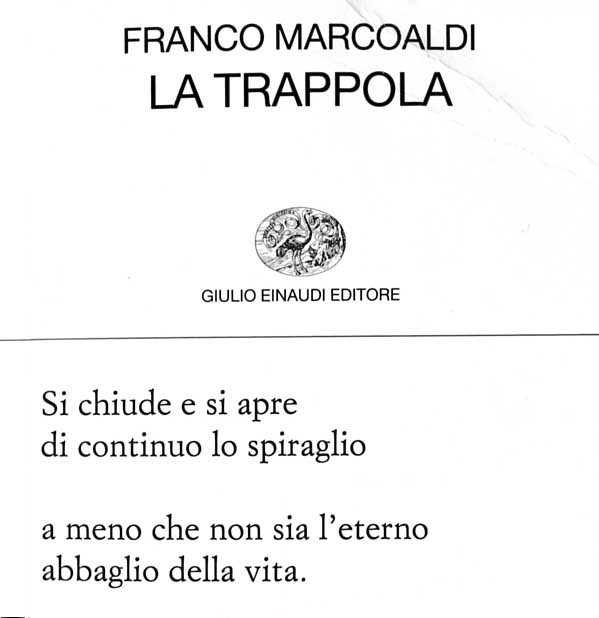

 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti