BATTUTA DI CACCIA
Sono una battuta
di caccia queste ombre staccate
agli oggetti che le consolano, la loro sola
struttura possibile. Lo so
questo spiarmi mentre dormo, guardarmi
sotto le coperte: le vedo
tutte quelle mani senza impronte
infilarsi nella carne per scoprirmi
la bile fino al cuore. E dopo
il setaccio: ecco
si tirano tutte indietro
innocenti e tornano a contornare
le cose.
Il volume di Azzurra De Paola da cui sono tratti questi versi (e anche quelli riportati sotto) ha per titolo Benedizione per la bassa moltitudine (Le voci della luna, 2011) ed è dedicato ad Amelia Rosselli. Le è dedicato non per un debito stilistico (non in maniera evidente, almeno), ma perché si tratta di una lunga ripetuta meditazione sulla morte della Rosselli. Dai versi della Rosselli è tratto il titolo.
Amelia Rosselli parla in prima persona in questi versi, come se fosse un eroe tragico, uscito dal mito. Ed è così che ci appare, distillata nell’umanità della sua tragedia come un’Antigone, o un’Elettra; ogni componimento una diversa riflessione sulla difficoltà di vivere, sull’attrazione del salto nel vuoto. Non è tanto la poetessa Amelia Rosselli ad apparire qui, quanto la donna, l’essere umano, attraversata nella propria permanente condizione di tragedia.
Che tipo di verso si deve scegliere per raccontare liricamente una tragedia? Scegliere un verso tradizionale regolare, come l’endecasillabo, vorrebbe dire compiere un’operazione di distacco, vorrebbe dire mostrare le cose attraverso il velo della tradizione. Non si tratta necessariamente di una scelta sbagliata; ma sarebbe un’altra scelta, e certamente non è mai stata la scelta della Rosselli.
Il verso, qui, vuole restare il più aderente possibile all’espressione dell’angoscia; anzi, se possibile, deve amplificare quello che la sequenza sintattica esprimerebbe se fosse stesa in prosa. L’a capo deve mettere in evidenza le parole più forti, oppure spezzare le espressioni a rischio di frasi fatte, per ridare loro vita; oppure enfatizzare parallelismi; oppure isolare dal contesto intere espressioni…
Non si possono utilizzare, per i medesimi motivi, vere rime a fine verso. Assonanze, consonanze, e soprattutto allitterazioni, meglio se lontane dalla sede forte di fine verso, e quindi più irregolarmente dislocate, possono ugualmente costruire un tessuto musicale, una rete di ricorrenze. Sono un segnale di poeticità, di appartenenza al linguaggio; ma si impongono con sufficiente discrezione. Anzi, sono spesso l’occasione per richiamare o suggerire foneticamente dei legami narrativi.
La ripetuta allitterazione sulle liquide (l ed r) e sulla s al verso 3 di “Battuta di caccia” (che le consolano, la loro sola) viene raccolta dalla paronomasia con cui si chiude il verso 4 (Lo so), che a sua volta apre, sintatticamente, la spiegazione dell’incubo – rallentata a sua volta dallo spazio bianco dell’interlinea del cambio di strofa. (Si chiamano ancora strofe, queste, perché non abbiamo un altro modo per chiamarle; ma quello che conta davvero qui non è l’unità dei versi che le compone, bensì la spezzatura che le separa dalla precedente e dalla successiva).
E poi i versi 5 e 6 sono ritmicamente irregolari, segnati dagli enjambement, volutamente quasi-prosastici, così che l’isolamento in cui si trova posto il verso 7 (anticipato dal le vedo che riprende il lo so della strofa precedente) ne metta in evidenza l’ossessiva struttura giambica (tùtte quélle màni sènz’imprónte, accenti sulle sillabe 1, 3, 5, 7 e 9), che corrisponde al momento della contemplazione ossessiva e protratta delle figure del male. Queste figure del male si rimettono poi in moto nel verso successivo, ugualmente giambico ma dinamizzato dalla divisione in tre gruppi di quattro sillabe (ìnfilàrsi | nélla càrne | pér scoprìrmi – in neretto gli accenti forti, in corsivo quelli deboli) e sfociano di nuovo, proseguendo, in una struttura meno definita (molto debolmente trocaica), di nuovo tendente alla prosa.
Regolarità e irregolarità metrica sono perciò qui altrettanti espedienti narrativi, volti a enfatizzare in vario modo, o ad abbassare il tono, o a modificarlo di colpo. Il verso è ciò che rende possibili questi effetti, rimanendo comunque, anche nella sua variabilità, una misura del respiro. Anzi essendolo tanto di più in questa sede, dove il respiro della voce narrante (la stessa Rosselli, nella finzione narrativa) vuole essere rotto dall’angoscia, vuole essere tragico.
È singolare come nella poesia dell’ultimo secolo e mezzo una figura come il verso, che è tradizionalmente stata una figura di mediazione, di presa di distanza, nei confronti della cruda espressività delle emozioni forti, sia finita per diventare spesso una figura a sua volta espressiva. La natura scritta della nostra poesia garantisce l’immediata riconoscibilità del verso (così non era per gli antichi); e quindi il verso può rimanere un’unità formale anche là dove questo non sia evidente all’orecchio. Sarà poi compito del rapsodo moderno quello di riuscire a far sentire ugualmente questa unità – ma non è detto che ci possa riuscire davvero: la cesura di fine verso va certamente fatta sentire in qualche modo; ma come fa l’ascoltatore che non vede il testo scritto a distinguerla dalle cesure sintattiche o espressive di altro tipo?
Il verso libero permette alla modulazione della lunghezza del verso di farsi elemento fortemente espressivo, giocando pure, se si vuole, sulla maggiore o minore regolarità prosodica al suo interno. In questo modo, la scansione dei versi si trasforma in un sistema sintattico ulteriore, che si affianca a quello vero e proprio, ora assecondandolo, ora contrapponendovisi. Abbiamo così due modalità diverse di gestione del respiro: il verso, che dovrebbe esprimere un respiro, e la punteggiatura che dovrebbe suggerire a sua volta le possibili modulazioni della presa di fiato.
Questa complessità di respirazione si presta bene a esprimere quella dell’angoscia, che anche è complessa e difficile. Eppure è proprio la scansione dei versi, che di questa complessità fa parte, a permettere che si conservi comunque un senso ritmico, una dimensione ancora sotterraneamente rituale. Raccontare in versi l’agonia della Rosselli vuol dire comunque celebrare il rito che la ricorda, che la rende presente – come si poteva fare, a suo tempo, a Epidauro celebrando l’agonia di Cassandra, o quella di Ifigenia.
DISSENSO PRIVATO
Si deve
dissossare il pensiero – comprendere
per sottrazione e togliere
tutte le parti iniziando
dalla pelle.
Pianificare un olocausto
del senso del pudore e poi l’angoscia
e togliere anche questi
al computo finale.
Sottrarre all’amore il tarlo del proibito.
E resta
un’impalcatura vuota, un mucchio
di costole a scaffali
e da una parte all’altra il vuoto
purissimo del corpo.
15 Dicembre 2011 | Tags: poesia, Sergio Rotino, verso | Category: poesia |  Sergio Rotino, "Loro", Dot.Com Press 2011, p.16 ————————————————–
 Sergio Rotino, "Loro", Dot.Com Press 2011, p.20 ———————————————————-
 Sergio Rotino, "Loro", Dot.Com Press 2011, p.28 I correlativi oggettivi di queste poesie di Sergio Rotino si manifestano in sequenze di versi lunghi o extra-lunghi e privi di punteggiatura, come emissioni interminabili di fiato sporcato dalle parole e dal loro senso. Le immagini nette, dure, occasionalmente crude, che rimandano a un evento (a un seguito di eventi) crudele della nostra storia, sembrano annegare in questo movimento omogeneo del respiro che dà loro vita materiale. Non che ne risultino indebolite: è piuttosto come se si trovassero registrate nel flusso di una pellicola che scorre senza potersi fermare, così che la loro giustapposizione in sequenza è più forte della natura di ciascuna.
Lo sguardo distaccato riservato a queste immagini finisce così per avere una tonalità apocalittica, perché la ragione di questi versi va fatta risalire a una tradizione che ha al suo principio come modello il versetto biblico, e il suo andamento apodittico e definitivo, sanzionante, alla William Blake o alla Walt Whitman. In questo respiro dilatato, prosodicamente atonale, le parole suonano come occorrenze del destino, presenze numinose anche in assenza di qualsiasi dio. In questo ritmo da Antico Testamento, sequenze di discorso che sarebbero normali in prosa si ritrovano qui straniate dalla sospensione di quei nessi logici che spetterebbero alla punteggiatura, e trasformate così, dai rari ma non meno significativi a capo, in qualcosa di diverso.
È quindi questo specifico straniamento a trasformare gli oggetti in correlativi, gli eventi del mondo in oscure allusioni alla dinamica del male, o alla vuotezza dell’essere, al dramma banale del trovarsi qui – o magari semplicemente al posto giusto, normale, ma nel momento sbagliato.
E poi, di quando in quando, qualcuno di questi oggetti finisce come per caso in un’ansa del discorso, un verso capricciosamente breve, da cui riemerge nitidissimo, violento, come radicalizzato dalla luce potente di un riflettore vicino. Il film si è fermato per un attimo, ci ha lasciato, anzi costretto, a mettere a fuoco il dettaglio adesso immobile – salvo poi ripartire, rigettarci nel flusso. Sembra di non arrivare mai in fondo, a volte, in questi versi: gli eventi si susseguono senza arrivare a una fine che dia loro un senso; il tempo resta sospeso talmente a lungo durante questo sterminato procedere che la fine del verso giunge poi come una sorpresa, quasi fosse quello il vero evento di cui si sta parlando, la possibilità, finalmente, di tirare il fiato, abbandonando per una frazione di secondo il ciclo doloroso delle reincarnazioni verbali e continue delle cose.
 Sergio Rotino, "Loro", Dot.Com Press 2011, p.64 —————————————–
 Sergio Rotino, "Loro", Dot.Com Press 2011, p.65
 Il linguaggio della poesia .
Non posso negare un poco di emozione. Ieri sera, nel tornare a casa ho trovato un pacco con le copie di spettanza del mio nuovo libro. Ho controllato nelle librerie on line, ed è già in vendita. Non sono riuscito ad andare a vedere in quelle tradizionali, ma se ancora non c’è è questione di giorni.
Per dare un’idea di che cosa si tratta, ecco qui di seguito l’Indice del volume e l’Introduzione. Se cliccate qui o sulla copertina a sinistra, potete vedere la scheda del libro sul sito Bompiani.
.

Introduzione
0.1. Linguaggio
Argomento di questo libro è il linguaggio della poesia. La parola linguaggio, certo, può essere intesa in sensi abbastanza differenti: quando si parla, per esempio, del linguaggio di Alessandro Manzoni si può fare riferimento alle sue preferenze lessicali e di costruzione sintattica; ma quando si parla del linguaggio dell’arte visiva, o del linguaggio della musica, stiamo evidentemente parlando d’altro. Si parla persino del linguaggio delle api, o del linguaggio del DNA – e non abbiamo la sensazione che si tratti di estensioni metaforiche dell’uso di questo termine.
È bene puntualizzare da subito che l’oggetto di questo libro non è il linguaggio della poesia nel senso delle sue scelte lessicali e di costruzione sintattica. Anche di questi aspetti, senza dubbio, si parla in queste pagine – ma è piuttosto l’altra accezione di linguaggio quella che ci riguarda, quella che avvicina il problema del linguaggio della poesia a quello del linguaggio dell’arte visiva, o della musica, o persino delle api.
Per dirla con le parole più semplici possibili, l’oggetto di questo libro è il modo in cui la poesia comunica, o agisce su chi la legge. Questo modo è legato anche al problema delle scelte lessicali e sintattiche, ma è ben lontano dal ridursi a questo, così come il problema del linguaggio delle arti visive non si può ridurre al problema della scelta dei colori e delle forme, né il problema del linguaggio musicale può ridursi al problema della scelta delle note.
Si potrebbe discutere a lungo se il linguaggio delle api contempli davvero l’uso di un codice. Da fuori, si direbbe che possa essere così. Ma, anche ammettendo che un codice vi sia, nessun linguaggio naturale, compreso quello delle api, si limita e può essere ridotto alla sua componente codificata. Quando pensiamo al linguaggio della musica lo vediamo con chiarezza: la musica comunica, non ci sono dubbi, ma la sua componente codificata è talmente ridotta che la maggior parte della comunicazione ne passa al di fuori.
Ferdinand de Saussure (1922) ha parlato, a suo tempo, di fenomeni di langue – cioè legati alla componente codificata, più strettamente linguistica, del discorso verbale – e di fenomeni di parole – cioè dipendenti dalla situazione contingente, dalla particolare combinazione specifica di parole. Il significato delle nostre comunicazioni verbali è costituito sia da elementi di langue che da elementi di parole, e dunque il nostro linguaggio verbale è basato sugli uni non meno che sugli altri.
Il linguaggio della poesia enfatizza questa componente, locale e idiosincratica, di parole. Fa uso della langue, evidentemente, in quanto fa uso delle parole della lingua, e quindi del loro significato codificato; ma si allontana da questa base molto, molto di più di quanto non faccia il linguaggio ordinario, e anche più di quanto non faccia la prosa letteraria.
Il nostro intento, in queste pagine, è vedere da vicino alcuni degli aspetti di questo linguaggio della poesia, che prende il via dall’uso consueto della parola e arriva lontano.[1]
0.2. Comprensione, emozione e ritmo
Questo libro si occupa dunque del leggere la poesia, non solo del comprenderne il senso. Quando leggiamo cerchiamo sempre di comprendere, ma non leggiamo testi solo per comprenderli – cosa che è vera, in diversa misura, per tutti i tipi di testo, ma è particolarmente vera per i testi che hanno finalità estetiche: tra questi la poesia possiede un ulteriore statuto particolare.
Per esempio, non leggiamo un romanzo solo per capirne il significato. Se non ne comprendiamo almeno a qualche livello il significato non lo stiamo in realtà nemmeno leggendo; e, certo, più a fondo lo comprendiamo e più intensa potrà essere la nostra esperienza di lettore. Ma se un romanzo non ci coinvolgesse emotivamente e non ci portasse con sé in un viaggio di sensazioni vivide e profonde, che ragione avremmo di leggerlo? Quanto ci importa dell’ideologia dei nichilisti russi di fine Ottocento? Il nostro scarso interesse per questo specifico tema non ci impedisce di leggere appassionatamente I demoni di Fedor Dostoevskij. E che a un gentiluomo francese vissuto circa un secolo fa sia un giorno capitato di mangiare un biscottino che ha scatenato la sua memoria e la sua ossessione grafomaniacale, è qualcosa di davvero interessante per noi? Non è davvero per sapere che cosa sia accaduto al signor Proust che leggiamo la Recherche.
Dostoevskij, come Proust e come ogni altro scrittore di qualità, non ha mai pensato di produrre un semplice resoconto di fatti di relativo interesse. Ciò che ha fatto, piuttosto, è stato costruire un meccanismo emotivo, basato su questi fatti, in cui il lettore si possa immergere, e possa vivere, anche se in forma surrettizia, un percorso emotivo, con risvolti cognitivi (si impara senza dubbio un sacco di cose anche leggendo romanzi) ed etici.
Della poesia si può dire lo stesso, però in misura ancora maggiore. Se un qualche interesse a priori per la storia russa o per la vita quotidiana francese di inizio Novecento possono talvolta costituire una ragione per leggere i romanzi di Dostoevskij e di Proust, non riesco proprio a immaginare perché mi dovrei interessare alle fantasie di un signorotto marchigiano di inizio Ottocento al guardare la siepe del suo giardino. E nemmeno trovo particolarmente interessante, in sé, il pessimismo leopardiano, che non è una filosofia di particolare originalità storica, e che nessuno si sarebbe preoccupato di studiare se non stesse alla base di alcune tra le poesie più straordinarie che siano mai state scritte.
Ancora più che il romanzo, la poesia costruisce dentro di sé le proprie ragioni di interesse per il suo lettore. Essendo più breve, mira a costruire un’esperienza emotiva più intensa, e per farlo utilizza le risorse del linguaggio in maniera estrema, rendendo pertinenti aspetti che normalmente non lo sono o lo sono poco. Proprio come il romanzo, poi, ma con maggiore intensità, anche la poesia ci insegna qualcosa, ma lo fa a partire dall’esperienza emotiva che induce nel suo lettore.
Questa collina solitaria mi è sempre stata cara, come pure quella siepe, che mi impedisce di vedere oltre. Eppure, se mi siedo e guardo, io mi immagino spazi senza fine al di là, silenzi eccezionali e una grande tranquillità, al punto che quasi mi spavento. E quando sento il vento muovere gli alberi, mi viene da fare il paragone tra questo fruscio e quel silenzio: e così penso all’eternità, al passato, al presente e ai suoi rumori. E in questo senso di immensità il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo.
Questo breve racconto segue evidentemente la falsariga del discorso di Leopardi ne L’infinito. Potremmo considerarlo come una parafrasi molto libera del testo originale. Probabilmente non tutto il fascino del componimento leopardiano si perde, e qualche ragione di interesse interno continua a sussistere – ma questo testo non sarebbe mai passato alla storia emozionando innumerevoli lettori. Senza l’emozione non si genera l’interesse, e senza interesse non ci può essere acquisizione cognitiva.
I meccanismi di sollecitazione emotiva ci interessano dunque per due ragioni: in primo luogo perché sono alla base di una migliore comprensione del significato del testo, e in secondo luogo perché non sempre possono essere ridotti a questo, e possiedono una propria autonomia e un proprio valore intrinseco.
C’è una situazione in cui il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Infatti, quando mi siedo di fronte a questa collina solitaria, a me molto cara, e guardo quella siepe che mi impedisce di vedere oltre, finisco per immaginarmi al di là di quella un’enormità di spazio e di silenzio, quasi spaventandomi per questo. Ma poi, se paragono queste sensazioni al suono del vento tra gli alberi, mi viene da pensare all’eternità e alle epoche, e provo un senso di immensità che mi fa smarrire.
Confrontiamo ora questo breve testo con la parafrasi dell’Infinito proposta appena sopra. Qui non si può più nemmeno parlare di parafrasi, per quanto libera; al più parleremo di “liberamente tratto da”. Entrambe le versioni condividono con l’originale il mero resoconto dei fatti, ma la prima è abbastanza fedele all’originale anche per l’ordine in cui i fatti vengono esposti, e per il risalto che viene dato a ciascuno di loro, mentre la seconda stravolge sia l’ordine che il risalto.
Per quanto poco conservi dell’esperienza dell’originale, la prima versione conserva di più della seconda, ed è in grado di produrre nel lettore un percorso emotivo che, per quanto molto più blando, assomiglia a quello dell’originale più di quanto gli possa assomigliare quello prodotto dalla seconda versione.
La prima versione ha infatti (parzialmente) in comune con l’originale non solo un percorso discorsivo-narrativo ma anche un ritmo discorsivo-narrativo e un sistema di tensioni. Gli eventi raccontati si succedono grosso modo con lo stesso andamento e con lo stesso specifico rilievo, e producono quindi nel lettore un andamento di interesse simile.
In poesia, tradizionalmente, quando si parla di ritmo si fa riferimento a una regolarità di andamento di carattere prosodico e fonetico (ovvero relativo al succedersi delle sillabe e dei loro accenti, nonché di suoni sufficientemente simili) o al massimo sintattico. Quando si parla di ritmo poetico, cioè, si fa tradizionalmente riferimento a eventi situati sul piano del significante (che la semiotica chiama, più propriamente, piano dell’espressione).
Il ritmo discorsivo-narrativo si pone invece sul piano del significato (che la semiotica chiama piano del contenuto) e non è un fatto specifico della poesia: qualsiasi discorso verbale possiede un ritmo dell’esposizione dei propri concetti, qualsiasi racconto ha un ritmo narrativo, cioè un andamento del modo in cui gli eventi arrivano alla ricezione del fruitore.[2]
Anche i ritmi prosodici, fonetici e sintattici non sono specifici della poesia; tuttavia, mentre nel discorso in prosa sono di solito semplicemente non pertinenti o poco pertinenti, in poesia la relazione di contrasto con la dimensione metrica (che è a sua volta una dimensione ritmica) li rende significativi e influenti. Il ritmo discorsivo-narrativo è influente in qualsiasi tipo di testo, ma in poesia esiste una relazione di contrasto con altri tipi di ritmo dell’espressione e del contenuto – come vedremo più avanti – che modifica e spesso magnifica questa stessa influenza.
Analizzare la poesia e la sua efficacia emotiva significa dunque considerare non solo la dimensione ritmica tradizionale e la sua relazione con il metro, ed eventualmente le modalità in cui queste interagiscono con la dimensione del significato, ma anche tutta una sfera ritmica della dimensione del significato che produce effetti sia sul significato stesso che sul coinvolgimento emotivo diretto del lettore.
A questo si aggiunge la comprensione del sistema di aspettative e tensioni messo in moto dalla poesia. Anche in questo caso, tutti i testi generano aspettative nel loro fruitore, ma la poesia lo fa con le sue specifiche modalità e i suoi specifici effetti.
0.3. Leggere, guardare, ascoltare
Il leggere è naturalmente diverso dal guardare[3]. Certo per leggere è necessario guardare, ma qualsiasi guardare che non comporta un leggere è un guardare che segue regole diverse dal guardare per leggere. Nella sua bella storia dell’arte tipografica, Warren Chappell caratterizza come segue la differenza:
Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo. (Chappell-Bringhurst 2004:194)
La differenza principale tra leggere e guardare è una differenza ritmica. Leggendo, respiriamo, ovvero seguiamo un percorso impostato in maniera più o meno diretta sui ritmi del respiro. Guardando, viceversa, seguiamo un percorso più o meno arbitrario a seconda del caso, ma in ogni caso del tutto indipendente da qualsiasi impostazione ritmica, in particolare da quella del respiro.
Per dirla in un altro modo, la scrittura è sì qualcosa che si guarda, ma che non perde mai del tutto la relazione che intrattiene con la dimensione lineare e sonora della lingua parlata. E la lingua parlata è per sua stessa natura impostata sul respiro, è emissione di fiato, ritmata dalla necessità di inspirare l’aria necessaria per produrre i suoni delle parole. Come vedremo tra breve, questa ineludibile natura sonora della lingua agisce in qualche modo anche attraverso la scrittura, e riverbera sulla parola scritta le proprie qualità.
La scrittura è però comunque un fatto grafico, ancor prima che sonoro. Di sicuro nella scrittura poetica la dimensione sonora procrastina la propria scomparsa molto più di quanto non faccia nella prosa – eppure sappiamo bene quanto i testi prodotti per essere letti con gli occhi siano differenti da quelli prodotti per essere ascoltati! E la poesia è fatta per essere letta o per essere ascoltata?
In questo libro assumiamo che la poesia sia fatta prima di tutto per essere letta, ma che, di questa lettura, una sorta di “recitazione ad alta voce interiore” sia una parte così importante che anche l’ascolto vero e proprio può giocare il suo ruolo. Non a caso una gran parte delle pagine di questo libro è dedicata alla dimensione sonora evocata dal testo poetico.
Di sicuro, la poesia è uno strano ibrido: gran parte dei testi poetici sono così complessi da pretendere di essere letti, piuttosto che ascoltati, per poter essere capiti; eppure per loro tradizione e natura sono così legati alla propria sostanza fonica da pretendere l’ascolto, almeno virtuale. Anche se dedicheremo molte pagine a questa sorta di ascolto che la poesia mette in scena, la natura scritta della poesia comporta inevitabilmente una certa rilevanza della sua dimensione visiva, ovvero di un qualche guardare che non si risolva in un leggere.
La lunghezza media dei versi, la divisione in strofe, la posizione sulla pagina, sono elementi tradizionali del testo poetico che non hanno necessariamente un effetto diretto nella dimensione sonora. Quando Stéphane Mallarmé scrive il suo Coup de dés[4], distribuendo graficamente i suoi versi sullo spazio bianco della pagina, sta sviluppando una possibilità che esiste da quando la poesia è sostanzialmente una testualità scritta. Nessuna recitazione del poemetto di Mallarmé può esprimere compiutamente la differenza tra la sua impaginazione e quella tradizionale. Quindi, l’impaginazione ha un valore visivo proprio, indipendente dalla qualità sonora della poesia, un valore che dipende da un guardare che, pur se accompagnato da un leggere, non si risolve in quel leggere.
All’esperimento di Mallarmé ne faranno seguito tanti, nel corso del Novecento, sino al costituirsi di una vera e propria poesia visiva, spesso molto più da guardare che non da leggere – anche se la componente della lettura non scompare mai del tutto.
Questa dimensione puramente visiva, legata al guardare, secondaria ma non assente nella poesia tradizionale e talvolta primaria nella poesia più recente, richiede di essere esplorata. Anche la componente visiva, cioè, contribuisce al significato di un testo poetico e alla sua sollecitazione emotiva. La natura ambigua della parola scritta costituisce un campo di possibilità espressive che la poesia può sfruttare, anche quando gioca soprattutto sull’evocazione della dimensione orale.
0.4. Immersivo vs frontale
Per capire la rilevanza specifica della dimensione orale, è necessario approfondire un poco le conseguenze delle differenze percettive che esistono tra visione e ascolto[5].
La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.
Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.
Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.
Attraverso lo scambio di suoni un animale non si limita a segnalare ai suoi simili la propria presenza, o a comunicare la presenza di un pericolo o la propria disponibilità sessuale. Nelle specie più evolute il suono può essere usato a scopo empatico. Le vibrazioni sonore della madre possono ricreare la sensazione di unione che il piccolo ha perso con la nascita, e calmare il suo pianto o la sua paura; con le grida si può trasmettere l’eccitazione o la stessa paura, e comunque rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, con la quale, appunto, ci si trova in sintonia.
Non c’è ragione di pensare che questa funzione empatica si perda quando nella specie umana il suono si evolve in linguaggio. Il comprendere il significato delle parole non inibisce il nostro vibrare al loro suono. Analogamente abbiamo ragione di pensare che la musica stessa nasca da un raffinamento delle potenzialità di questa dimensione compartecipativa su base immersiva.
Come vedremo meglio poco più avanti (par. 1.1), la musica non nasce per essere ascoltata, bensì compartecipata e vissuta, con un atteggiamento che ha caratteri simili a quelli che accompagnano il rito. La danza e la cerimonia sono i contesti in cui per molti secoli la musica viene eseguita, a cui si potrebbe aggiungere la dimensione empatica diretta del canto su base poetica. In questi contesti non esiste un ascoltatore come lo pensiamo oggi, posto di fronte alla musica in un’attività solo ricettiva-interpretativa. Nella danza come nella cerimonia – situazioni tradizionalmente rituali – la musica è il fattore socialmente unificante, è cioè il ritmo, l’andamento nel quale la collettività si può riconoscere come collettività.
In questa dimensione sostanzialmente immersiva, al suono, specie se prodotto dalla voce di qualcuno, non viene attribuita una funzione di informazione sul mondo come accade per l’immagine. Il suono è soprattutto latore di una funzione di consonanza, attraverso l’eventuale sintonia con chi lo produce o con gli altri che lo stanno percependo insieme a me: stiamo vibrando insieme, ondeggiando insieme, sentendo insieme.
L’andamento della vibrazione può finire per corrispondere all’andamento di sensazioni ed emozioni. Queste sensazioni ed emozioni possono essere comuni, compartecipate, condivise da tutti i presenti. E se questo andamento sonoro ed emotivo si accompagna a un discorso, per esempio sviluppato attraverso quelle stesse parole che sono state espresse con i suoni, inevitabilmente questo discorso verrà interpretato all’interno della dimensione sonora, sensitiva ed emotiva, e al senso di compartecipazione creato dai suoni.
Come vedremo in questo libro, la poesia ha una relazione complessa con la dimensione sonora, che necessita di un’analisi precisa. Tuttavia, pur con i limiti che vedremo, questa dimensione sonora è presente e determinante per la fruizione del testo poetico.
In altre parole, la fruizione di un testo poetico non si esaurisce nella sua comprensione. Benché la comprensione sia necessaria, l’esperienza del lettore di poesia non è fatta solo del capire quello che il testo gli sta dicendo. La poesia non è solo un discorso complesso e fascinoso, che sfrutta dimensioni del senso che la parola normalmente ignora: è anche l’occasione per un’esperienza immersiva, compartecipativa, rituale, con caratteristiche orfiche.
Capire le modalità di questa esperienza ci permette, in molti casi, anche di raggiungere un ulteriore livello di comprensione del testo poetico, e a sua volta questa comprensione può mettere in moto ulteriori risonanze orfiche, con un meccanismo che, nei casi più felici, davvero non si interrompe mai. Che continuiamo oggi a studiare Dante, Catullo, Saffo, a tanti secoli di distanza, è la dimostrazione che esistono testi poetici inesauribili, destinati a produrre nuove significazioni e nuove emozioni ogni volta che si confrontano con un’epoca nuova.
0.5. La questione della lirica
È ormai un luogo comune osservare che, dei diversi generi in cui era tradizionalmente divisa la poesia, solo la lirica è rimasto in auge, e che, di fatto, il campo della lirica oggi corrisponda a quello della poesia. La lirica è la poesia di espressione soggettiva, quella al centro della quale c’è un io, un io lirico, ingenuamente identificato di solito con l’io del poeta.
Ma non c’è bisogno di un io manifesto perché la poesia sia lirica. L’espressione può essere benissimo soggettiva anche se si sta utilizzando la terza persona. Il soggettivismo[6], cioè la tendenza a mettere il soggetto al centro del componimento poetico, si può esprimere anche, per esempio, attraverso la scelta di una forma metrico-ritmica particolare, al di fuori delle regole costituite. In questo senso, la nascita e lo sviluppo del verso libero a fine Ottocento è una conseguenza del dominio della lirica, perché il verso libero è quello attraverso cui il poeta esprime la propria soggettività anche nella forma metrica – che stia esplicitamente dicendo “io” oppure no.
Se vediamo le cose in questi termini, praticamente tutta la poesia del Novecento può essere vista come lirica, compresi i tentativi di riduzione dell’io, cioè i tentativi di costruire una modalità poetica che non si presenti come espressione del soggetto[7]. Il luogo comune che riduce la poesia a espressione spontanea della soggettività individuale è a sua voglia un figlio ingenuo di questa prospettiva. Ne riparleremo nelle ultimissime pagine.
Due cose vanno osservate a proposito del predominio della lirica. La prima è che esso corrisponde sì, certamente, a un imporsi del valore dell’individuo e del soggetto nella nostra società degli ultimi secoli[8]; ma all’interno di questo medesimo soggetto, la psicoanalisi e l’antropologia hanno situato delle aree che non gli appartengono affatto, e sono piuttosto sociali, condivise. Anche per questa acquisizione (o perdita intrinseca di soggettività, se preferiamo), la soggettività di oggi può pretendere di esprimere l’universale, visto che, in fin dei conti, essa ce l’ha, volente o nolente, dentro di sé.
La seconda è che la dimensione lirica si deve comunque confrontare con quella immersiva, rituale, di cui stiamo parlando in questo libro; e quindi confluire in un senso di condivisione sovra-soggettivo. Se non facesse questo, non sarebbe nemmeno riconoscibile come poesia.
0.6. Questo libro
Questo libro cerca di descrivere l’esperienza della fruizione poetica. Per fare questo deve parlare sia della dimensione discorsiva del testo poetico – che dipende dalla sequenza delle parole (proprio come nella prosa) ma anche dalle interazioni tra questa sequenza e una serie di caratteristiche specifiche della poesia – sia della sua dimensione immersiva, partecipativa, orfica. Questa seconda dimensione si articola in sistemi di ritmi e di tensioni che si manifestano sul piano dell’espressione come anche sul piano del contenuto: ritmi e tensioni morfologiche e sintattiche, ma anche ritmi e tensioni semantiche e narrative.
Inizieremo (cap. 1) parlando della fruizione musicale, cercando di definire che cosa caratterizzi l’esperienza sonora, quando è diretta a testi di carattere estetico. Questo ci sarà utile per capire subito dopo quale sia lo specifico sonoro della poesia; e su questo quadro di fondo esploreremo le caratteristiche del metro e del ritmo prosodico. Ma questa stessa comprensione ci sarà utile, nel capitolo successivo (cap. 2), anche per capire che cosa siano e come si manifestino i ritmi semantici e narrativi.
Un capitolo (cap. 3) sarà dedicato alla costruzione del discorso in prosa, ricercando al suo interno una serie di aspetti (alcuni anche di carattere emotivo) di cui pure la poesia fa uso. Ritroveremo questi aspetti anche nel capitolo 4, dedicato alla costruzione del discorso poetico, ma sarà a questo punto centrale la loro interazione con gli aspetti specificamente poetici che sono stati descritti nei capitoli precedenti.
Incominceremo ad avere, a questo punto, un quadro abbastanza dettagliato della situazione, e potremo permetterci di mettere in gioco (cap. 5) quegli elementi, puramente visivi, che non hanno nessuna relazione diretta con la dimensione sonora. La scrittura ha una sua specificità, come ce l’hanno una serie di aspetti visivi presenti da lungo tempo in poesia. Esiste però anche una poesia fortemente basata sulla dimensione visiva, cui è necessario dedicare uno spazio.
Nell’ultimo capitolo (cap. 6) cercheremo quindi di descrivere la fruizione poetica nella sua complessità, tracciando alcune linee di un’estetica poetica, con un accenno finale alla dimensione dello scrivere.
[1] Vedi il par.3.1, per un’espansione di questo discorso.
[2] Sui ritmi del contenuto, vedi sotto Cap. 2. Più in generale, su ritmi e tensioni nei testi, narrativi e non, cfr. Barbieri(2004).
[3] Al rapporto tra leggere e guardare nella comunicazione visiva (poesia visiva e poesia concreta incluse) ho dedicato il volume Barbieri (2011).
[4] Vedi sotto, par.5.2.1.
[5] Ho dedicato a questo tema diversi articoli (Barbieri 2008, 2009 e 2010), ma la problematica nasce in Ong (1967 e 1982). Per quanto riguarda la musica si trova affrontata anche in Piana (1991), in Capuano (2002) e in Sparti (2007).
[6] O meglio, quello che Guido Mazzoni (2005) chiama piuttosto espressivismo.
[7] Per lo sviluppo di questa tesi, vedi ancora Mazzoni (2005). L’espressione “riduzione dell’io” è invece di Alfredo Giuliani (1965), nell’Introduzione 1961 all’antologia de I Novissimi.
[8] Su questo tema, oltre a Mazzoni (2005) vedi anche Ferry (1990).
Nonostante le apparenze, questo non è un post (solo) sulla poesia. Ecco dunque queste apparenze.
Ci sono due eventi all’origine delle riflessioni che sto per esporre. Intanto, mi sono arrivate le bozze del mio libro sulla poesia (Il linguaggio della poesia, Bompiani – ne ho anticipato qualcosa qui), e nel correggerle mi si sono inevitabilmente scatenate varie riflessioni. L’altro è la segnalazione di un sonetto di Gongora (grande poeta spagnolo del Seicento), da parte di un’amica ispanista che mi ha promesso un riferimento più preciso di quello che ricordava a memoria e che, a quando ho capito, per parlare di una bellezza imperfetta, concluderebbe la sua sequenza con un endecasillabo eccedente e sgraziato, un po’ a modello di ciò di cui sta parlando.
Mentre sono in attesa del riferimento preciso, per leggermi davvero il sonetto, non posso fare a meno di pensare che l’uso di un verso a-metrico non fa certo di Gongora un precursore del verso libero. Anzi, se le cose stanno come ho capito, il verso “sbagliato” di Gongora deve la sua efficacia locale proprio al contesto in cui si trova, all’allusione che produce, e alla sostanziale validità del principio metrico: insomma, è la classica eccezione che conferma la regola, mettendola in evidenza proprio con il suo occasionale scarto.
Dunque, sinché lo scarto è occasionale, esso contribuisce a rafforzare la regola – ma quando comincia a diventare a sua volta regola, la nuova regola scaccia quella vecchia. E il verso libero vero e proprio non è in nessun senso una conferma della metrica tradizionale.
Nel mio libro sostengo, tra le altre cose, che la metrica tradizionale rappresenta un quadro regolare, sicuro e confortante, attraverso cui possono essere trasmessi anche i significati più inquietanti o spaventosi, rendendoli accettabili. Sono accettabili, in questi casi, perché la regolarità metrica funziona come metafora (o persino come locale implementazione) dell’ordine imposto dall’uomo alla natura selvaggia (ivi compresa quella, interiore, dei sentimenti). Il quadro regolare e assestato del sonetto, per esempio, fa da cornice, e rende più facilmente accettabili sin la disperazione e la tragedia, quando emergono. Proprio come gli elementi di antropizzazione del paesaggio, o il riconoscimento di una struttura narrativa in una situazione di angoscia incontrollata (e il mestiere degli psicoanalisti è fatto anche del saperla fare emergere dal caos mentale del paziente).
Così, possiamo pensare la metrica tradizionale come il corrispondente in poesia delle strutture sociali tradizionali – quelle al cui interno abbiamo vissuto per secoli, al riparo dagli eccessi della natura, esterna o interna a noi. Da questo punto di vista il sonetto di Gongora (così come me lo sto immaginando) non viola nulla: quello che fa è semplicemente giocare sul principio, suggerendo che l’imperfezione del suo oggetto possa riflettersi persino in un’imperfezione dell’ordine umano delle cose.
Ma il verso libero è un’altra cosa. Nel mio libro suggerisco che l’uscita dalle strette del metro permetta alla disperazione e alla tragedia (o a quant’altro) di esprimersi in maniera più diretta ed efficace, perché la cornice in cui vengono inserite è più leggera e meno distanziante. In altre parole, una poesia in versi liberi rimanderebbe molto meno (ma in qualche modo deve continuare a farlo) all’ordine umano e sociale imposto alla natura; e in questo modo ridurrebbe la distanza nei confronti del proprio oggetto emotivo, rendendolo più vivido ed efficace.
Continuo a pensarla così (nel libro tutto questo viene spiegato molto più ampiamente), ma ho la sensazione che ci sia dell’altro.
Il punto è che la poesia in versi libero non esclude il metro. Semmai, quello che è accaduto è che a una serie di strutture metriche (all’incirca) stabili da secoli si cerca di sostituire delle strutture nuove, adatte alla situazione espressiva particolare. Ma se la metafora (o locale implementazione) di cui parlavamo sopra resta valida, questo tentativo dovrebbe corrispondere anche a un tentativo di costruire strutture sociali nuove. È certamente un tentativo presuntuoso, ma è proprio quello che la modernità ha cercato di portare avanti, timidamente nel corso dell’Ottocento e poi molto più spavaldamente nel Novecento, sino alle utopie razionaliste del comunismo sovietico, che ha sognato di ricostruire l’ordine sociale da zero, coi risultati che sappiamo.
Senza arrivare a questi estremi, mi sembra comunque che il verso libero sia figlio della stessa presunzione che ci fa pensare di poter essere davvero i capitani della nostra stessa società e delle nostre vite, capaci di sottomettere tutto a un nuovo ordine, razionalmente fondato. Non è un’idea campata in aria, e soprattutto è l’idea dentro cui viviamo, ma ancora non sappiamo se sia destinata ad avere successo sul lungo termine, e in che misura andrà eventualmente emendata per poter funzionare a lungo. Rispetto alle società tradizionali, che funzionavano così perché si basavano su un ordine che, giusto o ingiusto che fosse, era validato da secoli o millenni di sopravvivenza, la nostra società pretende di sapersi progettare in termini nuovi, e magari anche più giusti. Allo stesso modo lo pretende la poesia moderna, che ha abbandonato le certezze dell’organizzazione assestata da secoli a favore delle incertezze del progetto.
Il punto non è, a questo punto, se il passato sia meglio del presente, o viceversa. Questo sarebbe oggi un problema unicamente virtuale, perché al punto in cui siamo non c’è possibilità di ritorno (se non attraverso una certo non auspicabile catastrofe). Nell’ambito ristretto del metro, non basta affatto recuperare la metrica tradizionale per ripristinare la situazione precedente. Oggi come oggi, dopo un secolo di intensivo verso libero (e a due secoli e passa dalla sua nascita), l’endecasillabo, per esempio, appare una possibilità come un’altra, e non come un obbligo. I poeti cosiddetti neo-metricisti non stanno riproponendo il passato, ma soltanto avanzando un progetto tra i tanti, magari profumato di classicismo, ma niente di più. Se anche una volta l’endecasillabo si contrapponeva (statisticamente vincente) ad altri metri ugualmente canonici, inevitabilmente in numero limitato, tra i quali era giocoforza scegliere, oggi l’endecasillabo non è che una scelta tra innumerevoli potenzialità progettuali per il quadro di riferimento.
La poesia, alla fin fine, socialmente ne patisce – ma non perché i poeti di oggi siano meno capaci di quelli di ieri (e certamente, oltretutto, ci rappresentano di più). È semmai perché quella funzione di conforto, di sostegno all’ordine umano e riconosciuto delle cose, non è più possibile – ed è passata, sostanzialmente, ad altre modalità di espressione. Nel leggere una poesia dell’ultimo secolo non posso contare su un quadro di sfondo condiviso: persino la presenza di un simile quadro (o la possibilità di condividerlo) va verificata caso per caso. È naturale che la situazione venga sentita come enormemente più complicata di prima: non solo sono scomparse le certezze, ma ciascuno ha il diritto di suggerire le proprie. Meraviglioso! e insieme devastante. Non ne possiamo fare a meno, perché ciò che non è così non ci rappresenta; ma questo non è necessariamente positivo.
Ancora un’osservazione: non sto parlando delle avanguardie, degli esperimenti estremi. Quello che ho detto vale per Sandro Penna come per Nanni Balestrini. E siccome, nonostante le apparenze, non sto parlando solo di poesia, vale per Frank Miller come per Lorenzo Mattotti o Chris Ware; con il vantaggio (o lo svantaggio) per il mondo del fumetto, di non avere secoli di tradizione regolatrice alle spalle, essendo nato già in un mondo orientato più al progetto che alla tradizione. Ma, di questo, in qualche prossimo post.
25
Así como a veces desearíamos
que Karl Marx y Arthur Rimbaud
se hubieran conocido en una mesa
de algún Café de Londres,
mientras en el agua sórdida del Támesis
– ahíta de grumos aceitosos
que flotan entre botellas y colillas
y ropa gris de gente ahogata –
espera el Barco Ebrio, ya sin anclas,
a que el fantasma que recorre Europa
suba también, para zarpar
(Karl, vestido con blue jeans marineros
se despite de Engels en el muelle
y Arthur hace lo propio con Verlaine
– los sueños insolentes ahora enfundados
en la gorra que usó él mismo en la Comuna);
así come, a estas alturas, quisiéramos
que Hegel, apeado del estrado de su cátedra,
hubiese visitado a Hölderlin un día
en su manicomio oculto de la torre
para escuchar cómo el demente
– sin reconocerlo tal vez en su delirio –
le habla de un viejo amigo de Tubinga
con quien, en mitad de una fiesta adolescente,
bailó una mañana, junto a un árbol
por ellos mismos levantado
(“Libertad”, lo llamarían),
tan fieros y felices como niños orinándose,
con el impudor de los puros, frente al rey
(en la siesta monocorde del verano,
recordando novias suavísimas de Heidelberg,
los dos compañeros se confiesan:
la razón debe pedirle a la locura
su danza irreductible, la inocencia
con que el loco Hiperión, desde su torre,
enseña al profesor que la luz blanca,
la rosa de los vientos del Espíritu,
no termina en el Estado de los Césares,
se burla de las Prusias de los káiseres);
así querría yo hoy que a William Blake
lo hubiesen dejado predicar un solo día
sobre el púlpito labrado de una iglesia
– la catedral de Westminster, por ejemplo –
en presencia de arzobispos y presbíteros
y de una moltitud de feligreses
harta, como todas, de sermones.
Imagino el viento sagrado resonando,
por primera vez, junto a los mármoles,
mientras los cuerpos, desnudados por fin
como a la hora del agua o del amor,
se erizan con el paso del Dios vivo
y tiemblan ante el olor de Cristo el Tigre
devorando las ingles de las almas,
ahora tan intactas, tan ebrias y tan vírgenes
como la de aquel niño canoso viendo ángeles
a la hora en que arde Venus sobre Lambeth
y hasta las prostitutas de Soho profetizan.
(Armando Rojas Guardia, da Poemas de Quebrada de la Virgen, 1985)
25
Così come a volte sogneremmo
che Karl Marx e Arthur Rimbaud
si fossero incontrati a un tavolino
di un qualche caffè a Londra,
mentre là nell’acqua sozza del Tamigi
– piena di grumi oleosi
che fluttuano tra bottiglie e mozziconi
e abiti grigi di gente annegata –
attende il Battello Ebbro, già senz’ancore,
che il fantasma in giro per l’Europa
salga anche lui, per salpare
(Karl, vestito con blue jeans da marinaio
sta salutando Engels là sul molo
mentre Arthur fa del proprio con Verlaine
– i suoi sogni insolenti adesso infoderati
nel berretto da lui usato alla Comune);
così come, a queste altezze, amassimo
che Hegel, disceso dal gradino della cattedra,
avesse un giorno visitato Hölderlin
nel manicomio occulto della torre
per ascoltare come il demente
– senza riconoscerlo forse nel delirio –
gli parla di un vecchio amico di Tubinga
con cui, a metà di una festa adolescente
ballò una mattina, presso un albero
fondato da essi stessi
(“Libertà”, lo chiamerebbero),
così felici e fieri come bimbi che pisciano,
con l’impudicizia dei puri, verso il re
(nella siesta monocorde dell’estate,
ricordando ragazze dolcissime di Heidelberg,
si stanno confessando i due compagni:
dalla follia la ragione deve avere
la danza irriducibile, l’innocenza
con cui il matto Hiperion, dalla sua torre,
insegna al professore che la luce,
quella rosa dei venti dello Spirito,
non finisce nello Stato dei Cesari,
si burla della Prussia dei kaiser);
così io oggi vorrei che William Blake
lo avessero lasciato predicare un giorno solo
sopra il pulpito istoriato di una chiesa
– l’abbazia di Westminster, per esempio –
in presenza di arcivescovi e presbiteri
e di una grande folla di fedeli
esausta, come tutte, di sermoni.
Immagino il vento sacro che risuona
per la sua prima volta, insieme ai marmi,
sin quando i corpi, infine denudati
come nell’ora dell’acqua o dell’amore,
si impennano col passo del Dio vivo
e tremano all’odor di Cristo il Tigre
divorando gli inguini dell’anima,
adesso così intatti, così ubriachi e vergini
come quello del bimbo canuto a veder angeli
in quell’ora in cui arde sopra Lambeth Venere
e sin le prostitute di Soho profetizzano.
Altro esempio da Armando Rojas Guardia, e altro esperimento di traduzione, dopo quello della scorsa settimana. Qui i problemi sono diversi. Si tratta di un componimento molto più lungo in versi liberi. Il principio di base della mia traduzione rimane lo stesso: cercare di rendere in italiano l’effetto che l’originale produce in me. Mi rendo conto benissimo che questo principio implica un problema: per quanto io conosca lo spagnolo, l’effetto che una poesia di tradizione spagnola produce in me è inevitabilmente diverso da quello che può produrre in un lettore che è cresciuto in quella medesima tradizione. Non è solo questione di lingua. Per quanto io conosca Garcilaso e Lope e Gongora, e Darío e Jiménez e García Lorca e Storni e Caballero Bonald e García Montero, sono cresciuto a Dante e Petrarca, e a Leopardi e Montale, e a Pasolini e Sanguineti e De Angelis. Inevitabilmente, gli echi che un lettore nato ispanico (di lingua, intendo) sentirà, saranno diversi da quelli che sentirò io – e se pure la conoscenza del passato aiuta (anzi, è indispensabile) nessuna conoscenza approfondita sostituirà la mia specificità, il mio percorso di crescita.
In misura minore, certo, questo è vero anche a livello individuale, non solo di differenza linguistica. Quello che io posso sentire in qualsiasi componimento poetico anche nella mia lingua dipende inesorabilmente dal mio percorso di formazione – il quale, certo, non è mai terminato, e continua tuttora a modificare il mio gusto, ma in cui certe acquisizioni del passato rimangono comunque determinanti. Insomma, differenza di percorso individuale, o differenza di percorso culturale che sia, la lettura che posso fare, e dunque la traduzione che posso proporre di qualsiasi componimento è inevitabilmente la mia. E solo in parte posso appellarmi al fatto che condivido molte letture formative con tanti, e che la tradizione spagnola è abbastanza vicina (ma tutt’altro che identica) a quella italiana. I livelli di libertà che avrei anche solo con l’inglese sarebbero molto superiori.
Ecco quindi, inevitabilmente, il mio Rojas Guardia, e il mio verso libero di Rojas Guardia.
E poi si fa presto a dire verso libero. Se si guarda più da vicino l’originale ci si accorge che l’effetto ritmico complessivo è dato da una alternanza (non regolare, ma dettata da ragioni di retorica) di endecasillabi (anche ipermetri o ipometri, cioè con una sillaba in più o in meno), alessandrini e altri versi comunque piuttosto musicali, con qualche rottura ritmica qua e là. Lessico e sintassi sono abbastanza piani, su un registro non particolarmente alto – forse innalzato in verità solo dal ritmo prosodico.
È questo dunque che devo rendere nella mia lingua, cercando di essere fedele al senso il più possibile, ma all’interno dei vincoli posti dalle scelte metriche, lessicali e sintattiche generali – che sono più importanti, in poesia, della corrispondenza semantica esatta.
Così, dove mi era possibile rispettare il metro dell’originale, l’ho ovviamente fatto; mentre dove questo avrebbe portato a un lessico o a una sintassi di registro troppo alto (o troppo basso), ho cercato comunque di attenermi ai modelli ritmici di verso dominanti nell’originale. La fortuna dello spagnolo è che spesso è facile rispettare queste regole, per la somiglianza tra le due lingue; ma qualche rimpianto ce l’ho lo stesso. Per esempio, non sono contento di aver dovuto trasformare la “luz blanca” del quart’ultimo verso della seconda strofa in semplice “luce”, ma non ho trovato modo per conservare la caratterizzazione “bianca” senza perdere in efficacia ritmica – e alla fine ho deciso di levarla, scommettendo sul fatto che nel gioco poetico di Hölderlin (per come viene visto da Rojas Guardia) il fatto che la luce fosse “bianca” non fosse così essenziale.
Sono molto affezionato a questi versi, specie per la terza strofa, quella in cui il bimbo canuto che vede gli angeli William Blake predica a Westminster. Trovo molto bella, anche narrativamente, quella progressione.
Falta de mérito
Si yo fuera capaz de entrar por fin
en esa pulcritud del aire inmóvil
que he llamado silencio en el poema:
si yo fuera capaz de nombrar árbol
como esta tarde el árbol se mostraba
a sí mismo en la quietud del parque;
si yo fuera capaz de parecerme
al objeto real de mi escritura
(al agua misma cuando escribo agua
al vaso limpio cuando escribo vaso);
y si fuera posible merecerte,
cosa que ultrajo en tu mudez precisa
al hacerte sonar en mi palabra,
yo entraría en la luz de lo que digo.
——————————————————-
Mancanza di merito
Se io sapessi entrare finalmente
in questa pulizia dell’aria immobile
che ho chiamato silenzio nei miei versi:
se io sapessi nominare l’albero
come stasera l’albero appariva
a se stesso nella quiete del parco;
se io sapessi come assomigliare
all’oggetto reale del mio scrivere
(all’acqua stessa quando scrivo acqua
al terso calice quando scrivo calice);
e se riuscissi mai a meritarti,
cosa che offendo nel tuo stare muta
col farti suono nella mia parola,
nella luce entrerei di quel che dico.
Ho scoperto Armando Rojas Guardia per caso, trovandomi in Venezuela e acquistando qualche libro alla cieca. La dimensione dell’universo dei poeti di lingua spagnola è proporzionale alla diffusione della lingua, anzi di più, perché in quell’universo la poesia continua a godere di una considerazione pubblica un po’ più alta che da noi; ed è quindi ancora più difficile padroneggiarlo un minimo. È stata comunque una scoperta e un innamoramento. Non mi stupisce che Rojas Guardia sia considerato tra i maggiori poeti del suo paese, il Venezuela appunto, mentre mi stupisce che Wikipedia non abbia una voce su di lui nemmeno in lingua spagnola. Rojas Guardia è nato nel 1949; la lirica che citiamo qui appartiene alla sua prima raccolta, del 1979, Del mismo amor ardiendo (Ardendo dello stesso amore).
Mi sono provato a tradurre qualche verso suo (altri forse, oltre a questi, in futuro), e penso che possano essere interessanti alcune considerazioni sulle scelte che ho fatto.
Il criterio di base a cui mi sono attenuto è stato quello di cercare di ricostruire, nella mia lingua, il fascino che i versi di Rojas Guardia hanno esercitato su di me leggendoli nella sua. Credo che sia il criterio più corretto, anzi forse l’unico davvero corretto nel tradurre poesia – ma è tutt’altro che esente da problemi. Per esempio, tra gli aspetti che mi sono rimasti dentro c’è il nitore del suo endecasillabo, musicale e incisivo. Questa breve poesia è scritta in endecasillabi, come molte altre sue, ma la sua opera contiene tipi differenti di versi, tra cui tante composizioni in verso libero. L’endecasillabo è quindi una scelta locale, specifica.
E si tratta di una scelta che ha comunque un valore diverso che per l’italiano. Nella tradizione italiana, l’endecasillabo è il verso lirico ed epico, senza rivali; il settenario, che è forse il secondo verso più usato, è più un compagno di viaggio che un concorrente. Viceversa, nella tradizione spagnola, pur essendo ampiamente usato, l’endecasillabo è comunque un verso di provenienza italiana e petrarchesca, e, anche nella produzione del Novecento, oltre al verso libero, si trova come concorrenti sia l’alessandrino di origine francese, che l’ottosillabo (o doppio ottosillabo) che è il verso epico tradizionale spagnolo. Federico García Lorca, per esempio, nel sua Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, alterna sezioni (o anche solo gruppi di versi) in endecasillabi, ottosillabi, alessandrini e versi liberi. Mentre un poeta italiano del Novecento ha come scelte neutre solo endecasillabo e verso libero (perché tutte le altre sono particolari e meno diffuse), vale a dire – per certi versi – tradizione classica contro tradizione contemporanea, il poeta di lingua spagnola può giocare molto di più, pur senza uscire dallo stretto canone della norma (e senza dichiararsi implicitamente classicheggiante se non usa il verso libero).
Non c’è, nella metrica italiana, un verso che abbia dunque la posizione dell’endecasillabo nella metrica spagnola. Tradurre endecasillabi spagnoli con endecasillabi italiani è quasi inevitabile, ma è comunque un tradimento, perché si traduce un andamento ritmico tra i diversi possibili (e con una debole implicazione di classicità) con un andamento ritmico che è l’unico possibile (e con un’implicazione di classicità molto più forte). Scegliendo un metro diverso tradirei infatti ancora di più l’originale, perché sceglierei un andamento ritmico meno standard, meno normale. Sono rimasto affascinato, leggendo questi versi in originale, dall’endecasillabo di Rojas Guardia, e non c’è altro modo, per renderli in italiano, che riprodurre l’endecasillabo – ma bisogna essere consapevoli della differenza. Tra l’altro, benché lo spagnolo abbia una metrica simile a quella dell’italiano, e pure una prosodia e una sintassi piuttosto vicine alle nostre, le differenze ci sono, e queste differenze permettono una frequenza di effetti specifici che in italiano è più difficile ottenere, e che, riprodotta ad arte, potrebbe apparire artificiosa. Per esempio, lo spagnolo ha più parole tronche dell’italiano, essendo molto meno vincolato alla terminazione in vocale, ed è quindi più facile ottenere endecasillabi che altrove ho definito composti, cioè a tutti gli effetti costituiti da settenario+quinario (o quinario+settenario) grazie alla presenza di una parola tronca con accento in sesta (o quarta) sillaba. Nella poesia citata sopra 8 versi su 14 sono di questo tipo; per avere una frequenza analoga in italiano avremmo bisogno di ricorrere alle apocopi, ovvero al troncamento dell’ultima vocale – ma il Novecento italiano ha ripudiato quest’uso, e riprenderlo comporterebbe un ritorno a un uso passato della lingua che invece in Rojas Guardia non c’è per nulla.
Ho cercato anch’io inizialmente di mantenere la frequenza di versi composti, per rispettare al massimo la musicalità dei versi. In una prima versione avevo tradotto i versi 1, 3 e 5 rispettivamente così:
Se capace foss’io di entrare infine
se capace foss’io di dire l’albero
se capace foss’io di assomigliare
Certo, così avrei rispettato di più il ritmo prosodico dell’originale, ma a costo (come si è detto) di un uso della lingua che sa di arcaico, di petrarchesco, di ottocentesco – tutte sfumature completamente assenti dal testo originale, la cui lingua è sì colta, ma anche del tutto attuale. Per fortuna, ho trovato una soluzione diversa – ma non sempre ci si riesce; e ho comunque dovuto rinunciare a quello specifico ritmo, perché il costo sarebbe stato troppo alto.
Allo stesso modo, per i due penultimi versi, avevo inizialmente ipotizzato le seguenti soluzioni.
cosa che offendo in tua mutezza esatta
col farti risuonare in mia parola
col risuonare nella mia parola
col tuo suonare nella mia parola
con il tuo suono nella mia parola
Reso così, il terzultimo verso rispecchia maggiormente il senso dell’originale, ma la parola mutezza è piuttosto brutta e inconsueta in italiano; e poi, soprattutto, in tua invece che nella tua appare proprio una licenza poetica, che, pure lei, sa di passato.
Lo stesso problema si pone per la prima delle quattro proposte per il penultimo verso. Le successive tre sono migliori, ma si perde il fare (hacer) presente nell’originale, che mette in campo il lavoro del poeta, e mi dispiaceva molto perdere.
Infine, un po’ per gioco, ho provato anche a fare una traduzione del tutto diversa dell’intero componimento, che rispecchiasse al massimo il senso delle parole e delle espressioni, lasciando in subordine la questione del ritmo. Eccola:
Mancanza di merito
Se io fossi capace di entrare finalmente
in questa pulizia dell’aria immobile
che ho chiamato silenzio nella poesia:
se io fossi capace di dar nome albero
al modo in cui stasera l’albero si mostrava
a se stesso nella quiete del parco;
se io fossi capace di assomigliare
all’oggetto reale della mia scrittura
(all’acqua stessa quando scrivo acqua
al bicchiere terso quando scrivo bicchiere);
e se fosse possibile meritarti,
cosa che offendo nella tua mutezza esatta
col farti suonare nella mia parola,
io entrerei nella luce di quel che dico.
È una versione lessicalmente molto più fedele della prima, ma io credo che tradisca l’originale assai più dell’altra. Il verso libero non è l’endecasillabo, e l’occasionale guadagno di senso che otteniamo qui non è compensato dalla perdita di suono. Paradossalmente, il componimento di Rojas Guardia raggiunge, nella misura in cui è possibile farlo, la luce di quel che dice proprio attraverso il suo essere parola che suona, cioè essere se stessa ancora prima che altro, essere suono ancora prima che segno – proprio come sono in sé le cose di cui vorrebbe saper parlare. È questo che la mia versione ha cercato di rendere, che ci sia riuscita o no.
(Un’altra possibilità ancora, che questa seconda versione suggerisce, è di tradurre l’endecasillabo con l’alessandrino – o doppio settenario. Il primo verso è già un alessandrino, e si può lavorare per far sì che anche gli altri lo diventino. Il vantaggio sarebbe – forse – di poter essere più letteralmente fedeli al senso delle singole parole, pur mantenendo un ritmo che alla poesia spagnola è familiare. Non lo è però alla poesia italiana. Quindi, anche a patto di riuscirci con efficacia, il tradimento sarebbe comunque maggiore.)
14 Settembre 2011 | Tags: Dante Alighieri, metrica, poesia, verso | Category: poesia | Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Permettetemi qualche riflessione vissuta da autore, senza pretesa di confrontarmi con uno con cui qualsiasi confronto è perdente, ma nell’ipotesi di poter sentire, almeno un minimo, alcune cose come lui. Però mi sembra di aver visto qualcosa, in questi versi di avvio della Commedia, che non ho letto da nessuna parte. D’altra parte, non essendo un dantista, può benissimo trattarsi di ignoranza mia. Nel qual caso, se vi è noto qualche approccio simile a questo mio, vi prego di segnalarmelo.
Dico riflessione da autore perché le osservazioni che vado a fare su questi versi derivano da mie specifiche considerazioni sulla scrittura dei versi – e riguardano quasi esclusivamente metrica e prosodia.
Ho bisogno di fare una piccola premessa sull’endecasillabo, il verso della Commedia e il verso principe della poesia italiana. Ci insegnano i manuali di metrica che l’endecasillabo, pur non essendo davvero un verso composto, è tuttavia costituito di due parti: un settenario seguito da un quinario nella versione cosiddetta a majore (accento forte sulla sesta sillaba), oppure un quinario seguito da un settenario nella versione a minore (accento forte sulla quarta). L’endecasillabo non è veramente un verso composto perché 7+5 (come 5+7) fa 12 e non 11, e le condizioni per cui siano davvero leggibili sia il settenerio che il quinario sono particolari e non sempre presenti.
Non sono presenti certamente quando l’endecasillabo non è canonico, ovvero non presenta accento né sulla quarta né sulla sesta sillaba. L’endecasillabo non canonico è raro in Dante come pure in generale nella poesia italiana, perché con facilità suona poco musicale al nostro orecchio.
Al contrario, le condizioni sono effettivamente presenti quando il primo emiverso (settenario o quinario che sia) è tronco, e ha di conseguenza una sillaba in meno, lasciando la sillaba libera a completare il secondo. I primi tre versi della Commedia sono di questo tipo. Per intenderci, chiamerò qui questo tipo di endecasillabo fortemente composto, o anche solo composto (nelle versioni, rispettivamente, a majore e a minore).
C’è un altro modo per far sì che 7+5 (o 5+7) possa fare 11, ed è la sinalefe sulla settima (o sulla quinta) sillaba. Per esempio, nel verso 5 del nostro esempio, la “e” dopo “selvaggia” fa sinalefe con la vocale che la precede, e quindi viene inglobata nella medesima (settima) sillaba. Questo è un modo molto debole per ottenere il verso composto, perché per far sentire l’andamento dell’endecasillabo dovremo far sentire anche la sinalefe, e ridurre di fatto il conto del secondo emiverso a quattro (o sei, se a minore) sillabe. Ma la lettura separata (come se la sinalefe non ci fosse) non è completamente esclusa, e può ritornare ad aver senso in qualche caso. Chiamerò perciò qui questo tipo di endecasillabo debolmente composto.
Chiamerò infine non composto ogni endecasillabo canonico in cui non sia possibile percepire entrambi gli emiversi come settenario e quinario, come succede, per esempio, nei versi 7 e 9 riportati qui sopra (tra “poco” ed “è” c’è dialefe, e “cose” e “ch’i'” sono chiaramente separati).
Il particolare andamento dei versi di Dante riportati sopra non dipende, mi pare, solo dalla distribuzione degli accenti, ma anche dalla loro natura composta o non composta. Per verificarlo, ecco un piccolo esperimento: modificherò i versi 1-3 con alcune piccole sostituzioni, che ne rispettino grosso modo il senso (che comunque non è in gioco in questo discorso), e ne mantengano lo schema di accenti (per il verso 2 dovrò introdurre una voce verbale che non esiste, facendo finta che esista, perché non trovo in italiano un’alternativa sensata che regga alle mie condizioni). Ecco dunque:
Nel mezzo del cammino della vita
mi ritrovetti in una selva oscura,
ché la diritta strada era smarrita.
Anche senza prendere in considerazione il senso leggermente mutato, e nonostante il sistema degli accenti di questi versi sia esattamente lo stesso di quelli originali, essi suonano al mio orecchio molto meno melodiosi di quelli veri. Credo che il punto stia nella perdita della sospensione che gli endecasillabi fortemente composti manifestano in concomitanza della cesura dopo la sesta o la quarta sillaba, nelle versioni rispettivamente a majore e a minore. Nella mia versione alterata i versi sono diventati non composti (1) o debolmente composti (2 e 3), e la cesura è scomparsa.
Con la scomparsa della cesura si viene ad affievolire anche la differenza tra l’endecasillabo a majore e quello a minore:tutti e tre i versi portano infatti accenti sia sulla quarta che sulla sesta sillaba, e possono essere perciò letti in ambedue i modi. Tuttavia, nell’originale dantesco, la natura fortemente composta dei versi permette di sentire chiaramente la cesura, che si trova dopo la sesta sillaba nei versi 1 e 3, e dopo la quarta nel verso 2. Da questo punto di vista, dunque, la terzina propone la medesima struttura ABA che si trova anche nella rima, secondo la successione: proposta-variante-ripresa. Aggiungiamo che le sillabe accentate messe in evidenza dal troncamento contengono nei versi 1 e 3 la stessa vocale “i” della rima finale, mentre è diversa quella del verso centrale – e anche questo contribuisce a rafforzare la struttura della ripresa.
Considerando le cose in questo modo, ecco come sono organizzati questi primi dodici versi:
A majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore fortemente composto)
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a majore non composto)
a majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore non composto)
A majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore non composto (ma anche leggibile come a minore non composto)
a minore fortemente composto (ma anche leggibile come a majore fortemente composto)
a majore non composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
Eccetto il verso 5, tutti gli altri portano accenti sia su quarta che su sesta sillaba, con generalizzato ritmo dunque giambico, e seconda diversa lettura possibile. Tra l’altro, è interessante osservare come la rottura del ritmo giambico cada sulla forte paronomasia di “esta selva selvaggia”, e si situi in un verso interno della terzina, sempre a conferma della struttura ABA riconosciuta sopra.
La struttura ABA è dunque presente in tutte e quattro le terzine in esame, ma cambiano gli elementi di diversificazione: nella prima terzina è il rapporto a majore/a minore; nella seconda è la presenza/assenza del ritmo giambico (o l’assenza/presenza della paronomasia); nella terza è la natura non composta/composta, insieme al rapporto a majore/a minore; nella quarta la natura fortemente/debolmente composta.
La varietà di ritmi si trova dunque organizzata in schemi di ricorrenze, che non riguardano solo le singole terzine al proprio interno: la prima e la terza terzina, per esempio, sono entrambe caratterizzate da una comune alternanza di endecasillabi a majore e a minore, anche se la terza introduce un’ulteriore differenziazione. Ma la prima e la terza terzina sono avvicinate anche dalla comune opposizione alla seconda, che gioca sulla presenza di un cambiamento assai più forte degli accenti al suo centro.
Se ora mettiamo in ordine i versi in cui è presente il momento di sospensione determinato dalla cesura (endecasillabi composti), otteniamo questo schema (che include anche alcune terzine successive, sino al verso 36):
+++ –+ -+- +-+ +– -++ -++ ++- +-+ -+- — +-+.
Versi non giambici oltre al 5 sono il 15, 20, 22, 25, 29, 32, 33, ottenendo lo schema:
+++ +-+ +++ +++ ++- +++ +-+ -++ -++ +-+ +– +++. I versi con ritmo non giambico si fanno più frequenti dopo le prime terzine, e perdono in parte la forza accentuativa dovuta alla loro particolarità.
A partire dalla quinta terzina la struttura ABA non si presenta più così stabilmente, e il gioco (come si vede anche dagli schemi qui sopra) diventa più irregolare. Ma con la quinta terzina incomincia anche la narrazione vera e propria e si è già concluso questa sorta di piccolo prologo, che ha avuto anche la funzione di impostare gli andamenti ritmici. A questo punto il lettore è già entrato nel gioco delle sospensioni e dei rilassamenti, del ritmo accentuativo standard (giambico) e delle sue rotture, delle varie alternanze tra a majore e a minore. L’endecasillabo si è mostrato nelle sue tre facce (endecasillabo indivisibile, settenario e quinario) e nelle loro possibili combinazioni. La varietà metrica è stata esibita, ma anche il quadro in cui può essere comunque organizzata.
 Umberto Piersanti, L'attesa, da I luoghi persi Non sta davvero il carattere “bucolico” al centro della fascinazione che ha per me questa poesia di Umberto Piersanti, al pari di molte sue altre. Certamente anche i temi della natura, del ricordo, della quotidianità e del sesso hanno il loro peso; tuttavia, nella mia percezione, ritenere Piersanti, sulla base di questi temi, un poeta crepuscolare e intimista, e dunque sostanzialmente tradizionale, è davvero un errore. Piuttosto che a Pascoli e a Pasolini, a me viene da accostare questi versi a quelli di Amelia Rosselli che ho commentato qualche settimana fa.
Naturalmente questa affermazione chiede di essere giustificata, perché tutt’altro che evidente. A prima vista, semmai, i due testi appaiono davvero diversissimi, quanto ai temi, alla costruzione complessiva e all’architettura metrica e ritmica. Non si tratta comunque di individuare una dipendenza, un influsso, che magari ci sono e magari no; ma semmai una convergenza, una vicinanza di fondo tra questi due testi così apparentemente divergenti.
Se si leggono ad alta voce tutti e due i testi, ci si accorge meglio dell’intensità dell’ossessione ritmica su cui sono entrambi giocati. Nel caso della Rosselli c’è un’affabulazione dall’apparenza antimetrica (in cui sono cruciali i tagli arbitrari del verso) su cui si innesta un’insistita ripetizione di suoni, di intere parole, di formule sintattiche e di esplicite citazioni. Nel caso di Piersanti c’è un endecasillabo iperrealistico, tagliato in maniera da enfatizzare la coincidenza tra i versi e le singole clausole sintattico-narrative, a cui la quasi totale assenza di segni di interpunzione delega tutta l’articolazione prosodica del discorso. L’ossessione iterativa lessicale della Rosselli corrisponde all’ossessione iterativa ritmico-prosodica di Piersanti, e in tutti e due i casi quello di cui si parla finisce in secondo piano rispetto alla dominanza di un ritmo della parola che rimanda al ritmo con cui i singoli momenti del discorso arrivano a consapevolezza.
È questo ritmo, nella Rosselli come in Piersanti, che ci prende, che ci trascina, che ci affascina. Solo in quanto siamo trascinati in questo meccanismo regolato e omogeneo di emergenze al livello del senso, solo in quanto ci ritroviamo, leggendo, a vivere direttamente questo andamento dell’azione (un’azione ricostruttiva ed evocatrice); solo in quanto, in questo modo, ci sentiamo vivere insieme con il soggetto lirico la sua stessa esperienza, solo allora l’esperienza specifica si trova qualificata, ed emergono le differenze, e il delirio drammatico e sentimentale della Rosselli, e il sospiro bucolico di Piersanti. Tuttavia, a questo punto, il gioco è già fatto; ci siamo già dentro, e tanto la Rosselli come Piersanti potrebbero raccontarci (quasi) qualsiasi cosa.
L’esperienza ritmica, che coinvolge la dimensione del suono quanto quella del senso, è un’esperienza che viene vissuta dal lettore; mentre ciò di cui il testo parla (discorso o racconto che sia) è comunque un resoconto, qualcosa che ci arriva tramite il linguaggio, attraverso la sua mediazione. L’esperienza ritmica non è mediata dal linguaggio; piuttosto, essa è direttamente prodotta dalla lettura della sequenza verbale. Per questo si trova enfatizzata e più facilmente riconoscibile attraverso una lettura ad alta voce; ma il lettore esperto riesce a ricostruirla anche solo interiormente.
Se lo leggiamo in questi termini, il testo di Piersanti perde grandissima parte del tono crepuscolare e bucolico che gli attribuisce chi ne privilegia il senso letterale delle parole e delle frasi che lo compongono. La campagna, la quotidianità, il sesso ci sono, certamente; sono ciò di cui si parla, sono l’occasione del discorso – e sono comunque diretti, non oggetto di parodia, né di recupero post- o neo-qualcosa. Ma quello che rende Piersanti un mio contemporaneo, cioè un poeta che leggo e in cui posso riconoscermi, è l’inevitabile distanza mediata dal principio ossessivo, che scardina il discorso tradizionale, quello tipicamente atteso di fronte a questi temi.
Potremmo dire, esagerando un po’, che l’endecasillabo agisce in questo testo di Piersanti come le parole (citate e più volte ripetute) di Campana agiscono nel testo della Rosselli. È il quadro, il contesto attraverso cui ci appare ancora possibile accedere all’esperienza, specie quella emotivamente profonda, nel momento stesso in cui quell’esperienza si trova inevitabilmente e dolorosamente al di fuori di noi, in verità inattingibile. La possiamo, in letteratura, soltanto evocare, nominare, mentre le nostre parole producono, attraverso i propri ritmi, nuove e differenti esperienze in chi ci legge.
La poesia, e la letteratura in generale, finge sempre di portarci nel luogo di cui parla; mentre in realtà ci sta violentemente trascinando altrove – almeno quando ci riesce, quando funziona.
 Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).
I versi di Campana sono quelli che iniziano così:
Non so se tra rocce il tuo pallido
Viso m’apparve, o sorriso
Di lontananze ignote
Fosti, la china eburnea
Fronte fulgente o giovine
Suora de la Gioconda:
O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O Regina o Regina adolescente…
Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.
Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.
Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.
L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.
Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.
La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.
Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.
Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.
A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.
Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.
La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?
Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.
Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:
Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.
Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).
Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.
Sarà per le radici musicali comuni, che rendevano una volta poesia e canzone solo due facce diverse di uno stesso linguaggio (e vedi come se ne discute su Absoluteville anche – e non solo – nelle rubriche di Stefano La Via e di Rosaria Lo Russo) ma sarà anche per la separazione netta che la storia ha poi sancito tra loro. Sarà per questo e probabilmente pure per altro, ma se mi venisse chiesto a bruciapelo che cos’è il verso in poesia, mi verrebbe da rispondere che si tratta della versione stilizzata (ritualizzata) del respiro.
Nelle canzoni – è facile – il verso è direttamente l’estensione del respiro, anche quando chi canta non tira davvero il fiato tra un verso e l’altro; ed è così per ragioni fisiologico-musicali di cantabilità. Ma in poesia la componente di stilizzazione non è meno importante del richiamo al respiro stesso. Da diversi secoli a questa parte, la poesia esiste anche senza che nessuno la declami, quando la percorriamo con gli occhi ed è solo una voce interiore stilizzata a renderne per noi i suoni. (Se manca pure la voce interiore, e leggiamo unicamente con gli occhi, allora o quello che leggiamo non è poesia, oppure non sappiamo davvero leggere la poesia, e il verso non è che un disturbo visivo alla continuità della lettura.)
Il principio del respiro stilizzato (che l’eventuale declamazione dovrebbe in qualche modo rendere acusticamente, riavvicinando – almeno rispetto a questo – la poesia alla canzone) è ciò che dà senso al verso libero. Nella poesia che fa uso del verso libero, secondo la proposta già di William Blake, quando scriveva Jerusalem intorno al 1804, ogni verso ha un respiro differente, adatto alle sue specifiche necessità espressive (qualche idea sul come si va a capo in poesia l’avevo già presentata qualche mese fa in questo post).
Ma allora quello che dovremmo chiarire ora è: che differenza c’è tra usare versi lunghi e usare versi brevi? Oppure, in altre parole: in che cosa è diverso il respiro lungo da quello breve? E come si collega la problematica della lunghezza del verso con quella della lunghezza della proposizione o del periodo? E poi: che differenza si produce tra il fare uso del verso libero, e il sottoporre i versi a un qualche tipo di regolarità (che sia sillabico-accentuativa come nella tradizione italiana, o magari solo accentuativa come in quella germanica, o solo sillabica come in quella francese, o qualsiasi altra purché percepibile)? E infine: perché si usano (o si evitano) i versi canonici?
È un po’ di tempo che sto provando, nei miei esperimenti poetici, a fare uso di un verso non canonico relativamente breve, un ottosillabo alla spagnola, senza gli accenti fissi di quello italiano (qualche esempio si può leggere qui, qui o qui). Ultimamente ho invece cercato di sperimentare un modello diverso, basato su un verso molto lungo, con un andamento cantilenante caratterizzato da quattro o cinque accenti e un numero variabile di sillabe – che non è però un vero verso libero, perché la percezione alla lettura è comunque di una certa uniformità ritmica da un verso all’altro (un esempio qui, e un altro qui).
L’ottosillabo è stato per me una scoperta importante (ne ho già parlato qui) perché mi ha permesso di costruire delle strutture poetiche con respiro fisso ma senza il richiamo ad andamenti prosodici già troppo presenti nelle orecchie del lettore italiano – come sarebbe, per esempio, quello del settenario, appena differente in apparenza, ma in realtà sancito da secoli di tradizione. La (relativa) brevità dell’ottosillabo, aggiunta alla sua regolarità sillabica, permette di costruire delle strutture sufficientemente ossessive; mentre l’irregolarità degli accenti ne permette un uso narrativo, evitando l’effetto filastrocca tanto caro a Pascoli. Questa combinazione tra formalità (e ripetitività) rituale (e ritmica) da un lato, e varietà sintattica e narrativa dall’altro, è – per me – quello che fa l’essenza della poesia, mettendo in comunicazione il nuovo con il già noto e viceversa, ovvero la comunicazione riguardo al mondo (esteriore ed interiore) con le nostre strutture assestate personali, sociali e naturali.
Certo, non è che la ripetitività stia solo dalla parte del metro e la novità solo da quella del racconto. La poesia è qualcosa di molto più complicato di così – ma in qualche caso può trovarsi anche ridotta a questo. D’altra parte, l’adozione di un ottosillabo ad accenti variabili comporta un innesto di variabilità (e quindi di novità) anche nel metro stesso – e si può bene, d’altro canto, giocare di ricorrenze sintattiche o anche narrative…
Passare, nella scrittura, da un verso breve a un verso molto lungo significa per me prima di tutto abbassare il livello di ansietà, di tensione ritmica di base. È come abbandonare il respiro affannoso della corsa o della marcia per quello lungo del riposo o del sonno. Tuttavia questa maggiore lunghezza rende anche più probabile la coincidenza tra le cesure metriche di fine verso e quelle sintattico-narrative di fine proposizione o periodo. Questo vuol dire che, nonostante che il respiro sia più calmo, la componente rituale, iterativa, coinvolge in qualche modo anche il racconto. Gli enjambement, che con il verso breve sono probabili e attesi, con quello lungo diventano più rari, e producono perciò, quando si presentano, effetti molto più radicali.
A grandi linee (perché esistono anche casi particolari in cui accade il contrario), il verso libero privilegia la componente espressiva, comunicativa; mentre la ricorrenza di una clausola regolare (comunque sia ottenuta questa regolarità) sottolinea la componente rituale (ritmica). Se le cose stanno così, il verso libero avvicina la poesia alla prosa, costringendola – per mantenere la distanza – a enfatizzare altre differenze (per esempio di carattere tematico, o moltiplicando le iterazioni sintattiche o narrative).
Giusto per chiudere, è giusto osservare che il rapporto tra espressività e ritualità non caratterizza solo la poesia, bensì – in diversa misura – ogni specifica forma di comunicazione. Quello che potremmo dire della poesia è che si tratta di una forma molto ritualizzata, pur se ancora molto meno della musica.
Cosa succede, in questi termini, nel fumetto? Un po’ ne ho già parlato in qualche post precedente, un po’ ci tornerò sopra, spero presto.
1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.
Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.
Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)
Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.
Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.
Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.
Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.
E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.
1. La parola poetica e la sua natura collettiva
È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:
Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.
La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.
La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.
L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.
La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.
Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.
Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:
Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.
Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.
D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.
Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.
Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.
Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.
Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.
17 Marzo 2010 | Tags: Amelia Rosselli, Dante Alighieri, endecasillabo, enjambement, Francesco Petrarca, Giovanni Della Casa, metrica, petrarchismo, poesia, risoluzione, tensione, Ugo Foscolo, verso | Category: poesia | Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro?
La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no).
La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:
- l’inizio e (soprattutto) la fine di un verso sono luoghi di rilievo: quello che capita in queste posizioni viene enfatizzato rispetto a quello che si trova nella parte centrale del verso;
- di conseguenza, un verso molto breve enfatizza molto il suo contenuto (che si trova al contempo all’inizio e alla fine del verso);
- la coincidenza tra la clausola metrica (data dal verso) e quella sintattica (data dal periodo, dalla proposizione o dal sintagma compiuto) ha impostazione conclusiva: ne farò uso se voglio enfatizzare la cesura tra un verso e l’altro (e tra una clausola sintattica e l’altra), ottenendo un ritmo diviso; la eviterò se invece voglio minimizzare le cesure, ottenendo un ritmo più fluido;
- le forme regolari sono come la tonica nella musica tonale: un luogo di risoluzione della tensione; finché voglio mantenere la tensione devo mantenere irregolare la forma, e spezzare il verso in modo che lo sia; la regolarità, viceversa, è conclusiva. Posso fare uso dei versi più anomali in una poesia, ma un bell’endecasillabo con accenti sulle sillabe 4 e 6 darà l’impressione di un punto di arrivo, parziale se la sintassi non lo conferma, totale se anche sintatticamente si arriva in fondo;
- quest’ultima regola è particolarmente importante quando si fa uso di versi della stessa lunghezza (cioè non versi liberi): il gioco tra le versioni non canoniche e quelle canoniche del verso che stiamo usando crea tutta la tensione metrico-sintattica della poesia. In questo senso la presenza dell’enjambement permette di rendere forme irregolari anche i versi più canonici, inserendo nel gioco un’ulteriore variabile.
Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso.
Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558):
Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due
brevi e notturne ore trapassa, oscura
e fredda; involto avea fin qui la pura
parte di me ne l’atre nubi sue.
Or a mirar le grazie tante tue
prendo: ché frutti e fior, gelo ed arsura,
e sí dolce del ciel legge e misura,
eterno Dio, tuo magisterio fue.
Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce
chiara, che ‘l mondo a gli occhi nostri scopre,
traesti tu d’abissi oscuri e misti.
E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce,
di tenebre era chiuso, e tu ‘apristi;
e ‘l giorno e ‘l Sol de le tue man son opre.
Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato.
Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73):
Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a
graffiare la mia porta d’entrata, a
guarire il mio misterioso non andare
non potere andare in alcun modo con
gli altri. Come fai? Mi sorvegli e
nel passo che ci congiunge v’è soprattutto
quintessenza di Dio; il suo farneticare
se non proprio amore qualcosa di più
grande: il tuo corpo la tua mente e
i tuoi muscoli tutti affaticati: da
un messaggio che restò lì nel vuoto
come se ad ombra non portasse messaggio
augurale l’inquilino che sono io: tua
figlia, in una foresta pietrificata.
In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario.
(come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui)
I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.
Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:
La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte.
Col mantello tutto blu
noci e fichi butta giù.
o anche, come abbiamo visto con Rubino:
Ha la zia dimenticata
la credenza spalancata:
Quadratino di soppiatto
v’entra lesto come un gatto.
Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).
Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:
Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia!
Chi vuol essere lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:
Viene viene la Befana
vien dai monti a notte fonda.
Come è stanca! La circonda
neve, gelo e tramontana.
Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.
Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.
…
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
…
Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.
Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.
Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?
La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.
Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.
Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.
E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.
Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.
Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.
7 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Antonio Rubino, comunicazione visiva, Corriere dei Piccoli, Fabio Gadducci, fumetto, Igort, metrica, nascita del fumetto, ottonario, poesia, verso | Category: comunicazione visiva, fumetto, poesia | A Bilbolbul mi sono abbuffato di mostre e incontri (compreso quello sul mio libro). Tutto interessante e di alto livello; talvolta ancora meglio. Gli effetti di quello che ho visto e udito prima o poi salteranno fuori, magari anche in questo blog. Per adesso voglio concentrarmi su un tema solo, perché credo di aver fatto una piccola scoperta.
Ieri (6 marzo) pomeriggio, Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli presentavano, insieme con Igort, il loro volume Antonio Rubino. Gli anni del “Corriere dei Piccoli”. Bello il libro, interessante la spiegazione e la discussione. A un certo punto è uscito il tema dell’ossessione di Rubino per la geometria, per le simmetrie e per le ripetizioni, e Igort è intervenuto con un’osservazione sulla natura un po’ ossessiva di tutta la produzione di Rubino.
A questo punto sono intervenuto anch’io, con un’osservazione che mi era divenuta sempre più evidente man mano che il loro discorso procedeva, e che ora esporrò ed espanderò qui.
Si tratta delle rimette. Le rimette sono un’invenzione tutta italiana, anzi, del medesimo Rubino (che inoltre, a quanto mi hanno poi assicurato Stefanelli e Gadducci, per lungo tempo la ha scritte per tutte le serie a fumetti del Corrierino). Negli altri paesi europei, lo standard era la sequenza di immagini accompagnata da una narrazione in prosa (come nell’esempio di Ally Sloper che  abbiamo postato qualche giorno fa). abbiamo postato qualche giorno fa).
Ora, perché Rubino spinge così fortemente verso l’uso del verso anziché del più assestato racconto in prosa? La spiegazione più naturale è quella di far riferimento alla tradizione dei cantastorie, che raccontavano in versi accompagnandosi con delle figure. Ma la spiegazione vale solo in parte, perché i cantastorie facevano presumibilmente uso di un altro tipo di verso, cioè l’endecasillabo, che è il verso epico della tradizione italiana, e magari addirittura l’ottava rima, che è quella dell’Orlando Furioso e dei poemi cavallereschi. L’ottonario è piuttosto un verso da canzonetta o da burla, proprio per la sua natura ossessiva, che mal si presta a raccontare.
Credo che la scelta di Rubino sia dovuta invece proprio alla natura non solo popolare, ma soprattutto ossessiva e “quadrata” dell’ottonario. È una scelta, in realtà, tutt’altro che popolare e ingenua (se non magari in seconda istanza): il versus quadratus, o dimetro trocaico, era il metro che i latini usavano, in età classica, per indovinelli, cantilene infantili, scherzi popolari. È caratterizzato dall’espansione di un modulo binario, con accento sulla prima sillaba: Tàta. Se raddoppiate questo modulo e poi lo raddoppiate ancora (Tàta tàta Tàta tàta) avete l’ottonario; se prendete l’ottonario e lo raddoppiate e poi lo raddoppiate ancora, avete le quartine di Rubino: “Ha la zia dimenticata / la credenza spalancata: / Quadratino di soppiatto / v’entra lesto come un gatto.” Più quadrato e ossessivo di così è impossibile.
Nel contesto di questa struttura iper-regolare Rubino inserisce le sue  narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento. narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento.
Ora, se osserviamo le sue figure vi ritroviamo la stessa strategia: un universo di invenzioni strampalate, trasmesse attraverso uno studio, decisamente geometrico, sulla ripetizione, sulla regolarità e sulla rima visiva! Una strategia dell’anti-reale costruita assemblando elementi di carattere opposto: assurdi e irregolari narrativamente, geometrici e iper-regolari strutturalmente.
Il fascino di Rubino sta probabilmente proprio in questa fantasmagorica gestione di opposti. La si vede persino nel suo stile grafico, insieme floreale e liberty da un lato, e geometrico-futurista dall’altro. Credo che Rubino non si sia mai riconosciuto in nessuna di queste correnti. Era abbastanza complesso da sé, evidentemente!
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|






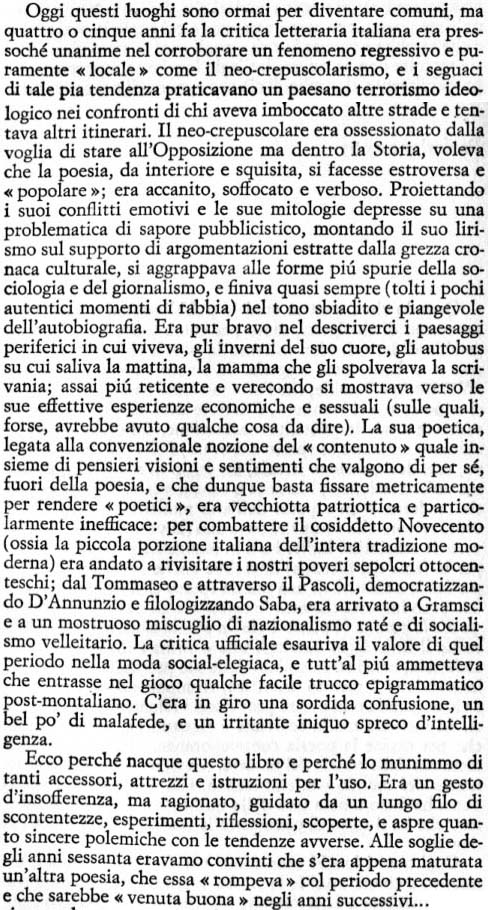


 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco


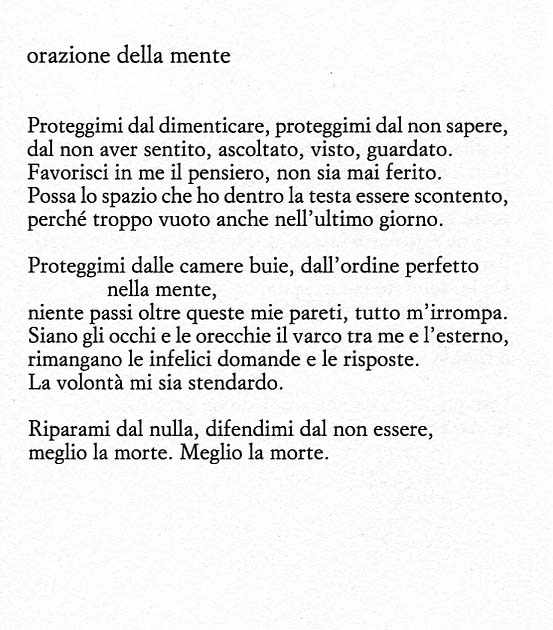
Commenti recenti