Quando mi è capitato per la prima volta in mano Il gatto del rabbino di Joann Sfar, non ci ha messo molto a conquistarmi. Dopo tre pagine ero già appeso al fascino di questo racconto insieme quotidiano e magico – come solo Sfar sa fare. Recentemente, a Bilbolbul, ho visto anche il film d’animazione, e ho provato lo stesso fascino. Che Sfar sappia raccontare è difficile metterlo in discussione.
Ma c’è anche a chi non piace. Qualcuno, qualche mese fa, titolava un post “Sfar mi sembra un autore svogliato e privo di idee che disegna col piede sinistro mentre chiacchiera al telefono”. Volevo rispondere subito, ma poi la cosa mi è sfuggita. Rimedio oggi.
Sullo svogliato e privo di idee, con tutto il rispetto per chi esprime l’opinione, non si può che dissentire. Sfar produce anche troppo, persino per uno che di voglia ne ha. Quanto alle idee, pure di queste io ce ne vedo tantissime, e spesso assai originali.
Mi diverte invece la questione del disegnare col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono. Posso capire che Sfar produca questa impressione. Ma non è un difetto. Anzi credo che sia proprio il segreto della sua arte. Le storie di Sfar scorrono. Non ti puoi fermare, e non solo perché il racconto chiede che si prosegua: è anche il disegno che non ti induce a sostare. Benché sia pieno di dettagli, e la composizione complessiva sia sempre molto ben studiata (le vignette sembrano quasi dei dipinti, spesso, sotto questo aspetto), le linee di inchiostro sono tutte tremolanti, sia quelle di contorno che quelle di tessitura per le ombre.
Questo rende scarsamente definite le figure, e lievemente faticoso il loro riconoscimento. Tanto più che i personaggi principali (il gatto, il rabbino) sono proprio quelli definiti con la massima economia di linee.
Ciò che invece rimane sempre immediatamente evidente, e magari persino enfatizzato dalla scarsa definizione delle figure complessive, sono le espressioni, le sfumature emotive, e le azioni, gli eventi. In maniera del tutto diversa da Hergé e dai patiti della ligne claire, Sfar sta insomma seguendo il medesimo principio, quello di un disegno interamente funzionale al racconto – solo che il suo racconto è di tutt’altro tipo di quello di Hergé.
Le macchie di luce e di ombra, la linea nervosa, il frequente effetto di schizzato, producono l’effetto di qualcosa che ci arriva da lontano, quasi da un altro mondo, come può essere per noi l’Algeria degli anni Venti, vista dal punto di vista degli ebrei – cioè un punto di vista ancora più marginale di quello degli arabi dominati dai francesi. Con tutta la sua dolce ironia, Sfar è, in senso positivo, un sentimentale persino nel disegno. Se definisse troppo le sue figure, darebbe loro una realtà che esse non hanno; ne distruggerebbe il senso di sogno, di altrove. Quel senso che rende così naturale, nelle sue storie, che un gatto si metta a parlare, o che un leone possa essere un animale domestico. Il segno di Sfar è insieme minuzioso e trascurato, descrittivo ed evocativo.
A questo serve la sua aria svagata, il suo sembrare realizzato col piede sinistro mentre si chiacchiera al telefono: è perché tutto quello che con quel segno si racconta non è serio, non si può prendere troppo sul serio, proprio come la vita quando la si racconta attraverso una favola che appare come un sogno narrato da qualcuno che viene da un altrove che si mostra in tutta la sua diversità, proprio mentre ci affascina con la sua familiarità.
A me Sfar piace perché nei suoi racconti e nei suoi disegni ci sono tutte queste contraddizioni, attraverso lo sguardo ironico di un figlio di rabbini, figlio di una tradizione secolarmente ironica e secolarmente favolosa. Il disegno di Sfar è semplicemente come il suo racconto: qualcosa che deve scorrere, facendoci sorridere, lasciandoci alla fine con il sospetto che ci sia qualcosa di profondo nascosto sotto quella superficie. Ma non ci dice mai che cosa. Un po’ come la scienza dei numeri e della Kabbalah.




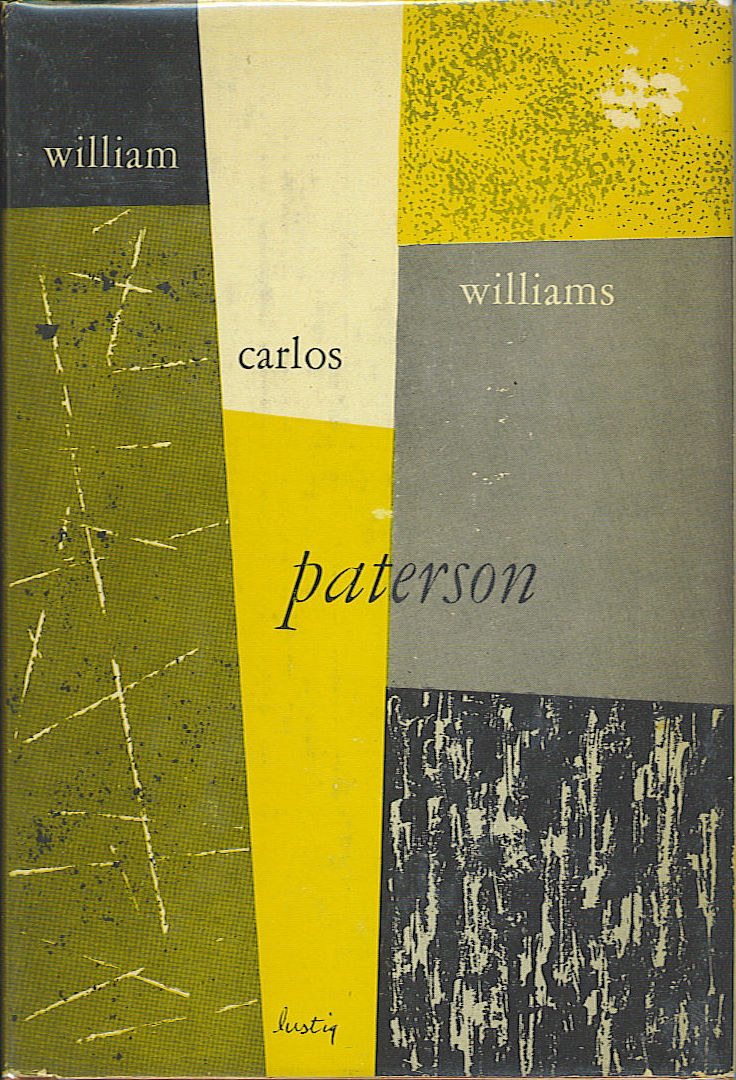
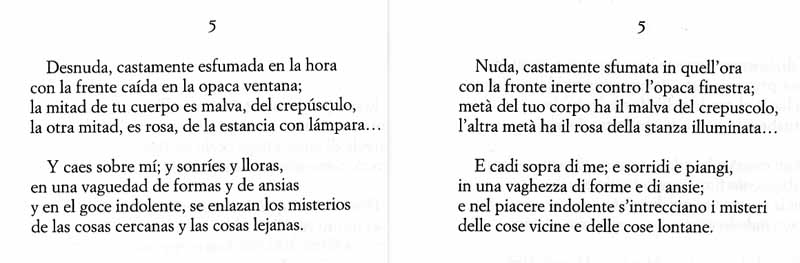




 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco





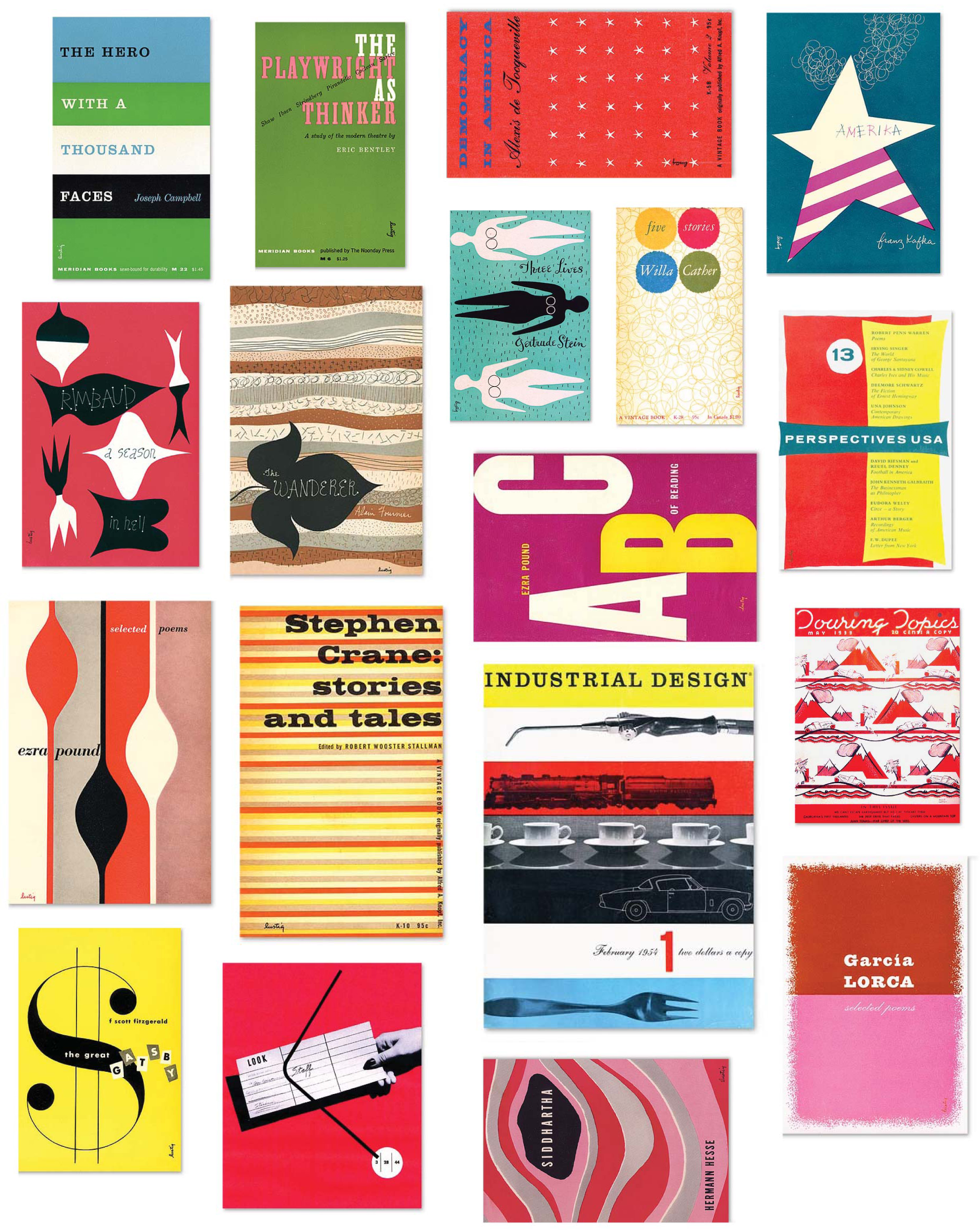



Commenti recenti