29 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | Ho finalmente trovato un Internet point! Non credevo sarebbe stato cosi’ complicato. Ma adesso sono in una citta’ vera e ho il tempo. Prima o l’uno oppure l’altro.
Sono arrivato a Delhi alle 0.30 del 27. Ho dormito all’albergo (mediocre e sporchino) che avevo prenotato. Alle 10 mi sono messo in moto. Prima destinazione Bharatpur, dove si trova il Keoladeo Ghana National Park, famoso per i suoi uccelli, e caldamente consigliatomi da Enrico Guroli. Per arrivarci bisogna far tappa ad Agra.
Ma qui la bibbia (leggasi Lonely Planet) mi tradisce, non dandomi affatto idea di dove prendere il bus per Agra, o dando per scontato che si vada alla Stazione dei bus di Kashmiri gate. Ho visto che c’e’ la metro che porta a Kashmiri Gate, e la metro parte da New Delhi Railway Station, che e’ vicino a dove sono io. Ma poi alla stazione non si capisce dove sia la metro, e il primo a cui lo chiedo mi dice che e’ inutile che ci vada: i bus buoni per Agra non partono da li’. Mi consiglia un’agenzia e mi affida a un suo amico che mi fa prendere un riscio’ per 20 rupie, e mi porta a Connaught Place.
Ma all’agenzia cercano di vendermi di tutto e di piu’, e il bus per Agra non c’e’. Pero’ in compenso posso prendere un pulmino che mi costera’ appena 78 volte il costo del bus, e in piu’ prenotare una camera a Udaipur che mi costera’ appena il triplo del suo prezzo – e cosi’ via. Me ne vado sbattendo la porta e fermo un riscio’ che mi porta a Kashmiri gate.
Quando sono alla stazione dei bus, dopo un po’ di ricerche scopro davvero che da li’ i bus per Agra non partono. Mi spiegano che devo prendere un bus e andare a un’altra stazione dei bus, a 9 km da li’.
Ci arrivo e mi metto a cercarla. Dopo 40 minuti di ricerca scopro che il mio posto era al punto di partenza, solo che non era una stazione, ma una semplice fermata. In compenso, come succede quasi sempre in questo paese, il bus per Agra passa immediatamente. In controcompenso, come succede sempre in questo paese, impiega 7 ore per fare i 200 km del percorso.
Sono 7 ore dotate di un certo fascino, in mezzo all’umanita’ debordante delle strade indiane – ma sono sempre sette ore. Anche ad Agra la mia coincidenza per Bharatpur arriva immediatamente, e in un’ora e mezza (verso le 9) sono a destinazione. Mi faccio portare da un riscio’, che mi lascia davanti alla mia guest house (dove non sono atteso) chiusa a chiave e silenziosa. E non c’e’ un campanello!
Ma sulla bibbia c’e’ il numero di telefono. E cosi’ riesco a farmi aprire, ed accogliere. La stanza e’ elementare, ma pulita, e costa meno della meta’ di quella di Delhi. Fuori c’e’ silenzio, il che, dopo tutto il rumore della giornata, e’ una cosa meravigliosa.
Vengo svegliato all’alba dal grido del pavone (che fosse del pavone l’ho imparato poco dopo). Mi alzo presto e alle 7.30 sono al parco, prendo una bicicletta e parto.
In effetti, il Keoladeo Park e’ un luogo affascinante. Ci ho visto non so quante specie di uccelli tra grandi e piccoli. Mi sono anche perso negli stradelli fangosi (qui c’e’ il monsone, e piove un po’), ma soprattutto sono riuscito persino a girare per mezz’ora senza incontrare nessuno; e in India questo non mi era mai successo!
Poi e’ finita. Sono tornato in camera.Ho pranzato. Ho dormito un po’. Poi sono uscito per andare in citta’ per trovare un Bancomat, un Internet point e un’agenzia che mi facesse un biglietto del treno. Ho trovato, a fatica, solo il primo – ma funziona. Ora so che non restero’ senza soldi!
La citta’ non era niente di che. Ho girato un po’, poi mi sono fatto portare a casa da un riscio’ a pedali.
Stamattina, sveglia alle 6. Colazione, poi bus station, dove c’era persino, pronto a partire, un bus de lux, con aria condizionata e veloce. Ci ha messo solo 3 ore e mezza per i 150 km da Bharatpur a qui. (se vi domandate perche’ i bus vadano cosi’ piano e’ perche’ non avete idea di cosa succeda sulle strade e autostrade indiane: veicoli contromano – anche in autostrada -, camion fermi a sostituire la gomma in corsia di sorpasso, e pure le mucche che dormono sull’asfalto – anche in autostrada).
Insomma, parco a parte, per adesso dell’India ho vissuto solo la parte rumorosa e puzzolente – con tutto il fascino che comunque ha. Ora vedremo cosa ha da offrire Jaipur. Certo, qui mancano del tutto i templi meravigliosi del Tamil Nadu. I templi qui sono di solito brutti e di cemento.
Ma staremo a vedere.
25 Luglio 2013 | Tags: diario d'India, India | Category: viaggi | È la sera prima della partenza. Domattina alle 10.20 aereo per Frankfurt e da lì Delhi. Poi, inizialmente, verso il Rajastan.
Per i primi 14 giorni sarò da solo. Poi tornerò a Delhi, il 9, a incontrare mio figlio Emiliano, che arriva dall’Australia e non vedo da un anno. Il giorno dopo andremo a Rishikesh a prendere Daniela, che è già partita stamattina, e starà là due settimane a fare yoga.
Questa anteprima è una dichiarazione d’intenti. Mi proverò a scrivere un blog di viaggio, approfittando di qualche Internet Point. Per adesso, più che altro è una scommessa. Al momento non potrei raccontare altro che l’ansia della partenza, quella cosa che, anche se tutto è pronto, la testa continua a frullare pensando a quale cosa fondamentale abbiamo dimenticato.
Per il momento basta. Faccio qualche piano di viaggio, e poi a letto presto.
 Nel tempio di notte Un po’ di India fa bene, ogni tanto. Qui, come è evidente dalla scritta, siamo in Tamil Nadu, esattamente qui.
Be’, indubbiamente, a fare la parte del leone, qui, sono i contrasti cromatici. I colori (data anche l’esposizione notturna) sono già così saturi che mi sono guardato bene dal caricarli ulteriormente. Un po’ per questi contrasti, un po’ per le luci comunque notturne, molti elementi di questa immagine sembrano quasi disegnati: i capitelli, il lungo fastigio con la divinità e il cartellone, persino i dettagli architettonici sulla sinistra.
Probabilmente è proprio questa ambivalenza tra realtà fotografica e irrealtà disegnata a dare fascino a questa foto, riflettendo visivamente la stessa ambivalenza sul piano narrativo: una tranquilla situazione di una calda sera indiana, in uno dei luoghi più sacri e mistici dell’India, il tempio di Annamalai, ovvero di Shiva, nella città di Tiruvannamalai, cioè la città di Shiva, ai piedi della collina di Arunachala, la Collina dell’Alba, che è Shiva in persona.
La presenza del dio terribile non sembra preoccupare molto i fedeli. Ma loro sanno di vivere in Shiva, e di esserne in qualche modo un avatar, proprio come lo è il tempio in cui si trovano e il mondo intero. Insomma, la realtà è disegnata, proprio come in questa immagine. È il velo di Maya a impedirci di distinguere le cose così come esse sono. Siamo tutti parte della lila, il gioco degli dei, insomma, il loro disegno – proprio come qui.
 Il cortile con le signore Questa foto è stata scattata da qualche parte qui, lungo la Bazaar road di Mattancherry. È una foto “rubata”, scattata quasi senza fermarmi davanti all’androne – ma la signora in rosso sembra avermi notato e stare gradendo che la si fotografi (a tutti, in Tamil Nadu piace essere fotografati, e lo dimostrano sempre con entusiasmo).
Una delle ragioni per cui mi piace questa foto è la sua allegria, incorniciata però dal nero dell’oscurità dell’androne, con quel mucchio di cose incerte lì sulla destra, e l’architrave sopra.
Persino le due signore hanno i colori dell’ambiente: quella giovane che ci guarda ha il colore dei gradini e del corrimano; quella anziana di spalle i colori dei muro di fondo e dell’acqua in basso.
A modo suo, anche questa è una foto geometrica, come spesso sono le mie. E l’India è il paese della matematica e delle astrazioni logiche. Però è incredibile quanta vita sporca e meravigliosa si annidi negli angoli di quel rigore.
 Ravi Shankar Per molto tempo Ravi Shankar è stato il mio principale, se non unico, accesso alla musica dell’India. Da quando ho iniziato ad ascoltarlo, l’ho sempre trovato appassionante, ed è tuttora così.
In seguito, però, ho scoperto un intero universo musicale, anzi due, che provengono dal suo paese, e ho imparato che Shankar non era solo nemmeno a qualità. Non mancano davvero i musicisti straordinari, in India.
A lui resta certamente il merito di aver appassionato l’Occidente a una musica così diversa dalla nostra (dalle nostre, tutti i generi compresi), diversa non solo nei timbri e nell’armonia, ma anche nelle modalità dell’ascolto – ed è questo l’aspetto più interessante.
La musica colta occidentale, in linea di massima, chiede un ascolto consapevole e attivo; chiede che si segua con la massima attenzione possibile il discorso che passa attraverso le note. La danza, la canzone, la cerimonia e la celebrazione che caratterizzano la musica popolare, e tutta la musica occidentale sino a qualche secolo fa, nelle musica colta degli ultimi secoli continuano a essere presenti come base del discorso, come riferimento implicito o esplicito; una sorta di mattoni da costruzione (ancora carichi del loro valore orfico, o rituale, e comunque collettivo) per un discorso emotivo/sensuale/intellettuale (l’accento su quale di questi elementi dipenderà dall’autore e dal periodo).
Anche se le sue basi sono orfiche, e continuano ad agire, la musica colta occidentale è in generale fatta per essere contemplata intellettualmente, come un discorso da persona a persona, come se Beethoven, Stockhausen, Coltrane o Hendrix, nel fare musica, stessero parlando a me (così come a ciascuno dei loro ascoltatori). Anche se il cosiddetto ascolto strutturale (di adorniana memoria) è più un mito che una realtà, si tratta però di un mito costitutivo: è raro che ascoltiamo davvero un brano di musica comprendendo pienamente l’evoluzione dei motivi, ma sappiamo benissimo che, idealmente, dovremmo fare così. Danzare mentalmente insieme con la musica non è affatto un’azione riprovevole, e va benissimo farlo, secondo me; però, limitarsi a questo vuol dire aver rinunciato a comprendere tutto il resto. Nella musica semplicemente da ballare, il resto non c’è (o quasi), e il discorso finisce più o meno lì; ma nella musica colta, di qualunque genere sia, è proprio il resto che fa la differenza.
La musica di Ravi Shankar, e in generale la musica indiana colta (nelle due tradizioni, indostana, del nord, e carnatica, del sud) chiede di essere ascoltata in un altro modo, io credo. Ho provato più volte ad ascoltare strutturalmente qualche esecuzione di raga. Qualcosa, indubbiamente, ne ho ricavato; però molto poco che giustificasse il piacere che quella musica mi stava donando. In questo, la differenza con l’ascolto, diciamo, di una sonata di Beethoven o anche di un pezzo di Miles Davis (che però credo che da Shankar alcune cose le abbia imparate), c’è: capire il senso di un passaggio beethoveniano mi dice sempre qualcosa anche sul piacere che mi dà.
A forza di provare, e cercare il modo giusto per ascoltare, mi sono fatto l’idea che la musica colta indiana richieda un approccio diverso, un ascolto diverso. L’accento non è, direi, sul discorso, bensì ugualmente sulla condivisione di qualcosa. Quando si balla, la musica costituisce il fattore condiviso, all’interno del quale chi si trova al momento dentro il flusso musicale si deve accordare. Ma l’accordo collettivo si risolve nell’atto del ballare, che è un atto pratico (con tutti i suoi rivolti simbolici, certo – ma essi dipendono più dal ballare che dalla musica). Quando Shankar suona, io mi sento indotto a cercare un accordo con lui (e con chiunque altro ascolti) proprio come nella danza, solo che la musica è molto più complessa di quella necessaria a danzare.
L’ascolto ideale dell’esecuzione di un raga – questa è l’idea che mi sono fatto – è una sorta di ascolto ipnotico, in cui io, insieme al musicista e a tutti gli altri ascoltatori (anche passati e futuri, se il brano è registrato) mi accordo non solo su un ritmo ma su un percorso di carattere emozionale di cui le note sono il tramite. Non sto dicendo che le note esprimono l’emozione del musicista; di questo mi interessa poco, in verità. Sto dicendo che il flusso di note è il medium attorno a cui io posso vivere un’esperienza emotiva complessa insieme con tutti coloro che stanno attorno a questa musica con me; una specie di danza intellettuale, che si sviluppa attraverso il tempo. Non che questo aspetto sia del tutto sconosciuto alla musica occidentale (né la musica indiana è del tutto priva della componente di discorso di cui sopra), ma in generale è piuttosto secondario – o relegato ai margini dell’ascolto.
Dovrei dire che, mentre la musica occidentale privilegia la componente di discorso, quella indiana privilegia la componente rituale – a parità di complessità potenziale. Magari sono io che proietto anche sulla musica le categorie con cui già interpreto l’India rispetto all’Occidente: meno io e più collettività, meno affermazione della distanza tra sé e sé, e più interpenetrazione tra gli individui. Magari l’India funge da schermo (come spesso è successo) per proiettare l’Occidente che non è e che si vorrebbe che fosse.
Ravi Shankar, primo tra tutti, è stato per me queste cose. Onore a Ravi Shankar.
4 Giugno 2011 | Tags: città invisibili, fotografia, India | Category: fotografia |  Il cimitero ebraico, lontano Ovunque tu sia, da qualche parte nella zona, qualunque sia la tua città invisibile, lì c’è un cimitero ebraico. Restiamo in tema cimiteriale, dopo la scorsa settimana – e anche qui, come là, nella foto c’è un interno, in basso, sovrastato dall’esterno, dietro, in alto. Un po’ diverso, senza dubbio, da quello della volta scorsa.
A Finale Emilia, dove sono nato, e poi ritornato per lunghi periodi da giovane, ce n’è uno bellissimo; come anche ad Ancona, in cima alla collina a strapiombo sul mare. Hanno sempre un’aria strana, misteriosa, come se insieme appartenessero e non appartenessero al luogo in cui sorgono.
Un fascino simile, tra i nostri, ce l’ha solo, un poco, il Cimitero degli Inglesi, quello che sta a Roma vicino alla Piramide; quello di Shelley, e delle ceneri di Gramsci, con tanto di spettro di Pasolini che si aggira. Ce l’ha forse, perché anche quello è un cimitero che a noi appare anormale, differente, stranamente fuori posto.
Questo specifico cimitero ebraico, qui nella foto, non avrebbe in sé niente di particolare. Sarebbe forse anche meno affascinante degli altri, se non fosse per il luogo in cui si trova, così lontano da essere sorprendente, e quindi anche sorprendentemente fuori luogo.
Sembra che gli ebrei siano arrivati qui ai primi del sedicesimo secolo, ma venivano da poco lontano (dove avevano litigato con il signore locale). Lì, però, ci abitavano già da oltre 1400 anni, cioè dall’epoca della diaspora. È questo che io continuo a trovare stupefacente: millequattrocento anni (e poi altri cinquecento) e sono ancora distinti, riconoscibili, differenti. Sono arrivati sin qui, in questo universo alieno, in questo altro mondo, e hanno continuato protervamente a essere loro.
Non mi stupisce che persino i loro cimiteri mi comunichino insieme familiarità e differenza. Provengono non solo da un altro luogo, ma anche da un altro tempo. E appaiono irreali anche quando ci sei dentro, li tocchi, li respiri.
 Il cielo a Tiruchirapalli Scrivendo il post indiano della scorsa settimana ho avuto una intuizione. Vuoi mai che questa mia ossessione per le foto dei luoghi dell’India non sia legata alla mia antica e mai sopita passione per un romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili, letto e riletto e amato al punto da aver provato più volte nella mia vita a scrivere le mie personali città invisibili? Vuoi mai che queste sono davvero le mie città invisibili, vale a dire quei luoghi che dispiegano in qualche modo il mio io nascosto, quelli che si raccontano a chi non c’è stato come luoghi favolosi, perché per noi lo sono, e lo sono profondamente?
 René Magritte - Empire of Light Se così fosse, un cielo non sarebbe meno informativo (cioè meno evocativo) dell’architettura sottostante. C’è molto più cielo che architettura umana in questa foto scattata nel Ranganathaswamy Temple a Tiruchirapalli, quasi come in un famoso dipinto di Magritte (a sua volta altra città invisibile, senza dubbio). Lo spazio verde dentro il mandapam in basso sembra appartenere a un mondo diverso dallo spazio bianco-azzurro del cielo.
Eppure, quando ho scattato questa foto, c’erano tutti e due, quegli spazi di fronte a me. E mi piacciono molto anche quelle due frecce bianche a sinistra, che rimandano ai luoghi circostanti, quelli che qui, inevitabilmente, non ci sono, non si vedono. Come al solito, le cose intriganti non sono quelle che ci sono davvero, ma quelle che sembrano poterci essere, sulla base di quelle che ci sono (e anche questo, con altre parole, avrebbe potuto scriverlo Calvino).
(P.S. Magritte, Calvino: non sono il primo a percepire un legame tra loro. Chi progettò nel 1972 la copertina de Le città invisibili vi inserì un altro dipinto di Magritte. O forse la mia evocazione di oggi è soltanto vittima di quella scelta di allora.)
 La vasca del loto d'oro nel grande tempio di Madurai Di questa foto, scattata all’interno del tempio di Meenakshi e Shiva a Madurai, posso dire che mi piace, per il gioco delle linee verticali e dei colori, per la prospettiva accennata e per quella colonna scura a sinistra. Ma soprattutto dovrei dire che se c’è un posto in cui mi piacerebbe ora andare e sedermi sui gradini e lasciar scorrere il tempo, è proprio questo – magari insieme alla fortunata turista intenta alla lettura in questa immagine.
Sembra di essere in una delle città invisibili sognate da Calvino, un luogo che non c’è, un luogo da leggere.
Eppure, stranamente, c’è.
 L'aquila dalla testa bianca di Aleppey Questa foto è stata presa da una barca, lungo i canali delle lagune di Aleppey, Kerala. Nel farla, volevo mettere in luce il contrasto tra il cartellone commerciale, forse di gusto un po’ retrò, ma indubbiamente contemporaneo, e l’atmosfera da bordi della giungla di tutto il resto – salvo il fatto che la ragazza del locale è tranquillamente seduta a leggere il giornale di oggi. Questo mix molto indiano di contemporaneità, quotidianità e misteri della giungla nera era così forte in me mentre scattavo la foto, che non avevo nemmeno visto il soggetto più interessante che stavo inquadrando, cioè la piccola aquila dalla testa bianca appollaiata sul palo, come fosse un pappagallo o una cornacchia.
L’ho scoperta in seguito, guardando la foto, come se si fosse materializzata soltanto allora. Probabilmente, in quel contesto così ricco di stimoli naturali, l’aquila era qualcosa di troppo normale per essere notata.
Ma insomma, eccola qui, a fare la guardia al negozio di Vishnu, di pesce fresco e noci di cocco tenere, tra la laguna e la giungla, tra il XXI secolo e l’eternità senza tempo (o di enormi ere ricorrenti all’infinito) del mito indiano. C’è da farsi strane domande su quello che noi chiamiamo progresso, e sul suo senso.
 Il bagno a Mamallapuram Questa foto è stata presa sulla spiaggia appena a nord di Mamallapuram, il 15 agosto, festa dell’Indipendenza dell’India. È così che le signore indiane prendono il bagno, un po’ perché l’oceano è troppo pericoloso per immergervicisi, un po’ perché le signore non si possono spogliare, giovani o vecchie che siano – o, almeno, non ne ho mai vista nessuna meno vestita di così.
Questa foto mi piace perché i vestiti colorati portano un’aria di festa a questo mare così grigio e grosso, e perché mi piace la composizione un po’ orizzontale, ma in verità incerta, e questa tensione verso sinistra creata dalla prospettiva e dagli sguardi. Non di tutte, però: le due signore in rosso sono troppo impegnate con la sabbia e con l’acqua. Ma sembra che stiano danzando, queste signore sedute. C’è una misteriosa coreografia, che organizza i loro gesti.
 Donna nel tempio Arunachaleswarar a Tiruvannamalai Siamo nel medesimo tempio che la scorsa settimana vedevamo in assurda assonometria dall’alto della Montagna dell’alba, a Tiruvannamalai. Ora, da dentro, la prospettiva centrale è tornata a riaffermare il suo impero. La donna al centro è verticale, così come verticale è il palo che la sovrasta, anch’esso al centro. Di fianco a lei la riga diagonale del bordo della cisterna (sormontato da una fila di statue del Toro Nandi), che viene ripresa dall’altra diagonale della parete del gopuram, la grande torre d’ingresso piramidale.
Attorno a queste linee centrali, questa foto è piena di verticali (pali, colonne, umani) e di orizzontali (i panni stesi, le ombre, e poi cornici, tetti, basamenti), e ancora altre diagonali (altre fughe prospettiche, l’altro gopuram a sinistra, le cupolette, le schiene dei tori). La donna e il palo che la sormonta dividono la foto in due metà verticali; la base del tempietto a sinistra e la sua prosecuzione nell’ombra prima e poi nel bordo della cisterna in fondo dividono la foto in due metà orizzontali. Abbiamo così quattro quadranti.
I due quadranti in basso sono semivuoti, specie quello a sinistra. Anche i due quadranti in alto si assomigliano, affollati entrambi nella parte inferiore e caratterizzati da una grande V in quella superiore (per il quadrante di destra valgono i fili della luce). I due quadranti a destra (inferiore e superiore) sono accomunati da quella diagonale che continua (prima prospettiva, poi parete della torre). I due quadranti a sinistra sono invece contrapposti: l’uno è il quadrante più affollato, l’altro il più spoglio, praticamente vuoto.
La testa della donna, con il suo fazzoletto azzurro, è al centro di questo meccanismo, ed è rivolta a sinistra, verso lo spazio vuoto, che diventa così, paradossalmente, il luogo più pieno, quello dove si può trovare qualcosa degno di interesse, ma che noi non vediamo. A questo punto non facciamo fatica invece a vedere (con gli occhi della mente) qualcosa come la rotazione di un grande orologio, le cui lancette (che focalizzano l’attenzione dello spettatore) incominciano la loro corsa sulle 9, a sinistra, e proseguono attraverso i tre quadranti successivi per concludersi in quello vuoto, insieme con lo sguardo della donna, che sta proprio nel perno della loro rotazione.
Sono quindi i colori del vestito di lei a dare senso visivo a questa foto, imponendo la prima verticale e il cuore della rotazione, da cui tutto il resto segue. Puro esprit de geométrie indiano, colto per caso dal fotografo. O esprit de finesse, se volete. Qualche volta c’est la même chose.
 Il tempio di Tiruvannamalai visto da Arunachala Sembra quasi un’assonometria, o prospettiva parallela, questa veduta del grande tempio Arunachaleswarar di Tiruvannamalai, presa dall’alto della montagna-che-è-Shiva Arunachala, la montagna dell’alba. Questa foto potrebbe essere il pendant di questa, presa da più in alto, nella direzione opposta, questa qui sopra tutta città, quella tutta campi.
Ma questa foto mi piace anche perché il tempio e la città sembrano come emergere dagli alberi, in questa posizione irreale – quasi che il mondo fosse in salita. E poi ancora perché, in questa foto, la confusione tipica dell’India rivela un’attenta costruzione razionale di fondo, proprio come mi era già capitato di osservare in quest’altro post.
Secondo me non è mica un caso che questo paese abbia inventato i nostri numeri e continui a sfornare grandi matematici (per non dire del software che utilizzamo, che è in larga misura scritto in India). Qui persino la religione ha a che fare con la logica: solo se ci si ferma alla superficie non se ne vede che l’effervescente (e affascinante) mitologia. Quando si scava sotto, si trovano pagine del Vedanta e dei suoi commentari che rivelano strane somiglianze con il teorema di Gödel e con i paradossi di Russell: fantastici apparati razionali che hanno come scopo di mostrare i limiti della razionalità.
 La rivincita del verde a Fort Kochin Non so se la foto è bella, ma il soggetto era davvero straordinario, e del tutto integrato nell’ambiente urbano/naturale di Fort Kochin, nel Kerala, in un viale di alberi giganteschi, nel bel mezzo di un paese immerso in una sorta di giungla addomesticata, eppure grande, grandissimo, praticamente una città.
Il camion abbandonato sulla pubblica strada, che da noi sarebbe presto additato a vergogna e rimosso, qui si trasforma naturalmente in una singolarissima e affascinante aiuola, del tutto in sintonia con l’ambiente circostante. Ancora un anno o due e poi della struttura metallica non si vedrà più niente.
Mi vengono in mente i racconti (inventati) di Guido Gozzano di fronte alle rovine di Goa ricoperte dalla giungla. Bellissimo e struggente, da un lato. Sottilmente inquietante dall’altro. È una natura amica questa, che si prende beffa della nostra superba tecnologia, oppure è un’amara metafora del destino della nostra civiltà?
 Mucca sulla spiaggia a Mamallapuram Questa mucca presa sulla spiaggia di Mamallapuram sembra davvero camminare sul profilo del mondo contro un cielo uniforme e grigio, o contro un muro di nebbia. La verità si può vedere nella foto qui sotto (da cui si capisce anche che ho barato un pochino).
Certo, quello non è il cielo, ma l’acqua di una pozza. Eppure il cielo vero non è meno grigio, e la mucca cammina lo stesso in una dimensione metafisica, sul profilo di una qualche terra, che si interrompe, per poi riprendere nella sua realtà un poco più in là, e infine perdere concretezza del tutto verso il fondo.
C’è un grande senso di quiete, non disturbato ma persino confermato dall’irruzione del quotidiano all’estrema sinistra, nel cartellone del ristorante e nell’asta diagonale del lampione. Tutto è orizzontale, e procede da sinistra verso destra (le barche amarrate, la mucca e il vitello in alto a destra, l’insegna del ristorante, persino le due barche in mare sullo sfondo), ma senza fretta. Pure l’orizzonte lievemente inclinato ci rimanda a destra.
La ruota delle cose gira, il mondo scorre. Noi lo osserviamo da turisti, seduti sotto la tettoia del ristorante. Dalla foto non si capisce, ma sta piovendo un’acqua finissima…
 Mucca sulla spiaggia a Mamallapuram
 Donne in rosso a Kanyakumari Kanyakumari, punta estrema sud dell’India, la punta dei tre mari. Questa foto mi piace per quel gruppo di donne in rosso (con l’uomo in bianco), vivace e mosso, e con un atteggiamento molto presente, che si staglia su questa geometria immobile o ricorsiva del mare sotto l’orizzonte, della terra con i suoi muretti merlati, del palo un po’ storto.
Ci sono due colori dominanti e immobili: l’azzurro del cielo-mare, l’ocra delle cose solide. Cielo e mare sono orizzontali; la terra è caratterizzata da questa lunga diagonale che va verso l’orizzonte, a metà della quale c’è il gruppo di persone.
Sono attive e ben presenti. Stanno certamente parlando tra loro. Ma l’atteggiamento prevalente è il guardare, guardare oltre il muretto, guardare nell’oceano. Quella macchia rossa e contrastata è ciò che crea un ponte tra la terra e il mare. Se non ci fossero loro sarebbe tutto vuoto – interessante lo stesso, magari, ma vuoto.
 Statua del Toro Nandi a Madurai Se, dalla posizione da cui è stata presa questa foto, ci si volta e si attraversa lo spazio mostrato da quest’altra foto, uscendo fuori dal Pudhu Mandapam, questo è quello che si vede. Questa grande statua coloratissima del Toro Nandi è ovviamente rivolta verso il tempio di Shiva che si trova, dopo il Pudhu Mandapam, alle mie spalle.
Il Toro Nandi è, per la tradizione shivaita, il proto-asceta, il primo adoratore di Shiva perso nella contemplazione del dio, nell’unione mistica dell’advaita. Eppure, come si può facilmente vedere da questa immagine, si tratta di una figura festosa, quasi allegra – specie se comparata all’immagine che tipicamente abbiamo in Occidente dell’ascesi mistica, fatta di santi emaciati se non flagellati in un contesto decisamente drammatico (anche se più che di santi dovremmo parlare di solito di santini, e il dramma è quello per noi ormai reso ridicolo da secoli di insulsa insistenza ecclesiastica sugli aspetti più spettacolari di qualcosa che dovrebbe piuttosto essere vissuto in maniera esclusivamente interiore).
Qui di drammatico mi pare che ci sia molto poco. Di questa foto a me piace il contrasto tra tre elementi così differenti: gli austeri cinquecenteschi propilei del tempio sullo sfondo, il coloratissimo asceta con la lingua fuori, e il traffico quotidiano circostante. Ciascuno di questi elementi, poi, ostenta da sé la propria specifica complessità. Siamo in India, insomma – e comprendiamo quel che possiamo.
 Risaie presso Aleppey Poiché la persona inquadrata nella foto sono io, e ancora non ho il dono dell’ubiquità (né amo gli autoscatti), è ovvio che questa foto non è stata scattata da me. Ci trovavamo poco lontano da Aleppey (o Alappuzha) nel Kerala. Avevamo preso una barca senza motore, per girare i canali in silenzio. A un certo punto il nostro conduttore ci ha proposto di fermarci per un te.
Siamo scesi, e non ci hanno messo di fronte a un tavolino, ma davanti a questa meravigliosa distesa di verde, come se fosse ovvio che eravamo capaci di apprezzarne la bellezza. Ma lo eravamo davvero, e quando il tè è arrivato ci ha fatto appena sorridere il fatto che i nostri ospiti si rendessero conto che non avevamo dove appoggiarlo. Si è rimediato con un’altra sedia.
Guardare davanti a noi era così coinvolgente che tutto il resto rimaneva in secondo piano. L’augurio da fare oggi, all’inizio dell’anno, sarebbe che guardare davanti a noi potesse essere ugualmente ispirante. Non viviamo nel paese giusto né nel periodo giusto, ma il primo dell’anno è fatto per illudersi felicemente.
Proprio come lo stare seduti su quella sedia.
 Cristo tra gli angeli a Shantivanam, Kulittalai Questa foto è stata presa presso il monastero camaldolese di Shantivanam, vicino a Kulittalai nel Tamil Nadu. Quel signore con tre teste al centro dell’immagine è Cristo, e quella davanti a lui è una croce. Alle spalle degli altrettanto cristianissimi angeli c’è invece un tempio, in classico stile tamil.
Il Cristo a tre teste non è un’immagine deviante della Trinità, ma semplicemente l’adeguamento a una consuetudine iconografica diffusa in India, dove spesso le divinità sono rappresentate con più teste, senza che questo debba implicare che le hanno per davvero.
Comunque, questo portale (è l’ingresso all’area della chiesa) dà bene l’idea del modo in cui i monaci di Shantivanam intendono il cristianesimo, anzi il cattolicesimo. Dal punto di vista della dottrina è un cattolicesimo sostanzialmente ortodosso, ma nel modo in cui si presenta, e persino nella liturgia, prende una serie di forme della tradizione religiosa induista, in modo da essere più accettabile per la popolazione locale.
Ho passato tre giorni a Shantivanam, in missione – diciamo così – antropologica, ma partecipando alla vita della comunità, liturgie comprese. Il luogo in cui si trova è incantevole, e sono stati giorni molto rilassanti e interessanti.
Devo dire, tuttavia, che, anche se i monaci camaldolesi meritano tutto il rispetto (perché sono camaldolesi, per la vicenda umana e spirituale che ha portato alla nascita di questo luogo, per la vita contemplativa che fanno e per il sostegno educativo e lavorativo che prestano alle popolazioni circostanti) questa isola di cattolicesimo camuffato mi sembra una sorta di piccolo tumore, con componenti benigne e maligne – ma comunque estraneo all’universo in cui si situa. È il prodotto di un sogno, fatto da alcuni Europei infatuati dell’India e del suo misticismo, che non hanno saputo rinunciare alla propria tradizione e hanno preferito cercare di impiantarla qui – per quanto riformata e adattata.
Con tutto l’onore che si può (si deve) tributare ai padri Henri Le Saux e Jules Monchanin, la sensazione oggi è che del loro sogno panreligioso non sia rimasta che questa piccola operazione imperialista cattolica, il cui fascino residuo sta anche nella sua impossibilità di crescere più di tanto. La spiritualità induista qui attorno sembra rigogliosa come la vegetazione che circonda il monastero. E magari qualche volta succede pure che chi si traveste finisce per diventare davvero quello che faceva finta di essere.
I dominatori inglesi consideravano l’induismo una forma di barbarie. Nel mio viaggio in India ho avuto spesso l’impressione, piuttosto, che i veri barbari siamo noi. Buon Natale.
 Indipendence Day tra i templi di Mamallapuram Questa foto è stata scattata a Mamallapuram il 15 agosto, Indipendence Day, nel parco archeologico dei Five Rathas, parte del complesso dei templi scolpiti, settimo secoli, i più antichi del Tamil Nadu (e tra i più antichi dell’India). Questi templi e le due sculture dell’elefante e del leone (proprio dietro l’elefante) sono realizzati ciascuno in un solo blocco di pietra, così come emergeva dal terreno. Non si possono quindi smontare: sono monoliti.
Mi piace, questa foto, perché tutti i turisti (meno uno) sono indiani, e tutti vestiti da festa, anche quello che ostenta, in primo piano a destra, soltanto un vezzoso straccio giallo. C’è una bella luce, una bella atmosfera di festa, un bello scorcio prospettico.
Forse avrei preferito visitare quel luogo in solitudine, di fronte a quelle antichità così struggenti. Ma anche questa festività era bella, ed era bene in sintonia con la luce del giorno.
Ovviamente, poco dopo, pure io mi sono fatto fotografare sotto la proboscide dell’elefante, magari senza eguagliare il fascino di quella bella ragazza indiana…
 Il Pudhu Mandapam a Madurai Questa foto è stata scattata a Madurai, nel Pudhu Mandapam, quello dei sarti, solo che questa è la navata centrale, chiusa da un cancello alle due estremità. Nel mezzo di quella confusione da mercato, con gli stimoli contraddittori delle merci in basso e delle decorazioni in pietra in alto, ma tutto fittissimo, affollatissimo sia sotto che sopra, si apre di colpo questa inaccessibile prospettiva, questo spazio enorme e vuoto, assolutamente favoloso.
Non c’è molto da aggiungere a quello che la foto dice da sola, perché proprio qui come là è impossibile andare oltre, camminare tra quei pilastri, sfiorare i pali di legno per impalcature appena smontate o sul punto di essere costruite. Il cuore del Pudhu Mandapam si rivela così, come una promessa di divinità impossibile da mantenere, ma anche da smentire.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
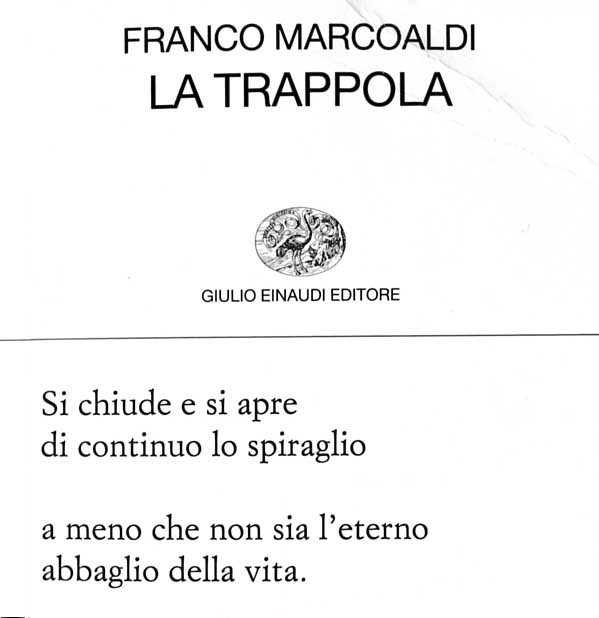










 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email







































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco
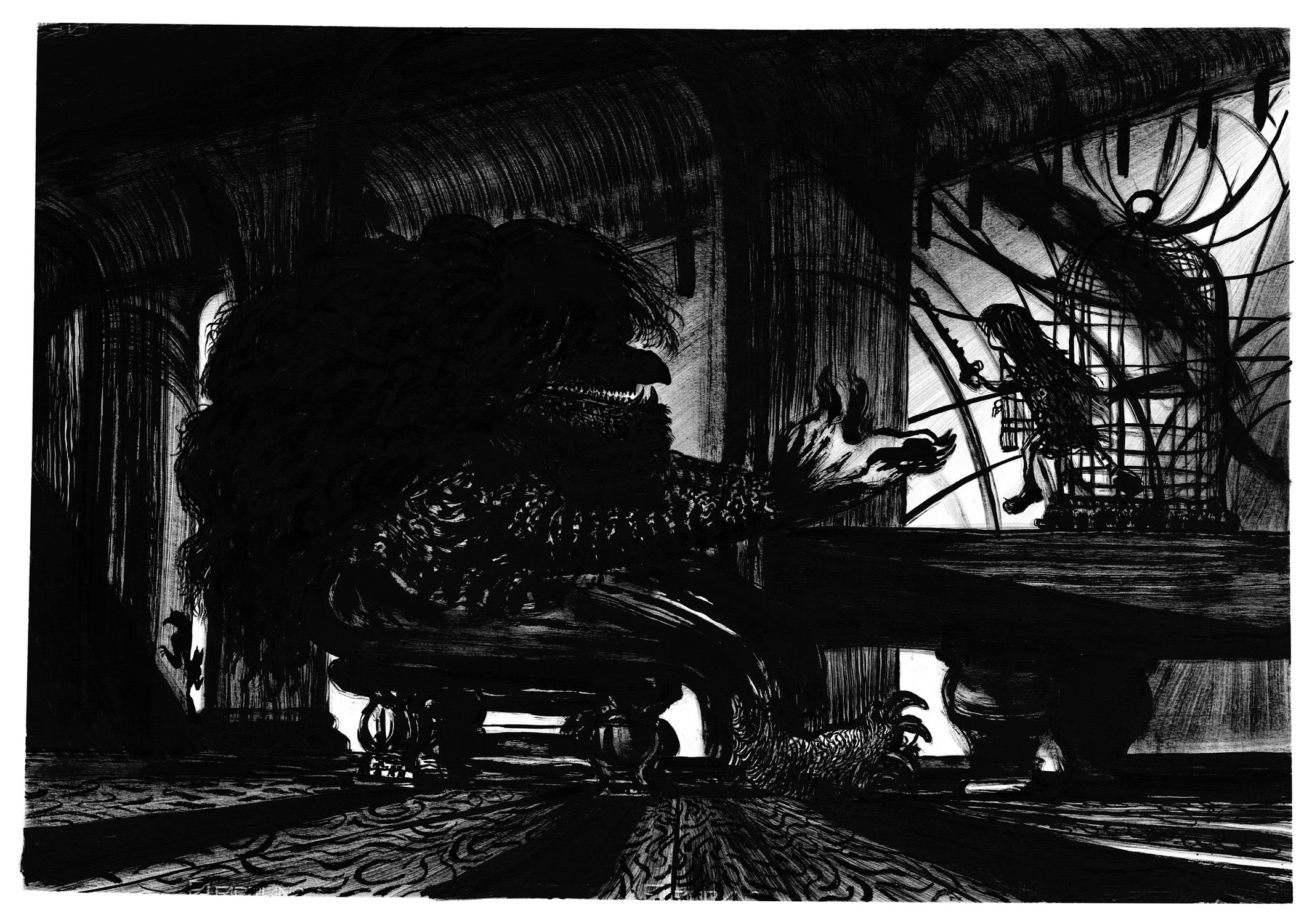








Commenti recenti