3 Giugno 2016 | Tags: fumetto, onomatopea, suono, Treccani | Category: fumetto |
Il suono delle cose del mondo nel fumetto
di Daniele Barbieri*
 Nel valutare le problematiche della comunicazione a fumetti, non si può separare l’eventuale valore fonosimbolico di un’espressione dal suo aspetto grafico. Nel narrare per immagini statiche, infatti, passa inevitabilmente attraverso questa dimensione anche qualsiasi evocazione di dimensioni diverse: di dinamismo, di odore, di gusto, di calore, e naturalmente di suono, che esso sia naturale o verbale. I suoni vengono di solito espressi verbalmente attraverso onomatopee, non necessariamente correnti nella lingua standard, ma possono virtualmente anche trovarsi rappresentati in maniera del tutto grafica. Nel valutare le problematiche della comunicazione a fumetti, non si può separare l’eventuale valore fonosimbolico di un’espressione dal suo aspetto grafico. Nel narrare per immagini statiche, infatti, passa inevitabilmente attraverso questa dimensione anche qualsiasi evocazione di dimensioni diverse: di dinamismo, di odore, di gusto, di calore, e naturalmente di suono, che esso sia naturale o verbale. I suoni vengono di solito espressi verbalmente attraverso onomatopee, non necessariamente correnti nella lingua standard, ma possono virtualmente anche trovarsi rappresentati in maniera del tutto grafica.
Enfasi grafica come indice di registro
Oggetti visivi in un contesto visivo di carattere rappresentativo/narrativo, i suoni visualizzati sono destinati a imporsi all’attenzione per il loro aspetto non mimetico di cose del mondo, mentre il contesto stesso ne giustifica narrativamente la presenza. A volte, l’evento rappresentato appare già così pregnante nella logica dei fatti raccontati, da evocare di per sé il suono o rumore che lo accompagna. Per questo talvolta nel fumetto la scrittura del sonoro può addirittura mancare del tutto, senza con questo produrre la sensazione di una scena muta. Quando – il più delle volte – il segno di rumore è presente, la sua caratterizzazione dipende in larga misura dal registro complessivo del testo: storie umoristiche o avventurosamente spettacolari tendono a enfatizzare graficamente i rumori molto di più di storie intimistiche o comunque basate sull’esplorazione della psicologia dei personaggi. La maggiore o minore enfasi grafica è infatti già di per sé un indice di registro.
Le deviazioni umoristiche e spettacolari
A questa enfasi si possono accompagnare termini onomatopeici divenuti standard nel fumetto oppure deviazioni più o meno accentuate e inventive, rese comunque comprensibili dal contesto, e in grado di portare lo stesso grado di efficacia di una metafora creativa – anch’essi eventualmente destinati a catacresizzarsi nel tempo in caso di successo e uso ripetuto. Anche qui, le deviazioni più consistenti dalla norma avverranno tipicamente nei contesti umoristici o avventurosamente spettacolari….
Segue qui, sul sito Treccani.
17 Maggio 2016 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto, Fumettologica | Category: fumetto |
In occasione dei 60 anni dalla nascita di Andrea Pazienza, che ricorrono il prossimo 23 maggio, Fumettologica dedicherà al fumettista una settimana di articoli, interviste, ricordi e approfondimenti. L’iniziativa si può seguire sui social tramite l’hashtag #pazweek.

Il principio è molto noto e teoricamente semplice: si chiama effetto di straniamento (in tedescoVerfremdungseffekt, in russo ostranenie). Si tratta di mostrare qualcosa attraverso procedimenti diversi dal solito, creando in questo modo un effetto come di alienazione, attraverso il quale è possibile vedere di nuovo quello che l’abitudine impediva ormai di vedere. Lo teorizzavano i formalisti russi; lo metteva in pratica Bertolt Brecht nel suo teatro. Tanto è semplice nella teoria quanto è maledettamente difficile in pratica realizzare uno straniamento che sia davvero tale e che non appaia posticcio, artificioso, creato a bella posta senza intima connessione con quello che mostra. Come dire che straniare male è tanto facile quanto è difficile straniare con efficacia: e la retorica se ne sta sempre in agguato, pronta a percorrere una di quelle mille strade attraverso cui è sempre capace di infilarsi.
Andrea Pazienza lo conosceva bene questo principio. Il DAMS degli anni Settanta rigurgitava di studi sul formalismo russo e sulle tecniche teatrali. Quegli stessi studi, nella loro pratica quotidiana, potevano essere oggetto di parodia, da parte sua, mentre lui utilizzava, magistralmente, i loro insegnamenti. Troppo intelligente per non capire, APaz si metteva nei panni degli studenti che non capivano, strizzava l’occhio ai compagni di percorso più in difficoltà di lui, ben consapevole che è la mediocrità a far ridere, specie quando messa di fronte a situazioni particolari ed estreme.
Queste situazioni potevano incarnarsi in un giovanotto scaltro e del tutto amorale, a nome Zanardi, nell’esame di Storia del cinema su Apocalipse Now, ma anche nelle ultime ore di vita di un tossicomane deciso a morire ma perso nelle vacuità del quotidiano. Solo che in Pompeo, Pazienza usa la medesima ricetta ribaltandone i termini, e invece di avere il comico come scopo finale, lo usa come strumento straniante per enfatizzare il tragico, la tragedia di una vita ridotta a non servire più a niente, talmente tragica nella sua insipienza da apparire persino ridicola, e in questa risibilità si trasmette un dramma ancora maggiore.

Addirittura già nel titolo, Gli ultimi giorni di Pompeo …
Segue qui, su Fumettologica.
9 Maggio 2016 | Tags: Carlos Sampayo, fumetto, José Muñoz | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 José Muñon, Carlo Sampayo, Nel Bar. Quelli che, pagina 1 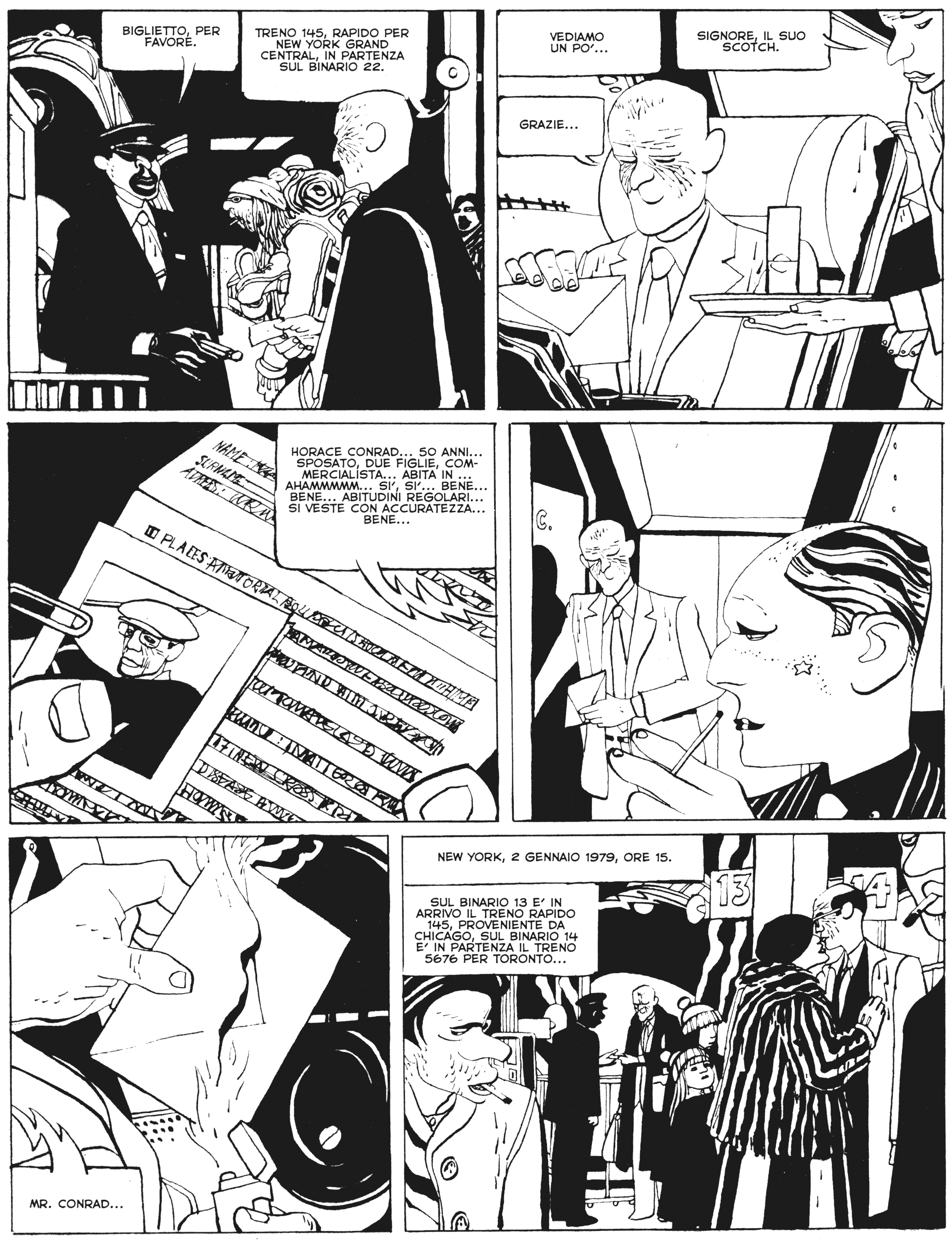 José Muñon, Carlo Sampayo, Nel Bar. Quelli che, pagina 2
Abbiamo aperto questa rubrica la volta scorsa analizzando Pratt, argentino acquisito. Stavolta voglio proseguire con l’unico allievo argentino di Pratt che abbia (forse) superato il maestro: José Muñoz, qui in collaborazione, come sempre, con Carlos Sampayo. E, si sa, il rapporto tra loro non è quello tra un semplice sceneggiatore che consegna una semplice sceneggiatura a un semplice disegnatore: piuttosto, Sampayo è il principale responsabile di una sceneggiatura a cui partecipa anche Muñoz, così come Muñoz è il principale responsabile di scelte grafiche a cui collabora anche Sampayo.
Quelle riprodotte qui sono le prime due pagine dell’episodio “Quelli che” (1979) di “Nel bar”, una serie in cui ogni episodio focalizza personaggi diversi, con storie diverse, messe in parallelo dalla frequentazione del medesimo Bar da Joe (quello di Alack Sinner, per capirci, e anche lui appare di quando in quando come comparsa).
Dedichiamo qualche parola, per cominciare, agli inchiostri di Muñoz. Attraverso Pratt, questo modo di usare il nero arriva a Muñoz direttamente da Caniff, con anche un comune amore (con il quale invece Pratt non ha relazione) per il continuo interscambio tra il realistico e il grottesco. Ma ci sono anche delle differenze importanti: intanto l’uso del grottesco in Caniff è leggero e muove al riso, mentre il grottesco di Muñoz è ancora più tragico e disperato del suo realismo. E poi, più tecnicamente, laddove in Caniff come in Pratt l’uso del pennello è espressivo e dinamizzante, mentre il pennino descrive e delinea le figure, qui al pennello è riservata la funzione di riempire delle aree già ben definite, mentre è il segno del pennino a creare insieme la forma delle figure e la loro espressività. Si potrebbe quasi dire che laddove in Caniff i personaggi e le scene possono assumere forme espressive o grottesche, in Muñoz espressività e grottesco sono parte dei personaggi, nel modo stesso in cui il pennino li delinea. Anche il pennello finisce quindi per avere una funzione semplicemente descrittiva, ma in più le grandi masse nere creano effetti complessivi di equilibrio plastico. Il dinamismo non è al centro dell’interesse di Muñoz, almeno non nel senso che gli possa interessare (di solito) creare effetti di movimento rapido. Se osservate nell’insieme le due tavole di cui stiamo parlando, vi accorgerete che l’effetto dinamico complessivo (che c’è, ed è anche forte) è creato piuttosto dalla varietà delle inquadrature e delle pose (piuttosto statiche) dei personaggi, e che in questo le campiture nere hanno un ruolo importante.
Questa prevalenza del pennino, con l’uso piatto del pennello, e questa varietà di inquadrature particolari (un riferimento cinematografico obbligato qui è il Citizen Kane di Orson Welles), fanno sì che le immagini non siano di facile lettura. Ci sono molte linee, e l’assenza di mezze tinte chiede all’occhio un lavoro notevole per interpretare le immagini. Guardate la primissima vignetta e fate un esame di coscienza: avete davvero capito subito che cosa rappresenta? Oppure magari solo guardando la seconda vignetta vi è stato chiaro che cosa raffigura la prima?
In un fumetto più tradizionale si tratterebbe di un errore: troppa attenzione richiesta per ciascuna immagine, quindi un ritmo di lettura lento, con, come conseguenza, una probabile lentezza ritmica complessiva del racconto; una storia pesante, troppo impegnativa… Be’, che il lavoro di Muñoz e Sampayo sia impegnativo, è fuori discussione; ma qui la lentezza ritmica è programmata: il lettore deve leggere piano, soffermarsi a lungo su ogni vignetta, perché il racconto non deve correre, e non correndo mostra che quello che si sta raccontando non è soltanto una storia, bensì un insieme di storie intrecciate nella grande città, tra le quali la nostra è solo (quasi casualmente) quella maggiormente focalizzata.
Ed ecco quindi che, quasi a complicare ulteriormente la situazione, e mentre ancora si sta introducendo il personaggio principale e il suo ruolo, appaiono altri personaggi che sembrano non avere (e di fatto non hanno) nessun ruolo narrativo: la signora col cane della quarta vignetta, il tassista della quinta, l’hippie con lo zaino sul fondo della prima vignetta della seconda pagina, l’effeminato della quarta, i tanti personaggi della sesta. La storia principale si snoda attraverso tutte le altre storie che la toccano tangenzialmente, che il testo non racconta, ma vi fa allusione. E in questo modo, tra l’altro, proprio il Mr. Conrad oggetto del lavoro di Wilcox compare senza che ce ne rendiamo conto. Lo capiremo solo un paio di pagine più avanti, quando, accompagnando moglie e figlie alla stazione, Conrad si ritroverà inquadrato sul fondo, mentre in primo piano ci sarà di nuovo Wilcox di fronte al controllore, ma in veste di comparsa, adesso.
È così che Muñoz e Sampayo costruiscono la sensazione di due storie parallele che casualmente si incrociano tra le mille storie parallele che si sfiorano soltanto (e il Bar da Joe è chiaramente la metafora di questo avvicinarsi più o meno determinante tra percorsi diversi).
Se ora leggete la sequenza, vi accorgerete che questo è esattamente l’effetto a cui mira la sceneggiatura di Sampayo: una serie di fatti quasi casuali, attraverso cui si snoda l’unica serie di eventi con una qualche coerenza narrativa. Ma anche che Wilcox debba aver a che fare proprio con Conrad è un fatto quasi casuale. La messa a fuoco sulla storia che sta per essere raccontata è lenta e progressiva, proprio come la messa a fuoco sulle singole immagini di Muñoz.
(altre osservazioni su queste tavole si possono trovare in un post del mio blog: www.guardareleggere.net/wordpress/2013/01/28/)

25 anni di Linguaggi del fumetto
Giornata di studi sullo stato della critica fumettistica
a 25 anni dalla pubblicazione de
I linguaggi del fumetto di Daniele Barbieri
Con Daniele Barbieri, Sergio Brancato, Antonio Faeti,
Alberto Sebastiani, Matteo Stefanelli.
Conduce Enrico Fornaroli
Accademia di Belle Arti di Bologna
via Belle Arti 54, 40126 Bologna
12 maggio 2016, Aula Magna, ore 15.00
Per scaricare una versione in PDF di qualità stampa (34Mb) per A4 clicca qui.
Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 HugoPratt, Una ballata del mare salato, tavola di apertura Per inaugurare questa rubrica ho scelto il classico dei classici: quella che avete qui a fianco è la pagina di apertura di Una ballata del mare salato, così come appare sul numero 1 della rivista Sgt. Kirk, diretta e realizzata dal medesimo Hugo Pratt a partire dal 1967. Nelle ristampe successive del capolavoro di Pratt, qualche volta il ritocco si è limitato al lettering (e questo è perdonabile), mentre in altri casi, per adattare la storia a un formato più ridotto, si sono stravolte le proporzioni delle singole immagini e in qualche caso persino la sequenza (e questo è molto meno perdonabile).
Prima di proseguire la lettura delle mie parole, leggetevi e osservate con attenzione, nell’insieme e nei dettagli, la pagina di Pratt.
Penso che già a prima vista possa essere evidente come un’organizzazione diversa delle vignette sulla pagina, che spostasse sulla pagina successiva, per esempio, le vignette dalla quarta in poi, comprometterebbe l’effetto di suspense costruito qui dall’autore, che fa comparire di spalle il primo personaggio presumibilmente importante proprio nell’ultima vignetta, lasciando la sua rivelazione a quello che succederà dopo il cambio pagina. Si sa: l’atto stesso di voltare una pagina richiede un tempo maggiore che quello di passare da una vignetta alla successiva; e, inoltre, mentre sulle vignette che stanno sulla medesima pagina l’occhio ha già trasvolato, pur senza fermarsi nel dettaglio, quelle che stanno di là sono del tutto sconosciute…
Visto che, a questo punto, avete osservato e letto con attenzione la pagina di Pratt, vi sarete accorti che, proprio come colui che parla in prima persona nella lunga didascalia iniziale è il mare (il mare salato del titolo), anche il punto di vista, fortemente ribassato, da cui è inquadrata la prima vignetta, è di nuovo quello del mare. Guardate dove si posiziona l’orizzonte, nei limiti di quello che permettono le oscillazioni delle onde: è all’altezza della carena del catamarano, proprio sul pelo dell’acqua.
All’apertura della storia, noi, spettatori, siamo lì, sulla cresta dell’onda, così vicini che l’immagine del catamarano arriva persino a sfondare, a sinistra e in alto, i limiti del campo visivo. Sembra quasi di toccarlo, questo naviglio.
E poi, osservate bene: le curve convergenti delle due chiglie in basso e della vela in alto creano come un vettore, un puntatore, una freccia, che rimanda il nostro sguardo nella stessa direzione in cui puntano gli sguardi e le mani dei marinai. È solo adesso infatti che, a fatica, riconosciamo che c’è in scena un’altra barca, ma assai meno gloriosa della prima: mentre il catamarano si libra audacemente proprio in cima alla cresta della grande onda, quasi messo in volo dalla vela spiegata, la barchetta laggiù aderisce al fianco dell’altra onda, e la sua vela è stracciata o ammainata, e non c’è alcun dubbio sul fatto che si tratti di un relitto.
Ora guardate la distribuzione ritmica dei marinai e dei loro balloon da sinistra verso destra, e da vicino verso lontano: la barchetta occupa il posto successivo di quella stessa ripetizione, ma è passiva quanto loro sono attivi, dominata dal mare quanto loro lo sanno dominare. Basterebbe quel fantastico insieme di macchie bianche e nere che definisce il riflesso delle onde sotto la chiglia a mostrare come il catamarano è parte stessa del mare, lo vive e lo partecipa.
Dopo la grande immagine iniziale, ecco che le vignette si fanno piccole e più distesamente narrative. Osservate ora le inquadrature: la seconda vignetta prende sì i due marinai in primo piano, ma li vede ancora dal basso, e dal basso viene vista anche la terza inquadratura. Insomma, lo sguardo sta continuando a essere quello del mare.
Solo con la quarta vignetta le cose cambiano. Ora il punto di vista è dall’interno della barca, e vediamo quello che il marinaio stesso aveva visto sino a un attimo prima di voltarsi. Nelle due vignette successive, il punto di vista torna ancora a spostarsi, per diventare sempre più interno alla barca, ed è sempre simile a quello che avrebbe uno dei personaggi inquadrati.
È come una corsa all’indietro, per arrivare, alla fine, allo sguardo più importante, quello del capitano, del quale possiamo vedere, al momento, solo la nuca e il libro che ha davanti. Il testimone dello sguardo è passato, attraverso le vignette, dal mare ai marinai (gli abili marinai delle isole Figi) e infine al capitano Rasputin (uno che sa il fatto suo, sul mare): sono, loro, gli unici che hanno superato la tempesta, hanno controllato l’oceano Pacifico, e sono un po’ mare anche loro.
Sappiamo come prosegue la storia: Corto Maltese sarà anche lui consegnato dal mare un paio di pagine più in là, e il mare continuerà a essere protagonista diretto e indiretto del racconto sino alla fine. Ma fin da questa prima pagina, Pratt ci ha già buttati dentro di lui. Stiamo già nuotando, nelle onde come nella storia, sballonzolati dal destino, in un romanzo indimenticabile.
Corte Sconta detta Arcana: anatomia di un’incoerenza funzionale
Ovvero come accade che una storia troppo piena di coincidenze per essere davvero credibile sia lo stesso un racconto avvincente e memorabile
Daniele Barbieri
Corto Maltese in Siberia: Anatomy of a Functional Incoherence. A critical reading of CMiS reveals a general weakness in the narrative coherence of the text: too many casual events, playing a crucial role in the development of the story, like if a deus-ex-machina were actually arranging anything. Nonetheless, the reader that approaches CMiS for the first time generally does not feel any sense of artificiality, and even when realizing the weakness of the narrative mechanism the critical reader too can go on and appreciate the quality of Pratt’s work. What, then, does hide or make this weakness scarcely relevant in the general economy of CMiS? This paper argues for looking at Pratt’s text as a sort of (visual) narrative fresco, transforming main narration in just a thin string to collect a sequence of epic and human portraits, each of them suggesting its own semi-mythological narration: and in this the fascination of this text is grounded, much more than in having the protagonist gaining his goal.
Keywords: Hugo Pratt, Corto Maltese, narration, comics, coherence, epics
Lessi originariamente Corte Sconta detta Arcana in parte a puntate su Linus e in parte nell’edizione originale in volume, la quale uscì mentre la pubblicazione sulla rivista era ancora in corso. Ricordo ancora bene la fascinazione profonda che questa lettura mi procurò e la sensazione di essere di fronte alla migliore storia mai realizzata da Pratt. Col senno di poi, un po’ svaniti gli effetti di quell’innamoramento, mi ritrovo ancora a preferire Una ballata del mare salato; e tuttavia non ho mai smesso di considerare Corte Sconta un’opera affascinante, favolosa, una sorta di turbine in cui si entra trovandosi trasportati pagina dopo pagina sino alla fine.
Parecchi anni dopo (ma ancora diversi anni fa) Corte Sconta mi è ricapitata in mano, e l’ho riletta. Il fascino dell’opera di Pratt persisteva, ma poiché si trattava di una seconda (o, in verità, ennesima) lettura, il lettore (io) era più distaccato e più attento agli aspetti strutturali. Proprio per questo, finiva per saltare agli occhi qualcosa che si sarebbe potuto osservare anche prima, probabilmente, ma che aveva finito in verità per essere occultato da altro.
In altre parole, da un punto di vista strettamente narrativo, nei termini di struttura generale, secondo quello che dovrebbe idealmente essere un buon racconto, un racconto coerente, ben sviluppato, plausibile, in questi termini Corte Sconta non funziona, appare posticcia, artificiosa, sostanzialmente incoerente. Insomma, avrei dovuto buttarla via, o etichettarla come un disastro.
E invece mi accorgevo che il trovarmi di fronte a un’opera formalmente sbagliata ma sostanzialmente riuscitissima mi poneva un problema davvero interessante, la cui stessa esistenza aggiungeva ulteriore valore al lavoro di Pratt. Insomma, come è possibile che un’opera così formalmente sbagliata funzioni in realtà benissimo? e come mai il lettore normale (come me stesso durante le mie precedenti letture) non se ne accorge? che cosa glielo nasconde? e che cosa invece viene apprezzato a tal punto da compensare quelle deficienze? oppure, non sarà magari che quelle deficienze in realtà non esistono, e il problema non sta nell’opera di Pratt bensì nella teoria che vorrebbe valutarla?
L’occasione di questo scritto mi dà finalmente l’opportunità per rileggere Corte Sconta, e per cercare di dare risposta a queste domande.
L’articolo nella sua interezza si trova qui, su H-ermes. Journal of Communication.

Ho passato un po’ di tempo a riguardarmi i frontespizi di The Spirit (ce n’è, per esempio, una vasta collezione online qui, ordinati dalla fine, 1952, verso l’inizio, 1940), lasciandomi andare alle libere associazioni di un antico lettore di fumetti. Il risultato è almeno in parte documentato dalle immagini a corredo di questo articolo.
Ce n’è un primo gruppetto in cui affianco un frontespizio del 1940 a una tavola di Sergio Toppi del 1980. Non c’è bisogno di sottolineare le differenze, che saltano all’occhio. È invece interessante osservare che Will Eisner (e siamo a pochi mesi dall’apertura della serie) introduce una tecnica che permette la composizione sequenziale della tavola secondo una logica che non è quella canonica delle vignette: nello specifico, la lettura della didascalia sotto la testata introduce al titolo The Spirit, il quale si collega, attraverso il braccio levato che afferra l’ultima lettera, alla ragazza bionda, il cui sguardo conduce allo scimmione vestito in primo piano, che si appoggia sul piano di una banchina che è lo stesso su cui agiscono i due personaggi con cui inizia davvero il racconto, all’interno di una quasi-vignetta, i cui limiti vengono suggeriti da quelli della situazione narrativa e da quelli del rettangolo della dida che la sovrasta.
Analogamente, nella pagina di Toppi la direzione alto-basso e varie linee che costituiscono altrettanti impliciti vettori conducono la lettura.

C’è un secondo gruppetto, in cui affianco due frontespizi del 1947 e ’48 a due tavole rispettivamente di Gianni De Luca e di Frank Miller. Qui la tecnica è leggermente diversa: c’è un quadro spaziale generale, sopra il quale le medesime figure ricorrono più volte, senza che possano sorgere dubbi sul fatto che non sono compresenze di personaggi diversi, bensì ripetizioni dei medesimi. Sappiamo l’uso straordinario che ha fatto De Luca di questa tecnica nella sua trilogia shakespeariana del 1976, ed è suggestivo riflettere sul fatto che la rivista Eureka inizia a pubblicare regolarmente The Spirit in Italia nel 1969.
Guarda caso gli esperimenti sia di Toppi che di De Luca iniziano qualche anno dopo. E questo lascia anche capire come non ci sia bisogno di scomodare davvero De Luca per individuare l’ispirazione dell’uso di questa tecnica da parte di Miller nel 1990…
Prosegue qui, su Lo Spazio Bianco
Sappiamo un po’ tutti come è andata. Negli anni Settanta Will Eisner torna al fumetto narrativo (dopovent’anni di fumetto didattico per l’esercito americano), e dopo aver tergiversato un po’ con cose varie, capisce che affinché il fumetto possa conquistare pubblicamente la dignità culturale che si merita deve cambiare i suoi formati di pubblicazione, o almeno acquisirne altri, o meglio, un altro: il formato libro. E libro vuol dire romanzo; e quindi romanzo a fumetti, graphic novel.
In Europa si faceva già, in Francia da ben quarant’anni; e questo, almeno in Francia, aveva davvero contribuito a migliorare la pubblica considerazione del fumetto. In Italia, si faceva molto meno, e restava un bel po’ di strada da fare, dal punto di vista della pubblica considerazione, Ma il rinnovamento intellettuale del fumetto aveva già almeno un decennio anche qui, a partire dalla nascita di Linus. In ogni caso, Eisner aveva ragione, e il tempo gliel’ha riconosciuta. Se oggi in Italia ci sono recensioni a proposito di graphic novel su giornali e riviste che mai prima si sarebbero sognate di pubblicare recensioni su fumetti, lo dobbiamo anche alla sua invenzione (oltre che alla qualità delle opere con cui l’ha in seguito sostenuta).
Riconosciuto questo, e assumendo la riconosciuta pubblica dignità intellettuale che il fumetto si meritava, è arrivato il momento di porsi un’altra domanda, che riguardi non le strategie di successo nel contesto culturale alto, ma il guadagno effettivo di qualità che il fumetto avrebbe ricevuto dall’invenzione dellagraphic novel. In altre parole, il romanzo fa davvero bene al fumetto?
Qualche vantaggio, indubbiamente c’è, rispetto alla narrativa seriale, ovvero una certa maggiore libertà degli autori, e soprattutto (ma non necessariamente) una minore stringenza delle consegne, che permette un lavoro più approfondito. Anche per questo (ma non solo per questo) abbiamo avuto anchegraphic novel straordinarie, degne dei premi letterari che talvolta hanno vinto e talaltra ci sono andate vicino – insieme a tanta fuffa, il che è normale e in sé non depone né pro né contro. E però ci sono stati (ci sono) prodotti seriali che, a dispetto della loro maggiore difficoltà di produzione, sarebbero altrettanto degni di vincere quei medesimi premi, ma non possono partecipare perché non sono romanzi. Pensate al lavoro di Pratt, in generale. Oppure io penso al Kozure Okami (Lone Wolf and Cub) di Koike e Kojima, di cui mi sono riletto questa estate i 142 episodi (in vacanza, su iPad) facendo fatica a sospendere la lettura, e riattaccandola ogni volta che potevo.

Il punto è che per noi, oggi, in Occidente, dire racconto di qualità vuol dire romanzo, ovvero un racconto di una certa durata e struttura, dotato di una certa unitarietà, ovvero avente al centro una qualche vicenda che si sviluppa e arriva a conclusione, pur potendo articolarsi in sottovicende, e pur potendo divagare in vicende secondarie ma collegate. Questa idea di racconto è per noi così forte da articolare anche il film. Ma nel film lavora anche qualcos’altro…
Prosegue su Fumettologica, qui.
23 Settembre 2015 | Tags: fumetto, Will Eisner | Category: fumetto |
Giovedì 24 settembre sarò a S.Marino a parlare a un convegno sull’uso didattico dei fumetti nell’educazione sanitaria. Ci saranno con me Otto Gabos e Sara Colaone, che sul tema diranno di sicuro cose più strettamente pertinenti di me. Io ho pensato di cogliere l’occasione per studiarmi un poco una serie didascalica un po’ particolare, ovvero quella che Will Eisner realizzò per l’esercito americano dal 1951 al 1971, curando nel suo complesso una rivista che forniva istruzioni per la manutenzione dei veicoli e di altri apparati di uso bellico. Evidentemente il tema non è direttamente pertinente, ma si tratta comunque di una lunghissima serie di fumetti didascalici (fumetti didattici), realizzati da uno dei maggiori maestri dell’arte.
I presupposti sono (più o meno) noti. Will Eisner vive una giovinezza produttiva folgorante, creando a 23 anni (dopo un sacco di altre serie minori) uno dei capisaldi della storia del fumetto, The Spirit, 1940. Lo realizza per 12 anni, poi nel 1952 chiude lo studio e cambia mestiere. Ritorna a fare fumetti negli anni Settanta, quando è già una sorta di mito, grazie anche alle numerose ristampe del suo lavoro degli anni Quaranta. Fa un po’ di fumetti umoristici sparsi, e poi decide che non è quello che gli interessa, e che il fumetto, specie il suo, ha bisogno di una dignità culturale che solo la pubblicazione in forma di libro gli può fornire. E così, nel 1978, pubblica la prima graphic novel, A Contract With God, and Other Tenement Stories, aprendo la strada a un formato che cambierà la storia del fumetto, e a cui contribuirà lui stesso con ben 20 opere, sino alla morte, nel 2005.
Tra questi due periodi di grande fama si stende un ventennio del quale, sino a qualche anno fa, non si sapeva nulla. Poi, nel 2011, c’è stato il volume curato da Eddie Campbell, PS Magazine. The Best of the Preventive Maintenance Monthly (New York, Abrams) (in italiano PS magazine. Il meglio del mensile di manutenzione preventiva, Bao) che ha permesso di leggere una bella scelta di quello che Eisner ha prodotto tra il 1951 e il ’71 (praticamente tutto PS Magazine può essere comunque sfogliato qui).

La storia, da quel che ho capito, è dunque questa. A partire dal 1949 Eisner aveva affiancato allo studio che produceva The Spirit un secondo studio, per realizzare comics sostanzialmente per la pubblicità e cose simili. E’ nella sua veste di responsabile di questo secondo studio…
Prosegue qui, su Fumettologica.
11 Marzo 2015 | Tags: fumetto, Fumettologica, Linus | Category: fumetto |
Ho partecipato l’altro giorno, a Milano, a un incontro per celebrare 50 anni di Linus, il cui numero 1 uscirà il 1 aprile del 1965. Poiché Umberto Eco e Bruno Cavallone hanno raccontato la loro esperienza di co-responsabili della rivista creata dall’amico Giovanni Gandini, io ho scelto di portare piuttosto la mia testimonianza di lettore.
Quando il primo numero di Linus apparve in edicola io avevo 8 anni; troppo pochi per esserne un lettore della prima ora. Però avevo un maestro elementare, Antonio Faeti, che già pochi mesi dopo ce ne parlava con entusiasmo, e ci spingeva a leggerla. La rivista costava troppo per le problematiche finanze della mia famiglia, e riuscii solo, qualche anno dopo, ad acquisire fortunosamente un paio di supplementi. Ricordo ancora con emozione un paio di storie lette su quelle pagine: un episodio del Jeff Hawke di Sidney Jordan, intitolato “Il biscazziere”, e una “Favola slobboviana” dal Li’l Abner di Al Capp. Potrei ancora raccontarle a memoria (ma non varrebbe come prova: le ho rilette, in seguito, un sacco di volte!).

Un po’ più grandicello comperavo Eureka!, la rivista di Secchi/Bunker, che non era priva di qualità, pur essendo – vista da oggi – evidentemente un’imitazione. Linus si era fatta la fama di una rivista più intellettuale e un po’ spocchiosa, e forse c’era anche un po’ di timore adolescenziale nell’avvicinarsi all’originale di quel mito di cui, su Eureka!, gli echi arrivavano sufficientemente attutiti. Qualche anno dopo ancora ero invece già un frequentatore compulsivo di bancarelle, con la mia brava mancolista, per rifarmi della collezione mancante, progressivamente ricostruita, numero per numero, dalle origini al presente.
La mia storia di lettore di Linus non è solo un fatto personale…
Continua su Fumettologica, qui.
12 Febbraio 2015 | Tags: fumetto, Fumettologica, storiografia | Category: fumetto | 
Sto terminando il mio primo corso di Storia del fumetto, all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Quello che più mi è costato fatica è stato raccogliere le immagini da mostrare. Per fortuna e per disgrazia esiste il Web. Per fortuna, perché rispetto ai tempi per scansionare dalla carta quelli del rinvenimento sul Web sono molto minori. Per disgrazia, perché per questa medesima ragione si è facilmente colti da una sorta di bulimia, e le immagini sembrano non bastare mai.
In effetti non bastano mai. Anche se a lezione su moltissime sorvoli, poi ti raccomandi con gli studenti (a cui le immagini vengono poi fatte avere) di guardarle tutte con attenzione. Non si impara la storia del fumetto senza guardare innumerevoli figure. In verità bisognerebbe leggere innumerevoli storie, e con questo guardarne ovviamente anche le figure. Però più di tanto agli studenti del primo anno non si può chiedere, e andrebbe già bene se si leggessero un po’ di storie (qua e là sono riuscito a metterne di intere, o grossi stralci), riuscendo comunque a riconoscere gli stili grafici, almeno per epoca e paese.
In sostanza, è stata una sfacchinata. Alla fine sono più di seimilacinquecento immagini. Ma è stata anche un’avventura visiva e un grande ripasso: per ogni immagine, ogni volta che potevo, ho cercato l’anno e il titolo della serie o della storia – oltre agli autori, ovviamente. Preso dalla verve storiografica, mi sono trovato anche a riflettere sul senso del fare storia del fumetto – non solo per insegnarla a un primo anno di Accademia, ma in generale…
Continua qui, su Fumettologica.
Aggiungo qualcosa alle mie riflessioni di mercoledì su Charlie Hebdo. Quando ho scritto quelle righe non avevo ancora visto questa copertina:

Che cos’è che fa ridere qui? Un lettore medio occidentale non può non cogliere il riferimento a un luogo comune di film e racconti specialmente western, quella Bibbia portata nel taschino che intercetta la pallottola diretta al cuore del protagonista salvandogli la vita (il luogo comune di cui Woody Allen fa la parodia dicendo, più o meno, “portavo sempre una pallottola nel taschino; un giorno uno mi ha tirato una bibbia, e la pallottola mi ha salvato la vita”). Se si capisce il riferimento, si ride perché si capisce che il vero obiettivo satirico di questa vignetta non è il Corano, bensì la presunzione di salvezza da parte dei libri sacri, e della Bibbia in particolare. Si tratta, insomma, di una vignetta anticristiana, non antimusulmana, mostrando, parodisticamente, la Bibbia come superiore al Corano, un libro sacro che nemmeno ferma le pallottole.
Ma per un arabo che non conosca questo riferimento, né sia particolarmente interessato alle questioni interne della cultura occidentale, questa vignetta dice tutt’altro, e non fa nemmeno particolarmente ridere…
Continua qui, su Fumettologica.
Nell’indignazione e nell’emozione che hanno colpito me come tutti, dopo i fatti della scorsa settimana, c’è qualcosa che continua a non quadrarmi, qualcosa di fuori posto nella messa a fuoco degli eventi.
Non sono le pacchianerie macroscopiche e vergognose: le strumentalizzazioni, si sa, ci sono sempre; sono irritanti, anche molto, specie per la loro pretestuosità. Ma fanno parte del gioco. Come l’annuncio visto di passaggio di un programma con dibattito televisivo, in cui il giornalista annunciava il tema “È scontro di religioni?”. Scontro di religioni!? Come se quelli di Charlie Hebdo fossero cristiani che prendevano in giro dei musulmani, o come se i terroristi che li hanno fatti fuori intendessero colpire il cristianesimo – quando sappiamo benissimo che tra gli obiettivi polemici di Charb & company c’era semmai proprio la religione in quanto tale, e quindi l’Islam, certo, ma non meno e non più del cristianesimo o dell’ebraismo.

Non è nemmeno la definizione in termini assoluti del nemico a non quadrarmi: i fondamentalisti islamici. Sì, certo, la manovalanza del terrorismo sono loro: questo sembra fuori discussione. Ma è così facile e così comodo influenzare dei massimalisti, infiltrando qualcuno che suggerisce gli obiettivi, scalda gli animi e fornisce strumenti logistici e armi, che sospettare un controllo da parte di servizi segreti (americani?, israeliani?, europei?) interessati a fomentare la tensione e a creare un nemico, è il minimo che si possa fare. Ci sono tante destre nel mondo occidentale che hanno bisogno…
Continua su Fumettologica.
10 Dicembre 2014 | Tags: fumetto, Roman Muradov | Category: fumetto |
Girando per BilBOlbul arriviamo alla mostra di questo giovane russo americanizzato, Roman Muradov, ed è subito un susseguirsi di “Oh!”, “Guarda!”, “Che bravo!”, “Questa è una copertina per Vogue!”, “Guarda come ha costruito questa prospettiva!”. Compro la sua graphic novel al volo (si vanno esaurendo rapidamente le copie) e mi faccio fare una dedicasse dall’autore diligentemente e felicemente presente. Mi riprometto di tornare a visitarlo il giorno dopo da Teiera, ma il giorno dopo (quarto ininterrotto di festival e altri impegni concomitanti) sono troppo distrutto e non ce la faccio.
Nell’osservarlo mentre disegna c’è qualcosa però che non mi quadra: sembra che tracci dei segni certo non a caso, ma con quella sorta di distratta concentrazione che si ha quando, magari ascoltando una conferenza o una lezione, si tracciano disegnini con la penna su un foglio volante. Linee curve e voluttuose, in apparenza scoordinate.
In realtà, alla fine, l’effetto è coordinatissimo, e decisamente elegante. Al ragazzo non manca la mano né lo stile; su questo è difficile avere dubbi. Ma qualcosa continua a non quadrarmi.

A casa mi leggo la graphic novel (In a Sense) Lost & Found. E’ stampata…
Prosegue qui, su Fumettologica.
19 Novembre 2014 | Tags: fumetto, horror, Suehiro Maruo | Category: fumetto |
Coconino Press torna alle origini pubblicando il seguito de Il vampiro che ride, di Suehiro Maruo, la cui prima parte è stata, nel 2000, il primo titolo della allora neonata casa editrice. Si tratta di un testo al tempo stesso raffinato e terribile, come nello stile di Maruo (su altri lavori di Maruo avevo scritto qui), che mette in scena sesso e violenza estrema, ma anche sentimenti sottili e un disegno raffinato e pieno di riferimenti colti.
All’estetismo del male Maruo non è affatto estraneo, perché è sempre attorno a questo che girano i suoi lavori. Non di rado mi viene da domandarmi il perché di questi eccessi e di questo godimento nel rappresentarli; ma poi è così evidente che si tratta (anche) di un gioco intellettuale, che mi viene da pensare che una condanna a sfondo moralistico del lavoro di Maruo sarebbe in realtà un cadere nella trappola stessa tesa dall’autore, il quale, in fin dei conti, lavora sempre un gradino più in là, e sembra sempre giocare appositamente sul limite dello scandaloso affinché il lettore si scandalizzi.

Ma non è questo ciò di cui voglio parlare nel post di oggi, anche se è proprio questo ciò che me ne dà l’occasione. Mi rendo cioè conto che una parte dell’efficacia della strategia di Maruo sta proprio nel suo raccontare per immagini. Se lo stesso racconto fosse contenuto in un romanzo (solo verbale) inevitabilmente l’impatto delle scene di uccisione e di sesso sarebbe più debole; certo, molto dipenderebbe dal modo in cui queste scene sarebbero raccontate; tuttavia, anche immaginando lo stile narrativo più crudo ed efficace possibile, una storia raccontata a parole presenta un livello di mediazione in più rispetto a una storia raccontata per immagini.
Proseguiamo l’analogia. Immaginiamo che la medesima storia…
Prosegue qui, su Fumettologica.
17 Novembre 2014 | Tags: fumetto, Manuele Fior | Category: fumetto |
“C’È NELLA VITA UN TEMPO IN CUI ESSA RALLENTA VISTOSAMENTE”: SU “L’INTERVISTA”, DI MANUELE FIOR
Mi era già capitato, scrivendo un post su Cinquemila chilometri al secondo, di trovare un riferimento all’ispirazione di Manuele Fior in una frase di Musil. È l’inizio di “Grigia”, la prima novella di Tre donne:
“C’è nella vita un tempo in cui essa rallenta vistosamente, come se esitasse a proseguire o volesse mutare direzione.”
L’intervista, pur raccontando una storia diversissima, funziona nel medesimo modo: i due protagonisti si trovano a incrociarsi quasi per caso, e ciascuno sta vivendo proprio quel momento di rallentamento, quello in cui la vita potrebbe anche fermarsi, o forse cambierà direzione: in più, anche la società in cui vivono si trova a vivere un momento dello stesso tipo, e gli eventi personali di lei avranno conseguenze per tutti, come si scopre al momento dell’intervista, alla fine del volume, oltre un secolo dopo i fatti raccontati nelle pagine precedenti.

La crisi sembra essere vissuta anche dai colori, scomparsi come sono…
Continua qui, sul blog di Bilbolbul.
Roman Jakobson ebbe a dire, parlando della poesia, anzi della funzione poetica, che ”la funzione poetica proietta il principio d’equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione” (Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli 2002, p. 189). Che sarebbe come dire che, nella costruzione del linguaggio poetico l’equivalenza o la similarità tra gli elementi – parole o sintagmi che siano – possono prevalere sulle regole stesse della successione dettate dalle esigenze sintattiche e narrative. Per cui, ancora in Jakobson, “in poesia l’equazione serve a costruire la successione” (ibidem, p. 192). Per esempio, una parola può essere scelta più per esigenze di rima che per esigenze di chiarezza espositiva e questo può andare benissimo perché la chiarezza espositiva è al massimo un fine marginale della poesia, mentre molto più centrale è il tentativo di creare una rete di rimandi (fonetici, prosodici, semantici…) che si sovrapponga alla sequenza lineare del discorso narrativo o espositivo, sovradeterminandola, ovvero caricandola di ulteriore e ulteriore senso. Certo la condizione ideale è quella in cui la parola-rima viene scelta così magistralmente da apparire anche come la parola migliore per esprimere il senso – ma a volte anche l’evidenza di una leggera forzatura può aggiungere interessanti sfumature di senso.
Perché parlo di funzione poetica proprio qui? Guardate questa tavola dal Little Nemo di Winsor McCay:

oppure quest’altra (famosissima):

Non è difficile accorgersi che la forma complessiva della tavola non dipende soltanto dalle esigenze espressive della narrazione. Nella tavola del 1907, per esempio, la coincidenza di posizione e forma tra le colonne della seconda striscia e gli alberi della terza è narrativamente irrilevante; cioè, per quanto riguarda le esigenze di un’efficace narrazione, non ve ne sarebbe alcun bisogno. In quella, sopra, del 1906, c’è una prima striscia in cui dominano le orizzontali, una seconda le diagonali discendenti verso destra, e una terza in cui dominano le diagonali discendenti verso sinistra (linee prospettiche incluse): anche qui questa articolata costruzione non sarebbe necessaria all’efficacia del racconto…
Prosegue qui, su Fumettologica.
Mi sono ritrovato a pormi una strana domanda, una di quelle che di solito non ci si pone perché le cose stanno così e non sentiamo un particolare desiderio di cambiarle – e di quello che per noi è normale, come ci insegna Wittgenstein, nemmeno ci accorgiamo più. In questo caso la domanda riguarda proprio ilperché le cose stiano così, e perché non sentiamo il desiderio di cambiarle, se non occasionalmente, in circostanze particolari o visibilmente eccezionali. A queste circostanze particolari appartengono i tre esempi che ho voluto mostrare qui.

Il problema, evidentemente, riguarda il lettering, e la domanda è: perché, con poche eccezioni, il lettering nel fumetto è da sempre così standardizzato? Certo, vi sono varianti individuali (come quello, bellissimo e personalissimo, di Dino Battaglia), però, all’interno di quella variante la standardizzazione agisce di nuovo. Perché, insomma, non si usano le innumerevoli varianti grafiche della scrittura che pure sarebbero possibili e facili da produrre per caratterizzare gli aspetti espressivi delle parole dei personaggi, che pure saranno espresse con qualche tono emotivo nel mondo rappresentato? Visto che, giustamente, il bravo disegnatore caratterizza le espressioni del viso e del corpo a seconda del tono emotivo del personaggio, perché mai (con rare eccezioni) il bravo letterista non fa lo stesso con le parole dei suoi balloon?…
Prosegue qui, su Fumettologica.
Nel febbraio 1905, quando il cinema era ancora una specie di teatro su pellicola, uscito fresco fresco dalla testa di Méliès, e ancora qualche anno prima di diventare lui stesso uno dei protagonisti di quella rivoluzione narrativa, Winsor McCay si permise di anticipare una delle sue grandi potenzialità. C’è infatti una tavola del Dream of the Rarebit Fiend (Sogno del patito di fonduta al formaggio) interamente in soggettiva. Eccola qui:

Il cinema era ancora lontano da questa intuizione. In quegli anni era ancora lontano persino dall’alternanza di inquadrature come principio narrativo fondamentale. Il fumetto era ancora (e per molti anni sarebbe sostanzialmente rimasto) fumetto comico, a cui l’inquadratura a figura intera (o giù di lì) è in generale sufficiente. In pittura erano certamente presenti mezzibusti e facce, ma il tema del punto di vista dell’immagine non era tra quelli caldi e particolarmente discussi. Era semmai in fotografia che la tematica dell’inquadratura aveva già un senso forte….
Prosegue qui, su Fumettologica.
Dopo avere parlato di fumetto e letteratura, questa volta parliamo di pittura.
In estrema sintesi, possiamo dire che la nascita della pittura astratta, poco più di un secolo fa, ha sancito definitivamente una concezione della pittura sostanzialmente formale, come costruzione plastica. Solo perché la pittura, pur avendo un soggetto, era ormai da lungo tempo concepita così, a Kandinsky e Malevitch è stato possibile fare il salto, ed eliminare definitivamente il soggetto. Questa concezione della pittura ha origine nel Rinascimento, quando la pittura inizia ad avere una sostanziale committenza privata, e i dipinti iniziano ad essere (anche) oggetti da esporre nelle case private: quindi begli oggetti, il cui tema è di importanza relativa (certo non irrilevante, ma nemmeno fondamentale).
Ben diverse erano le cose prima di questo cambiamento, quando la destinazione dei dipinti era pubblica, per chiese ed edifici di governo. Quando i dipinti erano fatti per essere visti da tanta gente, non erano pensati per la libera contemplazione che si può avere in un luogo privato. Erano piuttosto supporti per la predicazione, o per il racconto. Li si guardava quando qualcuno ne spiegava il senso, o la storia raccontata; o quando qualcuno già l’aveva fatto, e le sue parole risuonavano nella memoria…
Prosegue qui, su Fumettologica.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
Nel valutare le problematiche della comunicazione a fumetti, non si può separare l’eventuale valore fonosimbolico di un’espressione dal suo aspetto grafico. Nel narrare per immagini statiche, infatti, passa inevitabilmente attraverso questa dimensione anche qualsiasi evocazione di dimensioni diverse: di dinamismo, di odore, di gusto, di calore, e naturalmente di suono, che esso sia naturale o verbale. I suoni vengono di solito espressi verbalmente attraverso onomatopee, non necessariamente correnti nella lingua standard, ma possono virtualmente anche trovarsi rappresentati in maniera del tutto grafica.






 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email


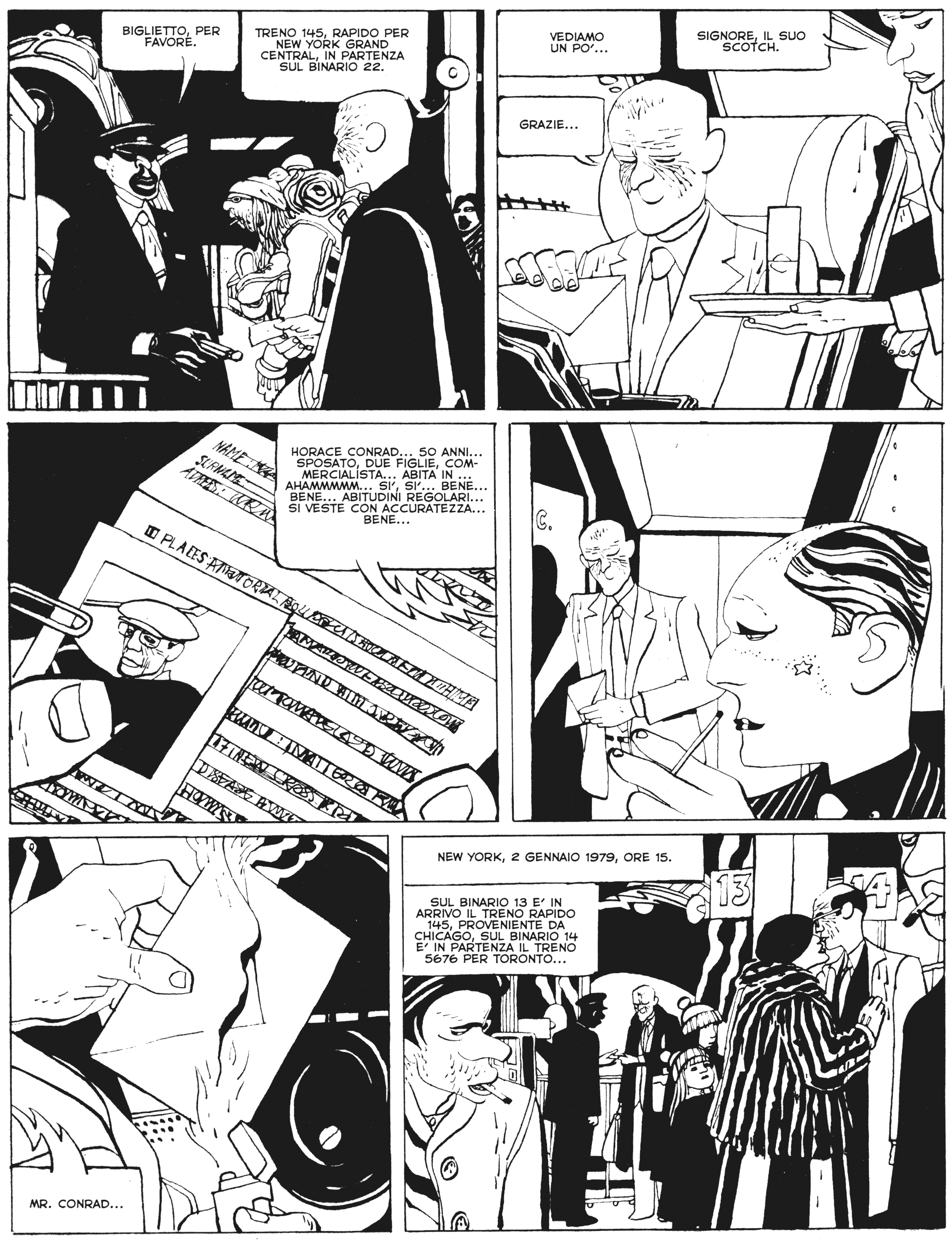




































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti