 Dino Battaglia, La caduta della casa degli Usher (da Poe), 1969 .
Gli antichi, greci e romani, non conoscevano lo spazio bianco. Non conoscevano neanche la minuscola, né la punteggiatura. COSIITESTISCRITTIAPPARIVANOALOR OINQUESTOMODOELEGGERENONERAAFFATTOUNCOMPITOSEMPLICECOMESIPUOF ACILMENTECAPIREDAQUESTERIGHE. I romani, che avevano uno spirito più pratico dei greci, a volte (non sempre) inserivano un puntino per separare le parole. Ma si capisce bene perché la lettura interiore, senza la voce, fosse prerogativa di pochissimi intellettuali. Se provate a leggere ad alta voce, vi accorgerete che il testo continuo acquista più facilmente senso.
L’invenzione (medievale) dello spazio bianco rende distinguibili le parole al colpo d’occhio, e permette, col tempo, lo sviluppo della cosiddetta lectio spiritualis, ovvero la lettura interiore, fatta solo con gli occhi, quella che noi pratichiamo normalmente. Lo sviluppo della punteggiatura migliorerà ulteriormente questa situazione.
Senza lo spazio bianco il fumetto non potrebbe esistere. Lo spazio bianco è ciò che ci permette di distinguere non le singole parole del fumetto, ma quelle unità narrativo-ritmiche che sono le vignette. In effetti, non è necessario che di uno spazio bianco si tratti. Tutto sommato, anche il puntino separava abbastanza bene le parole, però lo spazio bianco si è imposto perché mediamente più efficiente. Nel fumetto, la situazione è analoga: al posto dello spazio bianco possiamo avere uno spazio di un altro colore, o una semplice linea, o un semplice palese cambio di sfondo (come in tante pagine del secondo Eisner). Però il fatto che nella maggior parte dei fumetti il separatore sia lo spazio bianco è un forte indizio della sua maggiore efficienza media (maggiore efficienza media non vuol dire che sia sempre meglio – c’è sempre qualche caso in cui può essere migliore una scelta diversa – ma vuol dire che è la scelta migliore nella maggior parte dei casi).
Lo spazio bianco funziona bene perché è un vuoto, un’assenza, uno iato, un non-essere; lo si guarda senza vederlo, senza che l’attenzione gli si rivolga mai. Ma se lo si elimina non c’è più il racconto, non c’è più la sequenza; oppure, nella migliore delle ipotesi c’è una sequenza continua e confusa da sbrogliare come succede nell’esempio verbale in tutto maiuscolo fatto sopra. Qualcosa, insomma, che richiede uno sforzo intellettuale notevole, e che deve garantire al lettore una soddisfazione fruitiva per lo meno equivalente (una ricetta insomma dal successo poco probabile).
Questa natura neutra dello spazio bianco lo rende un buon candidato per dei raffinati giochi di senso, in cui il bianco come confine tra le immagini si mescola e confonde con il bianco di sfondo, e le figure emergono al tempo stesso dal nulla del loro sfondo spaziale e dal nulla del tempo sospeso tra un evento e l’altro (tra una vignetta e l’altra, tra un battito e l’altro del racconto).
Anche Eisner ha fatto spesso uso di questa ambivalenza del bianco, ma il maestro di questi giochi è stato sicuramente Dino Battaglia, ai cui spazi bianchi ho dedicato, nella mia vita, diverse pagine in diverse occasioni, e che non finisco mai di apprezzare.
—————————————————
Aggiungo qui due brevi segnalazioni, di tema differente.
La prima, se leggete il francese, è quella di questo bellissimo post su
Science-fiction et bande dessinée : années 1960, dedicato sostanzialmente a Jean-Claude Forest e ai suoi indimenticabili Barbarella e Les Naufragés du temps (con Paul Gillon). Il post compare sul blog Phylacterium, dove gli scritti interessanti e competenti sono tutt’altro che rari.
Forest è indubbiamente uno degli autori francesi di fumetti più importanti del Novecento, e uno che mi ha fatto molte volte sognare, anche proprio con quelle stesse serie di cui si parla qui.
La seconda segnalazione è che domani 1 luglio su questo blog non appariranno post, ovvero questo blog tacerà, in adesione alla manifestazione indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa, contro la legge bavaglio.
 Geo McManus, Les jeunes mariés, da Nos Loisirs n. 25, 1907 Nel post del 29 giugno del suo bel blog, Neuf et demi, Thierry Groensteen ci presenta questa immagine, che lui trae a sua volta da uno studio di Eckart Sackmann e Harald Kien pubblicato nel volume Deutsche Comicforschung 2010. (L’immagine che Thierry ci propone è purtroppo a bassa risoluzione, per cui è inutile cercare di ingrandirla). Si tratta della versione francese di una serie americana, di Geo McManus, The Newlyweds, precedente di qualche anno alla più nota Bringing up Father.
La pagina ci viene proposta come esempio della difficoltà che all’inizio del Novecento i giornali europei hanno, e per parecchi anni continueranno ad avere, ad accettare l’idea di una narrazione fatta principalmente d’immagini. Ma l’esempio in questione è particolarmente interessante perché, a differenza di quello che accade di solito, i balloon non sono stati cancellati, e ciononostante il testo che accompagna le vignette è un testo di dialogo, fatto di battute così esplicitamente teatrali da riportare, qua e là, le stesse note che a volte portano i copioni teatrali stessi: “a parte”, “a se stesso”…
Questo ci fa intuire alcune cose su come doveva essere inteso nella vecchia Europa il nuovo fumetto che proveniva dall’America. Non una narrazione per immagini indipendente, come oramai erà già negli USA, dove la parola fa parte della scena rappresentata, bensì un set di tipo teatrale, dove la parola precede l’immagine ed è comunque più importante, come succedeva chiaramente nel teatro dell’epoca, basato sulla testualità letteraria del copione e sulla sua messa in scena. Visto in questo modo, il teatro non è poi così lontano dal racconto illustrato, con il tramite del cantastorie che racconta a voce alta mostrando le immagini.
Questo modello tutto basato sulla parola scritta è talmente forte da permettere ai lettori di Nos Loisirs di accettare anche una situazione testuale assurda come quella che vediamo qui, in cui ci sono dialoghi che accompagnano le immagini e dialoghi dentro le immagini – senza che si possa capire in che relazione stiano tra loro. È un po’ come se i dialoghi nei balloon facessero parte delle immagini stesse, cioè della parte illustrata, mentre il racconto vero scorre sotto, nelle didascalie.
Questo mi dà ulteriore ragione di pensare che qualcosa di nuovo è davvero successo in America, qualche anno prima, e che il fumetto non poteva nascere in Europa, perché questa è la fine cui sarebbe stato destinato: una versione statica del teatro, una narrazione per immagini, dove la narrazione è inevitabilmente legata alla parola. Forse Outcault e i suoi immediati contemporanei non hanno inventato molto, ma il piccolo passo che hanno fatto non sarebbe mai stato possibile nell’Europa di quegli anni (e di molti anni a venire), troppo letteraria, troppo legata alla parola e alla scrittura.
Mi viene da pensare che, paradossalmente, la fortuna del cinema è di essere nato muto, e di essere stato costretto, per questo, a nascere come arte dell’immagine in movimento, e non del racconto. Se fosse nato con la parola, è piuttosto probabile che in Europa non avrebbe avuto una sorte molto differente da quella del fumetto.
Magari l’America si sarebbe salvata lo stesso. E comunque, quando il sonoro è arrivato, per fortuna, c’era già abbastanza storia per non poter più tornare indietro.
E infine – guarda un po’ – gli anni dell’adozione del balloon in Europa sono grosso modo gli anni dell’invenzione del sonoro nel cinema. Non ci sarà un legame?
24 Giugno 2010 | Tags: Alberto Salinas, Carlos Gomez, comunicazione visiva, Dago, estetica, fumetto, ritmo, rito, Robin Wood | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto |  Carlos Gomez, Dago Riprendo questo tema che ha lanciato Harry qui, e l’ha poi ripreso qui, dopo un mio commento in cui gli chiedevo di spiegarmi perché anch’io leggo così volentieri Dago. Intendiamoci, si parla delle storie contenute nel mensile Dago Ristampa (che contiene le ristampe delle storie già pubblicate sui settimanali della Eura/Aurea), scritte da Robin Wood e disegnate da Carlos Gomez – e non confondiamolo col mensile Dago, che pubblica storie nuove, scritte e disegnate da altri apposta per il mercato italiano, di qualità mediamente molto bassa, e di cui non varrebbe affatto la pena di parlare (e nemmeno di leggerlo, in verità). A vantaggio di chi si è perso quello che è uscito sin qui, dal 2008 è iniziata anche la ristampa della ristampa, a colori, nella Collezione Tuttocolore.
Il mistero è questo: Dago è un fumetto seriale. I disegni, prima di Alberto Salinas e in seguito di Carlos Gomez, sono di ottima qualità. Le storie, a giudicare dalla passione con cui io stesso e tanti altri le leggiamo, pure: ma i temi ormai si ripetono, e anche prima che all’interno della serie si ripetessero erano noti e stranoti, puri stereotipi di genere, strabordanti di un moralismo che in altre circostanze io troverei stucchevole, popolati di personaggi già conosciuti mille volte. Inoltre, se uno ha praticato un po’ il fumetto argentino, tutto questo appare ancora più vivido, e più ossessivamente ricalcato.
Insomma, la mia testa mi dice che, se devo giudicare da questo, Dago non è che un ennesimo prodotto seriale che non fa che ricalcare percorsi già pesantemente calcati da altre mille storie, roba buona per lettori poco esperti, o dal palato grezzo. Eppure, a dispetto di questo, mi ritrovo ogni tanto a domandarmi quando uscirà il prossimo numero; e poi, quando torno a casa dall’edicola dove ho fatto incetta di nuove uscite, la mia prima lettura è inevitabilmente Dago. Di conseguenza, o il mio palato fumettistico è davvero grezzo, oppure in quello che la mia testa mi dice c’è qualche errore o mancanza.
Harry suggerisce questo:
Ma osservando da un altro punto di vista la risposta è antropologica: Wood sa raccontare la vita nei suoi bisogni primari. Prima ancora che tecnico, è un successo basato sulla sensibilità artistica dello sceneggiatore. Wood mette a nudo le dinamiche primarie che muovono le esistenze. Il filtro della guerra in forma di dramma svela gli attaccamenti, il desiderio sessuale, il bisogno di affermazione, la crudeltà, la fame, la vendetta, la sacralità della vita, e così via. Di questo Wood sa raccontare alla perfezione. E ogni tassello, ogni ritorno, ogni variazione, offrono un’opportunità di comprensione. Il gioco funziona, insomma, per forza dell’occhio con cui Wood osserva e della sua forza evocativa. Doni rari.
Tutto questo è vero, ma in realtà non mi basta. Ci sono tanti fumetti che affrontano questi temi e non hanno certo la qualità di Dago. Però quello che Harry dice è ugualmente utile a circoscrivere meglio il problema: ovvero, dunque, come fa Wood a mettere a nudo così bene queste dinamiche primarie? In che cosa consiste la sua perfezione?
Voglio approfittare anche di un suggerimento che proviene da un altro lettore appassionato di Dago, cioè Umberto Eco, che nell’introduzione al convegno La linea inquieta, nel 2004, diceva:
Cito Dago come caso interessante perché in esso si manifestano tre fenomeni molto ben distinti: (i) la rivisitazione visiva sia della tradizione rinascimentale che della tradizione dei grandi illustratori moderni come Gustavino; (ii) la sapienza narratologica di Robin Wood nel realizzare una combinatoria infinita di vari topoi romanzeschi, da quelli picareschi a quelli neogotici e romantici; (iii) l’assoluta banalità stilistica del discorso verbale, che si attiene a una retorica da feuilleton ottocentesco, e senza alcuna ironia sottintesa. Aggiungerei che dal punto di vista sociologico è forse proprio questa strana commistione che giustifica il successo popolare della serie, ma ecco che si vede come un’analisi sociologica debba sovente essere preceduta da una valutazione critica molto rigorosa.
Anche qui non andiamo molto al di là di qualche intuizione, però trovo che sul fuoco ci sia già più carne. Intanto vi si osserva che non è che Salinas e Gomez siano semplicemente bravi disegnatori, ma che in questa bravura è presente una competenza iconologica che ci permette di collegare continuamente Dago a una serie disparata di tradizioni, da quella rinascimentale (epoca di ambientazione delle vicende) a quella otto-novecentesca degli illustratori (epoca in cui si forma la nostra competenza visiva di lettori).
La banalità stilistica del racconto verbale è quello che potremmo definire il basso continuo della serie: una specie di accompagnamento necessario, senza il quale non si comprenderebbero le vicende, ma che è il più banale e scontato possibile proprio perché non deve attirare l’attenzione: si legge e scorre via. L’accento è su altro.
E poi c’è la combinatoria infinita dei topoi romanzeschi, presi dalle tradizioni più diverse, che corrisponde, sul piano narrativo, alla competenza iconologica su quello visivo. È come dire che il lettore di Dago ritrova continuamente il già noto, però intrecciato in combinazioni non necessariamente note.
Di nuovo, tutto questo è vero, ma ancora non basta. Ci avvicina un po’ alla soluzione, ma non ce la dà.
E allora proverò a esplorare dentro di me, a capire quali sono le sensazioni che mi tengono avvinto a queste storie, senza escludere neanche le più banali.
Così, intanto, c’è l’ambientazione storica. La prima metà del Cinquecento è un periodo già di per sé affascinante (per me in particolare, anche prima di Dago): l’Europa è ricca, piena di artisti e di entusiasmo, ma è già scivolata in un’epoca di guerre feroci e di contrapposizioni religiose, che la stanno portando molto vicina al disastro. Da questo punto di vista la documentazione di Wood è davvero rigorosa; è ovvio che la storia di Dago è fantastica, però ogni tanto si incrocia con eventi e personaggi storici: ho fatto diversi controlli, ma non sono riuscito a cogliere Wood storicamente in fallo.
Poi, c’è la ricchezza dei temi: è vero che i temi si ripetono e che si rifanno sempre a un qualche modello noto, però sono tantissimi, e di conseguenza è multiforme la loro combinatoria. Non so se si possa dire che Wood è capace di sottigliezza psicologica: i personaggi appartengono tutti a casistiche abbastanza ben definite, di provenienza follettonistica. Però sono combinati così intelligentemente con la storia in cui agiscono che anche nel rispetto dello stereotipo appaiono credibili, convincenti, molto umani.
Poi c’è la questione del moralismo. Certo, in Dago il bene è bene e il male è male, però c’è anche un’ampia zona intermedia, e non è detto che il bene trionfi sempre pienamente. Lo stesso Dago, il protagonista, sempre pronto a battersi per cause giuste, porta nel cuore un desiderio sanguinoso di vendetta. Complessivamente i morti sono tantissimi sia dalla parte del bene che da quella del male. Lo potremmo definire un moralismo amaro, e pieno di comprensione per le debolezze della vita. Insomma, anche qui, qualcosa di sufficientemente complesso da non essere sentito come banale.
Infine, collegato a tutto questo, c’è la questione dell’epica. Per certi versi Dago è un romanzo cavalleresco popolare, fatto di schemi e stereotipi come già pure quelli del Pulci e dell’Ariosto, che erano i capolavori che erano anche a ragione di questi schemi e stereotipi.
In fin dei conti, la mia idea è che il piacere che Dago produce nella lettura sia una questione di ritmo, e di rito. Senza componenti rituali (di cui il ritmo è comunque la base) non si producono testi con qualità estetiche. Nella nostra cultura, alla componente rituale si deve associare una componente di originalità e di novità; ma non è sempre stato così. O meglio, la rilevanza della componente innovativa è diversa da epoca a epoca, da luogo a luogo, da genere a genere, da attività a attività. Nel rito vero e proprio, come quello religioso, la componente innovativa è nulla. Nelle produzioni estetiche, viceversa, è ciò che tiene vivo il nostro interesse, permettendoci di trovare piacere nel frattempo anche in quel ritorno del già noto che crea ritmo e rito. Così, il piacere delle produzioni estetiche ha due tipi di fonte: da un lato quello della scoperta (dovuto alla novità), dall’altro quello della conferma e sicurezza (dovuto al ritmo).
Credo che Wood (con Salinas e Gomez) abbia trovato una via inedita per riproporre quell’idea antica di racconto popolare di cui il poema cavalleresco è stata anche a suo tempo espressione, e che è il modello anche del mito: tutto quello che succede ci è in qualche modo già noto e i valori espressi sono i qualche modo i nostri; e tutto è rassicurante, ma non perché sia banalmente positivo, ma semplicemente perché rispecchia, anche nel male, l’idea che abbiamo della vita e del mondo.
Dago è una sorta di rassicurante liturgia, che si legge volentieri perché non mette in questione nulla, fondamentalmente, però ci porta alla mente tante cose diverse. È, in questo senso, una telenovela d’alto bordo, dai contenuti tutt’altro che banali. Non dobbiamo aspettarcene nessuna proposta particolarmente originale, perché Wood è sempre attento a tenersi eticamente e psicologicamente sul generico – e la distanza storica aiuta. Ma il suo gioco è comunque affascinante e confortante.
Tutto questo forse non svela del tutto il mistero di Dago, però qualche passo avanti mi sembra di averlo fatto.
 Jim Woodring, Weathercraft, pp. 24-25 Jim Woodring è un figlio deviato dell’underground americano. Deviato come tutti i figli di valore. Ma la sua deviazione rimane comunque molto underground. All’inizio della scarna autobiografia contenuta nel suo sito, sostiene che da bambino aveva allucinazioni. In seguito ha fatto di questo problema la propria fortuna. Certo, se questo è vero, essere stato adolescente negli anni Sessanta deve averlo aiutato molto nella sua presa di coscienza, quando allucinazione e psichedelia erano un obiettivo, mentre lui le aveva come punto di partenza.
 Jim Woodring, Weathercraft Jim è stata la sua rivista a partire dal 1980, ed era sua in tutti i sensi – almeno sino a quando, qualche anno dopo, la Fantagraphics non ha deciso di finanziarne la pubblicazione e distribuzione. Weathercraft è invece il titolo comune sotto cui, da qualche anno, Woodring raccoglie una serie di storie allucinate. Proprio con questo titolo, dunque, Coconino Press ha appena pubblicato un volume che ne contiene una lunga: l’incubo di un uomo-maiale in un mondo di creature ancora più strane di lui.
È una storia assurda e intrigante, una sorta di viaggio, nel senso psichedelico del termine. Si potrebbe sostenere che non ha né capo né coda, ma tra questi estremi mancanti si stende un mondo pieno di fascino sinistro. Proprio per questo fascino, e perché lascia il segno sul lettore, mi è venuto voglia di segnalarlo qui.
Giusto a titolo di confronto, e forse perché Woodring, in fin dei conti, come fumettista è anche migliore, metto qui in fondo due immagini allucinate di Robert Williams, realizzate quando Woodring aveva circa 18 anni. Indubbiamente, tra l’altro, Robert Williams è uno dei disegnatori che più hanno avuto influsso sul giovane Andrea Pazienza. Guardatele da vicino!
 Robert Williams, Coochy Cooty Men, 1970  Robert Williams, Coochy Cooty Men, 1970
16 Giugno 2010 | Tags: Al Williamson, Alex Raymond, fumetto | Category: fumetto |
 Al Williamson, Flash Gordon Al Williamson è uno degli autori che, molti anni fa, mi hanno fatto sognare. Ma era solo in parte merito suo. In verità, attraverso di lui, io vedevo Alex Raymond, ora quello di Flash Gordon, ora quello di Rip Kirby.
Lo vedevo anche attraverso Frazetta, ma lì c’era pure Frazetta, in maniera prepotente. Invece, se toglievo Raymond a Williamson sembrava non restare nulla.
Ora che Williamson se ne è andato, poco dopo Frazetta, è un’altro pezzo di quel che restava di Raymond che non resta più. Ed è comunque un peccato: anche se forse non erano sogni suoi, Williamson li sognava assai bene.
 Al Williamson
Nell’intervista che mi ha fatto Fabio Sera per Flashfumetto a proposito del mio libro Il pensiero disegnato, mi viene domandato di parlare del concetto di battito-vignetta-evento che è oggetto di alcune pagine dell’Introduzione. Vedo poi che House of mystery cita proprio quel medesimo spezzone dell’intervista; e io stesso presentando il mio libro su questo blog qualche mese fa avevo riportato parte di quelle medesime pagine dell’Introduzione. Mi sembra di capire che il tema interessa; e so per certo che interessa me; e anzi lo trovo centrale per capire che cosa sia specifico del linguaggio del fumetto.
Sarà perché la poesia è un altro dei miei interessi specifici, ma io qui ci vedo un nesso non banale. Purtroppo, la deriva degli ultimi secoli (e in particolare a causa del Romanticismo) ha fatto sì che quando si dicono le parole poesia e poetico, la mente corra subito all’universo rarefatto della lirica, sicché diventa del tutto lecito parlare anche di poesia in prosa o poesia visiva… Tutte cose interessanti e apprezzabili, di cui ho avuto anche occasione di parlare in altri post. Ma non è quello che mi interessa qui. Piuttosto, in una visione tradizionale e per nulla tramontata, la poesia è quella forma di scrittura in cui si va a capo a fine di ogni verso, contrapposta alla prosa, dove i versi non ci sono, e si va a capo solo quando finisce lo spazio della pagina o quando termina il capoverso. Si tratta di una contrapposizione tagliata con l’accetta – è evidente – però è quella che mi serve qui, e anche se non esaurisce la differenza tra poesia e prosa, è sufficiente da sola a spiegare tutta una serie di diversità.
Intanto, questo andare a capo arbitrario, proprio perché arbitrario, è necessariamente significativo, e, dal punto di vista della scansione della lettura, crea una pausa, o comunque una cesura. I cattivi attori ignorano questa cesura quando recitano poesia, riducendo la poesia a prosa: lo fanno perché non ne capiscono il senso.
Il verso è la versione stilizzata del respiro. Non che, leggendo poesia ad alta voce, si debba per forza respirare a fine verso, però possiamo ipotizzare che, quando la poesia era improvvisata dagli aedi ed esisteva solo come forma orale, fosse davvero così. Di fatto è così anche oggi nelle improvvisazioni in ottava rima dei poeti da braccio della Maremma. E il respiro è a sua volta modulato al suo interno dall’andamento metrico e ritmico del verso, in una (relativa) uniformità che avvicina la poesia al canto (e una volta davvero non erano cose distinte) e accresce la memorizzabilità.
Nella poesia più recente, il verso resta spesso solo un respiro stilizzato. Ma anche se non coincide necessariamente con il ritmo del fiato del lettore ad alta voce, influisce lo stesso; e i versi corti producono un effetto un po’ ansimante che si contrappone a quello disteso dei versi lunghi. Scrivere poesia in versi liberi significa anche saper calibrare questa portata variabile del respiro.
Osserviamo che la lingua possiede anche un’altra e più frequente forma di respiro stilizzato, che è quella espressa attraverso la punteggiatura. Si tratta però, ormai, di una stilizzazione ancora più antica e catacresizzata – per cui è ormai da secoli normale che si usino i punti e le virgole per sostenere più il senso del discorso che la voce. In poesia, comunque, due sistemi di respirazione stilizzati si confrontano e convivono, e la poesia (nel senso in cui ne stiamo parlando qui) è l’effetto di questa dialettica.
 Sergio Toppi, Sharaz-de Nel senso in cui ne stiamo parlando qui, dunque, il fumetto assomiglia molto alla poesia. Il battito-vignetta-evento è qualcosa che ricorda il verso, con l’inevitabile cesura che lo separa dal successivo e il suo carattere comunque unitario, pur all’interno della sequenza di cui fa parte. La scelta della complessità visiva della vignetta (che determina la velocità con cui sarà letta) è relativamente indipendente da ciò che essa racconta; così come anche la scelta della dimensione dell’evento è indipendente dalla storia raccontata. Come accenno anche nell’intervista di Flashfumetto, gli eventi-vignetta di Toppi sono ben diversi da quelli di Koike e Kojima, o anche da quelli del Dark Knight di Miller (che tanto ha imparato dagli autori di Kozure Okami). Quello che cambia è il respiro (qui anche nel senso metaforico in cui si parla di respiro narrativo): le storie di Toppi sembrano viste da una lontananza infinita, che dà loro un respiro epico; quelle di Miller o di Koike e Kojima sono viste invece da molto, molto vicino, con un effetto di compartecipazione emotiva inevitabilmente molto forte.
 Kazuo Koike, Goseki Kojima, Kozure Okami (Lone Wolf and Cub)  Frank Miller, The Dark Knight Returns
Il respiro del lettore di Dark Knight è un respiro rapido e affannato, che costruisce nel lettore direttamente (con il respiro stesso) quella medesima situazione emotiva che si sta intanto raccontando. Le pagine di Toppi hanno invece il respiro del canto epico, del mito, di quello che è lontano ma anche profondo, e profondamente innestato in noi.
Il modo di raccontare non dipende da quello che si racconta; però produce effetti molto differenti sul racconto stesso, anche a parità di racconto. Il racconto in sé ha i suoi momenti e i suoi eventi propri. In sé, essi non coincidono con i battiti-vignette-eventi del fumetto, proprio come l’articolazione del discorso creata dalla punteggiatura non coincide con quella procurata dalla divisione in versi e dal loro ritmo interno. O meglio: in qualche caso le due articolazioni possono coincidere del tutto, in qualche caso possono essere più o meno convergenti o divergenti, in altri casi sono del tutto diverse. La modulazione di questo rapporto è uno strumento fortissimo che sia il poeta che il fumettista hanno a propria disposizione per costruire il proprio discorso complessivo, e l’emozione di chi legge.
 Alex Raymond, Rip Kirby 02-11-1946, dettaglio. Edizione Comic Art 1992 Ecco di nuovo il nostro Maciullatore, questa volta dalla striscia di Rip Kirby del 2 novembre 1946. Siamo nell’ultima striscia di una storia. Il nostro villain, dato poco prima per morto, riemerge dall’acqua e viene salvato da una nave con destinazione Sudafrica, buono per la prossima riapparizione, ma per il momento fuori gioco.
Ho scansionato questo dettaglio dall’edizione da edicola realizzata da Comic Art, pubblicata nel 1992. La potrei trovare anche una bella immagine, magari un po’ scura, se non avessi sotto mano il confronto con l’originale, che potete vedere qui sotto, alla fine del post – scansionato dalla tavola di Alex Raymond conservata presso il Fondo Gregotti. (Ho giocato un po’ di luminosità e contrasto con Photoshop, giusto per rendere bianco il fondo, e per scurire appena quei neri che nell’originale non sono pieni ma nella stampa lo diventerebbero: insomma, in modo da simulare l’effetto di una resa a stampa di buona qualità)
Non vi pare che la differenza sia impressionante? Confrontate gli occhi, o il naso, e il modo in cui – per esempio, le piccole ombreggiature tratteggiate dell’originale diventano una linea spessa di nero nella copia. L’edizione Comic Art è anche leggermente deformata: a parità di altezza, è un poco più stretta. Ma questo sarebbe davvero un peccato veniale, al confronto dello scempio a cui risultano sottoposte le pennellate affilate e intensamente modulate di Raymond, che finiscono per trasformarsi in un blob di melassa d’inchiostro, dove tutte le estremità sono arrotondate, e dove tutte le linee sottili diventano spesse, non di rado fondendosi con quelle vicine.
Come accade? Non è difficile capirlo: si usa una fotocopia della fotocopia di una fotocopia. Spesso con i fumetti storici non ci sono molte alternative; e per un’edizione a basso costo le alternative, anche quando ci sono, non sono economicamente percorribili.
La cosa che stupisce è che Rip Kirby resta molto godibile persino in queste condizioni di stampa; segno che la qualità del disegno non è fatta solo di finezze, ma anche di costruzione plastica complessiva – e quella, nonostante tutto, rimane. Però sarebbe come se, nel leggere un romanzo tradotto da un’altra lingua, l’editore italiano avesse tolto tutti gli aggettivi e tutte le descrizioni di contorno, lasciando solo quello che è essenziale per capire ambientazione e trama. Magari si legge lo stesso. Magari lo si apprezza lo stesso. Però si ignora davvero tutto quello che è andato perduto, e quanto più gratificante sarebbe stato leggerlo nella versione completa!
 Alex Raymond, Rip Kirby 02-11-1946, dettaglio dall'originale
 Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Quello che vedete qui a fianco è un dettaglio della striscia del 3 maggio 1956 di Rip Kirby, disegnata da Alex Raymond. Il personaggio raffigurato è the Mangler, o il Maciullatore, un sinistro villain ricorrente nella serie. L’immagine è stata scansionata direttamente dall’originale dell’autore, conservato presso il Fondo Gregotti.
Non è stato Raymond a introdurre l’uso del pennello tra i disegnatori americani di fumetti. L’onore va a Noel Sickles, compagno di viaggio e di lavoro di Milton Caniff. Sickles abbandona l’universo del fumetto nel 1936, subito prima che lo stile grafico adottato da lui e Caniff faccia epoca, per diventare lo stile con cui vanno disegnati i fumetti d’avventura in America. Ma nessuno, nemmeno Caniff stesso, o Will Eisner, è arrivato alla padronanza che Raymond ci mostra con questo strumento negli anni di Rip Kirby, e in particolare in questa immagine.
Certo, non è necessariamente tutto opera del pennello, quello che stiamo vedendo. Molti tratti sottili, specie nella zona del viso, potrebbero essere stati tracciati con un pennino – che meglio si presta a ottenere certe spigolosità dinamiche, che caratterizzano tutto il disegno di Rip Kirby (esattamente al contrario di quello che succedeva qualche anno prima con Flash Gordon). Ma poi, anche parecchi tratti sottili da pennino sono stati rafforzati col pennello, per dare più incisività alle ombre – come nella linea del profilo, che dal sopracciglio destro scende al naso e alla bocca.
E comunque, l’effetto drammatico di questa costruzione monumentale, enfatizzata dall’inquadratura con il punto di vista ribassato, è tutto giocato sulle grandi pennellate nere dell’abito e della manica, che creano l’effetto di luce radente, il quale a sua volta permette di vedere il personaggio come colto da una luce violenta e improvvisa mentre emerge dall’ombra.
Il lettore affezionato di Rip Kirby è in grado di riconoscere immediatamente questa figura sinistra, che è stata al centro già di altre avventure del nostro protagonista, e che – ovviamente – era dato per morto. A dire il vero, questa immagine procura un brivido anche se non sappiamo chi è il personaggio rappresentato; tanto più lo farà dunque, quando lo sappiamo.
Ci sono due punti di forza, in questa figura. Uno è ovviamente il viso, che si vede. L’altro è la mano, nascosta nella tasca, ma messa fortemente in evidenza dal gesto, a sua volta sottolineato dalle pennellate delle pieghe della manica. La tasca nasconde probabilmente qualcosa, magari un’arma, o forse solo una mano capace di colpire. Se seguiamo il percorso della manica, vediamo che c’è una linea con tendenza ovale accennata dalla spalla in alto alla tasca in basso. E, conversamente, se da lì risaliamo tenendoci un po’ più a sinistra, un secondo arco conduce alla zona del bavero e quindi al viso. L’attenzione viene in questo modo portata alternativamente dall’uno all’altro dei due luoghi nodali, attraverso due percorsi, uno, discendente, dalla luminosità al buio; l’altro, ascendente, attraverso il buio sino alla luce del bavero e del viso.
Al centro di quel viso, il Maciullatore sta guardando noi, più in basso di lui. Proprio come nella scena madre di un film hollywoodiano, come in un Terzo uomo decisamente più cattivo dell’originale.
 Dino Buzzati "Poema a fumetti" pag.174 In un bel post del suo bel blog, Thierry Groensteen celebra Guy Peellaert, autore, nel 1966 e 1968 di due albi che appartengono alla storia del fumetto della migliore qualità, gli unici che abbiano davvero portato nel fumetto l’universo dell’immagine psichedelica.
 Guy Peellaert "Jodelle" p.34 Alla fine del post Groensteen scrive:
Si può rimpiangere che questo stile sia rimasto senza un vero seguito. Dino Buzzati ne trae ispirazione per il suo Poema a fumetti. In Spagna, Eric Sió tenta una sintesi tra pop e realismo fotografico. Touïs (Le Sergent Laterreur) inventa il cartoon psichedelico. Al di là di questi sforzi sparsi, nulla o quasi. Il solo erede lontano di Peellaert al quale io riesca a pensare è Alex Varenne, in alcune delle sue composizioni erotiche.
Adesso che Groensteen l’ha detto, mi domando come ho fatto a non vederlo prima. Peellaert pubblica Jodelle nel 1966 e Pravda nel 1968; Buzzati lavora al Poema a fumetti nel 1968 per pubblicarlo poi nel 1969. Aveva certamente visto Jodelle, e probabilmente anche Pravda.
 Dino Buzzati "Poema a fumetti" pagg. 74-75 Sicuramente, quello stile fatto di linee semplici e forti e di forti contrasti era già congeniale a Buzzati ancora prima di incrociare Peellaert, come si può vedere dai suoi dipinti; ma non c’è solo quello a tradire l’ispirazione peellaertiana. L’erotismo ostentato e parodiato dei fumetti di Peellaert viene fuori tutto nel Poema a fumetti, in chiave più melanconica e meno dirompente – ma con la stessa carica provocatoria per la cultura bigotta di quegli anni.
Certo Buzzati non aveva la mano di Peellaert, e il suo viaggio nel fumetto era più da appassionato che da professionista. La sua ispirazione era più classica, indubbiamente. Ma Buzzati ci vedeva bene, e capiva dove prendere quello che gli serviva facendone l’uso migliore per i propri scopi.
Non voglio fare altri commenti. Penso che le immagini bastino.
 Guy Peellaert "Pravda" pp.28-29  Dino Buzzati "Poema a fumetti" pagg. 210-211  Guy Peellaert "Jodelle" pag.44
 Lorenzo Mattotti, illustrazione da "Hänsel e Gretel", Orecchio Acerbo 2009 C’è qualcosa di ironico nel fatto che il premio Andersen di quest’anno sia andato a una fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm illustrata da Lorenzo Mattotti. Da un lato, è evidente una certa coerenza nel fatto che un premio intitolato a un autore di fiabe sia andata all’edizione di una fiaba scritta da altri autori di fiabe. Dall’altro, bene ha fatto la giuria del premio a giustificare la propria scelta iniziando con le parole: “Per essere un libro illustrato veramente ‘per tutti’”.
Il premio Andersen è infatti il principale premio italiano per il libro per ragazzi, ma né Andersen né i Grimm né tantomeno Mattotti sono mai stati davvero degli autori per ragazzi. Mi colpisce questo fatto, proprio mentre, riguardandomi il volume illustrato da Mattotti, penso che il premio l’ha davvero meritato – e che va benissimo che il premio sia intitolato ad Andersen, mentre insieme faccio fatica a vederci un prodotto per l’infanzia. “Per tutti” va bene; ma il problema è che andrebbe altrettanto bene per il medesimo Andersen e per i fratelli Grimm, che operavano raccogliendo fiabe e favole avendo in mente un recupero della letteratura popolare come espressione di un’epica, di un mito – con forti caratteristiche nazionali.
Possiamo giustamente lasciar perdere l’aspetto nazionale, e le sue conseguenze nazionalistiche, poiché le fiabe hanno valore indipendentemente da quello. Ma l’epica e il mito sono basilari, e mi conducono a loro volta a un’altra domanda: come mai un’altra epica e un altro mito, quelli greci antichi, non sono mai stati toccati dalla riduzione all’infanzia che ha toccato le fiabe? E non vale rispondere: ma come! si vede che le fiabe sono per ragazzi e i miti greci no! Ma si vede perché questo è ciò che ci hanno insegnato, e siamo cresciuto pensando che questa sia la norma.
Non vale nemmeno la risposta: perché i miti greci hanno Omero, e le fiabe no. Solo alcuni miti greci, di fatto, hanno Omero. Per tanti altri non c’è stato nemmeno un Andersen.
Piuttosto, riflettiamo sul modo in cui i miti greci e le fiabe sono arrivati all’universo della cultura “alta”: da un lato c’è un recupero che è stato cólto fin da sempre, e da sempre legato al fascino degli antichi; dall’altro c’è la scoperta, in secoli recenti, dell’esistenza di una cultura popolare, e il tentativo della sua riabilitazione. Ma questo tentativo, evidentemente, si è scontrato con qualcosa, con un qualche pregiudizio troppo forte da sradicare, e così la letteratura popolare non è stata considerata epos, o mito, ma è stata assimilata alla letteratura per bambini, utilizzando un’equazione implicita del tipo popolare=immaturo.
Al fumetto, guarda caso, nel suo arrivare in Europa, è successa la stessa cosa. Solo in America poteva nascere davvero una forma di letteratura popolare che non venisse immediatamente assimilata alla letteratura per l’infanzia! E questo poteva succedere proprio perché la tradizione cólta americana era ovviamente più debole, meno paludata, più disposta a differenziarsi da quella della madre Europa.
Un secolo è passato da allora, e molte cose sono cambiate. Ma al fondo il pregiudizio rimane, e Mattotti resta, per la cultura “alta”, un autore per l’infanzia, o comunque destinato a un consumo in qualche modo “immaturo”. Il problema non riguarda dunque esclusivamente il fumetto: i pregiudizi nei confronti del fumetto non sono che una delle applicazioni nei confronti di tutto quello che ha radici popolari più prossime – indipendentemente da quanto maturo, raffinato, colto, complesso sia oggi.
A saper guardare le figure di Mattotti sul racconto di Grimm, ci si accorge facilmente di quanto più “alta” sia in realtà questa cultura di quella di tanta letteratura verbale osannata dai giornali e dai media, e che riempie i dibattiti culturali dei nostri giorni.
Ci sono delle eccezioni, ed è interessante valutarle: non è successa la medesima cosa per la musica, per esempio. Perché?
In almeno un post precedente ho introdotto il tema delle immagini finalizzate al racconto. Ma quella volta poi il discorso si spostò, grazie alla polemica con Stefanelli, sul tema dell’origine del fumetto. Voglio tornarci sopra ora, per vedere le cose da un altro punto di vista.
Riprendo da alcune parole scritte allora:
La narrazione per immagini è sempre esistita, sin da quando si dipingevano i bisonti sulle pareti della grotta di Altamira, per farne presumibilmente gli attori di una storia raccontata a voce nel corso di una cerimonia rituale. Con l’avvento della scrittura e l’abitudine alla sequenzialità legata alla lettura, la narrazione per immagini prende talvolta essa stessa la forma di una sequenza, oppure inserisce filatteri di testo verbale in un contesto figurativo. In un certo senso gran parte della pittura medievale non è che narrazione per immagini, e non mancano gli esempi di sequenze narrative vere e proprie.
I concetti importanti li avevo già scritti allora, ma non ne avevo tratto le dovute conseguenze. Ora li ho evidenziati col neretto. Se riguardiamo l’arte visiva occidentale sino a qualche secolo fa, ci accorgiamo che essa è sostanzialmente narrativa. Non lo è talvolta nella decorazione (ma la decorazione è appunto tale – cioè non è figurazione autonoma); non lo è talvolta quando rappresenta la divinità e i luoghi ad essa vicini (perché qui vuole esprimere proprio l’assenza del tempo, e quindi degli eventi). Come ci ricorda Lina Bolzoni (La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi 2002) le immagini prodotte nel medioevo erano addirittura pensate per essere fruite in presenza di una voce narrativa di accompagnamento. E in questo senso non erano molto diverse, quanto a funzione, dai bisonti dipinti sulle grotte di Altamira.
Ma se pensiamo alla pittura in questi termini, è inevitabile pensarla, sino a un certo momento della sua storia, come narrazione per immagini. La concezione moderna della pittura, formalistica e plastica, è quindi impensabile prima del tardo Rinascimento, ed è figlia, credo, della pittura di genere, che è il primo tipo di pittura (non decorativa) che possa fare a meno del racconto – anche se per molto tempo continua a faticare davvero a farne a meno. E la nascita della pittura di genere, a sua volta, è legata alla diffusione di un modo diverso di utilizzare la pittura, in cui il privato (e l’arredamento delle case) gioca un ruolo particolare.
Comunque sia, nel corso del Rinascimento la pittura impara a costruire il proprio discorso da sé, e a fare a meno della necessità di una parola che l’accompagni. Quando Velázquez dipinge Las Meninas, l’acquisizione è pienamente compiuta, e la pittura è già qualcosa di molto simile a quello che intendiamo oggi.
Ma se le cose stanno così, e la pittura è stata sino a tutto il medioevo sostanzialmente narrazione per immagini, allora il problema storico non è quando sia nata la narrazione per immagini, bensì semmai quando sia nata la pittura intesa in senso moderno. In questa prospettiva, il discendente diretto di (poniamo) Paolo Uccello non è Pablo Picasso, ma Winsor McCay!
Certo, il fumetto, inteso in senso stretto, non poteva nascere prima. Gli mancava la possibilità di riprodurre tecnicamente le immagini per il grande pubblico – ma soprattutto gli mancava l’abitudine nel pubblico alla lettura e di conseguenza alla sequenzialità ad essa legata. Quando nel corso del Rinascimento a una pittura legata alla parola si sostituisce progressivamente (e mai del tutto, come sanno bene i teorici visivi della Controriforma) una pittura autonoma, autoesplicativa, la percentuale di coloro che sono avvezzi alla lettura e alla sequenzialità è ancora minima rispetto alla totalità dei fruitori delle immagini. Un’arte visiva sequenziale autonoma non può davvero nascere se non c’è nel suo pubblico una competenza sequenziale sufficientemente evoluta.
Nei due secoli che seguono, la narrazione per immagini vive un’esistenza più sotterranea, mentre l’alfabetizzazione si diffonde, e la cultura stampata inizia ad assumere forme anche popolari. Ma è interessante che l’evento scatenante, quello da cui esplode davvero il fumetto in senso stretto, avvenga negli Stati Uniti, nel medesimo contesto in cui nasce anche l’altra grande creazione artistica originale americana: il jazz.
Le riflessioni che state leggendo provengono da un incontro fortuito che ho fatto oggi in rete, un articolo di Giorgio Rimondi sul jazz dove si dicono (con tre anni di anticipo) cose piuttosto simili a quelle che ho scritto anch’io in un post di qualche settimana fa sulla scrittura e sulla musica. Rimondi ritiene, come me, che il jazz sia nato come reazione dell’oralità (con tutte le sue potenzialità espressive) al dominio della scrittura in ambito musicale. Ovviamente, la scrittura ha permesso alla musica un’evoluzione che altrimenti le sarebbe stata impossibile; ma le ha anche chiuso una serie di possibilità, che hanno continuato ad esprimersi nelle tradizioni popolari, senza però possibilità di accesso alla sfera colta, pubblica, di grande diffusione. Il jazz rappresenta questa mediazione: quella delle istanze dell’oralità, dell’espressività diretta, portate in un contesto sia popolare che colto.
La coincidenza del contesto di nascita tra fumetto e jazz mi ha sempre colpito; ma solo alla luce di considerazioni come queste sul rapporto tra scrittura e oralità, si può capire come non si tratti di una semplice casualità. Tutte e due le nascite avvengono in America, a cavallo tra i due secoli, in un contesto di minoranze etniche alla ricerca dell’integrazione; in un mondo nuovo che, in quanto tale, è sufficientemente slegato dalla tradizione da poter accettare più facilmente le innovazioni; in un mondo nuovo che si gloria di essere la patria della democrazia, dove non esistono privilegi di casta né alcun tipo di nobiltà – ma anche in un contesto di ricchezza crescente, di fiducia nel futuro, e di volontà di sviluppare un’identità propria, sufficientemente distinta da quella della vecchia Europa, nonostante essa resti comunque l’inevitabile punto di riferimento.
È questa situazione particolare che permette il riemergere di istanze che in Europa sarebbero probabilmente rimaste ancora a lungo sommerse: quella di una musica meno intellettualmente legata ai rigori geometrici della scrittura musicale, e quella di una narrazione per immagini finalmente dotata di un pubblico e di una tecnologia riproduttiva adatti. Queste istanze spingevano dappertutto, nell’Occidente, ma in Europa l’inerzia della tradizione le avrebbe probabilmente tenute ancora sotto controllo a lungo, se non per sempre. In America, viceversa, erano funzionali a quel diverso contesto.
Detto questo, si potrebbe pure osservare che non solo nel jazz ma anche nel fumetto sono in realtà presenti delle istanze orali importanti, e che, se pure di una sorta di scrittura si tratta, il fumetto è una scrittura che riproduce in immagine i corpi e li dota di parola diretta, ricreando in qualche modo con la sequenza delle vignette la sequenzialità della dimensione orale. Qualche accenno a questo tema l’ho fatto anche qui. Più estesamente ne parlo invece in un saggio che dovrebbe essere in uscita sulla rivista Fictions. Studi sulla narratività, dal titolo “Disegni che parlano. Il fumetto tra oralità e scrittura”.
Ieri ho commemorato troppo brevemente Frazetta utilizzando i pochi minuti che avevo a disposizione per farlo. Ho lodato l’originalità della sua donna-gatto, a dispetto del tema ormai troppe volte utilizzato da tanti. Voglio tornarci su ora, con più calma, per capire che cosa renda così intrigante quella immagine. Un po’ come cercare, attraverso un’attenta osservazione, di carpire qualche segreto dell’arte di Frazetta.
Osserviamo, dunque. L’immagine è complessivamente scura, ma i colori sono brillanti lo stesso. A parte la figura della donna, il colore che domina il primo piano è questo verde smeraldino, che sfuma ai lati verso il blu, con qualche macchia giallo-rossastra.
 Frank Frazetta, Cat-girl In quest’area che perde definizione man mano che ci si allontana dalla zona centrale sono nascoste le pantere, nere o maculate, che si rivelano allo sguardo progressivamente, una dopo l’altra, come se uscissero materialmente dall’oscurità in cui sono nascoste. Questo effetto è anche dovuto al fatto che l’attenzione di chi guarda è attirata verso il centro da diversi fattori, mentre la periferia gode qui di un privilegio decisamente minore. Questi fattori sono:
- la presenza di una figura umana, in particolare femminile, con una certa carica erotica – nella quale si riconosce facilmente lo stereotipo inquietante della donna-gatto;
- l’intreccio delle figure serpentine dei tronchi coperti di muschio, inanimati ma al tempo stesso contorti come se si stessero muovendo (quasi dei lunghi colli di dinosauri);
- la minore definizione dell’immagine man mano che ci si allontana dal centro;
- i colori poco saturi della figura femminile, contrapposti a quelli molto saturi attorno;
- la luce improvvisa sul seno di lei, posto quasi al centro esatto dell’immagine;
- lo sguardo della donna, rivolto verso di noi.
Al centro dell’immagine sta dunque l’elemento più palesemente erotico, il seno, che però è collegato allo sguardo della donna (anche per simmetria): l’attenzione viene catturata dal seno, per poi scivolare sullo sguardo. L’attenzione dello spettatore oscilla così tra questo centro ambivalente e i dettagli della periferia, dove la scoperta progressiva degli altri sguardi, quelli delle pantere, ribadisce sempre di più, momento dopo momento, il legame che lega i felini alla donna. Tutti ci stanno guardando, tutti emergono dall’ombra; ma gli occhi dei felini brillano, mentre quelli di lei sono della stessa ombra che circonda il suo viso. I suoi occhi oscuri si contrappongono ai suoi seni luminosi.
Questa è dunque la macchina retorica che guida l’attenzione di chi guarda, inquieta e oscillante. Il fulcro di questa attenzione è la donna stessa.
La donna è brevilinea e muscolosa, ma insieme anche morbida, rotonda: complessivamente all’opposto del modello longilineo che domina nell’immaginario del fumetto e del fantasy. È scura, dai capelli neri e dai lineamenti esotici, proprio come una pantera. Le sue gambe sono ancora più scure, o magari sporche di fanghiglia, proprio come quelle di un animale.
Nella zona illuminata spicca il dettaglio dell’asimmetria dei seni, essendo quello destro leggermente allungato dal sollevamento del braccio. Questa asimmetria, oltre a far risaltare la carnosità dei seni e della donna, rafforza la strategia antistatuaria. Se questa è una donna ideale, allora appartiene a un ideale che non è quello che normalmente ci aspetteremmo qui.
È quindi la sorpresa a rendere di colpo viva questa figura così volutamente imperfetta, e la sua carne immediatamente così vera che quasi ci sembra di poterla toccare. Ma se stiamo per toccarla, allora siamo lì, e quella che abbiamo davanti non è più donna di quanto non sia pantera, e ci sono i rami serpentini verde smeraldo, e le pantere immobili che respirano nell’ombra tutt’attorno. Se siamo lì, insomma, stiamo sospesi tra erotismo e pericolo mortale, e lo sguardo di lei promette insieme l’uno e l’altro; e lo stesso fa il suo gesto, di indifferenza e un po’ di sfida – come l’avessimo sorpresa, lei e le sue pantere, ma fossimo noi assai più sorpresi di lei, tutto di un tratto incerti tra il desiderio e lo spavento.
11 Maggio 2010 | Tags: Frank Frazetta, fumetto | Category: fumetto |  Frank Frazetta, 1964, da Creepy Non è che Frank Frazetta sapesse solo disegnare. Ci sono tanti disegnatori dotati di tecnica strabiliante, al mondo. E poi i suoi debiti nei confronti di Alex Raymond sono stati davvero grandi come una casa.
Quello che Frazetta ha fatto, semmai, attraverso la sua sapienza di disegnatore, è stata la costruzione di innumerevoli mondi inquietanti, che restavano inquietanti anche a dispetto della banalità dei temi. Quanti guerrieri armati e possenti abbiamo già visto sulle copertine del fantasy? Quante donne da sognare abbiamo già sognato in innumerevoli illustrazioni di quel tipo?
Ma ci sono quelle che restano e quelle che no, quelle che vengono prima e quelle che cercano di riprodurre quel fascino impossibile. Frazetta è stato il disegnatore dei fascini impossibili, a dispetto del già visto, a dispetto del banale.
E’ stato quel disegnatore che mi permette ancora oggi di continuare a sognare sulla femmina-gatto come se non fosse ormai uno stereotipo fritto e rifritto. Nei suoi disegni, continua a non esserlo. Per sempre, suppongo.
 Frank Frazetta, Cat-girl
9 Maggio 2010 | Tags: Alberto Breccia, fumetto, L'Eternauta | Category: fumetto | Passando ieri notte davanti a una vetrina di Feltrinelli mi casca l’occhio su un libro esposto, appena uscito. Non posso non notarlo. È uno dei fumetti che hanno segnato la mia storia di lettore, uno di quelli a causa dei quali io ora sono qui a tenere un blog, scrivere libri, discutere di racconti per immagini, invece di occuparmi – che so – di calcolo dei predicati.
È L’Eternauta, di Héctor Oesterheld, ma non nella versione classica di Francisco Solano López della fine degli anni Cinquanta, bensì nel remake realizzato da Alberto Breccia nel 1969 e pubblicato in Italia su Linus nel 1972. Lo ripubblica oggi Comma22, all’interno di una serie tutta dedicata a Breccia.
Credo che quella di Linus fosse la prima comparsa del Breccia maturo in Italia. L’effetto di quelle chine istoriate e graffiate, di quelle composizioni calibrate, e soprattutto di quell’espressionismo – l’espressionismo di Breccia – fu spaventoso.
E anche la storia (riscritta da Oesterheld per Breccia con tinte ancora più cupe che nella sua versione originale) era di quelle che non si dimenticano – e insegnano drammaticamente che un fumetto di fantascienza può essere un fumetto politico.
 Alberto Breccia e Héctor Oesterheld - L'Eternauta pag.02
 Alberto Breccia e Héctor Oesterheld - L'Eternauta pag.12 Ci dice la cronaca che la versione Breccia dell’Eternauta non ebbe fortuna. Non piaceva all’editore della rivista su cui compariva. È un peccato per lui, e per noi tutti, a cui non è stata data la possibilità di leggere un seguito.
Sto scrivendo un articolo sull’horror a fumetti, per un’iniziativa di cui presto si saprà di più. Mi sono ripercorso a grandi linee le diverse stagioni dell’horror di qua e di là dall’oceano (solo l’Atlantico: per il Pacifico non avrei avuto spazio) e ho fatto alcune scoperte. Lasciando perdere i casi isolati, le stagioni principali dell’horror occidentale a fumetti, viste da qui (Italia, 2010), mi sembrano le seguenti:
- la stagione E.C., dal 1950 al ’54, tarpata dalle fisime del dr. Wertham
- la stagione Warren, dai tardi Cinquanta in poi, comprensiva di Vampirella (dal ’69)
- i porno-horror italiani anni Settanta (tipo Jacula, Sukia e Cimiteria)
- un po’ di Argentina sparsa, dal Mort Cinder di Breccia e Oesterheld in poi
- Dylan Dog e il post-Sclavi, dall’effimera esplosione horror italiana del ’90 ai successivi prodotti Bonelli, da Magico Vento a Brendon a Dampyr
- quello che potremmo chiamare il neo-gotico americano, ovvero Swamp Thing e discendenti più o meno diretti (Hellblazer, Sandman ecc.)
La domanda è: quanto di questo horror è fatto per fare davvero paura? Naturalmente, in quanto horror, tutto è fatto per fare almeno un po’ paura. Però, se lo osserviamo da vicino, ci accorgiamo che il più delle volte la paura è abbondantemente condita con altri ingredienti, che nell’impasto risultano assai più salaci.
Per esempio, tutta la produzione E.C. è giocata sul grottesco, ovvero su uno humor nero sarcastico e mortifero: e anche quando si sobbalza per lo spavento c’è sempre una voce più o meno fuori campo che propone di riderci su (magari amaramente – ma pur sempre riso è).
La produzione Warren degli anni Sessanta ripropone (con meno vivacità) esattamente lo stesso modello, ma si riscatta con Vampirella – su cui lavoravano fior di sceneggiatori e disegnatori. Con Vampirella entra in gioco una sorta di erotismo gotico, e anche una qualche dose di superomismo. Vampirella potrebbe forse fare davvero più paura, se non fosse che la protagonista è troppo carina e svestita, e il tutto troppo fantastico e buonistico.
L’erotismo di Vampirella è il punto di partenza per i porno-horror italiani, ma qui già la definizione dice tutto: l’horror è una scusa per condire meglio il sesso, attraverso la tradizionale combinata sesso-grandguignol.
Dylan Dog trova un altro modo, assolutamente originale, per esorcizzare la paura. Lo si capisce benissimo sin dal primo numero, quell’Alba dei morti viventi che è una citazione già nel titolo: l’horror diventa gioco intellettuale, un gioco che è spesso praticabile anche da chi abbia una cultura massmediatica popolare, ma non meno gioco e non meno intellettuale per questo. La paura non può essere vera, in questo contesto: sarà necessariamente un gioco di citazione, pure lei!
Sin qui dunque (e abbiamo già fatto fuori, quantitativamente, il grosso dell’horror a fumetti) di paura vera ce n’è stata poca. Proviamo a domandarci perché.
Ho accennato in altri due post (qui e qui) della nascita del romanzo gotico nell’Inghilterra del Settecento, e di quanto sia legata questa nascita alla diffusione della nozione di sublime, che, guarda caso, è la stessa che sta dietro alle concezioni Romantica e moderna dell’arte. Il romanzo gotico, ovvero il primo horror, rappresenta l’esito più popolare (ma non solo) di questa diffusione: il mistero e l’orrore sono la manifestazione più semplice ed evidente di quello che è soverchiante e incontrollabile.
La cultura alta ha spesso riso di questa manifestazione bassa dei propri medesimi ideali, anche se più volte vi ha attinto a piene mani (come si può leggere, tra l’altro in un intrigante volumetto di Renato Giovannoli, Il vampiro innominato. Il “Caso Manzoni-Dracula” e altri casi di vampirismo letterario, Medusa 2008). Del resto non è difficile trovare occasione di ridere di cose di questo genere, che diventano molto facilmente troppo poco credibili, persino in un’ottica di fiction.
Il grottesco, l’erotismo, il citazionismo sono quindi altrettante strategie per permettere di tollerare questa natura volgarissimamente sublime che è propria dell’horror. Insomma: fare davvero paura, e avvicinarsi in questo modo al sublime stesso, è cosa molto, molto difficile – quando non si possiedono gli strumenti realistici del cinema (fotografia, ovvero pseudo realtà, movimento e sonoro) e la comprensione dei fatti è inevitabilmente mediata da una serie di ricostruzioni intellettuali (decifrare i disegni, metterli in sequenza, ricostruire la dinamica, collegare le parole…). È più facile, e spesso anche più efficace, giocare in vario modo con gli stereotipi e con quel poco di paura che comunque essi si portano attaccata.
Non è però sempre così, e il nostro elenco iniziale non è stato del tutto esaurito. Resta fuori certamente Breccia e anche una parte del fumetto argentino (mentre tanto altro rientra in qualche modo nei casi già visti); resta fuori una parte della produzione Bonelli post-Sclavi, come nel caso di Dampyr, in cui il citazionismo è marginale rispetto ad altro, assai più pauroso; e resta fuori quello che ho chiamato neo-gotico americano, ovvero le conseguenze della ripresa compiuta da Alan Moore, nel 1984, di Swamp Thing.
È tra questi esempi che troviamo dei fumetti horror che fanno davvero paura. È evidente che appartengono a culture diverse e anche a momenti storici diversi. Che cos’hanno in comune, sempre che lo abbiano?
La mia personale suggestione è che le storie che questi fumetti mettono in scena parlano di me e del mondo in cui vivo – mentre tutte le altre storie di cui abbiamo parlato, di buona o cattiva qualità che siano, parlano sostanzialmente di mostri immaginari. Il male che circonda Swamp Thing nelle storie di Moore ha sì la faccia tradizionale dei non-morti, ma è evidentemente un male molto più vero e vicino a noi: è la bomba atomica, è la discriminazione sociale, è la voracità capitalistica, è la stupidità, l’arroganza, il potere che non vuole limiti…
Solo a queste condizioni la nostra paura può rinascere davvero. E solo una vera paura può generare una paura letteraria che non sia puro gioco. La paura vera può essere sublime, in qualche caso. Il gioco è invece gioco: può essere intelligente, di alta qualità, ma è un’altra cosa.
Sento alla radio che si parla di Dino Buzzati. Sono settant’anni quest’anno che è stato pubblicato Il deserto dei tartari. Buzzati è stato una delle grandi passioni della mia maturazione culturale, passione che ho poi ripreso in più occasioni in tempi recenti, scrivendo alcuni saggi sulle sue opere, e dedicando anche un capitolo di un mio libro all’analisi di un suo racconto.
Credo che il mio amore per Buzzati sia parente della mia passione per l’universo del fumetto. Non che si debba cercare una relazione di causa-effetto tra le due cose, ma probabilmente esiste per loro una ragione comune – sostenuta anche dal fatto concomitante che pure Buzzati è stato un grande lettore di fumetti, e un difensore del loro valore, in un’epoca in cui era davvero assai più difficile di oggi sostenerne la qualità.
 Dino Buzzati, Piazza del Duomo di Milano, 1958 Ho amato Buzzati, credo, per la sua capacità di vedere il fantastico nel quotidiano, e di raccontare il quotidiano attraverso il fantastico. Buzzati si dilettava di pittura, e anche se non era proprio un virtuoso del pennello, le sue invenzioni visive lasciavano spesso il segno, come quell’immagine di Piazza del Duomo, a Milano, rappresentata come se fosse un pascolo dolomitico, circondata da rocce discoscese, la principale delle quali è il medesimo Duomo – un’immagine che potrebbe essere presa a emblema del suo modo stesso di raccontare: il fantastico, l’inquietante, l’altrove, nascosti in quello che ci sta davanti tutti i giorni.
Questo medesimo amore per il fantastico ha spinto me, in quegli anni, a leggere tanta fantascienza, e a preferire quella in cui l’elemento immaginativo non rescindeva il legame con la quotidianità della vita. Ho sempre trovato che l’universo del fumetto contiene, ovviamente in diversa misura a seconda dei casi, questa medesima relazione – e non a caso ho finito per amare un autore come Lorenzo Mattotti, molto tempo prima di sapere dalla sua stessa voce che pure lui era una vittima della stessa fascinazione giovanile per Buzzati di cui ero stato preda io. Ma chissà quanto Buzzati è presente nel lavoro di David B.? Non sarebbe sorprendente scoprire che anche lì c’è stato un influsso, visto che Buzzati è diventato famoso in Francia prima che in Italia (una storia ricorrente, e particolarmente ricorrente nel mondo del fumetto, come lo stesso Mattotti ben sa).
Non mi ha stupito invece scoprire (non molti anni fa) che Buzzati era anche un ascoltatore appassionato di musica, e che ha anche scritto dei libretti musicali. Ma questo ci porta a domandarci se ci sia un legame anche tra questa passione musicale e quella per il fantastico e per il fumetto. Certo, non è detto che ci sia, perché non è corretto ricondurre la personalità di un essere umano a un solo principio: siamo interessanti anche perché siamo fatti di tanti pezzi diversi, a volte collegati ma a volte anche contraddittori! La passione per la musica può ben appartenere a un ambito differente della personalità da quella per il fumetto e da quella per il fantastico.
Tuttavia Buzzati ci ha fornito un motivo molto forte per vedere il collegamento tra loro, e questo motivo è il Poema a fumetti. Il protagonista di questo romanzo è Orfi, un cantautore, che scende agli inferi per farsi restituire la sua Eura, e oltrepassa tutti gli ostacoli (tranne l’ultimo) grazie alla commozione prodotta dalla sua musica. Il mito di riferimento è quello, evidentemente, di Orfeo ed Euridice, che è già un mito sulla musica e sul suo potere. Ma Buzzati aggiunge a questo il fatto di costruire il suo Poema a fumetti proprio come si costruisce un melodramma, e la musica non ne è solo l’argomento del discorso, ma anche, metaforicamente, ciò che accompagna e modula continuamente il racconto. Non potendo fare uso di note e di suoni in un’opera a stampa, Buzzati adopera la forma del fumetto per ricoprire questo ruolo di musica metaforica: così, la capacità fantasmatica ed emotivamente coinvolgente del raccontare a fumetti diventa metafora del potere descrittivo e trascinante della musica.
 Dino Buzzati, due pagine da Poema a fumetti Poi, certo, Buzzati non era un disegnatore straordinario, e non era nemmeno un fumettista. Lo si capisce per la sua palese ignoranza di una serie di espedienti narrativo-visivi, che già negli anni Sessanta erano ampiamente usati. I lettori di fumetti dell’epoca non amarono Poema a fumetti, e credo che la ragione fosse proprio questo senso di estraneità alla norma che comunque, in quanto fumetto, questo romanzo (una prima graphic novel, qualche anno prima di Will Eisner) produce nel suo lettore. Ma non si può giudicare il lavoro di Buzzati con questi parametri.
Bisogna piuttosto capire che Buzzati ha cercato di ricostruire, con i propri mezzi e per le proprie necessità espressive, la narrazione a fumetti come un supporto narrativo potente, e legato all’idea di ritmo drammatico, con riferimento alla funzione della musica nel melodramma. Poema a fumetti è una proposta per un altro modo di fare fumetti – un modo che per gli anni Sessanta era troppo differente, ma che ha poi dato i suoi frutti dagli anni Ottanta in poi, quando autori con capacità grafiche e competenze fumettistiche decisamente superiori alle sue hanno scelto quella stessa strada.
Il legame suggerito da Buzzati tra fumetto, musica, racconto fantastico, e anche poesia (Orfi è un cantautore, che scrive testi poetici per la musica) è, guarda caso, anche al centro dei discorsi di questo blog. Anche questo è, dunque, uno dei frutti dei semi sparsi allora.
P.S. Se siete interessati a un discorso più approfondito sul legame tra musica (poesia) e fumetto nel Poema a fumetti, potete leggere qui l’intervento che tenni qualche anno fa a un convegno sul lavoro di Dino Buzzati.
Ho scoperto Mumin intorno al 1970. Stava su un supplemento di Linus dell’anno prima, finito in casa mia non so come. Allora si chiamava Moomin, all’inglese, perché, nonostante l’origine finlandese dell’autrice (e la sua lingua-madre svedese), a noi arrivava attraverso i suoi successi britannici. Fu per me una specie di colpo di fulmine, per la sua sottile demenzialità, per la sua tenerezza, per la sua capacità di rendere il mondo una fiaba, per il suo essere un fumetto che sembrava per bambini e non lo era affatto. Negli anni successivi, e per molto tempo, ne sono stato su Linus un appassionato lettore – fino a quando la stagione di Moomin è finita, e del fumetto in Italia si sono perse le tracce.
(Di passaggio: in quel supplemento di Linus – li’l linus, aprile 1969 – scoprivo contemporaneamente Li’l Abner, Popeye, Valentina e Jeff Hawke, più altre delizie minori – minori almeno per il mio gusto, visto che di tutte quelle maggiori sono stato da allora in poi un lettore quasi ossessivo. E questo comunque la dice lunga sulla qualità dell’operazione di Linus di quegli anni.)
Per chi non lo sapesse, il Mumin (o Moomin) di cui sto parlando è la versione a fumetti di una fortunata serie di romanzi per ragazzi, realizzata da Tove Jansson, e molto amata anche nei paesi di lingua inglese. Il fumetto è disegnato da suo fratello Lars. Dei romanzi c’è stata in Italia una serie di traduzioni, a partire dalla fine degli anni Ottanta, pubblicati dalla Salani e curati da Donatella Ziliotto. Il fumetto è invece quasi scomparso, per riapparire or ora in una bella edizione di Black Velvet, primo volume (si spera) di una serie cronologica completa.
Quando l’ho avuto in mano, ho pregustato l’emozione di rileggerlo, di ritrovare il piacere trasognato e divertito che le storie degli Jansson mi hanno sempre procurato.
E invece non è successo nulla, o quasi. Ho trovato un bel fumetto per bambini, sottile nel suo essere grottesco e insieme romantico, pieno di trovate brillanti. Insomma, comunque, un classico. Ma non qualcosa capace di destare in me una passione come quella che aveva risvegliato allora. Se lo leggessi ora per la prima volta, lo apprezzerei certamente, ma non mi sorgerebbe quel desiderio di averne ancora e poi ancora.
Mi sono domandato perché. C’è una prima risposta del tutto ovvia: nel 1970 avevo 40 anni in meno di oggi, e benché per certe cose io mi senta ancora la passione del ragazzino di allora, può davvero darsi che io non sia più lo stesso. Inoltre, le cose che si portano racchiuse nel ricordo per tanto tempo tendono a ingigantirsi, e magari io ho mitizzato Moomin. O forse ancora, quando lo leggevo allora, Moomin rispondeva a delle esigenze mie che nel frattempo sono cambiate – indipendentemente dal fatto che ora sono più vecchio, ma semplicemente perché vivo una vita diversa.
Tutto questo può essere: tra Moomin e Mumin magari non c’è differenza, ma nel suo lettore sì. Però nel leggere l’edizione Black Velvet qualcosa non mi quadrava lo stesso, e sono andato a cercarmi la copia di li’l linus dove l’avevo incontrato allora. E così, comparando Mumin con Moomin, la differenza è saltata fuori, ed è una differenza di traduzione.
Il sospetto lo avevo avuto già quando avevo letto il nome della fidanzata di Mumin, cioè Grugnina. Io ricordavo un nome più dolce e più ironico. E, in effetti, nella versione Moomin, lei si chiamava Adipella. Nelle note in fondo al libro si sottolinea che la traduzione dei nomi rispetta quella fatta da Donatella Ziliotto, e capisco bene che non sia facile trovare un corrispondente italiano per lo svedese Snorkfröken, o per il finlandese Niiskuneiti. Ma per gli inglesi il medesimo personaggio è Hattifatteners, e Adipella ha la stessa sfumatura di delicata grassezza – mentre Grugnina a me suona tanto di ingrugnato.
 Moomin vs Mumin Es. 1 E poi c’è il toscano. Certo, far parlare dei troll finlandesi come dei villici di San Casciano in val di Pesa era una scelta parecchio azzardata – e non so davvero quanto fosse giustificata dal linguaggio dei personaggi originali (ma quale poi? il finlandese, lo svedese o l’inglese?). E tuttavia questa idea era talmente stralunata, che, magari un po’ paradossalmente, corrispondeva davvero alla dimensione a sua volta stralunata del mondo di Moomin.
 Moomin vs Mumin Es. 2 Nella versione Black Velvet, i troll finlandesi parlano un corretto italiano. Poiché conosco bene la passione e la serietà dei curatori Omar Martini e Sergio Rossi, non ho alcun dubbio sul fatto che la scelta è stata meditata, e che si è preferito conservare la coerenza con la traduzione Ziliotto. Però così, per quel vecchio lettore di Moomin che sono io, Mumin non è più Moomin. E con quel toscano così assurdo ma così caratterizzante, se ne è andata anche una fetta del fascino di una volta.
 Moomin vs Mumin Es. 3 Ah. Qualche romanzo di Moomin me lo sono anche letto, molti anni fa, in inglese. Nemmeno lì avevo ritrovato lo stesso fascino dei fumetti pubblicati da Linus. E allora davvero: o la bellezza delle cose che vediamo dipende dallo stato d’animo in cui ci troviamo quando le incontriamo, oppure il merito era tutto del toscano, e di chi ebbe questa stramba idea.
20 Aprile 2010 | Tags: Charles M. Schulz, comunicazione visiva, Floyd Gottfredson, fumetto, graphic design, José Muñoz, marchio, semiotica, sistemi di scrittura, stilizzazione, Will Eisner | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, semiotica, sistemi di scrittura | Colgo l’occasione del dialogo seguito al mio post precedente (Della comunicazione visiva e della lista) per ricollegarmi ai temi di un libro importante appena uscito: è il libro di Will Eisner, L’arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei grandi disegnatori (a cura di Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis, BUR Rizzoli). Si tratta dell’edizione italiana congiunta di due libri diversi (ma evidentemente collegati) nei quali Eisner spiega le regole di base dell’arte sequenziale, ovvero della letteratura a fumetti. Per chi fa fumetti o aspira a farne, è una lettura obbligatoria. Per chi li legge con un interesse che vada al di là della risata o del sapere come va a finire la storia, è comunque una lettura fortemente consigliata – e anche piacevole, non foss’altro che per l’ampia quantità di esempi (anche storie intere) che vi vengono presentati.
Nel dialogo con Stefanelli e “un ospite”, quello che emerge è il tema della semplificazione, o meglio stilizzazione. Alla fine sembra che ci ritroviamo tutti d’accordo su questa frase: “da un lato si deve poter riconoscere con facilità i personaggi e le situazioni, dall’altra essi devono rimanere espressivi e vivaci”. Il manuale di Eisner è molto ricco, ma lo si potrebbe riportare, come morale di fondo, proprio a un principio di questo genere: da un lato il fumetto richiede una stilizzazione grafica e narrativa di personaggi e situazioni che permetta al suo lettore di riconoscerli (sia come esemplari di una casistica nota, sia nelle loro varie ricomparse nella sequenza di una vicenda narrata a fumetti); dall’altro, senza una complessità espressiva sufficiente non si producono fumetti interessanti.
Il principio non riguarda solo il fumetto. In ambito narrativo troviamo da sempre la stessa polarità tra stilizzazione ed espressività. Ma è interessante osservare che in ambito visivo il problema inizia a porsi con maggiore decisione nel corso dell’Ottocento, proprio quando la diffusione di una cultura visiva di massa (nella stampa e nella comunicazione aziendale) segna un punto di svolta rispetto alla visività tradizionale, espressa soprattutto attraverso la pittura e le belle arti in genere.
Non che in pittura il problema non si ponga, ma un oggetto visivo che deve rispondere sostanzialmente a una limitata committenza può contare su una specificità di competenze su cui non può contare un oggetto visivo pensato per una fruizione di massa. Sappiamo bene che il limite della stilizzazione grafica possibile è rappresentato dalla parola scritta: qualunque parlante italiano legga (per esempio) queste parole scritte, le riconosce al medesimo modo (poi magari le interpreterà in mille modi diversi, ma questo non è più un problema di stilizzazione visiva). I marchi aziendali che iniziano a diffondersi dalla fine dell’Ottocento tendono a una stilizzazione/standardizzazione di questo genere: vogliono essere una sorta di “parole visive”, che rimandano direttamente e univocamente all’azienda che rappresentano. Il linguaggio della pubblicità, che inizia a diffondersi in quei medesimi anni, nella misura in cui esibisce componenti visive (quelle verbali sono state per parecchio tempo dominanti), gioca su queste medesime stilizzazioni e immediate riconoscibilità.
Graficamente, il fumetto (e tutti i suoi predecessori ottocenteschi di letteratura per immagini) nasce e si sviluppa in un contesto di questo genere, e i suoi autori delle origini sono ben consapevoli del fatto che i loro personaggi possono diventare dei veri e propri marchi, immediatamente riconoscibili, purché siano progettati opportunamente. Questo aspetto è indubbiamente presente nel progetto di Yellow Kid (e in particolare di Buster Brown), ma anche dei Katzenjammer Kids, di Little Tiger e di Mutt & Jeff.
Ma non è questo l’unico motivo per cui il disegno del fumetto nasce in questa forma così semplificata. L’immagine stilizzata e facilmente riconoscibile permette una lettura più veloce, e quindi una scansione ritmica del testo che sarebbe messa in forte difficoltà da immagini più realistiche e più incertamente riconoscibili. Su questa dimensione ritmica del racconto a fumetti Eisner insiste diffusamente: una buona scansione ritmica è il requisito essenziale di una storia di qualità, ancora di più della qualità grafica delle immagini.
 L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 2  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 3 Un esempio straordinario, più vicino a noi, di quanto la stilizzazione grafica abbia contribuito al successo e alla qualità di una serie a fumetti (e anche, va certamente detto, al suo sfruttamento in termini di branding) è quello dei Peanuts di Charles M. Schulz. C’è un articolo del 1976 (“Les Peanuts: un graphisme idiomatique” Communications, 24) in cui Guy Gauthier mostra come le figure dei personaggi dei Peanuts possano essere costruite articolando un piccolo numero di elementi grafici, corrispondenti alle teste, ad alcuni tipi di espressioni facciali, ad alcune posizioni del corpo e delle sue estremità, secondo un procedimento di articolazione che ricorda quello del linguaggio verbale. Ne otteniamo una sorta di grammatica grafica dei Peanuts, ovvero un sistema degli elementi di base e delle combinazioni permesse e vietate.
Seguendo questa metafora sino in fondo (e anche oltre le intenzioni di Gauthier) si potrebbe pensare che i Peanuts siano un sistema di scrittura, dove poi tutta la ricchezza interpretativa (che, come sappiamo, è in questo caso enorme) si dispiega al livello del significato – proprio come con la scrittura verbale: le parole sono in numero limitato, e si possono combinare in un numero limitato di modi; quello che si legge è, al livello del significante, immediatamente comprensibile e semplicissimo; tutta la complessità e la ricchezza semantica si dispiegano a livello del significato.
Le cose, di fatto, non stanno sempre così neanche con la scrittura verbale, nel cui ambito la dimensione poetica costituisce già un controesempio. Ma neppure il disegno dei Peanuts può essere davvero ridotto alla grammatica di Gauthier: per quanto Schulz giochi il più possibile sulla semplificazione e standardizzazione, già le stesse variazioni minime del suo segno grafico producono differenze espressive enormi. E se invece di Schulz prendiamo Floyd Gottfredson come oggetto di analisi, non solo la “grammatica” di base diventa talmente complessa che non vale la pena di descriverla, ma sono soprattutto gli scarti espressivi rispetto alle regole a farcelo apprezzare e amare: Mickey Mouse va rappresentato certamente in questo e questo modo (anche perché è – lui più di tutti – un marchio), tuttavia, una volta fatta salva la riconoscibilità, è l’espressività grafica che conta! Questo, ovviamente, non taglia fuori tutta quella complessità che appartiene alla dimensione del significato e che, come abbiamo visto, caratterizza la scrittura verbale: essa ci può essere anche qui, nel medesimo modo, ma è anticipata, percettivamente, da una complessità espressiva di carattere grafico che la parola non può avere (se non nelle sue dimensioni calligrafiche, o di tipografia espressiva – ma con modalità molto diverse, e non ne parleremo qui).
Eisner appare, nel suo libro, ugualmente preoccupato di costruire la riconoscibilità (attraverso forme di stilizzazione e standardizzazione) e di garantire l’espressività (attraverso opportune deviazioni dalla norma). Comunque sia, il realismo, o naturalismo, rimane del tutto fuori gioco: una storia che ci appare come realistica è una storia che si basa su delle stilizzazioni che noi riconosciamo perché sono le stesse che applichiamo al mondo reale per comprenderlo; e che poi si allontana da quelle stilizzazioni in una maniera che è grosso modo imprevedibile quanto lo è la realtà rispetto alle nostre aspettative – in altre parole, che è imprevedibile in misura che possiamo prevedere e accettare. Se ci si allontana da questo standard si va o verso il noioso (l’eccessivamente prevedibile) o verso il difficile (l’eccessivamente imprevedibile).
Tutte le raccomandazioni di Eisner vanno verso la ricerca di questa difficile via di mezzo. E il libro è, proprio per questo, prezioso – anche se non tutte le sue affermazioni vanno prese come oro colato. Per esempio, da qualche parte Eisner raccomanda di non usare i balloon collegati per far dialogare di personaggi nella medesima vignetta. Gli esempi che propone sono convincenti. Ma noi sappiamo bene che, per esempio, Andrea Pazienza è riuscito a ottenere effetti di grande espressività proprio con questa tecnica. Evidentemente esistono dei casi, sfuggiti all’esperienza di Eisner, in cui la si può utilizzare con profitto.
Allo stesso modo, è anche possibile rendere il gioco più complesso di quello di Eisner dal punto di vista grafico: il lavoro di Muñoz e Sampayo di cui ho parlato pochi giorni fa qui ne è un esempio. Tuttavia il lavoro grafico di Muñoz non è un esempio di realismo: la stilizzazione è in opera, e fortemente, pure lì. Anzi, la sua deviazione grafica appare così fantasticamente espressiva proprio perché si basa su una stilizzazione evidente.
Insomma – e questo lo dico in particolare agli autori esordienti che devono leggere questo libro – i principi di base della proposta di Eisner sono quelli cruciali. Sulla loro applicazione specifica bisogna invece ragionare. Eisner ha trovato un modo esemplare di applicarli; ma esistono molti altri modi per farlo.
16 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, fumetto, Google, graphic design, immagini, liste, Pieter Bruegel il vecchio, poesia, ricerca, semiotica, sistemi di scrittura, tabelle, Web | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, poesia, semiotica, sistemi di scrittura | Ritorno dal congresso di Venezia dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva con alcune idee che provo qui a metter giù. Lo spunto me lo danno due delle diverse relazioni interessanti che ho ascoltato. La prima, di Vincenza Del Marco, riguardava la ricerca delle immagini sul Web e le difficoltà affrontate dai motori di ricerca per renderla possibile, con la conclusione che, tutto sommato, i motori che si basano sulle parole che accompagnano le immagini restano ancora più efficaci di quelli che si basano sulla somiglianza formale (eidetica e/o cromatica). La seconda, di Omar Calabrese, riguardava la natura di ”lista” (sulla scorta del libro recente di Eco) di diversi (non tutti) dipinti di Bruegel il vecchio, in particolare I proverbi fiamminghi e I giochi di bimbi.
Del discorso di Calabrese (che ha toccato più punti di quelli di cui mi occupo qui) mi interessa l’osservazione che, affinché il contenuto del dipinto possa essere concepito come lista (di proverbi, di giochi…) è necessario che gli elementi che costituiscono la lista siano ben riconoscibili e chiaramente concettualizzati: non a caso, infatti, sia dei proverbi che dei giochi (come dei diversi tipi di cecità che si possono osservare ne I ciechi) esistono liste verbali dell’epoca, da cui si vede chiaramente che i singoli elementi sono ben definiti. L’altra osservazione importante riguarda invece il modo di organizzare lo spazio, secondo una sorta di griglia di base prospettica, che permette di posizionare chiaramente ciascun elemento singolo, ponendolo in relazione con gli altri – e che deriverebbe, secondo la plausibile ipotesi di Calabrese, dalla frequentazione di Bruegel con il disegno delle carte geografiche dell’epoca, sulle quali era frequente non solo la visione assiale, ma anche quella assonometrica.
Ho già ragionato, in un post precedente di questo blog (e anche, in generale, su tutti i post etichettati con il tag sistemi di scrittura), sul legame che esiste tra la lista/tabella e la dimensione grafica. Dagli studi sull’antichità mesopotamica sappiamo che le liste sono precedenti alla scrittura intesa come trascrizione della parola orale, e che tutta una serie di capacità classificatorie (e matematiche) provengono da questa capacità di organizzazione grafica che ancora precede la parola scritta.
Insomma, le liste sono strumenti di organizzazione concettuale del mondo precedenti alla parola scritta, e che permettono di classificare, ordinare e contare su base grafica. Naturalmente, quando entra in gioco la parola, le liste si trovano ulteriormente avvantaggiate, perché la parola soddisfa con facilità il primo dei due requisiti elencati sopra: la riconoscibilità univoca e la chiarezza concettuale. Così, la lista (o tabella) di parole (o anche numeri, ovviamente) diventa facilmente il prototipo di un’organizzazione spaziale rigorosa (in questo caso, cartesiana) di concetti ben distinti e sufficientemente univoci.
Si noti che esiste un tipo particolare di lista che gode di un privilegio particolarissimo: quello di rendere graficamente la successione del discorso orale. Ne avete un esempio sotto gli occhi: questa lista di parole che state scorrendo in questo istante, organizzata secondo semplici regole che ne assicurano la sequenzialità (sinistra-destra, poi alto-basso), ha la proprietà di corrispondere, con sufficiente approssimazione, a una sequenza di discorso orale. Solo la sua natura grafica ci permette di coglierne la natura di lista: nell’oralità primaria la lista pura e semplice non c’è. Il passaggio attraverso la scrittura ci permette però di coglierla.
Voglio provare ora a fare un esperimento concettuale. Immaginiamo una tabella o diagramma cartesiano dove, nell’angolo in alto a sinistra posizioniamo le liste e tabelle fatte di parole (scrittura sequenziale compresa), intese come esempi (1) di massima chiarezza e distinzione dei singoli elementi e (2) di più rigorosa e definita organizzazione dello spazio che li organizza. Da questo massimo, procedendo orizzontalmente verso destra, immaginiamo di diminuire il valore (1), ovvero di porre artefatti visivi i cui singoli elementi sono, andando verso destra, progressivamente meno ben definiti. Andando verso il basso, invece faremo diminuire il valore (2) ponendo artefatti visivi con un’organizzazione complessiva sempre meno chiara. In questo modo, nell’angolo in basso a destra dovrebbero finire gli scarabocchi, ovvero le organizzazioni spaziali più confuse di oggetti per nulla definiti (quali sono infatti le unità di uno scarabocchio? lo scarabocchio è tale proprio perché non c’è nessuna chiara suddivisione possibile).
Tra i due estremi della lista/tabella verbale e dello scarabocchio può essere posizionata tutta la comunicazione visiva: verbale, non verbale e combinata. Una buona segnaletica, per esempio, come può essere quella che si trova ormai in tutti gli aeroporti, va posizionata praticamente nel medesimo angolo in alto a sinistra delle liste verbali: vi troviamo degli elementi ben distinti, univocamente significativi, organizzati secondo una griglia. È facile su questa base riconoscere alla segnaletica lo statuto di scrittura non verbale.
Tuttavia (e questo vale ancor di più per la scrittura verbale) le cose sono un po’ diverse quando la natura dei singoli elementi non ci è ancora del tutto chiara, perché ci troviamo ancora in una fase di apprendimento. Le segnaletiche sono create per essere autoapprese, e sono quindi molto più facili da acquisire della scrittura verbale; tuttavia al primo contatto con una segnaletica non è detto che i singoli elementi ci appaiano già del tutto chiari. In questo caso dovremo dunque posizionarla nel nostro diagramma un po’ spostata verso destra.
Un dipinto figurativo si trova invece posizionato di una certa e non piccola misura ancora più in basso e più a destra. Quanto spostato dall’origine esso sia dipenderà dalla qualità dell’organizzazione spaziale e dalla riconoscibilità dei singoli elementi. Tra i dipinti figurativi, quelli di Bruegel analizzati da Calabrese sono presumibilmente i più vicini all’angolo in alto a sinistra – ma certamente non possono arrivare a coincidere con la posizione delle liste verbali. Nella pittura è infatti necessariamente presente proprio una resistenza all’organizzazione troppo stringente e alla troppo semplice definizione degli elementi: un dipinto interessante non può assomigliare al tabellone di una stazione, il cui pregio è proprio quello di evitare di procurarci sorprese. Il valore di un dipinto, viceversa, sta proprio nel sorprenderci.
D’altra parte, il dipinto non può nemmeno raggiungere la posizione dello scarabocchio: neppure quello ci procura sorprese: la sua assenza di qualsiasi struttura lo impedisce.
Una tavola a fumetti, da parte sua, tende tende più del dipinto ad avvicinarsi all’angolo in alto a sinistra. Essa gode di un’organizzazione tabulare chiara (la gabbia grafica) e di elementi ben distinti (le singole vignette); tuttavia questi sono a loro volta al loro interno organizzati secondo una logica che è parente di quella del dipinto figurativo. Le tavole a fumetti tendono dunque a tenersi non lontano dal lato superiore, ma spaziano abbastanza nella dimensione orizzontale: l’elementarità delle figure dei Peanuts, per esempio, tende a posizionare il lavoro di Schulz piuttosto a sinistra nella nostra tabella, mentre la complessità di quello di Dave McKean o di Lorenzo Mattotti posizionerà il loro lavoro più a destra. Questo significa anche che McKean e Mattotti sono visivamente più interessanti (e meno semplici) di Schulz: il che, ovviamente, è sotto gli occhi di tutti.
Si potrebbe continuare il gioco, provando a posizionare lavori del mondo della grafica, della fotografia, del disegno tecnico e di vari generi illustrativi. Ma qual è l’utilità di questo gioco? Certo, il posizionamento è spesso difficile e quasi sempre discutibile. Ma il fatto di poter confrontare tutte le possibili comunicazioni visive nella medesima tabella ci permette (visivamente e tabularmente) di considerarle come istanze diverse di un medesimo principio, evitando o lasciando in subordine la tradizionale opposizione tra parole e immagini. Nel nostro diagramma le parole sono semplicemente immagini definite in modo molto chiaro, proprio come gli elementi di una buona segnaletica.
Naturalmente, la chiarezza e definizione di cui parliamo è una chiarezza e definizione, per così dire, di primo livello. Qualunque parlante italiano è in grado di riconoscere univocamente le parole del testo che avete sotto gli occhi – e il grande vantaggio della scrittura, specie se tipografica, è proprio questo. Quanto a interpretarne il senso, poi, l’univocità non c’è più. Tant’è vero che la scrittura poetica, prototipo dell’ambiguità e inafferrabilità completa del senso, segue di solito un’organizzazione spaziale che è ancora più regolata di quella della prosa: parte dell’effetto che produce deriva assai probabilmente dal contrasto tra questa organizzazione tabulare particolarmente rigorosa e l’abbondanza delle sorprese interpretative che ne saltano fuori. (E anche i Peanuts di Schulz, così semplici visivamente, trasmettono in realtà interpretazioni molto complesse)
Poi esiste anche la poesia visiva, che gioca proprio sull’allontanamento dalla posizione standard verso il basso, e talvolta persino verso destra, come accade, per esempio, negli Zeroglifici di Adriano Spatola, ai confini tra poesia e arti visive. L’accento sulla rilevanza della dimensione visuale significa infatti anche complicare il gioco sulla riconoscibilità dei singoli elementi e sull’organizzazione spaziale – e giustifica le perplessità di chi si domanda se questa si possa chiamare ancora poesia.
Che cosa ha a che fare tutto questo con i motori di ricerca per le immagini? Riflettiamo un attimo: la ricerca, o almeno quella che si fa sul Web, è un’operazione concettuale, ovvero si cerca qualcosa, e questo qualcosa dev’essere sufficientemente definito. Insomma, la ricerca stessa, così concepita, gode delle stesse proprietà delle liste (ed è pure internamente basata su quelle grandi liste che sono i database). Non c’è da stupirsi che funzioni bene per quelle cose che stanno sull’angolo in alto a sinistra del nostro diagramma, e sempre meno bene man mano che ci se ne allontana. Temo che dunque non si tratti solo di un problema tecnico, destinato a essere risolto in pochi anni.
P.S. Perché non inserisco un’immagine, che dia una chiara idea visiva del mio diagramma? La risposta è che si tratta di un esperimento concettuale, e non di un modo per creare una vera e propria mappa. Se mostrassi il diagramma dovrei per forza dare un posto preciso alle cose, e l’attenzione di chi legge questo post si sposterebbe sul dove metterle (un po’ più in alto, un po’ più in basso, più a sinistra, più a destra…). È poi un esperimento anche nel senso che si tratta di un’idea appena abbozzata, che mi appare suggestiva perché permette di mettere insieme tutto il campo del visivo. Ma richiede certamente ancora molto raffinamento per poter diventare una teoria.
Carlos Gardel fu un cantante straordinario. Non saprei dire se le canzoni che lui cantava erano davvero belle. Ascoltate oggi, poi, rivelano tutta la loro età, e le mode, le consuetudini, le idiosincrasie di un’epoca così lontana. Però, cantate dalla sua voce mi restano nelle orecchie (anzi, mi sono nelle orecchie, proprio ora mentre scrivo) come momenti di emotività straordinaria. Poco importa che io mi ripeta che appartengono a un mondo a me lontano nello spazio e nel tempo, e lontano pure ideologicamente e culturalmente. Persino io, italiano del 2010, non riesco a non fremere di strane emozioni al sentire questa voce che proviene dall’Argentina degli anni Trenta. Magari la ragione per cui non posso dire se quelle canzoni fossero belle in sé, è che è talmente forte l’impronta della sua voce che finisce per essere quella l’unica cosa che conta.
C’è poco da stupirsi dunque del fatto che, nella sua epoca e nel suo paese, Gardel fosse già un mito quando era vivo. Poi, la consacrazione della morte improvvisa, in un incidente aereo in Colombia nel 1935, lo proiettò per sempre nella dimensione del simbolico: non solo una voce mitica, capace di provocare straordinarie emozioni in chi la ascolti, ma il mito stesso dell’Argentina, l’incredibile simbolo di un’identità nazionale basata sul tango, sulla virilità, sulla capacità seduttiva, e sulla capacità di produrre e di provare emozioni. (Assai meglio che in Italia, comunque, dove, quando va bene, l’identità nazionale si fonda sul calcio, e quando va male… meglio lasciar perdere…)
A parte Maradona, l’Argentina non ha prodotto solo Gardel. Già solo nei campi per cui ho qualche interesse dovrei elencare tanti nomi. Stranamente, tutti condividono con il nome di Gardel una qualche impronta di tipo mitico e simbolico. Certo nessuno quanto lui, ma per chi ha qualche amore per la letteratura il nome di Jorge Luis Borges produce un effetto analogo. E per chi ama la letteratura a fumetti, l’Argentina è stata particolarmente generosa: se dico Hector Oesterheld o se dico Alberto Breccia, chi sa di che cosa parlo sente passare un fremito.
Non so se succeda a tutti. Come europeo, o forse magari proprio come italiano (e credo che succederebbe anche se io fossi spagnolo), la sensazione che provo è che in Argentina sia ancora presente nell’aria una dimensione mitica che è esistita anche qui, ma che nel corso del Novecento si è progressivamente estinta – o, meglio sarebbe dire, si è progressivamente banalizzata. È come se la cultura Argentina apparisse come la versione rimasta giovane di qualcosa che qui è irreparabilmente invecchiato.
Questo non significa che la cultura argentina (sto parlando di cultura in senso antropologico) sia qualcosa di universalmente apprezzabile. Certi suoi aspetti (come il machismo, per esempio) mi appaiono volgari e persino ridicoli. Ma il mito non è qualcosa di etico: è un respiro brutale, fascinoso per la sua brutalità, che è tale nel bene come nel male. È qualcosa che rimpiangiamo anche quando non rimpiangiamo i suoi contenuti. Lo rimpiangiamo perché contiene un’energia, un piacere di vivere, che è sconosciuto in sua assenza. Se potessimo, vorremmo vivere in presenza del mito, senza subirne le conseguenze brutali. Sembra che non sia possibile, e che siamo condannati a oscillare eternamente tra la valutazione razionale che ci salva la vita, e la passione mitica che ce la riempie di senso.
Per chi è appassionati di letteratura a fumetti, c’è almeno un altro nome mitico che proviene dall’Argentina, anzi due, quello della coppia di autori José Muñoz e Carlos Sampayo. Il fumetto italiano deve loro moltissimo, persino quello popolare alla Bonelli. Ma la loro produzione è certamente una produzione colta, non foss’altro per la non facilità della lettura, tanto visiva quanto narrativa, delle loro opere.
Non sono un mito per questo, tuttavia. Chi, come me, ne segue il lavoro dalle prime pubblicazione italiane degli anni Settanta, conosce bene lo strano groviglio di emozioni che persino le storie hard boiled del primo Alack Sinner sono in grado di produrre. A quell’epoca sia lo stile grafico di Muñoz che quello narrativo di Sampayo erano ancora decisamente più lineari di quello che sarebbero stati poi, ma era già presente un gioco polifonico di voci, di punti di vista, di vicende interallacciate che facevano di Alack Sinner un fumetto particolare e notevole.
Forse quello che era proprio di Muñoz e Sampayo sin dall’inizio era la capacità di vivere (e trasmettere) il mito con tutta la violenza che esso ancora vive nell’aria di Buenos Aires, e di fornircene una versione critica, mediata dall’occhio di chi si rende conto della sua problematicità etica. Ma questo non viene fatto discutendo il problema, bensì presentandolo attraverso la pluralità delle voci e dei punti di vista. In questo modo, anche se il mito viene messo in discussione, e lo sguardo critico dell’intellettuale razionale si sente soddisfatto, in realtà non c’è nessuna vera e propria razionalizzazione del mito; c’è piuttosto uno scontro tra mitologie differenti, che continuano a conservare il loro fascino terribile, la loro negatività sinistra, e la loro feroce vitalità.
Non c’è nessuna soluzione, nessuna ideologia razionale e positiva, nel discorso di Muñoz e Sampayo. Non c’è nemmeno l’utopia socialista, che promette la soluzione di tutti i problemi, ma a costo proprio di uccidere il mito. Ovviamente non c’è nemmeno l’utopia capitalista, che maschera di razionalità l’emersione di altri miti, ben meno soddisfacenti di quelli antichi. Semmai Muñoz e Sampayo si permettono di prendere questi (poveri) nuovi miti, e di metterli a contrasto con quelli tradizionali: in questo modo la dimensione etica (e la condanna implicita delle atrocità) emerge con forza, ma senza cancellare, senza diminuire nemmeno di un soffio la vitalità perversa e fascinosa del mito. Sin dall’inizio, leggere le storie scritte da Carlos Sampayo e disegnate da José Muñoz è stato un atto di confronto con una dimensione profonda e contraddittoria, dotata dello stesso fascino che possiedono i miti greci, terribili e meravigliosi proprio per la loro commistione di giustizia e di orrori.
Cosa succede quando il mito attuale e impietoso di Muñoz e Sampayo si confronta col mito stesso dell’identità argentina, Carlos Gardel? "Carlos Gardel" di José Muñoz e Carlos Sampayo, Nuages 2010
Non c’è un racconto vero e proprio della vita di Gardel, in questo romanzo. La falsariga è data da un dibattito televisivo sul cantante e sull’identità nazionale argentina, combattuto da due antipaticissimi contendenti, fieramente avversi l’un l’altro: l’uno nel difendere tutte le doti (tipicamente argentine) che si attribuiscono a Gardel, l’altro nel metterle tutte in discussione, una dopo l’altra. Ma il loro dialogo si intreccia con gli episodi stessi della vita di Gardel, e con le tante visioni delle persone che lo hanno accompagnato: il tutto quindi in una composizione corale, polifonica, che, nell’effetto complessivo, ha una struttura che è più simile a quella di un brano musicale (magari proprio un tango) che non a un racconto tradizionale.
Non è il cantante Carlos Gardel a essere messo in discussione: su quello e sulla sua capacità strepitosa nessuno esprime mai il benché minimo dubbio. Gardel è davvero il mito argentino, per tutti, allora come ora. Ma cos’è questo mito? Muñoz e Sampayo lo perpetuano, paradossalmente, proprio conducendoci ad osservarne, a patirne, tutti i lati oscuri – ma anche a godere di quelli luminosi, vitali. Persino quando non è possibile separarli.
Ho letto e riletto il loro libro. Poi non potevo non riascoltare Gardel.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
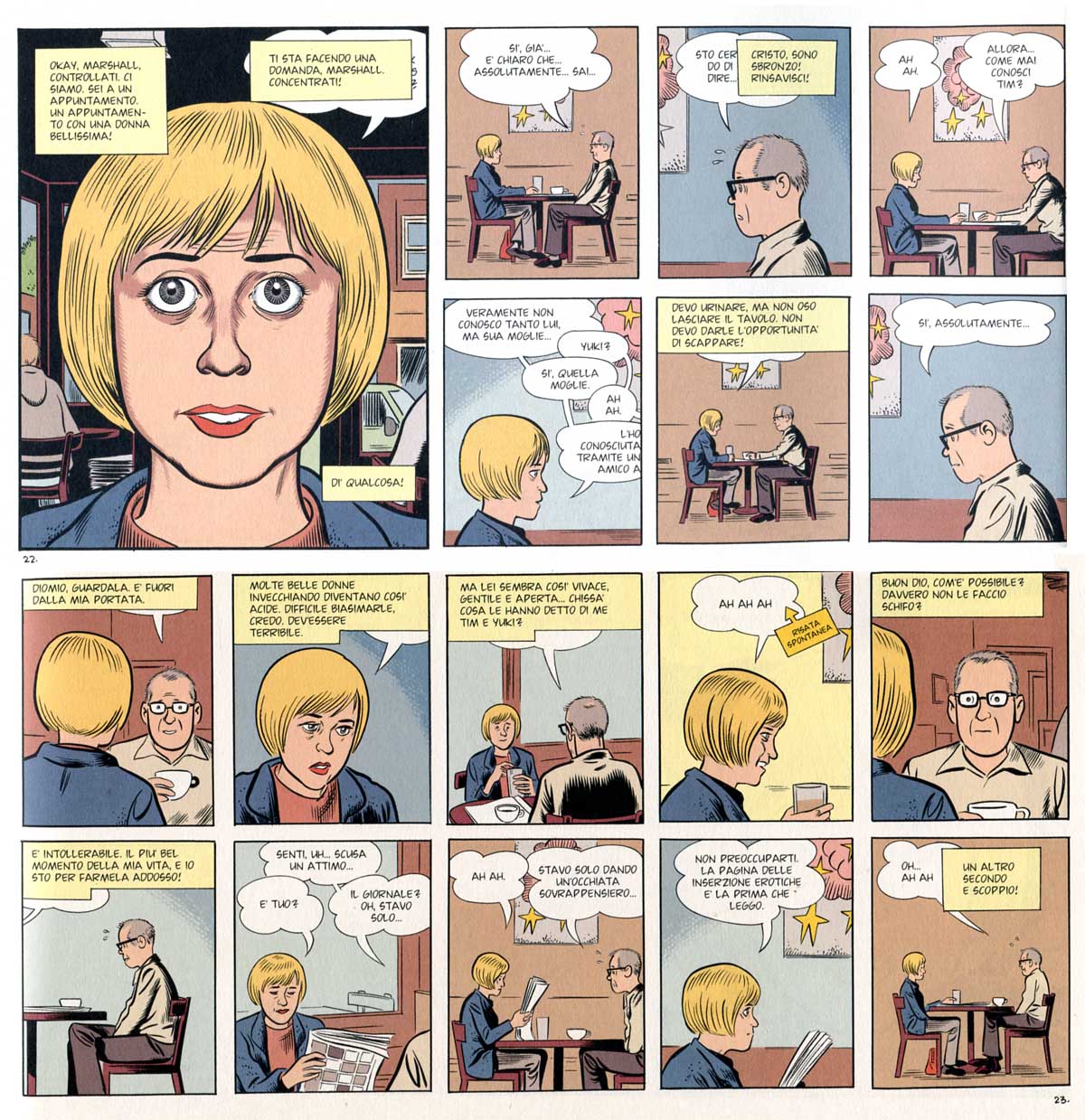













 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email





















































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco





Commenti recenti