.
 Kazuo Koike e Goseki Kojima, Lone Wolf and Cub Scrive Marco Pellitteri qualche giorno fa su Lo Spazio Bianco, elencando 11 “cose” che fanno male al fumetto in Italia, che, tra queste, ci sarebbero anche “Gli editori che da anni e ancor oggi pubblicano i manga in edizione ribaltata”. Ci dice Marco: “È una questione molto interessante, che riguarda un segno di distinzione nel gusto, un avvicinamento culturale al modo di lettura dei giapponesi, una corrispondenza maggiore all’esperienza di lettura dei manga da parte dei lettori nipponici.”
Temo che le cose siano molto più complicate di così. Della questione del ribaltamento ho avuto modo di parlare già qualche anno fa, e non ho cambiato idea. Basta guardare la coppia di immagini che ho allegato qui (e di cui non dirò quale sia l’originale giapponese) per rendersi conto che raccontano storie differenti di attacco o di difesa da parte dell’uno o dell’altro dei contendenti. All’obiezione che basterebbe conoscere il verso di lettura per saper leggere correttamente l’immagine, risponderò che non è vero. Certo, leggendo i manga alla giapponese, impariamo facilmente a scorrere le vignette nel verso giusto, e anche a leggere prima i balloon a destra di quelli a sinistra (pur se poi, all’interno di quegli stessi balloon, la scrittura occidentale mi reimpone di muovermi da sinistra verso destra). Ma la ricostruzione intuitiva del movimento si basa, oltre che su una serie di convenzioni (che possono certo essere apprese e reinterpretate dal lettore) anche su conseguenze percettive molto profonde di alcune di quelle medesime convenzioni. Noi, per esempio, cresciamo all’interno di un contesto in cui la successione sinistra-destra non è soltanto quella della scrittura, ma, a partire dal verso della scrittura, è diventata la successione generale delle cose che avanzano; e siamo quindi intimamente abituati a considerarla tale. Non è più una convenzione (modificabile e riacquisibile) a governare questa percezione, ma una capacità cognitivo-operativa di livello profondo, non dissimile da quella che ci permette di reagire agli stimoli del mondo quando ci si presentano improvvisamente davanti, comportandoci istintivamente ancora prima di qualsiasi riflessione.
.
 Kazuo Koike e Goseki Kojima, Lone Wolf and Cub Con queste premesse, sostenere che la lettura dei manga alla giapponese costituisce per un Occidentale “una corrispondenza maggiore all’esperienza di lettura dei manga da parte dei lettori nipponici” suggerisce che pure i nipponici debbano leggere con fatica i suggerimenti di movimento (magari contraddetti dalla direzione della scrittura) – il che chiaramente non è, salvo forse quando i Nipponici leggono fumetti occidentali non ribaltati (ma loro sono avvantaggiati dal fatto che la direzione sinistra-destra, pur minoritaria, non è estranea alla scrittura e cultura giapponese).
Comunque, precisa Marco, “La questione del ribaltamento dei manga non riguarda primariamente una faccenda di leggibilità e di direzionalità percettiva. Come ho scritto sopra, essa riguarda il gusto dei fan dei manga, la loro identità di lettori molto spesso nettamente distinta rispetto a quella dei seguaci di altri fumetti (occidentali), il desiderio, che trova oggi piena soddisfazione, di poter trovare nella lettura da destra a sinistra la sequenzialità e la direzionalità originariamente predisposte dagli autori nipponici.”
Questo a Marco lo posso concedere. In effetti, se quello che conta non è la qualità della lettura ma l’identità specifica di lettore, allora certamente quei manga (ribaltati) che non la rispettano fanno male al fumetto in generale. O meglio, fanno male all’editoria a fumetti, perlomeno nella misura in cui essa si regge sui lettori che costruiscono la propria identità sul ritrovare la direzione di lettura originaria del giapponese. Questo non basta tuttavia a definire gli altri “un fantomatico gruppo di lettori «casuali» (anziani? ignoranti? pigri? semi analfabeti?) presuntamente non abituati o non abituabili alla lettura non ribaltata”, e non solo perché mi sento chiamato direttamente in causa (e quindi potenzialmente ascritto a una delle categorie elencate), ma anche perché, come abbiamo visto sopra, ci sono caratteristiche della lettura ribaltata a cui è possibile abituarsi, e altre che sono troppo profonde per coglierle con la fluidità necessaria a una lettura goduta di un fumetto (come di qualsiasi altra cosa). In altre parole, in una situazione controintuitiva come quella del movimento nel manga non ribaltato, o leggiamo fluidamente oppure interpretiamo correttamente il movimento, ma non le due cose insieme; e siccome, di solito, siamo più interessati al piacere della lettura che alla filologia, questo va a scapito della corretta interpretazione del movimento. Certo, evidentemente capiamo grosso modo ugualmente quello che succede; gli elementi contestuali sono tali e tanti da portarci comunque nella giusta direzione; e tuttavia quello che perdiamo in precisione ed efficacia è assai di più di quello che perderemmo con samurai e tennisti mancini.
Marco potrà pure stupirsi che esistano dei lettori che non sono né anziani né ignoranti né pigri né semi analfabeti, e che pure preferiscono avere un’esperienza di lettura consona alle proprie consuetudini percettive proprio come ce l’hanno i Giapponesi. Ma se gli resta “incomprensibile” che esistano lettori di questo genere è evidentemente perché lui stesso appartiene a quei lettori che costruiscono la propria identità nel ritrovare “la sequenzialità e la direzionalità originariamente predisposte dagli autori nipponici”. Per un lettore di questo tipo, evidentemente, il mito del Giappone è più forte del riconoscimento delle differenze, e delle conseguenze che esse comportano. La cosa ha davvero le caratteristiche di un innamoramento. Quando siamo innamorati, tendiamo a vedere come meraviglioso tutto ciò che pertiene alla persona amata. Il che è certamente una cosa positiva, perché ci spinge a migliorarci e a imparare a fare delle cose nuove. L’innamoramento ci spinge però anche a non vedere quali sono i nostri limiti, e a trascurare il fatto che ci sono cose che possiamo imparare e altre che no. A volte ci salva la reciprocità dell’innamoramento, per cui, vivendo la medesima condizione, la persona amata tende a sua volta a non vedere i nostri limiti. Altre volte la passione termina, e ci troviamo a domandarci come abbiamo fatto a innamorarci di una persona così.
Nei confronti dei manga non possiamo troppo sperare nella reciprocità, non a livello individuale, almeno. Senz’altro, se li possiamo leggere (ribaltati o meno) è perché il Giappone ha vissuto un innamoramento per l’Occidente forse ancora maggiore del reciproco. Ma questo non riguarda nello specifico il lettore di manga, per il quale, evidentemente, potersi immergere un poco di più nel mito del Giappone, anche attraverso un’apparenza di rispetto della sua direzione di lettura, è più importante della correttezza dell’interpretazione. Questo lo capisco benissimo: si legge per piacere e per fascino. La correttezza dell’interpretazione è roba da critici. Come me, e Marco, peraltro.
Insomma, riconosco a Pellitteri che il manga ribaltato può far male all’editoria a fumetti, perché è probabilmente vero che la maggior parte dei lettori di manga vive nel mito del Giappone, ed è più interessato a riviverne il profumo che a leggere correttamente. Ma non è detto che ciò che fa bene all’editoria faccia bene al fumetto in generale. Non c’è dubbio che, se non si vende, il fumetto muore; e quindi, se i lettori sono così, continuiamo pure a stampare i manga alla giapponese. Ma questa abitudine a leggere con superficialità, trascurando i segnali più profondi, attaccati alla griffe nipponica come un dandy al suo Versace, fa davvero bene al fumetto nel suo complesso?
.
 Miles Qualche giorno fa, leggendo questo post di Sergio Pasquandrea, mi è venuto voglia di riascoltare Miles Davis. Con la musica di Miles ho uno strano rapporto. E non posso farci niente: ci ho già provato un sacco di volte. Insomma, finché suona il jazz tradizionale lo trovo noioso; non saprei neanche dire perché; so solo che la sua musica non mi prende, scorre su di me senza trovare appigli. Certo che come trombettista è bravo, ma è come se lui e io stessimo parlando lingue diverse: io sento che è fluente, e che può piacere, ma non capisco niente. Nei pezzi per il quartetto degli anni Cinquanta poi, quando ha al suo fianco il giovane Coltrane, la cosa mi diventa ancora più evidente, perché mi rendo conto che appena Coltrane attacca a suonare, di colpo sono tutto orecchi.
Poi c’è la svolta della fine dei Sessanta, e il mezzo milione di copie vendute di Bitches Brew, l’invenzione della fusion e le grida al tradimento, alla deriva commerciale. Bah. Sta di fatto che per me, Miles nasce con questo disco, che trovo straordinario – e gran parte di quello che ha fatto dopo mi piace da morire – al punto che non capisco bene come possa lo stesso musicista produrmi sensazioni così diverse.
Ora, io non sono un esperto di jazz e non ho nessuna pretesa di dire in merito qualcosa di interessante. Probabilmente c’è solo qualcosa che non capisco nel Miles classico, e sarei ben contento se qualcuno mi fornisse gli elementi per capire. A capire e a saper apprezzare c’è sempre solo da guadagnarci.
Quello, piuttosto, che sempre mi ha colpito, è l’anatema lanciato a suo tempo contro il Miles elettrico, e l’accusa di essere commerciale, di essersi venduto al successo. Mi colpisce, questa accusa, perché tradisce un certo atteggiamento purista che attraversa un po’ tutta la critica, di tutti i contesti, linguaggi e generi – con il correlato frequente di un atteggiamente contrario a quello che ho appena espresso, cioè il non voler apprezzare. Sembra quasi che il Miles del dopo la svolta non possa certamente fare della buona musica, perché siccome ha avuto successo commerciale quello che fa è necessariamente cattivo. Posso capire che il successo commerciale possa ingenerare dei sospetti sulla qualità, e che quello che ha avuto successo commerciale possa essere, abbia qualche probabilità in più, di essere cattivo. Ma poi le orecchie le abbiamo. I sospetti sono giustificati, ma solo finché non si tocca con mano come stanno le cose.
Eppure, stranamente, l’atteggiamento purista non solo esiste, ma è incredibilmente diffuso in tutti i contesti, e l’incapacità di apprezzare quello che esce dagli schemi è dilagante. Credo che contribuisca alla diffusione di questo atteggiamento anche un fraintendimento, sempre di origine aristocratica e adorniana come l’atteggiamento in sé: quando si parla di schemi (e dell’uscirne) sembra infatti che si parli necessariamente di industria culturale (e delle produzioni alternative, di nicchia, d’avanguardia, controcorrente). L’industria culturale ha i suoi schemi, certo, a cui di solito si deve adeguare un prodotto per essere commerciale; ma anche ciascuna delle sue alternative ce li ha (ce li hanno le produzioni alternative, quelle di nicchia, le avanguardie, l’essere controcorrente…). In una situazione di nicchia come quella del jazz degli anni Sessanta (una nicchia non troppo piccola, certo, ma sicuramente con le sue regole e il suo pubblico – e quindi i suoi schemi), andare verso il rock è certamente fare quello che non si deve fare, e quindi rompere lo schema.
Ora, essere puristi in una situazione di questo tipo vuol dire ritenere più importante lo schema dei risultati che si possono avere rompendolo. E questo non è un atteggiamento incomprensibile. Il rischio dell’operazione di Miles è quello – e tanto più se ha successo – di distruggere la nicchia; cioè, nello specifico, di distruggere il jazz, o almeno il jazz così come l’abbiamo amato sino a questo momento. La difesa dello schema è una difesa della casa in cui stiamo bene, che in qualche modo abitiamo, dove abbiamo amici con cui scambiamo opinioni, dove siamo riconosciuti e dove riconosciamo gli altri. Se la casa svanisce, come faremo? È per questo che la nuova musica di Miles, ancora prima che brutta, deve essere sbagliata, scorretta, intollerabile. In fin dei conti non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarla: questo è il senso dell’anatema.
Questo atteggiamento purista, di difesa degli schemi, non è una prerogativa di chi ama la tradizione. All’interno delle avanguardie, per esempio, è dominante. E tanto più piccolo è l’orto da salvaguardare, tanto più si sarà duri nel condannare ciò che ne fuoriesce; perché certo, se l’orto è piccolo, il pericolo che possa ridursi fino a scomparire è più grande, e sempre più grande.
Per la mia formazione e i miei interessi, io mi occupo di vari tipi di coltivazioni, tutti ambiti piuttosto piccoli, dove gli orti non hanno comunque modo di espandersi troppo. La varietà dei temi dei post di questo blog dà un’idea piuttosto chiara di quali siano queste coltivazioni. Tra loro, al giorno d’oggi, sicuramente la più piccola è quella del mondo poetico.
È la più piccola in termini quantitativi, di giro di affari e di visibilità pubblica, ma è anche quella che ha – e di gran lunga – la tradizione più antica. Questo produce un effetto paradossale: il prestigio dell’essere un poeta apprezzato non consiste tanto nel guadagno o nell’esposizione mediatica (quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Milo De Angelis, per esempio?), ma nel potersi presentare, prima di tutto a se stessi, come qualcuno che è riconosciuto come appartenente alla stessa tradizione di Omero, Dante, Leopardi e Montale. Si tratta di un prestigio virtuale, in termini commerciali, ma estremamente reale e vincente in termini psicologici. Il poeta di oggi riconosciuto grande nel suo ambito non sposta una virgola a livello di cultura dominante, ma per chi lo conosce (e per se stesso, di conseguenza) il suo prestigio è enorme, superiore a quello di un famoso regista, o di una rockstar.
Questo enorme prestigio è però legato alla dimensione minuscola della coltivazione, e a quella microscopica dell’orto di riferimento. C’è da stupirsi se nel mondo della poesia l’orticello venga difeso con le unghie e con i denti? C’è da stupirsi se ci siano critici che forniscono il decalogo di quella che è la poesia buona? Purtroppo non tutti coloro che rompono gli schemi consolidati lo fanno con qualcosa paragonabile a Bitches Brew, perché il talento è raro; ed è quindi facile ai puristi trovare dei controesempi di scarsa qualità, portandoli come prove della miseria in cui vive e produce chi è uscito dall’orto, o non ci è mai entrato.
Il campo del fumetto, che mi è altrettanto caro, mostra, da questo punto di vista, dialettiche molto meno irritanti, spesso fin troppo poco irritanti. Il campo è un po’ più grande (non molto più grande), vi gira più denaro (non granché, certo, ma decisamente di più) e più esposizione mediatica (almeno un poco), ma molto molto molto meno prestigio (quello virtuale di cui sopra). In poco più di un secolo di vita è dura avere degli antenati paragonabili a quelli dei poeti. Per questo le certezze e le difese che contraddistinguono i purismi hanno meno ragione di esistere – e non ci si scanna per decidere che tipo di fumetto sia più autentico, così come succede nel campo della poesia, e in altri. Ci si scanna magari per altro – ma è anche un altro discorso.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche cercare di spiegarmi perché il secondo Miles debba essere disprezzato, ma non credo che mi convincerà. Do invece qualche chance in più a chi mi volesse convincere della qualità del primo Miles – anche se ormai la vedo dura pure lì, ma non c’è nulla di ideologico in questo. Ci ho provato invano anche con Schumann a farmelo piacere, e lì non c’era né un Coltrane di riserva né una svolta elettrica a cambiare le carte in tavola. Quello che certamente non voglio è che le mie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male determino i miei gusti. Se facessi così mi precluderei qualsiasi possibilità di cambiarle, le mie opinioni, qualsiasi possibilità di capire le cose meglio di quanto non le capisca adesso.
.
 Jean-Claude Götting, Happy Living, pp. 72-73 Ci saranno i pittori nabis dietro al segno di Jean-Claude Götting, un po’ come dietro a quello di Mattotti, ma con effetti assai diversi. Mattotti, certo, se ne è staccato di più, con la sua passione per le geometrie di superficie, mentre Götting resta più legato a un qualche naturalismo. Lo si vede bene in Happy Living, l’ultimo libro suo uscito da Coconino, un libro che racconta una storia bella, intricata e malinconica – molto adatta alle nettezze un po’ inquietanti del suo segno.
È solo del segno che voglio parlare, dei colpi di pennello che stendono unicamente dei bianchi e dei grigi – ma una scelta oculata di una carta appena appena gialla li fa diventare quasi sfumature di colore. C’è sicuramente un sacco di pittura nel segno di Götting, ma questo non va a scapito del fumetto e del ritmo del racconto. Götting si sa trattenere, nella costruzione, nel virtuosismo dei tratti. Alla fine, il suo segno grosso, a chiazze di colore, può sembrare persino realistico: in verità lo è molto poco, ma essendo così funzionale al racconto (o essendo associato a un racconto così funzionale al segno stesso), magicamente è come se lo fosse.
A essere maligni, Götting ci guadagna in una grande economia di dettagli, risparmiando magari persino nel lavoro. Con un segno di questo genere, infatti, i dettagli sono pressoché impossibili da rendere – si evocano però molto bene. Bastano pochi tratti, a saperlo fare, per rendere una complessità di fondo. La narrazione ne gode in sintesi e in focalizzazione, e qualche volta il lettore si può persino permettere di perdersi nella costruzione formale di una singola immagine, un po’ come – nella doppia tavola qui sopra – nella vignetta in basso a sinistra. È solo un attimo di contemplazione, in verità suggerito pure dalla storia. Un attimo dopo si è di nuovo calati negli eventi.
Le macchie di colore definiscono una realtà che è coerente con il modo in cui la si racconta. In scena c’è un piccolo giallo, ma senza delitti (forse) e senza urgenze, dove invece prevale l’incertezza dei sentimenti. Sembra sempre che debba saltar fuori il colore, in questi disegni, e che ci debba essere una soluzione, nella storia. Guardare e leggere sono necessari allo stesso modo, e portano a risultati simili, fittamente intrecciati.
Viene voglia di entrarci a nostra volta, di perderci, in quel mondo fatto di macchie di luce e di forme un poco informi. Sembra il nostro, di mondo, quando cerchiamo di definirlo non con il senso della vista, ma attraverso quello, ben più complesso, attraverso cui comprendiamo le relazioni personali, sociali, umane.
Nonostante le apparenze, questo non è un post (solo) sulla poesia. Ecco dunque queste apparenze.
Ci sono due eventi all’origine delle riflessioni che sto per esporre. Intanto, mi sono arrivate le bozze del mio libro sulla poesia (Il linguaggio della poesia, Bompiani – ne ho anticipato qualcosa qui), e nel correggerle mi si sono inevitabilmente scatenate varie riflessioni. L’altro è la segnalazione di un sonetto di Gongora (grande poeta spagnolo del Seicento), da parte di un’amica ispanista che mi ha promesso un riferimento più preciso di quello che ricordava a memoria e che, a quando ho capito, per parlare di una bellezza imperfetta, concluderebbe la sua sequenza con un endecasillabo eccedente e sgraziato, un po’ a modello di ciò di cui sta parlando.
Mentre sono in attesa del riferimento preciso, per leggermi davvero il sonetto, non posso fare a meno di pensare che l’uso di un verso a-metrico non fa certo di Gongora un precursore del verso libero. Anzi, se le cose stanno come ho capito, il verso “sbagliato” di Gongora deve la sua efficacia locale proprio al contesto in cui si trova, all’allusione che produce, e alla sostanziale validità del principio metrico: insomma, è la classica eccezione che conferma la regola, mettendola in evidenza proprio con il suo occasionale scarto.
Dunque, sinché lo scarto è occasionale, esso contribuisce a rafforzare la regola – ma quando comincia a diventare a sua volta regola, la nuova regola scaccia quella vecchia. E il verso libero vero e proprio non è in nessun senso una conferma della metrica tradizionale.
Nel mio libro sostengo, tra le altre cose, che la metrica tradizionale rappresenta un quadro regolare, sicuro e confortante, attraverso cui possono essere trasmessi anche i significati più inquietanti o spaventosi, rendendoli accettabili. Sono accettabili, in questi casi, perché la regolarità metrica funziona come metafora (o persino come locale implementazione) dell’ordine imposto dall’uomo alla natura selvaggia (ivi compresa quella, interiore, dei sentimenti). Il quadro regolare e assestato del sonetto, per esempio, fa da cornice, e rende più facilmente accettabili sin la disperazione e la tragedia, quando emergono. Proprio come gli elementi di antropizzazione del paesaggio, o il riconoscimento di una struttura narrativa in una situazione di angoscia incontrollata (e il mestiere degli psicoanalisti è fatto anche del saperla fare emergere dal caos mentale del paziente).
Così, possiamo pensare la metrica tradizionale come il corrispondente in poesia delle strutture sociali tradizionali – quelle al cui interno abbiamo vissuto per secoli, al riparo dagli eccessi della natura, esterna o interna a noi. Da questo punto di vista il sonetto di Gongora (così come me lo sto immaginando) non viola nulla: quello che fa è semplicemente giocare sul principio, suggerendo che l’imperfezione del suo oggetto possa riflettersi persino in un’imperfezione dell’ordine umano delle cose.
Ma il verso libero è un’altra cosa. Nel mio libro suggerisco che l’uscita dalle strette del metro permetta alla disperazione e alla tragedia (o a quant’altro) di esprimersi in maniera più diretta ed efficace, perché la cornice in cui vengono inserite è più leggera e meno distanziante. In altre parole, una poesia in versi liberi rimanderebbe molto meno (ma in qualche modo deve continuare a farlo) all’ordine umano e sociale imposto alla natura; e in questo modo ridurrebbe la distanza nei confronti del proprio oggetto emotivo, rendendolo più vivido ed efficace.
Continuo a pensarla così (nel libro tutto questo viene spiegato molto più ampiamente), ma ho la sensazione che ci sia dell’altro.
Il punto è che la poesia in versi libero non esclude il metro. Semmai, quello che è accaduto è che a una serie di strutture metriche (all’incirca) stabili da secoli si cerca di sostituire delle strutture nuove, adatte alla situazione espressiva particolare. Ma se la metafora (o locale implementazione) di cui parlavamo sopra resta valida, questo tentativo dovrebbe corrispondere anche a un tentativo di costruire strutture sociali nuove. È certamente un tentativo presuntuoso, ma è proprio quello che la modernità ha cercato di portare avanti, timidamente nel corso dell’Ottocento e poi molto più spavaldamente nel Novecento, sino alle utopie razionaliste del comunismo sovietico, che ha sognato di ricostruire l’ordine sociale da zero, coi risultati che sappiamo.
Senza arrivare a questi estremi, mi sembra comunque che il verso libero sia figlio della stessa presunzione che ci fa pensare di poter essere davvero i capitani della nostra stessa società e delle nostre vite, capaci di sottomettere tutto a un nuovo ordine, razionalmente fondato. Non è un’idea campata in aria, e soprattutto è l’idea dentro cui viviamo, ma ancora non sappiamo se sia destinata ad avere successo sul lungo termine, e in che misura andrà eventualmente emendata per poter funzionare a lungo. Rispetto alle società tradizionali, che funzionavano così perché si basavano su un ordine che, giusto o ingiusto che fosse, era validato da secoli o millenni di sopravvivenza, la nostra società pretende di sapersi progettare in termini nuovi, e magari anche più giusti. Allo stesso modo lo pretende la poesia moderna, che ha abbandonato le certezze dell’organizzazione assestata da secoli a favore delle incertezze del progetto.
Il punto non è, a questo punto, se il passato sia meglio del presente, o viceversa. Questo sarebbe oggi un problema unicamente virtuale, perché al punto in cui siamo non c’è possibilità di ritorno (se non attraverso una certo non auspicabile catastrofe). Nell’ambito ristretto del metro, non basta affatto recuperare la metrica tradizionale per ripristinare la situazione precedente. Oggi come oggi, dopo un secolo di intensivo verso libero (e a due secoli e passa dalla sua nascita), l’endecasillabo, per esempio, appare una possibilità come un’altra, e non come un obbligo. I poeti cosiddetti neo-metricisti non stanno riproponendo il passato, ma soltanto avanzando un progetto tra i tanti, magari profumato di classicismo, ma niente di più. Se anche una volta l’endecasillabo si contrapponeva (statisticamente vincente) ad altri metri ugualmente canonici, inevitabilmente in numero limitato, tra i quali era giocoforza scegliere, oggi l’endecasillabo non è che una scelta tra innumerevoli potenzialità progettuali per il quadro di riferimento.
La poesia, alla fin fine, socialmente ne patisce – ma non perché i poeti di oggi siano meno capaci di quelli di ieri (e certamente, oltretutto, ci rappresentano di più). È semmai perché quella funzione di conforto, di sostegno all’ordine umano e riconosciuto delle cose, non è più possibile – ed è passata, sostanzialmente, ad altre modalità di espressione. Nel leggere una poesia dell’ultimo secolo non posso contare su un quadro di sfondo condiviso: persino la presenza di un simile quadro (o la possibilità di condividerlo) va verificata caso per caso. È naturale che la situazione venga sentita come enormemente più complicata di prima: non solo sono scomparse le certezze, ma ciascuno ha il diritto di suggerire le proprie. Meraviglioso! e insieme devastante. Non ne possiamo fare a meno, perché ciò che non è così non ci rappresenta; ma questo non è necessariamente positivo.
Ancora un’osservazione: non sto parlando delle avanguardie, degli esperimenti estremi. Quello che ho detto vale per Sandro Penna come per Nanni Balestrini. E siccome, nonostante le apparenze, non sto parlando solo di poesia, vale per Frank Miller come per Lorenzo Mattotti o Chris Ware; con il vantaggio (o lo svantaggio) per il mondo del fumetto, di non avere secoli di tradizione regolatrice alle spalle, essendo nato già in un mondo orientato più al progetto che alla tradizione. Ma, di questo, in qualche prossimo post.
 David Mazzucchelli, doppia pagina da Asterius Polyp Mazzucchelli è una strana bestia americana che di europeo non ha solo il cognome. Ora che è sufficientemente lontano dai precedenti superomistici dei suoi esordi, piano piano salta fuori tutta la sua passione per Joost Swarte e per la ligne claire francese, e ogni tanto sembra quasi di guardare Jean-Claude Floc’h. Ma siccome Mazzucchelli è un grande autore, tutto questo è diventato molto suo. Anzi è persino diventato l’oggetto, quasi il tema del suo racconto.
Asterius Polyp è un architetto, dai principi funzionalisti, talmente estremo nella propria adorazione della razionale teoria, che di fatto non ha mai costruito nulla, e i numerosi premi e riconoscimenti importanti che ha ricevuto sono stati tutti per progetti rimasti sulla carta. La sua stessa vita, il suo atteggiarsi, il suo vestire, sono ugualmente improntati ai suoi principi, secondo i quali ciò che non ha una funzione è decorazione (e la decorazione, lo sappiamo senza che ce lo dicano né Mazzucchelli né Polyp, per il funzionalismo è un delitto).
Questo prodigio di razionalità è ovviamente un freddo anaffettivo, tanto brillante e seduttore in società, quanto incapace di relazionarsi davvero con un’altra persona, troppo pieno della propria intelligenza per accorgersi che ce ne sono altre e diverse. Almeno finché non incontra Hana, la timida scultrice.
Guarda caso, questa dialettica tra funzionalismo razionale e sentimento è la stessa che caratterizza proprio la ligne claire. Quando Swarte ci dice che il segno grafico di Hergé elimina tutto quello che non è funzionale alla storia che sta raccontando, sta esprimendo principi simili ad Asterius Polyp – con la differenza che la materia cui il disegno del fumetto si applica non è quella dei principi rigorosi della scienza delle costruzioni, ma quella già sfumata e sporca del racconto. Per questo poi i migliori autori ligne claire non appaiono affatto freddi – e persino Chris Ware, che di questa tendenza è il maestro americano, e più estremo di qualsiasi europeo, non fa che raccontare profondi sentimenti, cui il gelo razionale, funzionalista, esattissimo delle immagini aggiunge una straniante dimensione rivelatoria.
Mazzucchelli non è però Chris Ware. Fin da principio il suo segno è più volutamente sporco e trasuda passione sotto il vincolo funzionale. Così, in questa storia, è il segno stesso, insieme con il colore, a determinare i personaggi e i loro stati d’animo. Asterius in persona e il suo mondo sono, di quando in quando, di un freddo azzurro da prova cianografica, disegnato con linee nette (da ligne claire estrema) che spesso definiscono i corpi come insiemi di solidi articolati (come se fossero manichini, come si fa per definirli chiaramente nella loro composizione plastica); Hana e il suo mondo sono invece rosa o rossi, tracciati con una grande quantità di linee sfumate e rotondeggianti – l’antitesi stessa della ligne claire. Mentre il mondo normale in cui Asterius precipita dopo il disastro da cui ha inizio il racconto ha colori grigi e gialli, tracciati con una linea semplice ma non troppo pulita.
Tra queste tre tonalità e modalità si snoda tutta la storia, che è una specie di romanzo di formazione, quelli in cui il protagonista deve passare attraverso delle prove per arrivare a capire, e diventare davvero uomo. In questo romanzo le prove sono delicate e ironiche, e il dramma di Polyp sempre solo suggerito senza ostentazione. L’immersione nel mondo della vita è necessaria per rendersi conto dei limiti dell’astrazione, per capire i limiti del funzionalismo, per rendersi conto che l’utopia della perfezione razionale nasconde con facilità il mito personale della propria inarrivabile superiorità, inattaccabile perché difesa dai baluardi della ragione – quando proprio questa ragione è già minata da dentro alle origini. La ragione è strumentale, ci ricorda qualcuno, non fondazionale: cioè insostituibile come strumento per raggiungere degli scopi, ma inutile per fondarli alla base, quegli stessi scopi.
Questo è il racconto che Mazzucchelli ci fa, con intelligenza, sensibilità, molta strumentale razionalità, una invidiabile capacità grafica, e un forte senso del ritmo del racconto, capace di rendere forti e grandi delle cose piccole – un po’, ma girato al contrario, come quando riportava sulla terra col suo segno terroso i miti superomistici di Batman e Daredevil, molti anni fa.
P.S. Se volete altre interessanti opinioni su Asterius Polyp, sul blog Conversazioni sul fumetto ne stanno programmaticamente uscendo numerose, sin’ora tutte davvero interessanti. Invece sulla polemica tra fumetto popolare e d’autore emersa nella conversazione seguita al primo intervento (di Andrea Queirolo) direi che ho dato implicitamente risposta col mio post di lunedì scorso. Aggiungo solo – a margine – che non credo che le parole di Eco lì riportate fossero una critica al fumetto d’autore e un rimpianto del fumetto popolare, ma semplicemente una considerazione su quanto è cresciuto il fumetto, che, a quanto mi pare stia dicendo Eco, può arrivare persino a condividere talvolta con la letteratura verbale certe difficoltà di comprensione. Mi pare una semplice constatazione di fatto, non una presa di posizione in nessun senso.
Torno da Romics, dove giovedì 29 abbiamo discusso di fumetto popolare, di eroi, e di autorialità. Il tema era deciso da tempo, ma l’ombra di Sergio Bonelli aleggiava inevitabilmente su di noi. Che l’eroe non sia indispensabile alla serialità lo sapevamo già, ma Camilla Patruno Marmonnier ci ha fatto toccare con mano che cosa succede in Francia, dove ci sono serie basate sugli sviluppi diversi possibili, serie basate su un gruppo con diversi personaggi e vicende parallele, serie basate sul ritornare di una situazione in epoche storiche diverse. Non sono cose che accadano solo in Francia. Anche da noi o negli Stati Uniti o altrove l’eroe è semplicemente la principale tra le opzioni per permettere la continuità.
E non è nemmeno una novità. Il mito greco (e altri miti ancora) è già implicitamente seriale. Talvolta la sequenza si basa sull’eroe (Ulisse, Ercole) talvolta su un gruppo (gli Argonauti) o una famiglia (gli Atridi, Edipo), talvolta su una situazione (la fuga di Elena e la guerra di Troia).
Parlando, dentro e fuori la sessione, con gli amici (Ivo Milazzo, Sergio Brancato, Paola Laura Gorla) ritornava poi continuamente il tema del rapporto tra autore e serialità – che, in forme di solito meno teoriche, usciva anche dai discorsi degli altri partecipanti (C.B. Cebulski, Takamasa Sakurai, Francesco Artibani, Pierdomenico Baccalario, Giacomo Bevilacqua, Giulio De Vita, Roberto Perpignani, Giovanni Ciofalo – e sto certamente dimenticando qualcuno): per esempio, un personaggio appartiene al suo autore? è giusto proseguire una serie dopo la morte dell’autore?
Non voglio riportare le opinioni di tutti (non ne sarei nemmeno capace). Solo ripetere, e magari ampliare un po’ le cose che ho detto in chiusura, stimolato da tutti i discorsi, privati e pubblici, del pomeriggio.
Ho accennato al mito greco. Di sicuro Omero, se mai è esistito, non ne è stato l’autore. Non ha inventato né storie né personaggi. È stato soltanto il più grande tra gli aedi, questi poeti da braccio che vivevano recitando pubblicamente dei versi di tradizione popolare e orale, ma anche modificandoli secondo la situazione del momento, la propria memoria, il proprio gusto e le proprie capacità. Evidentemente le capacità di Omero erano tali che i greci sentirono in seguito il bisogno di registrare le sue parole per non perderle, e adottarono la scrittura fenicia (anche) per questo.
Oltre due millenni dopo, quando la nozione di autore è già forte, un autore come Ludovico Ariosto non si fa nessun problema, nello scrivere il suo capolavoro, a riprendere non solo personaggi altrui ma addirittura nel proseguire la trama di un altro, il Luigi Pulci dell’Orlando innamorato. Nonostante questo, alla storia è passato molto più lui del suo predecessore su quegli eroi, e basta leggere l’uno e l’altro per capire il perché.
Ora, i miti greci sarebbero meravigliosi anche senza Omero, e pure lo sarebbero quelli cavallereschi, anche senza Pulci o Ariosto. Ma certo un poco l’uno e molto gli altri hanno aggiunto qualcosa, e quel qualcosa è lo specifico dell’autorialità, cioè il fatto di aggiungere al mito una riflessione personale, con la quale noi moderni amiamo confrontarci. Diciamo che il romanzo cavalleresco dell’Ariosto è il mito più il discorso, è il mito più una proposta personale di affrontarlo.
Quando nasce il fumetto, si trova in una situazione che condivide molte caratteristiche con l’oralità (ne ho parlato qui), e il suo successo si basa su una condivisione di valori e situazioni con il proprio pubblico che ha molti caratteri del mito. Naturalmente, trattandosi di un prodotto moderno, che vive la sua vita in un contesto di produzione in cui l’autore esiste in maniera inevitabile, la situazione non è certo la stessa che ai tempi di Omero. Tuttavia, per molto tempo in maniera quasi esclusiva e in vari suoi settori ancora oggi, nonostante la presenza di autori, il fumetto viene fruito da molto pubblico sostanzialmente come mito. La progressione verso l’autorialità c’è stata, nel suo secolo e passa di vita, ed era inevitabile che ci fosse, ma non ha affatto scalfito certi aspetti dello zoccolo duro della fruizione.
Non lasciamoci ingannare: le espressioni di serie e di autore non sono antonime, non definiscono due poli opposti, né per opposizione netta né su un continuum per gradi. L’autore di fatto c’è sempre, e il problema è semmai quanto egli sia presente nella ricezione del lettore. Questo vale tanto per le serie quanto per le storie autoconclusive, anche se per queste ultime è più frequente che lo si ritenga rilevante.
Non lasciamoci ingannare nemmeno da un’altra considerazione. L’industria culturale non ha il monopolio degli eroi e delle serie. Essa stessa, in un sistema commerciale, è inevitabilmente legata al gusto del pubblico. Un eroe ha successo se c’è un pubblico che lo apprezza, ovvero se muove qualcosa nell’immaginario di qualcuno, ovvero se può almeno un poco, per qualcuno, costituire una mitologia. Da questo punto di vista, l’autore di un personaggio di successo che viene fruito in maniera poco o punto autoriale è semplicemente colui che ha saputo lasciarsi attraversare meglio di altri dallo spirito del tempo (o da un qualche spirito del tempo), cogliendolo e restituendocelo.
Quando il testo viene fruito in maniera autoriale (di serie o meno che sia), l’autore aggiunge a questa capacità anche quella di trasmettere il proprio discorso, e quindi di dialogare con il suo pubblico e con gli altri autori attorno a lui.
È questo aspetto di discorso e di dialogo a essere sottolineato e spesso unicamente preso in considerazione da molta critica delle arti più riconosciute, dalla pittura al cinema al romanzo. Questa critica sbaglia anche in questi casi: un’opera d’arte firmata è sì certamente un discorso, ma non l’apprezzeremmo davvero come tale se fosse solo quello, e se non fosse pure, al tempo stesso, fortemente mitopoietica.
Aggiungiamo che, a sua volta, quello stesso dell’autore è, da qualche secolo a questa parte, un mito (moderno), il mito del genio creatore, il mito del Michelangelo ispirato, che rappresenta al meglio l’individualismo occidentale (moderno).
Tra mito dell’eroe (o di qualche altro elemento adatto alla serializzazione) e mito dell’autore, l’editore può sempre scegliere dove calcare la mano per le proprie operazioni di promozione, e a seconda del pubblico cui si rivolge enfatizzerà di più la componente mitica oppure quella di discorso.
Detto questo, non vedo quindi nulla di sbagliato nel fatto che un personaggio di successo possa essere proseguito da altri. Molto spesso i risultati sono peggiori, certo, perché il genio è raro, e la serie vivacchia sul prestigio acquisito in passato piuttosto che sul valore presente: Asterix senza Goscinny è una tristezza, né Sagendorf né Zaboly né nessun altro hanno saputo rendere a Popeye la dolce e incantevole demenzialità di Segar; rabbrividisco al pensiero di cosa possa accadere ai Peanuts, caduti in mani che non sono quelle di Schulz. E tuttavia, l’Asterix del dopo Goscinny non ci impedisce di preferire e leggere quello originale, e magari contribuisce a tener viva la memoria e il mito (a sua volta) del primo grande suo autore.
Aggiungiamo poi che qualche volta è pure successo di trovare prosecutori più bravi dei creatori iniziali: Lucky Luke è stato inventato da Morris anche per i testi, ma se Morris non avesse conosciuto Goscinny passandogli poi la mano per quel ruolo, oggi probabilmente non continueremmo a leggerlo. Spirou è stato creato da Rob-Vel nel 1938, ma è stato il suo successore Franquin (dal 1946) a incantare i francesi. Adoriamo il Paperino di Carl Barks, ma questo non ci impedisce di apprezzare Don Rosa (e vari altri). Chi si ricorderebbe di un oscuro personaggio DC Comics, chiamato The Sandman, se non l’avesse ripreso Neil Gaiman? La lista potrebbe continuare.
La continuità del personaggio è quella del mito; la presenza dell’autore è quella del discorso. La letteratura colta ha bisogno di entrambe le componenti, mentre quella popolare si può accontentare della prima. Non c’è un confine tra le due, oggi, ma solo un passaggio sfumato di modi diversi di ricezione.
Non confondiamo, per finire, le questioni di ricezione con quelle di diritto. Dal punto di vista del diritto conta la creazione, e per creare, al giorno d’oggi, un autore (o più di uno) c’è sempre. Non si potrà mai negare che il personaggio sia stato creato da lui, né disconoscergli i diritti – nemmeno quando il pubblico ignora il suo nome. Il pubblico ha il diritto di ignorarlo, perché in certi casi per la sua ricezione l’autore è davvero irrilevante. Ma la legge lo deve tutelare perché comunque quella cosa, ormai di pubblico consumo, ha avuto origine da lui.
È un vero peccato che Sergio non ci sia più. Credo che avrebbe apprezzato.
 Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940 Magari Ray Moore non è Alex Raymond, e nemmeno Caniff, e la composizione di queste figure è un po’ goffa, ma trovo che, ugualmente, qualcosa da imparare dai suoi inchiostri ci sia. Sarà per questo effetto tutto pennello (e niente pennino) con pennellate grosse e pastose, sin quasi all’eccesso, ma qui Moore riesce davvero a recuperare con gli inchiostri quello a cui la sua composizione non arriva.
Non è solo l’effetto drammatico delle ombre forti e nette contro le luci altrettanto forti e nette – ma certo c’è anche quello. È anche e soprattutto questa modulazione eccessiva delle pennellate che rende le figure fluide e vigorose – come ha da essere, naturalmente, the Phantom, l’Uomo Mascherato. Così, dove c’è movimento, il movimento fluisce, come nella vignetta in alto; mentre dove c’è tensione, come in quella in basso, tutto si tinge di forza, e la presa dell’eroe sembra quella di un gigantesco serpente che avvolge le sue spire.
Poi, sì, non è difficile trovare un sacco di difetti a questi disegni, realizzati molto probabilmente in tempi assai brevi, ma gli inchiostri di Moore, almeno su di me, giocano ugualmente un grande fascino.
Le immagini (ad alta risoluzione) sono prese dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti.
 Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940
 Dario Morgante e Gianluca Costantini - Julian Assange e Wikileaks, BeccoGiallo 2011 Non si può escludere che Gianluca Costantini si sia riletto troppe volte il Città di vetro disegnato da Mazzucchelli, o il Jimmy Corrigan di Chris Ware, però li ha digeriti bene, e questo è il primo libro di BeccoGiallo che non mi faccia pensare che l’impegno sociale fa male ai fumetti.
C’è una storia raccontata per flash back e flash forward che, anche se, inevitabilmente, non ha una fine, narrativamente funziona, e ti tiene lì, senza annoiarti. La sua struttura un po’ contorta (ma non troppo) è persino coerente con i giochi visivi di Costantini, che finiscono davvero per raccontare in maniera molto evocativa.
C’è forse, ogni tanto, un vago odore di esercizio di stile, ma è necessario riconoscere che non è mica facile raccontare una storia vera, politicamente forte, senza diventare retorici – quello che è, in generale, il difetto principale degli altri volumi di questa collana. Un difetto che invece questo volume non ha, e non mi sembra cosa da poco. Magari è anche lo stesso sospetto – occasionale – di esercizio di stile, a tenere alla larga il pericolo, molto più grave, della retorica.
In realtà non lo so, però il libro mi è piaciuto. L’ho letto volentieri dall’inizio alla fine. Mi ha persino fatto venir voglia di scriverne queste righe. Mi ha fatto addirittura rimpiangere che il libro su Amy Whinehouse Fatta di musica non sia che una beffa estiva. Magari Becco Giallo aveva finalmente imbroccato la strada giusta. È davvero un peccato quando su cause giuste si scrivono solo libri sbagliati. Ma magari il cambio di rotta ora c’è stato davvero. Tifiamo per Morgante e Costantini.
 Attilio Micheluzzi, Johnny Focus, dettaglio Le vacanze sono terminate, ma la mia testa non se ne è ancora accorta. Se non si sveglia finirò per essere un po’ latitante dal blog – tanto più che in questo periodo gli impegni si accumulano. Per questo colgo l’occasione che mi ha offerto qualche tempo fa Andrea Queirolo, di fare qualche riflessione sugli inchiostri di Attilio Micheluzzi, a partire da una tavola di sua proprietà, da cui è tratto il dettaglio che vedete qua sopra. Ovviamente per seguire il discorso consiglio di aprire l’immagine a piena risoluzione (che è piuttosto alta) in una diversa finestra. (la tavola nella sua interezza può invece essere vista qui)
Intanto, un’osservazione di massima: resto colpito da come queste belle immagini perdano di incisività quando le si guarda troppo nel dettaglio. Ovviamente questo non è in sé un difetto, perché non sono fatte per essere guardate tanto da vicino. Ci sono linee che appaiono troppo deboli rispetto ad altre vicine che sono invece forti, zone molto lavorate vicino a zone appena abbozzate, luoghi dove le linee sembrano intrecciarsi troppo, con effetti persino fastidiosi (come nel volto dell’uomo coi baffi della vignetta di sinistra). Nella vignetta di destra, lo sguardo della ragazza è certamente il punto maggiormente rilevante, e ingrandendo quella zona si può vedere quanto lavoro di pennello e biacca ci sia, su quegli occhi, che finiscono in questo modo per diventare una zona fortemente contrastata in mezzo al bianco piatto del volto di lei: focalizzazione narrativa e focalizzazione visiva che collaborano e si rinforzano a vicenda.
Questi inchiostri “trasandati” lasciano pensare che Micheluzzi voglia concentrare l’attenzione del lettore su altro. Questo altro potrebbe essere, per esempio, la composizione, che è notevole in entrambe le vignette e anche nel loro accostamento. La vignetta di sinistra, più concitata, mostra la grande diagonale bianca in primo piano in basso, a contrasto con l’altra struttura diagonale di fondo delle strisce bianche e nere della veneziana. A destra, nella medesima vignetta, i due personaggi si trovano in verticale, a dare presenza statica alla composizione, mentre a sinistra le tre teste formano a loro volta una diagonale dinamica, e il dinamismo implicito (perché di fatto nessuno dei personaggi si sta muovendo gran che) è assicurato dallo zigzag che parte dalla striscia bianca in basso, si inverte nel braccio della morta, ancora si inverte nel braccio dell’uomo a destra, e poi ancora dalla sua testa a quella dell’uomo coi baffi, e poi indietro alle due teste sul fondo: alla progressione dal basso verso l’alto corrisponde quella dal primo piano verso lo sfondo.
La vignetta di destra è più calma, e dominano le linee bianche e nere delle veneziane, ora diventate orizzontali, a contrasto con le figure verticali dei due personaggi. Ma anche qui – in misura minore – ci sono elementi dinamizzanti: le diagonali bianco-nere a sinistra, il braccio e il seno di lei, la posizione leggermente obliqua della testa e del corpo di lui, e soprattutto le linee bianche, nere e grigie della copertura del divano, che richiamano quelle del fondo contrapponendovisi come irregolarità a regolarità, dinamico a statico (senza contare che queste linee del divano sono la ripresa regolarizzata delle ombre e riflessi della giacca di lui; al tempo stesso lei è tutta pallini, boccoli e occhioni, forme di tipo circolare che la fanno emergere intensamente dal fondo, al quale lui invece appartiene molto di più – persino nel modo in cui sono tracciati gli occhi, non ellittici ma quasi lineari).
La grande diagonale bianca alla base della prima vignetta si ritrova rialzata nella parte sinistra della seconda. La composizione, è infatti, in Micheluzzi, una struttura dinamica, che incoraggia il passaggio rapido dell’occhio alla vignetta successiva. L’inchiostrazione “trasandata” sembra a questo punto assolvere la medesima funzione, impedendo all’occhio del lettore di fermarsi troppo a lungo sui dettagli molto curati, costringendolo a fluire. I tratti di pennello sono sufficientemente precisi per caratterizzare (e anche molto intensamente) i personaggi e le loro emozioni, ma al di là di questo diventano incerti, troppo rapidi, quasi confusi. Più che Raymond sembra di vedere i suoi epigoni (di valore) come Toth o Williamson, che sacrificano la precisione rappresentativa per l’effetto di fluidità. L’inchiostrazione che appare eseguita con rapidità invita a un’analoga rapidità di fruizione visiva.
In altre parole, gli inchiostri di Micheluzzi sembrano per l’appunto quelli di una testualità che chiede di essere letta assai più che guardata, ma letta proprio nella sua componente di immagine. Nel fumetto, di solito, si guarda l’immagine per leggerla, seguendo un filo discorsivo e narrativo predisposto dall’autore: poiché tuttavia guardare e leggere l’immagine non sono azioni davvero distinte, ma polarità di un medesimo comportamento visivo, troveremo fumetti le cui immagini sono più adatte ad essere staticamente guardate e altri che vogliono essere dinamicamente letti anche nelle loro figure. Enfatizzare l’aspetto del leggere (rispetto a quello del guardare) significa aumentare il coinvolgimento potenziale del lettore nella storia, cioè sottolineare attraverso la costruzione visiva la storia stessa e il suo procedere. Questo – mi sembra – è proprio ciò che fa Micheluzzi sia con le sue composizioni dinamiche che con i suoi inchiostri.
Sghignazzate con i galli
Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 1996
Tra i fumetti dall’umorismo travolgente – quelli che muovono al riso incontrollato e spasmodico persino il lettore solitario – ce n’è un gruppo con una caratteristica comune. Il cowboy Lucky Luke, l’indiano Oumpa Pah, il perfido Visir Iznogoud (leggere il nome ad alta voce per comprenderne il significato), il gallico Asterix hanno infatti tutti in comune un autore, il francese René Goscinny.
Purtroppo, il più geniale sceneggiatore umorista che il fumetto francese abbia avuto è scomparso nel 1977, quasi venti anni fa, ad appena 51 anni, lasciando un patrimonio di storie che avevano fatto epoca, e la direzione di un giornale, Pilote, su cui si erano formati i migliori autori della generazione successiva, da Gotlib a Fred alla Claire Bretecher. In Francia tante delle sue creazioni continuano a fare cassetta, ma all’estero almeno Lucky Luke e, soprattutto, Asterix, sembrano vivere un successo infinito.
Quest’anno, il piccolo gallo invincibile compie la bellezza di trentacinque anni, e appare davvero strano che, con tutta la sua freschezza e la sua immutata capacità di far ridere di cuore, tanti anni siano passati da quando per la prima volta, nel 1961, le sue storie vedevano la stampa. Goscinny aveva trentacinque anni allora, e già un passato glorioso: quest’anno ne compirebbe settanta.
Asterix inaugurava un modo di far ridere diverso, basato su un paradossale che faceva leva sulle piccolezze del quotidiano. Impossibile dimenticare, per esempio, le folgoranti parodie dei vari popoli europei (o dei loro stereotipi) che, storia dopo storia, si sono susseguite: dai Britanni che interrompono le battaglie per bere la loro tazzina di acqua calda (il tè non è ancora stato scoperto), agli Elvezi isterici per le pulizie, le casseforti e le fondute di formaggio – per non dire della puntualità delle clessidre (gli orologi, ahinoi, non essendo ancora stati inventati) al punto di svegliare con regolarità gli ospiti dell’albergo ogni ora affinché ciascuno possa girare la propria…
(E come dimenticare poi i vari tormentoni? Dai pirati, destinati ogni episodio a rimetterci una nave alla fame epocale di cinghiali di Obelix; dalla distruzione delle centurie romane all’imbavagliamento prudenziale del bardo. Si è trattato della creazione, episodio dopo episodio, di una serie di aspettative intratestuali, sulle modalità della cui soddisfazione si sono innestate poi le più esilaranti invenzioni umoristiche.)
Il cinema non ha fatto che consolidare un successo già enorme, con meriti assai minori di quelli delle storie originali, se pure il pubblico ricorderà soprattutto l’epopea di Asterix e Cleopatra, che certo principalmente nel cinema può fare evidentemente il verso al film con Liz Taylor. Campanilisti senza sciovinismo, i fumetti di Asterix ci mostrano, a noi italiani, una romanità risibile proprio per la sua grandezza – mai negata, ma soltanto contrapposta a una semplicità astuta e fiera della propria autonomia.
Due occasioni ci permettono di segnalare questo trentacinquennale, e il settantennio dalla nascita di Goscinny. Una è l’uscita dell’ennesimo volume della serie, passata interamente nella mani di Albert Uderzo, che ne era stato in precedenza solo il disegnatore. Il volume Asterix e la galera di Obelix, appena pubblicato per i tipi della Mondadori, aggiunge alcune spassose battute e situazioni alla lunga serie che già conoscevamo, confermando tuttavia una volta di più che la maestria di Uderzo come sceneggiatore non è pari a quella che ha sempre dimostrato come disegnatore.
L’altra occasione è una piccola mostra sul piccolo gallo ad Aosta, nella chiesa di San Lorenzo, aperta sino al 24 novembre, di cui abbiamo avuto gradita notizia.
Così Calvin ricomincia da zero
Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 1996
La notizia, di qualche mese fa, che Bill Watterson aveva smesso di disegnare Calvin & Hobbes, è di quelle che lasciano i lettori confusi e scontenti. Certo, come dargli torto, dal punto di vista personale? La vita di un autore di comic strip deve essere veramente uno stress: sei strisce originali più una storiella di una pagina ogni settimana. Per quanto originali si possa essere, e per quante variazioni permetta il tema, dopo dieci anni, tremilacentoventi strisce e cinquecentoventi pagine autoconclusive, si ha il diritto di essere stanchi del proprio personaggio – anche se ci ha portato fama e ricchezza!
E tuttavia l’abbandono di Watterson fa notizia. Calvin & Hobbes è nota come la striscia più originale che parli di bambini dopo i Peanuts di Charles M. Schulz, e Schulz continua a disegnare Snoopy e Charlie Brown da oltre quarant’anni. Ma Watterson non è il primo ad abbandonare: si inserisce in una tendenza di cui fanno parte anche altri autori della sua generazione, come Garry Trudeau (autore di Bloom County e del pinguino Opus) e Gary Larson. La tendenza preoccupa: nel giro di pochi anni hanno abbandonato il campo una larga maggioranza proprio di quei disegnatori di comic strip e vignette che si erano meritati il successo per innovatività e arguzia. E la motivazione è comune a tutti: “sono stanco”.
Mentre, con rammarico, ci rassegnamo a non poter più leggere strisce nuove di Calvin & Hobbes (così come era accaduto con quelle di Bloom County, e con le vignette di The Far Side) gli editori provvedono tempestivamente a consolarci. La rivista Linus, su cui la striscia di Watterson è pubblicata quasi da quando è nata, non ne ha interrotto l’uscita neppure per un mese, passando direttamente dalle strisce del 1996 alla riproposizione di quelle del 1986. E queste medesime strisce iniziali ci vengono proposte anche in volume dalla casa editrice Comix.
Scopriamo così che, al di là di qualche incertezza nel disegno – che scompare comunque molto rapidamente – il mondo umoristico di Watterson è completo ed esilarante sin dal primissimo inizio. Il rapporto tra il bimbo Calvin e il suo tigrotto di pezza Hobbes è già quello che, negli anni successivi, si svilupperà in innumerevoli variazioni. Hobbes è il vivissimo compagno di giochi e di malestri del bimbo (con un pizzico di ragionevolezza in più del suo padrone), salvo quando viene visto dagli occhi degli adulti, i quali lo vedono per quello che è, un inerte pupazzo. Calvin è il bambino che vede il mondo attraverso la lente deformante della propria dilagante fantasia, facendo disperare i genitori che ovviamente non capiscono mai che “un tirannosauro non può mangiare gli spinaci”, o che la camera da letto, di notte, è piena di terribili mostri.
Per chi non lo conosce, Calvin & Hobbes non è una comic strip per bambini, pure se – e con un certo successo – è stata proposta anche su riviste per l’infanzia. E’ semmai, una striscia che riflette (mi si perdoni il termine, e la sua – in questo contesto – un po’ grottesca seriosità) sulla capacità di interpretare il mondo con fantasia, e sul rapporto degli adulti con l’immaginario dei bambini. Non escludo che se ne possa fare anche un proficuo uso pedagogico: ma non sarebbero i bambini i destinatari di questo uso.
Bill Watterson, Calvin & Hobbes, Comix, Modena
128 pp. £.19.000
Un topo cattivo aiuta Telefono Azzurro
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 1996
Quando un tema è così drammatico e intenso come la violenza sui minori, è fin troppo facile cadere nell’eccesso e nella retorica dei buoni sentimenti e del rispetto. E’ facile scambiare moralità e moralismo, e credere che una qualsiasi storia di condanna possa essere una buona storia. Il tema, trattato da autori mediocri, diventa facilmente un tema “di tendenza” come tanti altri, e la condanna morale, affidata ad un testo noioso, appare come l’ennesima ripetizione di un copione ribadito ossessivamente dai media.
Non che se ne parli troppo, certo: di violenza ai minori non si parlerà mai abbastanza. Il fatto è che, per quanto importante e tragico sia, qualsiasi problema, qualsiasi dramma troppo ripetuto ci rende ciechi e sordi nei suoi confronti, a meno che il modo in cui ci viene presentato non sia in grado di risvegliare il nostro interesse. Per quanto cinico questo possa apparire, il mondo delle comunicazioni di massa funziona così.
La pubblicazione in italiano de “La storia del topo cattivo” di Bryan Talbot è per questo una molteplice occasione di interesse. E’ una storia sull’adolescenza e sul riscatto dalla violenza subita, affrontata con delicatezza e originalità; è una storia che varrebbe la pena di leggere anche se il suo tema non fosse quello che è; ed è una storia a fumetti, che segna il ritorno di un grande autore inglese a temi più specificamente suoi – dopo anni di, pur spesso notevolissime, produzioni seriali americane.
Di Bryan Talbot abbiamo parlato ancora, nel 1993, quando uscì in italiano Luther Arkwright, prototipo di un’avanguardia fumettistica britannica (l’originale inglese è dei primi anni Ottanta) con poco da invidiare alle avanguardie letterarie o artistiche. La storia del topo cattivo, invece, non ha nulla di avanguardistico: è una storia scritta e disegnata per essere letta anche da persone non abituate a frequentare i fumetti. Vi si racconta di una ragazza fuggita di casa, dopo anni di abusi sessuali da parte del padre, alla ricerca di qualcosa che nemmeno lei sa; o alla ricerca della forza, della consapevolezza per affrontare la situazione, e risolvere il nodo pauroso, l’angoscia e il senso di diversità e di colpa che le impediscono di vivere.
Il suo nome è Helen Potter, e la coincidenza con il nome di Helen Beatrix Potter è il secondo motore della storia. Helen vive la propria storia attraverso l’immaginario della sua più famosa omonima, copiandone i disegni e il senso ambiguamente tenero e tragico della vita. Troverà una via d’uscita dal suo dramma proprio attraverso i simboli dei personaggi della Potter. Troverà la forza di affrontare il padre quando, in qualche modo, si sarà ricongiunta con i simboli della propria infanzia.
Anche il disegno è un oggetto interessante, in questo “Topo cattivo”. Nessun virtuosismo, nessuna fuoriuscita da un realismo narrativo dall’apparenza semplice, elementare. Eppure un disegno del tutto fuori tendenza, di estrema efficacia persino quando i personaggi rappresentati ricordano in qualche modo (sempre discreto) gli animaletti della Potter. Il dramma della ragazza ne esce descritto con intensità, senza che mai si abbia l’impressione che l’immagine voglia impadronirsi di quello che la storia ci dice.
Pubblicato con il patrocinio del Telefono Azzurro (cui è destinata una parte dei ricavi delle vendite) “La storia del topo cattivo” è una miniserie di quattro albi, in vendita nelle edicole e nei negozi specializzati.
Bryan Talbot, La storia del topo cattivo, Phoenix, Bologna
Ritrovate Alack Sinner
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 1996
Per circa un decennio, dalla metà degli anni Settanta alla metà degli Ottanta, il fumetto italiano ha vissuto una stagione magica, per creatività degli autori e attenzione del pubblico. In quegli anni il racconto a fumetti è diventato in Italia un prodotto adulto e raffinato, spesso libero di esprimere al meglio una vocazione espressionista ed intimista, un tentativo di raccontare quello che a fumetti non si era mai raccontato.
All’origine di questa fioritura sta, con particolare rilievo ed enorme rispetto da parte di tutti gli autori che ne hanno seguito le tracce, una coppia di autori argentini, allora esuli politici, venuti a pubblicare sulle nostre riviste – invertendo una tradizione che vedeva gli autori italiani emigrare a Buenos Aires, con Hugo Pratt tra i tanti. Si tratta di José Muñoz e Carlos Sampayo, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore di una serie iniziata nel 1975, e intitolata Alack Sinner.
Benché si trattasse di una serie poliziesca di ispirazione chandleriana, sin dall’inizio Alack Sinner aveva colpito più per l’intensità emotiva, caricata magistralmente dal segno difficile di Muñoz, che non per l’intricatezza degli enigmi. Nel giro di qualche anno dei temi classici della detective story in Alack Sinner restava sempre meno, e una dopo l’altra le storie diventavano vicende di umanità, amicizia e disperazione metropolitana. Il nome del protagonista (che, in inglese suona come: io, povero peccatore) corrispondeva sempre di più al programma narrativo che veniva svolto.
Con la storia Trovare e ritrovare, del 1981, l’introverso, difficile Alack lascia la professione di investigatore. Per la prima volta non c’è nemmeno più la falsariga della detective story a condurre la trama. La vicenda di questo lungo racconto procede per episodi: Alack va a trovare il padre, che non vede da lungo tempo, e con cui non ha molto da dire, incrocia la sua indifferenza con la fama di Frank Sinatra, e gli eventi lo portano a reintrecciare la sua vita con quella di Enfer, una donna di colore con cui aveva avuto tempo prima una relazione. Sarà la notizia di aver avuto con lei una figlia a scuoterlo dalla propria melanconia, proprio mentre un poliziotto ubriaco cerca di ammazzarlo per antichi rancori e Sinner è costretto a difendersi, finendo in galera per omicidio.
La vicenda ha un finale problematico ma positivo. L’ex detective recupera un senso alla propria esistenza, anche attraverso le storie che apprende dai compagni di cella nel periodo in cui si trova in prigione. La paternità non si annuncia facile, ma è un occasione per non ripetere il rapporto da lui avuto con il proprio padre.
Il segno di Muñoz è tagliente, impietoso. Riempie i volti dei personaggi di segni di vita vissuta, oppure li lascia spogli, come maschere senza sentimento. I bianchi e neri netti, senza tinte intermedie disegnano spesso figure grottesche, violentemente caricaturali. E Sampayo racconta la storia di Sinner facendola attraversare da mille altre storie, così che la New York che ne esce appare davvero come un intrecciarsi di vite.
Dopo quindici anni dalla sua pubblicazione su rivista, questo testo cruciale, tanto amato da una generazione di autori e lettori di fumetti, esce finalmente in volume. Lo si rilegge con la stessa emozione di allora, con, in più, come l’impressione di ritrovare un vecchio e caro amico.
José Muñoz, Carlos Sampayo, Alack Sinner. Trovare e ritrovare, Milano, Hazard Edizioni
pp. 118, £. ***
Mano
Inedito per Il Sole 24 Ore, scritto il 18 marzo 1996
E’ un percorso di rigore quello che porta Maria Giovanna Anceschi e Stefano Ricci a creare Mano, fumetti scritti disegni, una rivista il cui primo numero è apparso da poco in libreria, e che contiamo di ritrovarvi ogni quattro mesi. Risalendo all’indietro in questo percorso potremmo reincontrare il lavoro di Ricci come illustratore, dotato di un segno difficile, ma davvero di rara profondità, creatore di immagini che richiedono una lettura attenta e ricompensano il loro lettore con intuizioni inquiete, echi e suggestioni che appaiono espresse e trattenute al tempo stesso.
Più di recente incontriamo un lavoro comune di promozione culturale, il caso singolare di una serigrafia che diviene al tempo stesso galleria, e dove le opere si trovano esposte nelle stesse sale dove si compie il lavoro di stampa. E’ la galleria Squadro di Bologna, dove si producono e si espongono le cartelle di serigrafie curate dalla Anceschi con la grafica di Ricci. Gli autori di queste serigrafie sono pittori, illustratori, fumettisti. Magnus, il grande disegnatore bolognese recentemente scomparso, è l’autore dell’ultima cartella prodotta. Seguirà Lorenzo Mattotti.
Con la stessa cura tenace, quasi ossessiva, con cui si realizzano le serigrafie, prova dopo prova, effetto materico dopo effetto materico, è stato realizzato questo primo numero di Mano. Il nome stesso è un programma, una dichiarazione di intenti a favore di una visione unitaria della comunicazione verbale e per immagini. La stessa mano scrive e disegna, produce significanti verbali e significanti visivi con la stessa leggerezza o con la stessa profondità. E’ ovvio che al centro di un programma di questo genere non può che esserci il fumetto, linguaggio verbo-visivo per eccellenza. Ma non è meno ovvio che letteratura e poesia, cinema, disegno e pittura siano i suoi compagni di strada inevitabili.
Contro l’analfabetismo dell’immagine, si potrebbe dire. Contro, cioè, l’abitudine di assorbire le immagini senza comprenderle, oscillando tra il voyeurismo della pubblicità e il feticismo dell’arte. Contro l’atteggiamento secondo cui la riflessione passa solo attraverso la parola, e l’immagine ne è, al più, un superfluo abbellimento.
Mano inizia con alcune rivisitazioni: vi sono Alfred Kubin e Diane Arbus che raccontano episodi cruciali della loro iniziazione all’immagine; e vi è un dialogo intrecciato tra Artaud e Balthus, del quale vengono presentati anche una serie di disegni per Cime Tempestose di Emily Brontë. Vi sono poi i disegni di Joseph Beuys e di Igort, cui fa seguito una nutrita sezione di fumetti per palati dal gusto educato: gli autori sono Jacques Faton e Philippe de Pierpont, Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky, Gabriella Giandelli e Lilia Ambrosi, Francesca Ghermandi e Massimo Semerano, Stefano Ricci, Onze e Francesca Astori. Conclude la sezione un giovane autore serbo, Aleksandar Zograf.
Il discorso prosegue abbordando il cinema e il suo rapporto con lo story-board, ovvero la versione disegnata della sceneggiatura. Ne parlano Thierry Groensteen, Terry Gilliam e Peter Greenaway. In fondo, ancora a cavallo tra la verbalità e la visività, Gianluigi Toccafondo, Ben Shahn, Alastair Reid e un sarcastico recupero di Osip Mandel’stam percorrono un evocato universo infantile.
Rivista di fumetti né più e né meno che d’altro, ma soprattutto rivista di cultura dell’immagine, nata in un momento difficilissimo per il fumetto italiano, Mano porta la propria proposta in libreria. Se vogliamo vedere la contrapposizione tra libreria ed edicola come una tra il duraturo e l’effimero (almeno in termini di memoria storica), la scelta di campo dei suoi ideatori è evidente. Da parte nostra, l’augurio di tutto cuore è che la rivista possa essere veramente duratura, e non soltanto come memoria.
I nuovi supereroi umani, troppo umani
Il Sole 24 Ore, 17 marzo 1996
Nell’anno del centenario del fumetto, Treviso Comics ha dedicato la sua Rassegna Internazionale del Fumetto e delle Comunicazioni Visive a un tema tra i più fortunati della storia del racconto per immagini: il supereroe. Vi sono dunque Superman, Batman, l’Uomo Ragno e Capitan America, ma non solo loro; e il fumetto di supereroi non è soltanto quello che normalmente si crede.
Intanto, dalla metà degli anni Ottanta in poi il fumetto americano di supereroi ha visto nascere al suo interno un fronte critico che ne ha modificato sostanzialmente l’impostazione complessiva, permettendo e spesso favorendo la nascita di testi di alta qualità. In questo genere di fumetti, spesso la tematica del superomismo è diventata un pretesto per parlare dei miti e della società americana – o del superomismo stesso, in quanto a sua volta mito americano. Non di rado dunque la qualità sia narrativa che grafica dei fumetti di supereroi ha raggiunto in questi anni livelli di grande interesse, documentati con una notevole scelta di esempi in due belle mostre di tavole originali nella manifestazione trevisana. Autori come John Bolton, Kent Williams, Stuart Immonen e Dave Mc Kean possono testimoniare il grado di maturità degli artisti che si misurano oggi con questa materia.
Ma il tema ha geminato. Visto il successo che questo genere di fumetti riscuote in Italia, c’è chi ha pensato che si poteva tentare la carta dei supereroi made in Italy, riprendendo il tema ma ammorbidendolo e approfondendolo con caratteristiche un po’ più “europee”. Protagonista di una mostra sui supereroi italiani – personaggi dalla vita assai più tormentata e difficile di quella dei cugini di oltreoceano – è la casa editrice Phoenix, che negli ultimi anni ha puntato molto sulla creazione di un universo superomistico autonomo, ottenendo una serie di interessanti risultati con personaggi come Examen, Sebastian o Team Adriatica, e con la ripresa di Ramarro, l’anti-supereroe inventato da Giuseppe Palumbo per Frigidaire già negli anni Ottanta. L’ambiente in cui questi personaggi si muovono è un’Italia del ventiduesimo secolo, ricca di conflitti e di angosce metropolitane. Conflitti che, nella migliore tradizione dei supereroi di questi ultimi anni, dilaniano anche la psicologia dei protagonisti: vi è l’eroe che fatica ad accettare il proprio superiore potere, e quello combattuto per un’omosessualità in singolare contrasto con il proprio stile di vita; vi è la squadra di giovanissimi in fuga, che non accettano il sacrificio cui è stato costetto il loro corpo per innestarvi i poteri, e vi è la squadra governativa, ricca di personaggi contrastanti, da quello ligio a un dovere a cui non ci si può sottrarre all’altro per cui sterminare o sedare è un piacere.
Tra le produzioni italiane non Phoenix si distingue invece Gabriel, di Riccardo Secchi, pubblicato da MBP, dove il supereroe è nientemeno che una giovane suora, che, nella migliore tradizione delle investiture di superpoteri, è rimasta vittima di un incidente con un apparato sperimentale, ed è in grado, da quel momento, di volare e di proiettare grandi quantità di energia dalle mani. E’ un fumetto ben sceneggiato e discretamente disegnato, anche se un po’ succube di molte storie americane degli ultimi anni.
Singolare, ma stimolante, è l’accostamento con la versione Disney del superomismo, non tanto con Superpippo (del quale nella mostra “I supereroi Disney” si sentiva un poco la mancanza) quanto con Paperinik, parodia paperinica (di origine italiana) dei giustizieri mascherati. Di Paperinik è stata presentata, tra l’altro, l’imminente versione rinnovata: sta per uscire infatti un albo mensile, formato comic book, che si chiamerà PK, e narrerà le imprese di Paperinik in uno strano mondo di alieni, con un segno davvero inconsueto per la Disney, una sorta di parodia del barocchismo grafico dei principali fumetti americani.
La giornata centrale della manifestazione è stata sabato 9 marzo, e si è conclusa con la premiazione dei volumi a fumetti migliori usciti nel corso del 1995. Per il genere realistico il volume più votato è stato Sogni a occhi aperti, che abbiamo già presentato su queste pagine (9.7.1995), a cura di Daniele Brolli, Michele Canosa e Franca Di Valerio, un omaggio collettivo all’amore dei surrealisti per il cinema. Per il genere comico-umoristico è stato invece premiato il divertente volume di Giorgio Cavazzano Capitan Rogers e il calumet della guerra.
Nell’anno del centenario del fumetto non è tuttavia solo un festival così amato dagli addetti ai lavori come quello di Treviso a far parlare di sé. Imminente è infatti l’apertura di una grande mostra celebrativa a Ferrara, che si propone di presentare una grande e dettagliata panoramica dei dieci decenni che sono stati attraversati da questa forma espressiva. Gulp! 100 anni a fumetti aprirà i battenti nella sede del Castello Estense il 3 aprile, per rimanere a disposizione del pubblico sino al 30 giugno.
La mostra sarà divisa in dieci sezioni, corrispondenti ai decenni del secolo, e mostrerà originali e copie d’epoca, accompagnati da una nutrita documentazione, con evidenti scopi al tempo stesso spettacolari e didattici. L’organizzazione è di Ferrara Arte, cioè del Comune e della Provincia di Ferrara. Sul catalogo sono previsti interventi di Abruzzese, Brancato, Calabrese, Caprettini, Castelli, Frezza e Pignatone. Un’apposita Guida per Ragazzi sarà realizzata da Silver, e sarà Lupo Alberto a condurre il discorso per i giovanissimi.
Alchimie tra immagini e parole
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 1996
Il fumetto ha vari nomi in varie lingue: “comics” rimanda alla sua origine umoristica, “bande dessinée” alla sua natura di “striscia disegnata”, “historietas” al fatto di raccontare (tra l’altro) piccole storie umoristiche. E’ solo l’uso italiano, “fumetto”, a dare al tutto il nome precipuo di una parte, cioè della nuvoletta che contiene le parole, quella che si chiama, in gergo tecnico, balloon, per evitare irrisolvibili omonimie.
Nonostante la connotazione vagamente denigratoria che la parola stessa possiede, il nome “fumetto” è adeguato al suo oggetto almeno nella misura in cui individua la componente davvero cruciale di questo linguaggio. Il fumetto, cioè il balloon, è quella parte della vignetta in cui l’immagine si fa parola, e la parola è immagine. E’ il luogo più simbolico di un linguaggio che vive a cavallo tra altri due, e che ha costruito la propria autonomia sull’apparenza di una dipendenza irrisolvibile.
Tutti i fumetti sono costruiti come rapporto tra immagini e parole, persino quelli dove le parole non ci sono, perché la loro assenza, in un contesto in cui normalmente sono presenti, è altamente significativa. Non si può valutare un testo a fumetti dalla sola qualità delle immagini, né dalla sola qualità del testo: l’errore diffuso è quello di ritenere che poiché la figuratività del fumetto non è in generale paragonabile a quella delle arti visive, e poiché la letterarietà del fumetto non è paragonabile a quella del romanzo, il fumetto non possa nemmeno sperare di assurgere alla dignità delle une o dell’altro. Ci si dimentica che nel fumetto la qualità sta nella relazione tra parole e immagini, e non nelle une o nelle altre singolarmente. E questa relazione si manifesta in innumerevoli modi, di non semplice catalogazione.
C’è un uso “classico” della parola, che rimanda direttamente all’uso “classico”, “hollywoodiano”, della parola nel cinema: i personaggi si scambiano le frasi di un dialogo di impronta realistica, e le didascalie intervengono solo di tanto in tanto a integrare quello che sarebbe troppo complesso (e troppo lento) mostrare con le immagini. Credo che chiunque abbia mai letto un fumetto classico d’avventura sappia perfettamente come funziona un uso di questo genere. E’, ovviamente, l’uso più normale e diffuso; è, per così dire, il livello zero, la norma.
Le strisce umoristiche adottano spesso varianti significative del modello normale di uso della parola. Sappiamo tutti quanto poco realistici siano i dialoghi di strisce come Peanuts, o Mafalda, o Doonesbury. La necessità di contenere in pochissime vignette significati complessi, spesso pluriallusivi, fa sì che disegno e parola vengano distillati sino a un’alchimia di prestazioni essenziali, la quale, col tempo, è in grado di costituire un microlinguaggio interno alla serie, che permette ai lettori abituali di cogliere significativi rimandi a partire da variazioni minuscole dalla norma. Avulsi dal loro contesto, i dialoghi di queste strisce apparirebbero assurdi e frammentati, spesso addirittura oscuri. Basta pensare alle riflessioni di Snoopy sulla vita, sulla scodella o sul gatto dei vicini.
Ma l’antirealismo non si trova solo nei fumetti umoristici. Persino in grandi classici come Tarzan, Flash Gordon, e Prince Valiant (in Italia Principe Valentino) la parola ha finito per assumere un ruolo diverso da quello standard. A partire da un certo momento nella loro carriera di autori, sia Harold Foster (Tarzan e Valiant) sia Alex Raymond (Gordon) decidono di fare a meno del balloon. Il processo avviene per gradi, ma alla fine degli anni Trenta il risultato è che ogni vignetta è accompagnata da alcune righe di didascalia narrativa, che inglobano i dialoghi come in una normale narrazione romanzesca. Nonostante questo la narrazione verbale non è autonoma, non sarebbe sufficiente da sola a sostenere il racconto, né tantomeno lo sarebbero le immagini: il senso è costruito da queste due narrazioni parallele e intrecciate, quella delle parole e quella delle figure.
Da qui al passo successivo, quello del rapporto straniato tra le due componenti, il passo è breve. Il primo a compierlo è un autore umoristico, George Herriman, che disegna Krazy Kat per quasi trent’anni sino al 1939, giustapponendo ai dialoghi surreali sfondi ancora più surreali, e costruendo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, un universo di deliziose e sentimentali incongruenze. Bisogna però arrivare agli anni Settanta per trovare un uso sistematico di questo rapporto straniato: inizia in Italia Sergio Toppi e iniziano in Francia Les Humanoides Associés; proseguono autori come Jacques de Loustal, Daniele Brolli e Igort, in cui il contrasto tra, da un lato la distanza tra narrazione verbale e narrazione iconica e, dall’altro, il loro necessario rapporto è un oggetto esplicito di poetica.
Nasce forse da questi esperimenti, ma nello spirito di un iperrealismo di vocazione popolare, il rapporto tra parola e immagini tipico di molti recenti fumetti americani di supereroi. La parola, in queste storie, accompagna l’immagine esplicitando lo stream of consciousness dei personaggi, non di rado giustapponendo sequenze di pensieri appartenenti a coscienze diverse, e giocando spesso sull’impossibilità di distinguere tra i pensieri riportati e la voce del narratore, come nel più classico “stile indiretto libero” del romanzo novecentesco. Non c’è vocazione “straniante” in questo uso, che viene davvero percepito dai suo lettori come una forma di realismo – ma siamo andati lontani, ormai, anche dal realismo del cinema, e dal suo ruolo di linguaggio di riferimento per tanto fumetto di avventura di qualche anno fa.
Quanto pesa un secolo di fumetto
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 1996
Il lungo delirio di Daniel Quinn, già poeta e ora scrittore di romanzi polizieschi sotto pseudonimo, inizia con una serie di telefonate in piena notte: qualcuno cerca Paul Auster, l’investigatore – e lo cerca con tanta insistenza presso Quinn che egli decide, dopo alcune perplessità, di spacciarsi per lui e di aiutare la persona che chiama. Più avanti, nella sua indagine su persone dall’identità personale smarrita, finirà per incontrare Paul Auster, nemmeno lui investigatore, bensì – come nella realtà – scrittore. L’indagine si trasformerà piano piano in una personale discesa nello smarrimento e nella perdita di identità, sinché alla fine non si saprà più nemmeno chi è che narra che cosa e perché.
La caratteristica singolare di questa edizione di Città di vetro di Paul Auster è di essere una traduzione a fumetti di questa storia di disidentità e solitudine. All’origine dell’operazione sta un’idea di Art Spiegelman, già autore del romanzo a fumetti Maus, vincitore del premio Pulitzer, e direttore di Raw, rivista dell’avanguardia newyorkese con cui collabora anche Paul Karasik, co-sceneggiatore e adattatore del testo. I disegni sono di David Mazzucchelli, uno dei più noti e significativi disegnatori americani di fumetti, già scelto da Frank Miller per illustrare alcune delle storie di supereroi che hanno sconvolto il genere nel corso degli anni Ottanta.
La ragione per cui Miller scelse Mazzucchelli per illustrare storie di Batman e di Daredevil è che il suo disegno è quanto di meno spettacolare e supereroistico si possa imaginare. Al contrario Mazzucchelli possiede una straordinaria capacità di esprimere sfumature narrative ed emozionali con semplici linee di pennello nero, con un tratto che della semplicità ha solo l’apparenza. Così quelle storie prendevano di colpo un tono che a un disegnatore tradizionale di supereroi – abituato ad enfatizzare piuttosto che ad esplorare – sarebbe risultato impossibile da realizzare. Con una sorta di effetto di straniamento, al mondo dei supereroi veniva restituita una vividezza emotiva che esso non aveva mai posseduto.
Nel romanzo di Paul Auster non c’è altro che questa vividezza emotiva. Il pennello di Mazzucchelli e il suo montaggio dal ritmo lento e un po’ ossessivo ricostruiscono con altri mezzi il senso di ossessione e di progressivo smarrimento della prosa di Auster. Siamo abituati a vedere versioni cinematografiche di romanzi: spesso sono inferiori allo scritto, ma qualche volta scopriamo con piacere opere originali che non hanno nulla da invidiare al testo cui si sono ispirate. Più raramente incontriamo traduzioni a fumetti: è tanto più ragione di godimento quando scopriamo che vale davvero la pena di averle lette. Pure se conoscevamo già l’opera da cui sono partite.
Paul Auster, Città di vetro, Versione a fumetti di David Mazzucchelli e Paul Karasik, Gli Squali Bompiani, 1995
pp. 140, £. 15.000
Il fumetto rende omaggio
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 1996
Epica del nostro tempo, il cinema affolla il nostro immaginario con stelle e miti. Neppure i pochi che restano indifferenti alla magia delle immagini che scorrono possono ignorare che il nome “Casablanca” non evoca soltanto una città del Marocco, e che “via col vento” non è solo un modo di dire. Tutti sogniamo, discutiamo, o semplicemente discorriamo di quello che accade nei film; e le storie raccontate dal cinema sono continuamente il fulcro, la cellula di aggregazione per parlare di mille nostri problemi ed esigenze, vuoi personali, vuoi culturali, vuoi sociali.
Così davvero, per tantissimi versi, il cinema ha assunto per noi la funzione antropologica del mito, come cuore dei discorsi, come fabbrica di oggetti simbolici. Poco importa che di tanti film passati alla storia si possa – del tutto a ragione – parlar male dal punto di vista della qualità artistica: non si può infatti guardare le scene d’amore (o di odio) tra Clark Gable e Vivien Leigh, o tra Humphrey e Ingrid, come si guarderebbero le scene d’amore di un film qualsiasi, dimenticando che mezzo secolo di passioni se le è tenute con passione sullo sfondo.
Allora, quando un’altra arte vuole fare un omaggio al cinema, è ben lecito che al centro di questo omaggio ci sia il mito, la leggenda del cinema. 48 omaggi ad altrettanti film sono altrettante riflessioni – ora appassionate, ora ironiche – di come sono entrati quelle immagini e quelle storie nella nostra vita. C’è la coppia di pensionati raccontati da Coco, che discutono di Casablanca, e lei glie ne racconta una versione in cui Woody Allen suona il piano, mentre Ingrid chiede a Rick di aiutare lei e il suo compagno Roberto Rossellini a fuggire dai nazisti. C’è la Luise Brooks/Valentina di Guido Crepax perduta nello sguardo di Jack, lo squartatore londinese. E ci sono gli studenti del DAMS preoccupati per l’esame di storia del cinema sui Sette Samurai – con inevitabile richiamo, per chi conosca un po’ i fumetti italiani, a un analogo e memorabile esame disegnato anni fa da Andrea Pazienza, che aveva per oggetto Apocalypse Now.
Presentato da Marco Giusti (quello di Blob, per intenderci), con 48 appassionate microrecensioni di tre righe, il volume Buon Compleanno Cinema è un augurio sentito da parte di un arte pressoché coeva, il fumetto. Dopo alcune pagine introduttive con le riflessioni per immagini di Quino, Mordillo e Cavandoli, cento anni di storia del cinema vengono attraversati con la rivisitazione immaginaria dei film che più sono rimasti nel nostro cuore. Inevitabili Il monello, la Potemkin, L’angelo azzurro e Biancaneve; ma anche 2001, Il mucchio selvaggio, Aguirre e Frankenstein Junior. Autori dei commenti a fumetti: Altan, Juan Ballesta, Renato Calligaro, Coco, Guido Crepax, Durante, Francesca Ghermandi, Cinzia Ghigliano, Gnago, Cinzia Leone, Ro Marcenaro, Luca Novelli, Valente.
Ne emerge sicuramente quanto il fumetto deve al cinema, e quanto gli autori di fumetti amino il cinema, ma ne emerge anche come questo debito sia comune e diffuso. Come si potrebbe condensare in poche immagini una riflessione ironica su un film, se questa non potesse attingere dai frammenti di una fascinazione collettiva, che lo ha riempito di sensi ben più ampi di quelli che poteva avere al suo inizio? Parrà pure blasfemo, ma non riusciamo più a pensare al capolavoro di Eisenstein senza che ci passi per la testa, sia pure per un attimo, la dissacrazione di Fantozzi/Villaggio, e non possiamo più guardare la scena della carrozzina senza che insieme a quella non scendano dalla scalinata di Odessa anche le mille carrozzine di altrettante parodie. Tutto questo non toglie nulla alla Potemkin; anzi, per noi, fa parte di lei, a almeno della sua aura.
Marco Giusti presenta 1895-1995. Buon compleanno cinema. Cent’anni di cinema disegnati dai maestri del fumetto
Paul Auster fatto a strisce
Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 1996
Il lungo delirio di Daniel Quinn, già poeta e ora scrittore di romanzi polizieschi sotto pseudonimo, inizia con una serie di telefonate in piena notte: qualcuno cerca Paul Auster, l’investigatore – e lo cerca con tanta insistenza presso Quinn che egli decide, dopo alcune perplessità, di spacciarsi per lui e di aiutare la persona che chiama. Più avanti, nella sua indagine su persone dall’identità personale smarrita, finirà per incontrare Paul Auster, nemmeno lui investigatore, bensì – come nella realtà – scrittore. L’indagine si trasformerà piano piano in una personale discesa nello smarrimento e nella perdita di identità, sinché alla fine non si saprà più nemmeno chi è che narra che cosa e perché.
La caratteristica singolare di questa edizione di Città di vetro di Paul Auster è di essere una traduzione a fumetti di questa storia di disidentità e solitudine. All’origine dell’operazione sta un’idea di Art Spiegelman, già autore del romanzo a fumetti Maus, vincitore del premio Pulitzer, e direttore di Raw, rivista dell’avanguardia newyorkese con cui collabora anche Paul Karasik, co-sceneggiatore e adattatore del testo. I disegni sono di David Mazzucchelli, uno dei più noti e significativi disegnatori americani di fumetti, già scelto da Frank Miller per illustrare alcune delle storie di supereroi che hanno sconvolto il genere nel corso degli anni Ottanta.
La ragione per cui Miller scelse Mazzucchelli per illustrare storie di Batman e di Daredevil è che il suo disegno è quanto di meno spettacolare e supereroistico si possa imaginare. Al contrario Mazzucchelli possiede una straordinaria capacità di esprimere sfumature narrative ed emozionali con semplici linee di pennello nero, con un tratto che della semplicità ha solo l’apparenza. Così quelle storie prendevano di colpo un tono che a un disegnatore tradizionale di supereroi – abituato ad enfatizzare piuttosto che ad esplorare – sarebbe risultato impossibile da realizzare. Con una sorta di effetto di straniamento, al mondo dei supereroi veniva restituita una vividezza emotiva che esso non aveva mai posseduto.
Nel romanzo di Paul Auster non c’è altro che questa vividezza emotiva. Il pennello di Mazzucchelli e il suo montaggio dal ritmo lento e un po’ ossessivo ricostruiscono con altri mezzi il senso di ossessione e di progressivo smarrimento della prosa di Auster. Siamo abituati a vedere versioni cinematografiche di romanzi: spesso sono inferiori allo scritto, ma qualche volta scopriamo con piacere opere originali che non hanno nulla da invidiare al testo cui si sono ispirate. Più raramente incontriamo traduzioni a fumetti: è tanto più ragione di godimento quando scopriamo che vale davvero la pena di averle lette. Pure se conoscevamo già l’opera da cui sono partite.
Paul Auster, Città di vetro, Versione a fumetti di David Mazzucchelli e Paul Karasik, Gli Squali Bompiani, 1995
pp. 140, £. 15.000
Magnus, la grande ossessione
Il Sole 24 Ore, 26 novembre 1995
Una riedizione a distanza di oltre dieci anni è sempre l’occasione per una riconsiderazione e per un bilancio del valore di un testo. Magnus pubblicò per la prima volta L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara sulla rivista Orient Express, nel 1983, come ultimo episodio della serie Lo Sconosciuto. Era un testo difficile, che la divisione in episodi mensili rendeva ancora più complicato e faticoso da tener fermo alla mente. Ma era anche, fin da allora, un testo che affascinava pure dove non lo si comprendeva, e non solo per la bellezza e la particolarità del disegno di Magnus, ma per il senso di intrigo, di corruzione e di morte che, per così dire, trasuda da ogni pagina, da ogni vignetta.
Un oscuro medico boliviano, cocainomane, in stretto contatto sia con l’autorità che con il mondo del traffico di droga, non riesce a liberarsi dell’ossessione dell’unico evento degno di memoria della sua vita: lui è l’uomo che, quindici anni prima, ha ucciso Ernesto Guevara, il “Che”, catturato e ferito dai soldati governativi. Giovane medico incaricato di vegliare il prigioniero, aveva ricevuto l’ordine segreto di finirlo, e l’aveva eseguito, contro la propria morale e il proprio codice deontologico. Quel gesto segnerà la sua vita, sino a portarlo, alla fine, a cercare di emulare le gesta dell’eroe in un disperato tentativo di riscattare la propria pochezza e vigliaccheria di tossicomane.
La storia gira e rigira attorno a un’ossessione che si fa, pagina dopo pagina, sempre più drammatica e presente, mentre ha luogo attorno al personaggio principale una vicenda intricata di spionaggio e di traffico di droga, in cui anche i personaggi dall’aria più onesta e impegnata trovano il proprio tornaconto in chilogrammi di cocaina. Le figure diventano progressivamente più nette, da ambigue comparse quali spesso appaiono nelle prime pagine sino a personaggi a tutto tondo, scavati nella loro personalità e nella loro doppiezza – o, meglio, molteplicità, perché ciascuno gioca per più fazioni, oltre che per se stesso.
Non tutto si capisce perché non tutto si deve capire. Quello che emerge chiaro, evidente, nel suo percorso narrativo, è il rivolgimento interiore dell’uomo che uccise Che Guevara. Il resto è oscuro come è oscuro il mondo che mescola il potere e il commercio di droga, dove forse nessuno conosce le vere ragioni degli altri e del mondo che lo circonda, ma l’unica cosa che conta è il proprio tornaconto personale. E sembra che l’unica cosa degna di nota, di memoria, di emersione da questa melma, sia in fondo la propria rivolta personale, la ribellione disperata e magari inutile in nome di un eroe in cui nessuno crede più – magari proprio perché, molti anni prima, se ne è stati l’assassino.
Dieci anni dopo, la rilettura del testo di Magnus – uno tra i più belli dei tantissimi fumetti che questo autore ha prodotto dagli anni sessanta ad oggi – non rivela nemmeno una crepa nel ritmo serrato, incalzante, ossessivo degli eventi e dei disegni. E neppure il tema, ora che un ulteriore decennio ci allontana dalla morte del Che, sembra risentirne: ci sono storie, infatti, che non hanno attualità, o che l’hanno sempre, perché il legame col presente della loro produzione appare del tutto irrilevante. Ciò di cui si parla in questo racconto ha a che fare più con le ragioni che hanno reso Guevara un mito, qualunque valutazione politica ne vogliamo poi dare, piuttosto che con quelle che l’hanno reso una moda, passeggera come tutte, e ormai passata.
Magnus, Lo Sconosciuto: L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara, Granata Press. pagg. 80, £. 10.000
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|



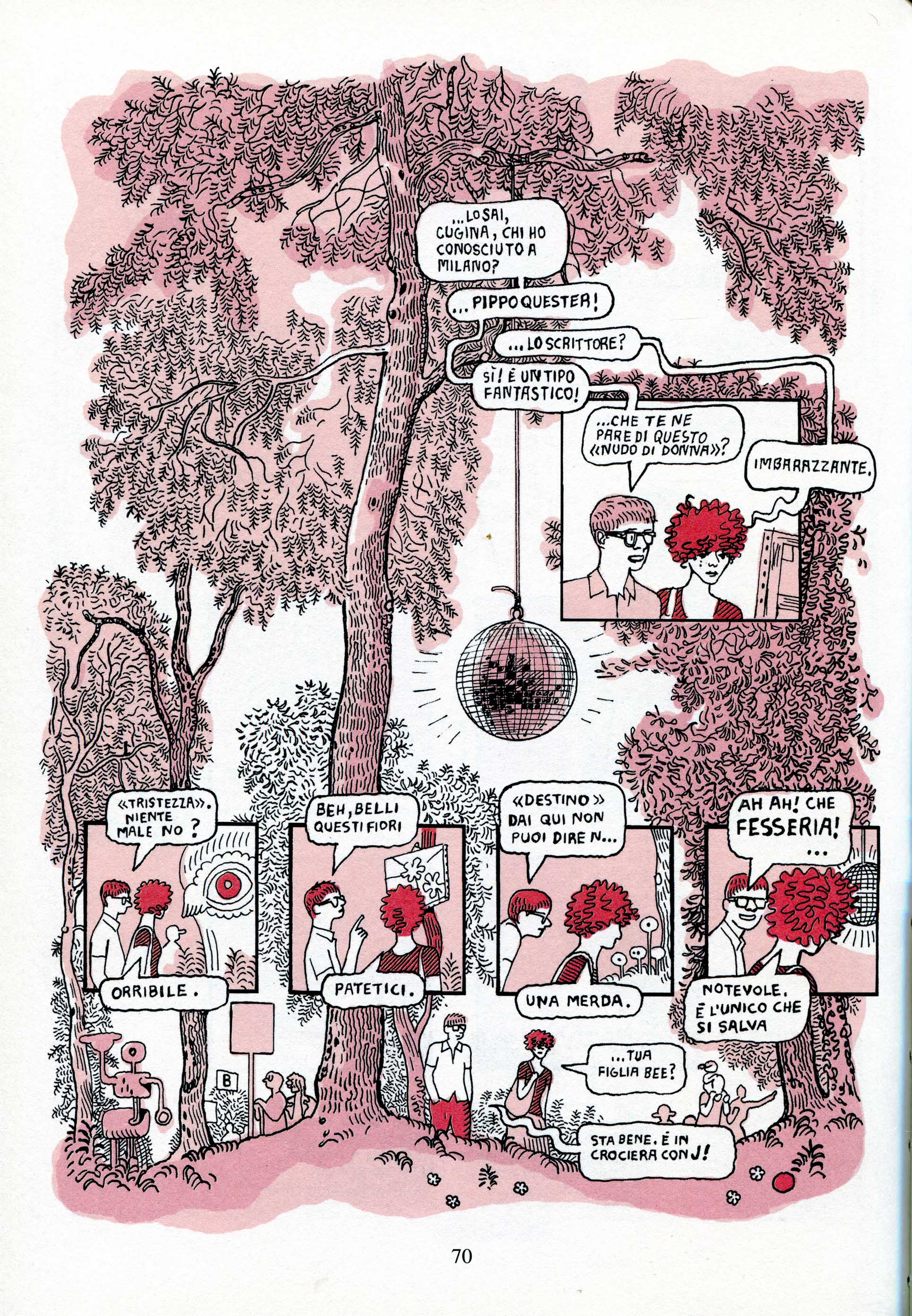






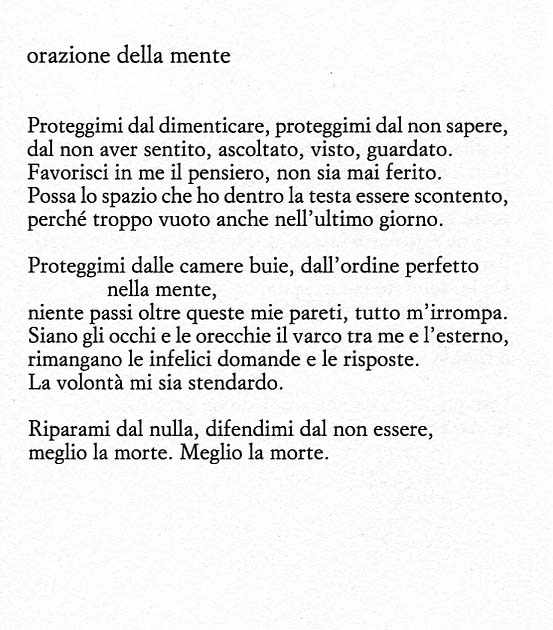

 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco


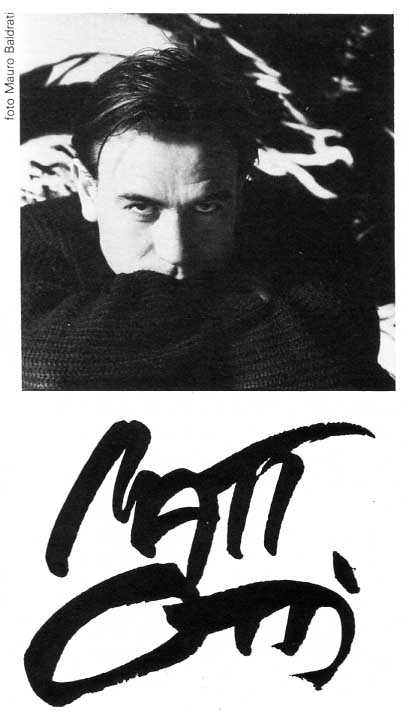


Commenti recenti