Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


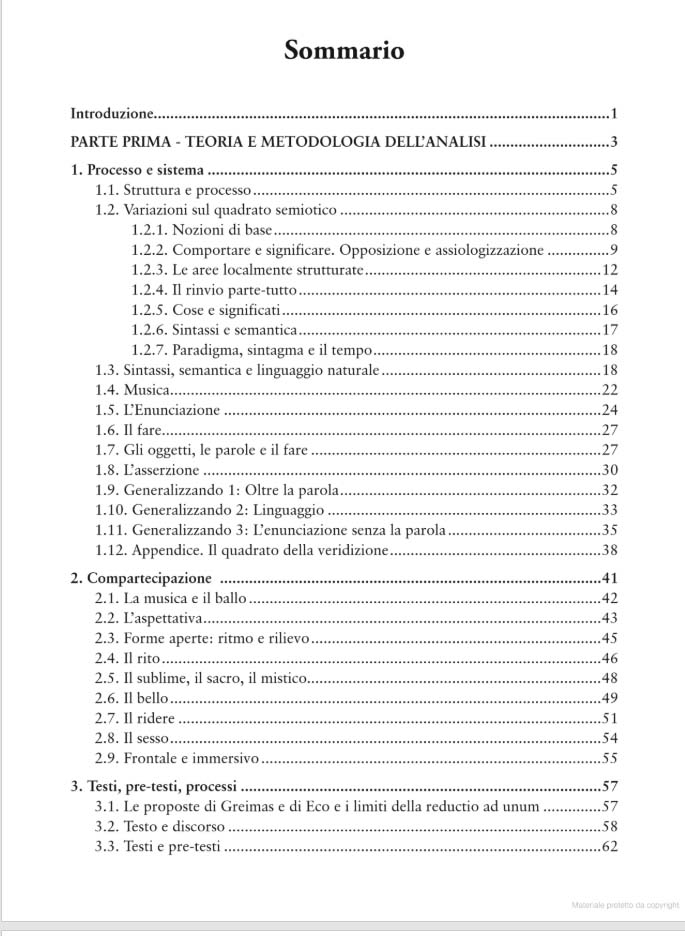
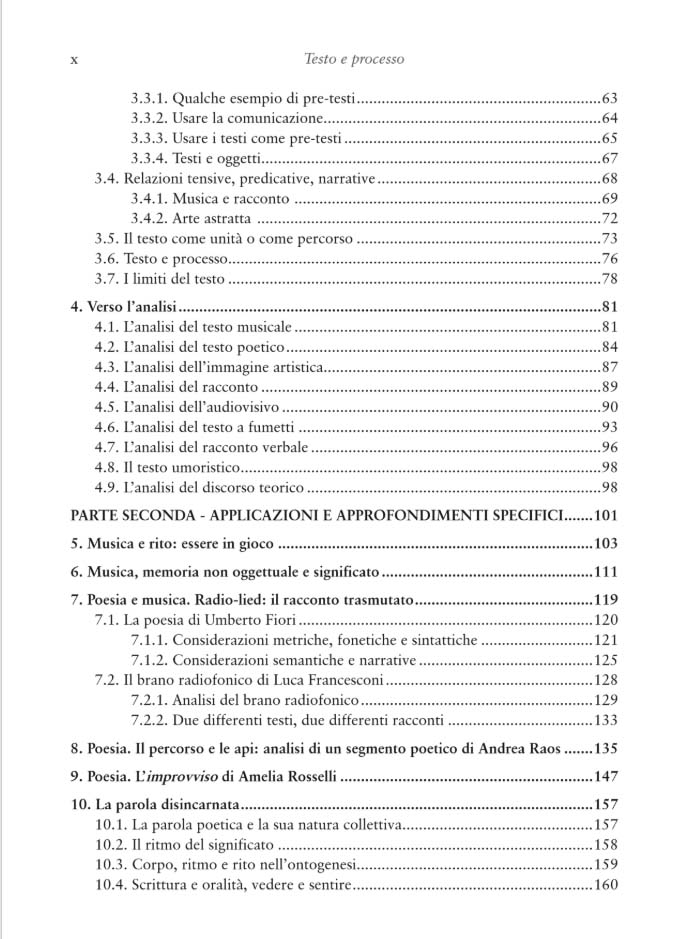
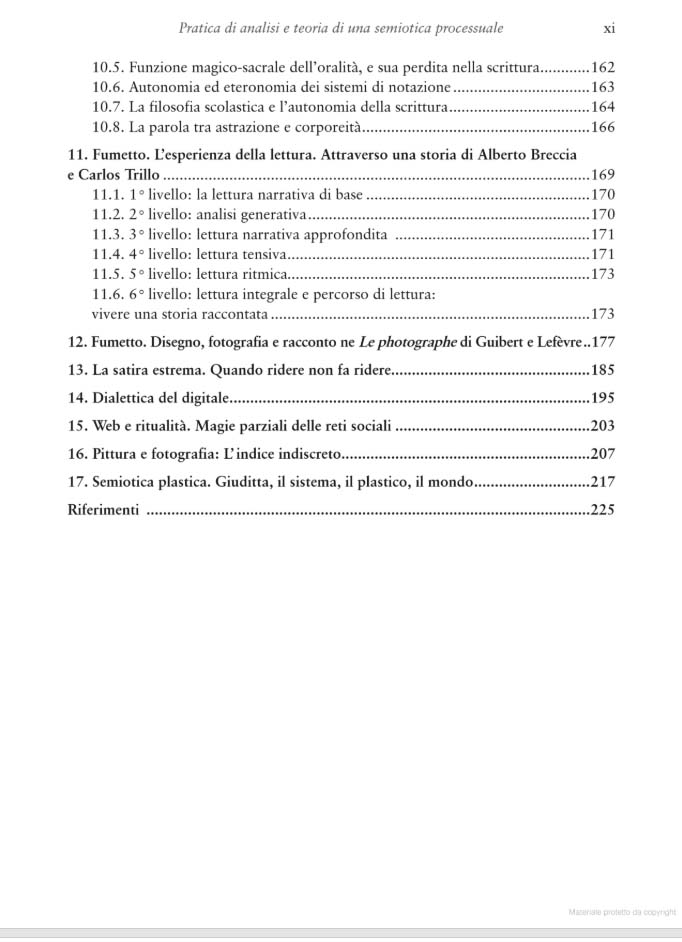

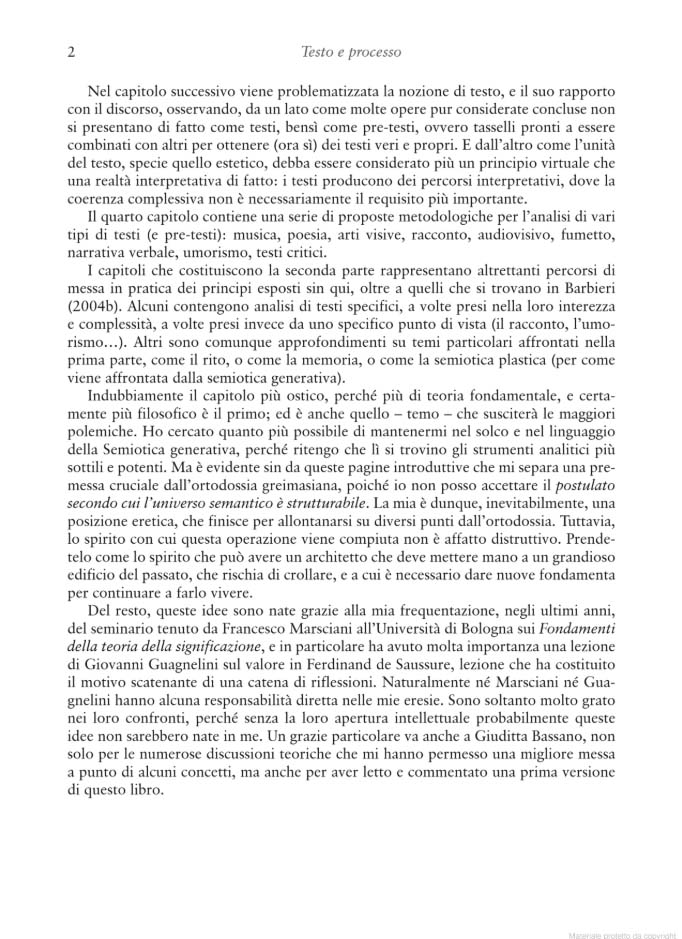
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
Prosegue qui, su Critica Impura. In questa intervista raccolta durante il Festival della Comunicazione di Camogli nel settembre 2015 da Giovanni Paolo Fontana per RAI Scuola, anticipo alcuni temi che saranno poi sviluppati nel mio ultimo libro Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.
Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.
Poesia semplice contro poesia semplice, per riprendere i termini di un tutt’altro che banale intervento di Mario De Santis uscito in questi giorni e più volte ripreso nel dibattito in rete. Dovrei dire, per semplificare, che quella di Penna mi appare poesia semplice, mentre quella della Vivinetto poesia banale, dove la differenza sta nel fatto che di semplice in Penna c’è solo – per così dire – il livello di base, e quindi si tratta, in verità, di una pura apparenza di semplicità; mentre nella Vivinetto si resta tutti lì, e dalla semplicità non si esce: c’è solo quello, nient’altro. Dirlo è facile, ma spiegare perché lo è forse un po’ meno. Diciamo che troppo spesso, leggendo la poesia banale, succede esattamente quello che ti aspetti che succeda: escono le parole che è normale che escano, insomma. La poesia banale parla con parole non sue: sono le parole della chiacchiera, direbbe Heidegger, quelle depositate nei discorsi che si fanno continuamente. Ma non solo parole: nella poesia banale escono anche i concetti che ti aspetti che escano. Il discorso è quello preconfezionato del parlare quotidiano, del pour parler, tanto per usare un’altra espressione cara agli esistenzialisti. Nella poesia banale il discorso è preconfezionato due volte (e in verità molte di più). Non c’è mai una sorpresa: il dolore è come deve essere, il sollievo pure; l’amore, la morte, il piacere, il sesso, l’avventura… tutti sono come devono essere, come ci aspettiamo che siano. La spocchia di un poeta complicato come Edoardo Sanguineti non gli ha impedito di definire efficacemente poetese la lingua della poesia banale. In verità, il poetese non parla, non dice. Si limita a confermare quello che ci aspettiamo. Si limita a rinchiudere un dolore (se è di un dolore che si parla) nella cornice scontata del dolore, quella che tutti con facilità riconosciamo come tale. In altre parole, si limita a nominarlo: insomma, il poeta dice “dolore”, e tutti i lettori rispondono “ah”! Molto più difficile è spiegare perché i versi di Sandro Penna, nonostante la loro semplicità di superficie, non ricadano sotto la specie della banalità e del poetese. Meglio: non ricadevano quando sono stati scritti e continuano a non ricadervi oggi, tanti anni dopo. Potremmo dire, quanto a quando sono stati scritti, che la loro semplicità discorsiva si contrappone agli Avorio luziani che costituivano il modello di quegli anni. Ma sarebbe facile allora ribattere che la semplicità delle parole della Vivinetto si contrappone alla complessità della cosiddetta poesia di ricerca (modello, anche se molto meno, di questi anni). Evidentemente non si tratta di una ragione sufficiente. La mia impressione è che, nella loro semplicità, le parole di Penna non siano affatto scontate. Per esempio, queste frasi così brevi si interrompono prima di poter diventare banali. Gettano l’amo della banalità, ma poi non abboccano. Ci fanno credere per un attimo alla scontatezza, ma poi non ci cadono. A ben guardare, poi, questa colloquialità normalità innocenza quasi improvvisazione sono davvero soltanto apparenti. Guardiamo da vicino questi quattro regolari novenari, che giocano astutamente il loro appartenere metrico a uno schema popolare frustissimo, ma già ambiguamente nobilitato da Giovanni Pascoli qualche decennio prima. Si tratta di quattro versi con il medesimo andamento ritmico e la medesima struttura proposizionale, fatta di un verbo all’infinito, un complemento e un suo attributo. I versi sono a rima alternata, ma le rime alternate non si limitano al finale del verso: anche sedere si riallaccia foneticamente a sentire, e tavola a piazza, a livello di assonanze e consonanze, specie se contrapposte, negli altri due versi, a dormire con gonfiarsi (prima vocale o, e poi la r e la i) e letto con tenero (insistenza sulle e, t e o). Eppure, questa struttura, resa ancora più regolare e quadrata attraverso queste insistenze, mostra a un certo punto un’asimmetria del tutto imprevista. Tra il primo e il secondo verso c’è un punto (come tra il secondo e il terzo), mentre tra il terzo e il quarto verso si va di seguito. Questa sorpresa (non proprio un enjambement, ma quasi) mette in movimento tutto, quasi rovinando il sistema delle simmetrie. Non è solo questione di parole e di sintassi: sedere e dormire sono due verbi che esprimono delle azioni indipendenti, ma sentire non lo è, e serve sostanzialmente a introdurre un gonfiarsi che, pur esprimendo di nuovo un’azione indipendente, è riflessivo, e quindi di colpo diverso dagli altri. Tutto questo non è banale esibizione di controllo verbale. Esibire un controllo verbale di questo livello vuol dire far capire bene che il controllo è stato ugualmente esercitato anche sulle parole all’apparenza banali. Dimostrandosi così perfettamente consapevole di quello che sta facendo, Penna, insomma, si può davvero permettere, a questo punto, di usare le parole più banali e trite di questo mondo, senza che esse appaiano per nulla banali e trite. La sua operazione finisce per essere simile a quella (molto posteriore) della musica minimalista: nella ripetizione ossessiva ogni diversità, ogni minima discrepanza emerge enfatizzata: è proprio perché il lessico e la sintassi di Penna sono così banali, in un contesto così evidentemente controllato, che le non banalità saltano all’occhio, ci colpiscono e intrigano. Quella vaga, smagata ironia che sempre traspare attraverso le parole di Penna finisce per essere indizio di questo attentissimo controllo e del gioco consapevole sul banale; ed è attraverso di lei che le parole più usurate, proprio quelle consunte della quotidianità, possono riacquistare il peso semantico che avrebbero se non fossero consumate dalla chiacchiera, dalla banalità dei mille discorsi in cui sempre appaiono. Non si tratta di una strategia facile. Più spesso i poeti preferiscono sancire il gap col banale rendendo più complicata la superficie del componimento. Quando leggete Montale non ricavate mai l’impressione di una poesia facile. Ma certamente la banalità si può nascondere, in altro modo, che non ci riguarda qui, anche nella poesia complicata. I mille imitatori della semplicità di Sandro Penna vedono insomma le sue parole semplici e la sua semplice sintassi, ma non colgono il suo controllo né la sua vaghissima ironia. Per questo finiscono per risultare alla lettura semplicemente banali. Ha ragione De Santis a riconoscere alle traduzioni una certa responsabilità in questa caduta: non è davvero facile riportare in un’altra lingua la sottilissima deformità che rende affascinante il discorso di Penna! E così sarà per i tanti grandi poeti di altre lingue, ridotti in italiano alla lettera di quello che dicono. Riducete Penna alla lettera di quello che dice e avrete qualcosa di simile ai versi della Vivinetto: un ininteressante resoconto di privati turbamenti, buono giusto per spiare dal buco della serratura l’intimità di qualcun altro, che magari gode pure della propria esibizione. Certo, in tutto questo niente di male, eticamente: sono fatti di chi guarda e di chi si fa guardare. Ma che non mi si parli di poesia, please. __________________________________ Sul tema della semplicità e complessità in poesia ho scritto anche altri post in questo blog: Del diritto della poesia a essere incomprensibile, Del cambio di paradigma, dei primi anni Sessanta, e della questione dell’io (una polemica con Marco Giovenale in due puntate, che prosegue qui: Del cambio di paradigma, della questione dell’io, dell’oscurità in poesia, dove va letta anche la fondamentale discussione in fondo), La letteralità impossibile. Risposta ad Andrea Inglese.
Partiamo dalla breve antologia dei presupposti, o delle anticipazioni del letteralismo, che Inglese traccia. Si incomincia con Van Doesburg, 1930, che nel suo manifesto Basi della pittura concreta scrive: “L’opera d’arte deve essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione. Essa non deve accogliere nulla dei dati formali della natura, della sensualità, della sentimentalità. Noi vogliamo escludere il lirismo, la drammatizzazione, il simbolismo, ecc.” E poi: “Il quadro dev’essere interamente costruito con degli elementi puramente plastici, ossia piani e colori. Un elemento pittorico non ha altro significato che ‘se stesso’, di conseguenza il quadro non altro significato che ‘se stesso’.” E poi ancora: “La tecnica deve essere meccanica, ossia esatta, anti-impressionista”. Credo che Mondrian, già compagno di strada di Van Doesburg, prima di andarsene sbattendo la porta perché l’amico non era sufficientemente conseguente (aveva introdotto gli angoli di 45 gradi nelle sue composizioni!!), avesse già espresso concetti simili con chiarezza ancora maggiore ben dieci anni prima. In un suo articolo del 1920, “Il Neoplasticismo. Principio generale dell’equivalenza plastica”, Mondrian arriva addirittura a spiegare come dovrebbe essere una musica che segua i principi del neoplasticismo; e così ecco l’idea di una musica che abbandona l’armonia tonale e adotta nuovi strumenti che eliminano l’espressività dai suoni, in nome del tentativo di raggiungere la forma pura, fatta di contrasti puri tra elementi essenziali. Potrebbe sembrare una precognizione della dodecafonia di Schönberg, che il musicista viennese sta sviluppando nei medesimi anni; ma Schönberg non arriverà mai a essere così estremista. Siamo più vicini, semmai, al serialismo di Pierre Boulez, che troverà campo a partire dalla fine degli anni quaranta; ma pure Boulez non arriva a voler eliminare l’espressione dai suoni. Proviamo a leggere qualche riga al proposito. Mondrian inizia dicendoci che in musica, a parte le fughe di Bach, “nella maggior parte dei casi la plastica costruttiva è velata dalla melodia descrittiva”, espressione dell’individuale; mentre “nella musica, come altrove, lo spirito nuovo esige una plastica equivalente dell’individuale e dell’universale governata da una proporzione equilibrata”. E più sotto: “La scala musicale con le sue sette note si basava sulla morfoplastica. […] La vecchia armonia rappresenta l’armonia naturale. […] La nuova armonia è una doppia armonia, una dualità di armonia spirituale e armonia naturale. […] Pertanto la nuova armonia non può mai essere com’è in natura: essa è l’armonia dell’arte”. E infine: “Se lo spirito nuovo deve essere espresso plasticamente, si deve bandire dalla musica la vecchia scala tonale, insieme agli strumenti tradizionali. Per giungere a una nuova tecnica si devono creare, oltre a una nuova composizione, anche altri mezzi plastici, come avviene nelle cosiddette arti plastiche. […] Archi, fiati, ottoni ecc. vanno sostituiti da una batteria di oggetti duri. […] Per la produzione del suono sarà preferibile ricorrere a mezzi elettrici, magnetici, meccanici, in quanto essi impediscono più facilmente l’intrusione dell’individuale.” Così, ecco la conclusione a cui Mondrian arriva: “Il contenuto della nuova opera d’arte deve essere un’esteriorizzazione plastica chiara, equilibrata ed estetica dei rapporti sonori, niente di più”. (tutti i corsivi di queste citazioni sono di Mondrian) Mondrian parla della musica, ma ci sta dicendo anche quale sia la sua idea della pittura. Scrivete visivi invece che sonori nell’ultima affermazione, e avrete l’ideale mondrianiano della pittura: la forma pura, irrelata, intesa come un sistema di rapporti plastici. Non siamo lontani dalle affermazioni degli altri precursori citati da Inglese, come Judd, Manzoni, Klein e Buren, attraverso i quali l’iconoclastia novecentesca diventa un’affermazione della sostanza dell’opera, del suo essere stesso. Come dice Piero Manzoni: “Qui l’immagine prende forma nella sua funzione vitale: essa non potrà valere per ciò che ricorda, spiega o esprime (casomai la questione è fondare) né voler essere o poter essere spiegata come allegoria di un processo fisico: essa vale solo in quanto è: essere”. Non siamo lontani nemmeno, come fa giustamente notare Inglese, da certe affermazioni di Adorno: “In generale – scrive Adorno – le opere d’arte potrebbero valere tanto di più quanto più sono articolate: laddove non è rimasto nulla di morto, di non-formato; nessun campo che non sia stato percorso dal configurare. Quanto più profondamente questo se ne è impadronito, tanto più l’opera è riuscita. L’articolazione è il salvataggio della molteplicità nell’uno.” Qui l’articolazione è il progetto, è la plastica costruttiva di Mondrian, è l’essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione di Van Doesburg. Ciò che è morto, non-formato, è quello che si presenta come semplice imitazione del mondo, melodia descrittiva, morfoplastica. Andando in una direzione simile (ma senza arrivare tanto in là), nel 1964 Susan Sontag già lamentava l’ossessione dell’interpretazione rispetto ai testi letterari, ormai impostasi a tal punto da portare talvolta gli autori stessi a produrli in funzione di un’interpretazione critica. L’accezione del termine interpretazione nell’uso della Sontag è diversa da quella di uso semiotico corrente, e più vicina semmai a quella dell’ermeneutica, e potrebbe essere considerata grosso modo equivalente a trovare un senso nascosto profondo. Gli autori letteralisti o pre-letteralisti di cui parla Inglese vanno certamente nella direzione auspicata dalla Sontag, e in questo senso la loro posizione è apprezzabile. Eppure, temo, finiscono per buttare via il bambino insieme con l’acqua sporca. Trovo comunque di grande interesse la posizione di Ponge, e la descrizione che ne fa Inglese. Mi permetto di citarla qui integralmente:
Mi sembra sufficientemente evidente che le immagini soggettive evocate qui non sono lontane dalla melodia descrittiva aborrita da Mondrian, né dal morto di Adorno. Così come ugualmente evidente mi pare che questo estremo andare verso il mondo, verso il reale finisca per ribaltarsi in un concettualismo altrettanto estremo, come quello di Mondrian, di Boulez e di Adorno. E il paradosso evidentemente c’è, ma non è quello suggerito da Inglese. L’opposizione di cui paradossalmente in Ponge si vedrebbe la negazione è infatti quella tra parole e cose, ma si tratta di una falsa opposizione. Ponge ha del tutto ragione nel trattare le parole come cose, anzi come quelle cose che ci sono familiari più di tutte le altre: curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo è un programma che non si può che condividere. Ma bisogna riconoscere che le cose non sono oggetti meno semiotici delle parole: sono solo strumenti che vengono utilizzati all’interno di pratiche diverse da quelle del parlare (o scrivere) che caratterizzano l’operato del poeta. Riconoscere questa identità semiotica di fondo tra parole e cose è la condizione per un programma come quello di Ponge, ma al tempo stesso lo destituisce di senso (il programma, non le opere, sue e di Gleize, che continuano ad avere un senso e un valore). Se infatti le cose sono oggetti semiotici quanto le parole, allora anche loro sono stracolme di significati ordinari e di figure retoriche (seppur diverse da quelle dalle parole), così come di immagini soggettive cariche di ideologia (seppur diverse da quelle delle parole). L’operazione di Ponge può allora funzionare non perché ripulisca il linguaggio sporco di soggettività e poeticità attraverso il contatto con il mondo pulito, ma perché questo confronto sporca il linguaggio con una sporcizia che non è specificamente la sua, ma semplicemente quella di un diverso ambito semiotico. Si tratta, insomma, di un effetto di Verfremdung, di straniamento, qualcosa che è ben noto al Novecento anche senza andare a disturbare la letteralità e i suoi antecedenti. In questa prospettiva, per emanciparsi dai significati ordinari e dalle immagini poetiche non c’è bisogno di idealizzare il mondo, non solo perché il mondo non è che un altro campo di significazione, ma anche perché basta giocare con un qualsiasi campo diverso di significazione per ottenere un effetto analogo (certo, poi, non tutte le scelte saranno ugualmente efficaci, ma non è l’opposizione parole/cose a fare da linea discriminante). In questa prospettiva, inoltre, nessuna letteralità è davvero possibile. Le forme pure di Mondrian non sarebbero gli oggetti straordinari che spesso sono se non si stagliassero contro vari millenni di immagini, che forniscono inevitabilmente il quadro concettuale di riferimento attraverso cui comprenderle. Qualsiasi paesaggio cittadino è pieno di angoli e incroci di linee e colori molto simili a quelli di Mondrian, ma noi non passiamo le giornate con il naso all’aria estasiati da quello che vediamo, come succede di fronte a una sua opera. Poi, certo, arriva un Franco Fontana a fotografare quelle stesse cose che possiamo vedere tutti i giorni e di colpo ecco che riacquistano quella potenza che in libertà non avevano; ma l’operazione di Fontana è proprio quella di riproporre quelle forme come immagini, e quindi di riproporle nel confronto con i millenni di immagini che hanno dietro, e quindi con il carico di significazione che questo comporta. La letteralità è l’illusione di poter arrivare a toccare direttamente almeno quelle cose che sono le parole, senza pagare lo scotto che già lamentava la Sontag. Eppure, nel momento stesso in cui Ponge, e Gleize, e gli autori di Prosa in prosa spoetizzano il linguaggio, si stanno già confrontando con l’ombra del linguaggio poetico, e da questa condizione non si esce. L’unico modo per uscirne sarebbe non fare letteratura: così come gli incroci di linee in giro per la città non sono opere di Mondrian, allo stesso modo le banalità dei discorsi quotidiani non sono le quartine da tavolino da caffè di Alessandro Broggi, così come il prodotto quotidiano delle deiezioni di Pietro Manzoni non è la sua Merda d’artista. Uscire dal dominio dell’illusione, come proporrebbe Daniel Buren, abolendo l’arte, impedendo le proiezioni soggettive sull’oggetto artistico, non riproporrebbe nessun accesso diretto al reale, ma semplicemente alimenterebbe l’illusione di poterlo avere, là dove l’arte, almeno, riconosce e ostenta la propria dimensione illusoria, rendendola discorso. L’interpretazione in senso ermeneutico, esecrata dalla Sontag, è spesso davvero una jattura, e spesso a sua volta una mistificazione di carattere religioso-rivelatorio, come se il critico (novello ermeneuta biblico) potesse rivelare una profonda verità nascosta dell’opera d’arte. Io condivido con Inglese la propensione, piuttosto, a un atteggiamento più vicino al misticismo, all’evitare di spiegare, all’evitare di cercare profonde verità nascoste. Ma di interpretare, in senso semiotico, non possiamo fare a meno. La nostra stessa azione per mezzo degli oggetti è sempre interpret-azione. E non è possibile fermare l’interpretazione al primo passo, quello letterale, specialmente quando ciò che dobbiamo interpretare si presenta come operazione artistica. Senza voler arrivare alle verità profonde, di cui facciamo volentieri a meno, il percorso su cui un’opera d’arte ci conduce è evidentemente un percorso interpretativo: accanirsi contro le immagini, accusandole di tutti i mali della poesia (o della pittura, prima) è come prendersela con i migranti per i mali dell’Italia. Un falso bersaglio, insomma, per uno scopo politico (di solito, in campo artistico, almeno meno becero di quello di Salvini). Per questo, anche solo come polo tensivo, la letteralità non è desiderabile.
Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male). Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi). Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.
Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):
La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare. Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra. Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare. È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso. *** Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore. Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie. Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo. Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere. La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?
Proviamo a seguire questa linea di pensiero: in principio c’era l’epica, Omero, insomma. Era poesia civile, quella? Non mi sembra un’espressione adeguata per parlare dei poemi omerici. Questi però, indubbiamente, esprimevano una serie di valori in cui i suoi fruitori si riconoscevano, e sappiamo bene quanto fosse importante la funzione anche didattica dell’epica omerica. Proviamo allora a definire quella della poesia omerica come una funzione sociale della poesia, nel senso che proprio perché i valori espressi da quella poesia erano valori condivisi e fondanti per la società greca, la definizione di sociale può essere accettabile. Sottolineo che non sono particolarmente legato a questa parola, sociale; potrebbe andar bene anche un altro termine, purché diverso da civile. Potremmo dire che era umana, nel senso di portatrice di valori umani, ma questo potrebbe implicare che si tratta di valori universali; mentre erano semplicemente greci. Potremmo dire che era culturale, nel senso che contribuiva a costruire la cultura greca, ovvero il modo che i Greci avevano di pensare il mondo; ma questo potrebbe apparire riduttivamente cognitivo. Per ora, sociale mi sembra il termine più adatto; ma sono pronto ad abbandonarlo di fronte a proposte migliori. Quello che è interessante è che, in questi termini, la lirica di Saffo non era meno sociale dell’epica di Omero. Se godeva di successo, era proprio perché a sua volta esprimeva dei valori socialmente condivisi. Si noti che l’espressione socialmente condivisi non vuol dire universalmente condivisi, nemmeno nell’universo ristretto della cultura greca. In altre parole, affinché la poesia di Saffo come quella di Omero sia sociale non occorre che i valori che esprime siano condivisi da tutti: è sufficiente che ci sia un gruppo che li condivide, e tanto meglio se si tratta di un gruppo influente, perché vasto o perché forte, o perché sufficientemente compatto e duraturo. Dovremo insomma ammettere che la poesia di qualità, ovvero la poesia che viene apprezzata da un gruppo in qualche modo influente, è comunque poesia sociale, anche se parla d’amore, perché l’amore stesso è un fatto sociale, ed è estremamente sociale il modo in cui se ne parla e lo si affronta. Il fatto che tutta la poesia, nella misura in cui viene apprezzata, sia comunque poesia sociale, non è esente da problemi. Appena (cioè sempre) la società non è compatta, appena gruppi sociali diversi hanno valori diversi, si diversificherà anche la possibilità di apprezzare la poesia sulla base dei valori che esprime. Certo, ci saranno presumibilmente dei valori molto profondi e indiscussi che vengono riconosciuti più o meno da tutti, e che permetteranno un consenso molto più vasto di altri. Questo non vuol dire che questi valori siano universali. L’epoca della Controriforma dà per esempio vita, specie in terra spagnola, a una straordinaria vena di poesia mistica. I suoi valori erano certamente all’epoca ampiamente condivisi. Tuttavia, per me, oggi, apprezzare la poesia, poniamo, di Juan de la Cruz, mi costringe a un esercizio di selezione dei valori, arrivando a vedere quelli più specificamente cattolici come prodotto della sua epoca, con una componente ineliminabile di persuasività pro-fede (propaganda cattolica controriformistica, insomma), e salvando invece gli altri, che comunque ci sono, e contribuiscono a mantenere grande e viva la sua poesia ancora oggi. Se la poesia è sociale, è anche terreno di scontro sociale, inevitabilmente. Nel frammento 84 della Gaia Scienza (non finirò mai di citarlo), Nietzsche sottolinea la straordinaria capacità persuasiva della poesia, dovuta al ritmo, e alla conseguente capacità di costruire un accordo condiviso, una Stimmung. Non è un caso che la riflessione di Nietzsche arrivi proprio sul finire di un secolo, l’Ottocento, che ha visto il trionfo della retorica (nel peggior senso del termine), ovvero della poesia utilizzata come motore persuasivo per cause politiche, dove la nobiltà della causa doveva essere associata alla nobiltà (ovvero classicità) del linguaggio. A questo modo (pessimamente) civile di intendere la poesia, il Novecento contrappone un’incapacità di certezze, un’indecisione sistematica, un’epica (se vogliamo chiamarla così) dell’impossibilità dell’epica. Questa nuova poesia non è meno sociale della precedente: è che tra i valori che esprime adesso ce n’è uno fondamentale, che prima restava molto più in ombra, ovvero la problematicità del rapporto tra l’individuale e il collettivo. Per quanto paradossale possa apparire, l’accordo collettivo che si viene a creare su questa nuova poesia si fonda proprio sul riconoscimento della difficoltà dell’accordo, sull’impossibilità di risolvere la coscienza individuale nei valori civili, qualunque essi siano. Quello che diventa cruciale, nella poesia del Novecento, è qualcosa che prima stava molto più nell’ombra (pur essendo presente) ovvero la sua capacità di mettere in movimento ciò che è assestato, di mettere in dubbio le certezze, di attivare dei modi differenti di guardare alle cose (di attivarli, non di proporli!), perché solo in questo modo essa esprime il valore (ormai fondamentale per noi) della problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. La poesia non è ora né più né meno sociale di prima, ma lo è certamente in modo diverso, perché si trova a cavalcare una contraddizione che è assurta a valore fondamentale. La proposta di Balestrini con cui concludevamo il post precedente va esattamente in questa direzione. Balestrini vede nello scardinamento del linguaggio lo strumento per attivare dei modi differenti di guardare alle cose, con spirito profondamente nietzschiano (ma ora è il Nietzsche del Crepuscolo). Che cosa succede quando la poesia non si limita ad attivare, ma cerca piuttosto di proporre dei modi differenti di guardare le cose. La mia sensazione è che, così facendo, la poesia stia invadendo il campo di altre forme espressive, più legittimamente persuasive, e che indebolisca implicitamente, in questo modo, la sua capacità di esprimere il valore del rapporto complesso tra individuo e collettività. Lo fa perché, proponendo dei modi specifici di guardare, sta già proponendo direttamente dei valori, e in questo modo sta anche proponendo l’appartenenza a una comunità ben definita, per quanto magari alternativa a quella dominante. In altre parole, la poesia che fa una scelta politica sta dichiarando un’appartenenza, e in questo senso può essere sentita come falsa (o addirittura propagandistica) da chi si riconosce nei valori della problematicità, dell’incertezza di appartenenza. Ecco quindi il problema della poesia civile: che per essere civile rischia di smettere di essere sociale. Che per sostenere un valore in cui io potrei pure riconoscermi, rischia di mettere in discussione un valore molto più profondo, in cui certamente io mi riconosco, perché è la base dell’idea stessa di libertà, che sta sotto a qualsiasi mozione civile. Proprio perché la poesia è intimamente sociale, essa vive a monte di qualsiasi scelta politica. I valori di libertà, responsabilità individuale, capacità personale di arrivare a comprendere sono quelli che la nostra poesia implicitamente esprime, e lo fa attraverso il modo in cui essa è costruita ancora prima che attraverso ciò di cui parla. La poesia ci deve turbare, deve permetterci di vedere le cose come altrimenti non le vedremmo. Se cerca di darci soluzioni, non ci esprime più, nemmeno quando quelle soluzioni sono condivisibili da noi. Avrebbe scelto, in questo modo, la strada facile del consenso: ma il consenso per noi è la morte, la negazione della libertà. Qualche volta riusciamo a chiamare civile una poesia che rispetta la problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. Si tratta probabilmente di una poesia che attiva dei dubbi di carattere civile, piuttosto che asserire delle certezze, piuttosto che fare delle proposte. Le proposte ideologiche e politiche sono certamente una cosa importante, ma non spettano alla poesia. Per entrare in poesia esse devono distruggere valori ben più importanti, e trascinarla verso la triste retorica della poesia dell’Ottocento. Certo, tutto questo non varrebbe più se i valori della libertà fossero tramontati. Credo che, per fortuna, non sia ancora così. Se lo fosse, quella che a me appare pessima retorica civile potrebbe legittimamente apparire ad altri come espressione di valori condivisi e profondi. Ho partecipato ieri sera a uno degli incontri quasi settimanali che si tengono il giovedì presso l’osteria Vamolà, a Bologna, “I giovedì di/versi” (info qui). Ieri sera il tema dell’incontro era la poesia civile, con presentazione di alcune esperienze e dibattito aperto in seguito. Si tratta di una situazione semiinformale, con i pro e i contro del caso. Più strutturata la parte di presentazioni, più selvaggio il dibattito, attorno a un lungo tavolo di osteria (una trentina i partecipanti), con una gestione un po’ anarchica di molte voci desiderose di dire la propria – e, purtroppo, molto rumore di fondo. Ma anche così, il dibattito è stato acceso e fecondo. Ho finito per non prendervi parte, un po’ subissato dal rumore di fondo che non favoriva la concentrazione, un po’ perché altri hanno detto una parte delle cose che avevo in mente, e un po’ perché non mi era del tutto chiaro quello che mi si è venuto poi chiarendo in seguito, e che voglio provare a esprimere qui. Della conversazione mi sono rimaste due voci (altre dicevano con meno chiarezza cose simili, ad altre ancora non ho avuto accesso acustico, per via del rumore di fondo). Mi perdonino le autrici degli interventi se sarò parziale; e mi perdonino maggiormente se farò loro dire qualcosa che non hanno detto: questo è quello che ho capito e che mi ricordo. Quindi me ne prendo tutta la responsabilità. Marinella Polidori ha esposto, con molta verve, due tesi che faccio fatica a far stare insieme. In primo luogo quella, che almeno in parte condivido, secondo cui tutta la poesia è civile, purché si sottragga alla logica neoliberista del successo, del farsi vedere, del vendere – che ha ormai assoggettato quasi interamente la narrativa. Poi però, pressata dall’obiezione che così si perderebbe un po’ il senso dell’espressione poesia civile Polidori ha insistito sull’idea di cercare di salvare la parola “civile”, che per lei resta una parola nobile; e la poesia sarebbe civile, dunque, se collegata a un impegno di carattere sociale. A questa seconda versione, non del tutto compatibile con la prima, mi opporrò tra poco, e in parte anche alla prima. Francesca Del Moro ha obiettato alla prima posizione che esiste anche un legittimo desiderio di riconoscimento e di successo da parte del poeta, e non lo si può ridurre a un asservimento al sistema. Ma soprattutto (su sollecitazione di qualcun altro) ha parlato del proprio recente volume Gli obbedienti, il cui tema è la vita in ufficio con le sue vessazioni. Riflessione sulla vita o denuncia civile? Ora, io capisco e mi piacerebbe approvare l’idea che tutta la poesia che non si sporchi le mani con il sistema delle vendite è di fatto civile, ma capisco bene che così facendo si vanifica il senso di “civile”, perché non esisterebbe poesia che non sia civile. La poesia, in quanto tale, ha già scelto la strada della marginalizzazione rispetto alla grande editoria. Se voglio recuperarle un senso, legando la poesia civile all’impegno sociale, finisco per dire che non è così, perché anche tra i poeti non compromessi con l’industria ci sarà chi non si distingue per impegno sociale. D’altra parte, anche la tesi secondo cui la poesia è civile se non si sporca le mani con il neoliberismo è difficile da sostenere. Supponiamo che un poeta che, come tutti, vive la sua situazione di marginalità culturale ed editoriale, diventi improvvisamente famoso, e i suoi libri inizino a vendere moltissime copie, creando un caso letterario. La stessa poesia sarebbe dunque civile prima e non civile dopo? Proviamo a guardare le cose in un altro modo. Che cosa è azione civile nel campo della comunicazione? Io direi che è cercare di informare e convincere il maggior numero di persone rispetto a fatti e opinioni che consideriamo politicamente/civilmente rilevanti. In questo senso una graphic novel come Kobane Calling di Zerocalcare è certamente una riuscita operazione di letteratura civile. E’ fatta molto bene, fornisce informazioni e un modo intelligente e originale di vedere le cose sulla cultura dei Curdi e sul loro ruolo di combattenti nella guerra in Medio Oriente. E raggiungerà molta gente, compresi tanti che non si erano mai posti il problema, e che ora saranno magari più sensibili a questi temi. Se vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto a una causa come quella del popolo curdo, la graphic novel può essere un ottimo canale, e lo è proprio in quanto inserito in quel sistema dell’editoria di successo cui la poesia è estranea. Tant’è vero che un buon servizio televisivo trasmesso nell’orario giusto potrebbe fare ancora di più (ed è infatti significativo che non lo si faccia). A quanto pare, per la massima efficacia di un’azione (comunicativa) civile la visibilità è essenziale, e quindi l’inserimento nel sistema (neoliberista) dei media. Se vediamo le cose in questi termini, fare azione (comunicativa) civile attraverso la poesia appare davvero come tempo sprecato, in termini di sfruttamento delle risorse: tempo buttato. La poesia, come di solito accade, sarà letta solo dagli addetti ai lavori, di solito già sensibili ai temi in oggetto – e comunque davvero pochi. Insomma, se quello che ci interessa è fare azione civile, la poesia civile appare come una sorta di fallimento se non di truffa: se l’azione civile ci interessasse davvero utilizzeremmo altri mezzi. L’obiezione che farlo attraverso la poesia nobilita comunque il tema, cosa a cui forse qualcuno crederà ancora, non sposta le carte in tavole: si tratta di una nobiltà che interessa solo ai poeti. E io la trovo anche un po’ demodé, per non dire falsificatoria a sua volta. E Pasolini, allora, non faceva poesia civile? Pasolini è un buon esempio: a mano a mano che si è reso conto che la poesia non era lo strumento davvero efficace per fare azione civile, la sua poesia si è disfatta in una sorta di prosa argomentativa in versi, che sceglieva contesti di pubblicazione, come i quotidiani, molto adatti all’azione civile e molto poco alla poesia. Alla fine sembra che della poesia gli importasse ben poco. Del resto, il cinema si prestava molto meglio a raggiungere un grande pubblico con temi civili. Il libro di Francesca Del Moro che abbiamo citato sopra non sarebbe poesia civile, dunque. Io, per chiarezza, abolirei la nozione, che fa pensare che esista un genere specifico, nobilitato particolarmente dalla sua missione civile. Volendola conservare a tutti i costi, la nozione, ne propongo qui di seguito una versione minimale, ma dotata – almeno per me – di qualche senso (e che permette di conservare a Gli obbedienti la qualifica di poesia civile). Proporsi di fare poesia civile, intesa come modo di usare la poesia per fare azione civile, è una falsificazione; un modo per lavarsi la coscienza, potendo dire di aver agito – mentre si è evitato di agire. Tuttavia fare poesia ha comunque un senso civile, che non è quello dell’azione civile, perché – come diceva inizialmente Polidori – è l’azione stessa di fare poesia anziché qualcos’altro di più compromesso con il potere a essere in sé civile. Proprio questo, secondo me, dovrebbe avere in mente il poeta: essere sincero con se stesso, non darsi fini di persuasione o propaganda (anche in senso positivo, come quella pro-Curdi di Zerocalcare). Potrà poi capitare, a posteriori, che una poesia scritta sinceramente possa essere riconosciuta da qualcuno come un intervento civile. E questo va bene; e questo potrà essere chiamato poesia civile. Ma si tratta di una valutazione a posteriori, che non aggiunge (né certamente toglie) valore alla poesia. Insomma, la poesia civile potrebbe essere quella poesia che per qualcuno fa anche azione (comunicativa) civile, e che è buona o cattiva poesia in maniera del tutto indipendente da questo. Troppo spesso, l’entusiasmo per una causa condivisa ci porta a introdurre (se siamo autori) o a perdonare (se siamo lettori) eccessi di retorica che altrimenti eviteremmo. In questo senso, il civile fa frequentemente molto male alla poesia. Ma ci sono stati grandi poeti nei cui versi echeggiano temi civili: poeti civili, dunque. Credo che la loro influenza sull’opinione pubblica sia stata comunque irrilevante. La poesia è di solito un discorso in cui ci si riconosce, e in cui si trova conferma. Per convincere chi ha opinioni diverse, la prosa argomentativa è già enormemente più efficace; ma anche la narrativa, verbale, filmica, fumettistica, teatrale che sia, funziona molto meglio. Diciamo che è bello incontrare buona poesia in cui scorrono idee civili in cui ci riconosciamo: questo è il massimo che all’idea di poesia civile posso concedere. Le parole che seguono sono state scritte poco fa come commento a un articolo di Andrea Inglese pubblicato su Nazione Indiana, “Paesaggio e convenzioni figurative nella poesia italiana contemporanea”. Dopo aver inviato il commento, mi sono reso conto che la questione che affronta è in realtà più vasta dell’occasione per cui è – di getto – stato scritto, e ho deciso di pubblicarlo, come post autonomo, anche qui.
Il saggio, come sempre quando Inglese scrive, è acuto e pieno di spunti. Non posso che condividere l’idea del testo come paesaggio, visto che io stesso l’avevo buttata lì in un post del 2010. Tuttavia, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi, continuo a sentire una sorta di perplessità, di cui provo a spiegarmi il motivo in questo modo.
(Mentre scrivevo le ultime righe qui sopra, il mio piccolo paradiso è svanito. Nel giro di pochi minuti sono arrivati prima un motoscafo con una dozzina di persone, e poi due battelli piuttosto grandi e così fitti di gente che parevano immigrati. Musica bumbum a tutto volume, schiamazzi, un sacco di gente a riva: un’improvvisa riminizzazione. Non certo l’altro con cui io potrei sentire alcun senso di intimità, nessuna connivenza, nessuna Stimmung – né peraltro nessun desiderio di trasmettere loro qualsiasi senso io possa essere in grado di dare alle cose. Me ne sono andato. Dopo qualche ricerca, nemmeno troppo sofferta, ho trovato questo rifugio che documento qui sotto, se potete capire, ed entrare in una qualche sintonia con me.)
Il punto non è tanto (o non è solo né soprattutto) l’impossibilità di cogliere il mondo nella totalità dei suoi aspetti. Che la cosa in sé fosse inattingibile ce lo diceva già Kant, e Peirce, correggendo la mira, parlava di un avvicinamento asintotico progressivo. Ma credo che il punto non fosse affatto quello, perché quello che sentivo era un’incapacità di dar senso, e quindi comunicare, qualcosa che nella mia esperienza comunque c’era – e quindi non si trova a livello della cosa in sé. Continuando a riflettere (l’eccesso di spiaggia conduce anche a questo) credo che il problema riguardi l’interazione che sto avendo con il mondo attorno – certo, in questo caso, un’interazione estremamente gratificante, e che amerei quindi trasmettere agli altri. Interazione, e quindi azione e percezione dei suoi effetti sul mondo, e conseguente ancora azione con conseguente percezione e così via. Assumiamo (eccedendo un poco, per semplicità) che nel percepire stiamo già dando un senso, e che quindi ciò che percepiamo sia comunicabile (non è vero per ciascun linguaggio specifico – provatevi a descrivere, con Wittgenstein, il suono di un clarinetto, o il sapore della cipolla! – ma se potessimo registrare tutte le dimensioni sensoriali arriveremmo probabilmente più vicini a questo). Rimane comunque il fatto che la nostra azione non è in sé comunicabile: ovvero, possiamo certamente comunicare la percezione che abbiamo della nostra azione (quello che ne sappiamo insomma, a priori come le sue ragioni, o a posteriori come i suoi effetti), ma non comunichiamo l’azione in sé. Nonostante siamo noi a compierla, noi conosciamo l’azione più o meno come conosciamo le cose attorno a noi, con l’aggiunta che ne conosciamo (riteniamo di conoscerne) il perché. Non diamo senso all’azione in sé, bensì alla percezione che ne abbiamo, ed è questo che possiamo comunicare. Ora, il punto è che mentre la cosa in sé appartiene al mondo là fuori, e siamo rassegnati a coglierla solo in parte, l’azione in sé appartiene al mondo qua dentro (l’ho prodotta io, insomma) e ci appare scandaloso, doloroso, non poterle dare senso se non in maniera tanto esteriore come ci accade con le cose. E’ uno smacco profondo al nostro senso dell’io: la drammatica presa di consapevolezza che il nostro fare, il nostro agire, ci è cognitivamente tanto estraneo quanto il mondo attorno. Profondamente dentro di noi c’è insomma un fuori. Il mondo esterno non è solo nella spiaggia attorno a me, bensì anche nella mia interazione con lei, scandalosamente inconoscibile, se non nella stessa maniera parziale con cui diamo senso al mondo. La filosofia occidentale, da Platone a Cartesio, da Kant a Husserl, è sembrata passare di fianco a questo abisso, senza coglierlo. Questo perché Platone (che, da quel genio che era, non faceva che dare chiarezza e precisione filosofica a dei presupposti contenuti nella sua lingua, come un po’ in tutte le lingue indoeuropee) ha impostato la base del nostro pensiero sull’idea, sul conoscere, giocando sempre al limite tra metafisica e gnoseologia – e così è stato per più o meno tutti quelli che hanno discusso con lui, da Aristotele ai giorni nostri. L’Occidente, così, ha messo il conoscere al centro del proprio mito, pensando la filosofia (conoscere il conoscere) come il proprio punto più alto. L’abisso viene intuito da Nietzsche, e sostanzialmente rifiutato – proprio nel guardarlo – da Freud, che proprio mentre fornisce i mezzi per concepirlo, continua a parlare di inconscio come di un soggetto nascosto, ma tutto sommato conoscibile. E comunque una sorta di io, non di mondo: un io segreto, sotterraneo, che lo psicoanalista può almeno in parte portare alla luce. Ma quando lo psicoanalista vi spiega che le ragioni per cui avete compiuto una certa azione non sono quelle che credete, bensì altre, cosa ne è del vostro io? Per un attimo scorgete confusamente l’abisso, poi la nuova spiegazione sostituisce la vecchia, e dove c’era l’Es ecco che c’è di nuovo l’Io; certo diverso, dotato di maggiore conoscenza. E alla lunga il processo analitico funziona… Di fronte al problema di dar compiutamente senso alla mia esperienza su questa spiaggia, l’abisso, invece, si manifesta con forza. La mia interazione con questo amabile intorno non può essere comunicata né più né meno che nei limiti con cui posso comunicare la percezione che ne ho. Peggio anzi: non c’è macchina fotografica, non c’è registratore sonoro, tattile, olfattivo, gustativo, che possa cogliere la mia azione, se non in maniera ancora più esteriore di quanto lo possano le mie parole, già loro evidentemente e ampiamente insufficienti. E la mia azione è l’interazione continua con tutto quello che ho attorno, dal modo di respirare, di muovermi, di toccare le cose: persino la percezione che delle cose sto avendo è intessuta della mia interazione con loro! Posso produrre un report di tutto ciò, con tutta l’inevitabile esteriorità che tale report avrà, come ho abbozzato ieri, come ho continuato a fare con le foto di oggi. Oppure posso scrivere una poesia, girare un film, dipingere, comporre un brano musicale. Sarà tanto più evidente, ora, quanto la credenza che un’opera di questi tipi possa comunicare la mia esperienza del qui ed ora, trasmetterne un senso. Non è certo così che funziona la poesia, né l’arte in generale: non descrivendo il mondo, né le emozioni del soggetto, come credevano i Romantici. Travolti dalla nostra adorazione per il Conoscere, abbiamo trattato l’arte come qualcosa che debba trasmettere un messaggio, e questo messaggio vada colto dal fruitore attraverso il processo di interpretazione. Già Susan Sontag, nei primi anni Sessanta, lamentava il dominio dell’interpretazione (il libro è, appunto, Contro l’interpretazione), facendo osservare che questo modo di vedere le cose ha condizionato gli artisti stessi, che hanno prodotto tante opere affinché fossero poi interpretate, riempiendole di verità nascoste, come in un esercizio di enigmistica. In realtà, quello che capiamo di un’opera d’arte, di una poesia, è importante probabilmente non di più di quello che non capiamo. Un’opera d’arte è tale non per quello che ci dice, ma perché ci propone un’esperienza, intessuta di capire e non capire come le cose del mondo, e a sua volta piena di interazione, perché noi le siamo di fronte, o immersi al suo interno (come nella musica), e quello che percepiamo dipende dalle mosse che facciamo nei suoi confronti. Proprio come con il mondo, non è che percepiamo e basta le opere d’arte, ma il percepire è frutto dell’agire nei loro confronti: dove posiamo lo sguardo, dove e come si fissa l’attenzione, come ci muoviamo nei loro confronti… Insomma, l’opera d’arte, come il mondo, viene vissuta prima che percepita, e quindi percepita nell’interazione con lei. In questo senso è piena, proprio come il mondo, di quell’inumano che finiamo per ritrovare anche dentro di noi. La differenza, come concludevamo ieri, è che di mondo si può anche morire, mentre di poesia no; e questo permette un’interazione molto più disinvolta. Ma questa disinvoltura, se siamo sufficientemente attenti, è anche quella che ci permette più facilmente di cogliere l’abisso. Una grande poesia può essere quindi un’esperienza lancinante, ancora più di questa spiaggia, perché mi riguarda ancora più da vicino. Ecco. Mi trovo qui. Ho camminato per più di un’ora sotto il sole greco, per sentieri mal tracciati e pieni di sassi, un paio di volte scivolando, passando di fianco a un’immensa cavità naturale sul fianco della montagna, un buco che finisce, verso l’alto, con una gigantesca caverna, profondo oltre venti metri dove lo è di meno, pieno di stalattiti e stalagmiti. E adesso sono qui, al bordo dell’acqua del mare appena ondulato, trasparentissimo, all’ombra di una piccola scarpata (e non so quanto quest’ombra durerà), con una lieve brezza. Non fa troppo caldo. Si sta bene.
L’articolo intero si trova qui, su Between.
Prosegue qui, su Versante ripido
Prosegue qui, su Nazione Indiana.
Prosegue qui, su Nazione Indiana Un pensierino sulla musica per rompere il silenzio. Mi è balzato come un’evidenza alla mente mentre ero in macchina e scorreva una musica su RAI3, della quale non sapevo cosa fosse, ma poteva essere un brano americano del 900, non Gershwin ma qualcuno che si sia ispirato a lui. Non è la qualità del brano che importa, ma il fatto che fosse chiaramente un discorso colto sulla musica che è più frequentemente nell’aria, jazz o altro che sia (non che il jazz non sia colto; semplicemente qui era un oggetto del discorso). Ciò che ha reso la musica un’arte, in Occidente e in poche altre parti del mondo, è stata la sua capacità di porsi come riflessione e discorso su qualcosa, e in questo senso destinarsi al semplice ascolto, attento e consapevole. Ma poteva benissimo non andare così. Non è andata così, per esempio, in tante parti del mondo, la cui musica è rimasta un evento da partecipare, ballando o cantando o suonando o vivendo la situazione pubblica cui la musica fornisce il sottofondo. Anche in Occidente, sino a qualche secolo fa, la musica era questo – e, mi preme sottolinearlo, non era più bella o più brutta di quella che è seguita: non è questo il punto. La trasformazione, quando e dove c’è stata, è stata da evento compartecipato a discorso da seguire e comprendere (comprendere magari sentimentalmente, non necessariamente per via intellettuale; ma in certi casi anche intellettualmente, come per tante cose di Bach). Poteva non andare così. Oggi ci appare ovvio che la musica sia questo, ma le cose ci appaiono così proprio perché è andata in questo modo. Poteva forse accadere nell’universo del tattile? Avremmo, in questo caso, un’arte degli oggetti da toccare, capace di trasmettere discorsi complessi come fa la musica. Magari l’universo tattile non è in grado di articolare lo stesso livello di complessità che possono articolare i suoni: e certamente questa potenzialità dell’universo sonoro giustifica la possibilità dell’evoluzione della musica in Occidente. Ovvero mi mostra che esistono i presupposti, ma non mi spiega perché questi presupposti si sono sviluppati – e soprattutto perché si sono sviluppati soprattutto in Occidente, in misura minore in India e Iran (sempre universo indoeuropeo), e ancora meno altrove. Pensare che perché esistevano le possibilità, queste dovevano necessariamente svilupparsi, mi pare un errore. Il campo della matematica astratta possiede un’articolazione concettuale che è forse ancora maggiore, ma questo non ne ha fatto un’arte, nel senso di una forma di discorso in grado di muovere le nostre emozioni. Forse è necessaria una radice compartecipativa, da cui la complessità possa emergere? Ma allora la pittura, che è certamente un’arte, come lo è diventata, visto che – per sua stessa natura – non ha mai potuto essere compartecipativa? Pensiamo alla cucina, alla gastronomia. A certi livelli di alta cucina, possiamo forse davvero parlare di arte. Tuttavia, mentre riconosciamo alla musica la capacità di parlare, eventualmente, dei mali del mondo, o dell’angoscia, riconosceremmo mai la qualità della creazione di uno chef che fa riferimento alla tristezza, o allo struggimento, o alla morte? Woody Allen scrisse su questo tema un racconto molto divertente, immaginando delle recensioni alle creazioni di grandi chef come se si trattasse di dipinti; e l’effetto paradossale ed esilarante stava proprio nell’impossibilità di utilizzare quel tipo di discorso critico per delle opere d’arte culinaria. Per cui, forse l’alta cucina, a certi livelli, è davvero un’arte; ma ci appare così difficile e limitata la sua possibilità di discorso che facciamo fatica ad attribuirle questa qualifica. Poteva andare così, magari, anche alla musica. Poteva accadere che certi suoni, o combinazioni di suoni, dovessero essere rifiutati alla base, a prescindere dal loro ruolo testuale, proprio come faremmo se la pietanza che ci viene messa nel piatto sapesse di cacca: poco ci importerebbe il discorso; la rifiuteremmo con sdegno e basta. Del resto, l’atteggiamento di molti ascoltatori di fronte a certe sonorità difficili della musica colta del Novecento è esattamente dello stesso tipo. E forse non aveva tutti i torti Adorno a definire gastronomica la loro modalità di fruizione – anche se volessimo (e vorremmo!) eliminare dal termine tutta l’acrimonia dispregiativa che Adorno sembra intenderci mettere. Quello che Adorno sembra dimenticare, infatti, è che la musica, pure quella delle avanguardie, per quanto sia discorso non è mai soltanto discorso, e una qualche componente compartecipativa rimane in gioco persino nelle musiche più astruse. Comunque davvero poteva non andare come è andata. E poteva magari svilupparsi qualche altra arte. Non sarà che la nostra prospettiva europocentrica ci sta impedendo di accorgerci che qualcosa del genere altrove esiste?
Cepollaro ricorda quanto importante continui a essere l’opposizione adorniana tra arte conciliata e non conciliata, o pacificata e non pacificata (o anche, direi io, sempre riprendendo la terminologia di Adorno, tra un’arte che si rende conto di avere perso l’innocenza e un’arte che non se ne rende conto), e di come, sino agli anni Novanta, questo sia stato inteso dalla poesia italiana in termini di deriva del linguaggio e della sintassi, allontanamento da una naturale comprensibilità del discorso poetico. Sino a quando, dice ancora Cepollaro, questa strategia ha incominciato a ripetersi, a sclerotizzarsi, e c’è stato un diffuso rifiuto nei suoi confronti. A partire da queste premesse, che condivido, il problema cui io, come autore, come poeta, mi trovo davanti è comunque quello di produrre un’arte non pacificata, consapevole della perdita della propria innocenza. Solo che non posso più utilizzare la formula della dissoluzione della sintassi, perché non funziona più – se mai ha funzionato in quanto tale. Oggi è invecchiata e a sua volta inserita nel meccanismo dell’industria culturale, almeno per quel poco che può succedere per il mondo un po’ estraniato e marginale della poesia. Anzi, visto da oggi, io vedo quella strategia come una scorciatoia un po’ troppo comoda per arrivare al regno dell’arte non pacificata. Col che non intendo squalificare in sé il lavoro della neo-avanguardia, che ha comunque prodotto un certo numero di poeti di altissimo livello, e non solo nel gruppo ristretto dei Novissimi, ma cautelarmi rispetto alla loro maniera e soprattutto rispetto al loro epigonismo. Tenderei ad annettere a questo insieme, ovvero a quello della scorciatoia, non solo le strategie di sovvertimento sintattico, ma anche quelle sostanzialmente neo-dadaiste di presentazione di objet trouvé, o di searched objects (leggasi googlism), in cui il distacco emotivo del poeta è messo in evidenza dal lavoro su materiali chiaramente esterni, chiaramente oggettivi, spesso utilizzati senza una particolare elaborazione – che correrebbe il rischio di inserire una marca di soggettività nel gioco – un po’ secondo il principio del collage. Sto parlando in termini di poetica personale, non di estetica normativa. Cioè non escludo che queste strade possano ancora portare a risultati interessanti, e sono pronto ad accoglierli felicemente appena li incontro. Solo che, in primis, in linea di massima tendo a non incontrarli, cioè faccio fatica a trovarne, e, in secundis, non mi interessa personalmente percorrerle come autore. Da questo punto di vista, potrei dire, ho già dato, ho già fatto: sono cresciuto all’interno di quella temperie culturale, e tutta la mia produzione giovanile ne risente pesantemente. Credo, oggi, che il lettore abbia diritto di avere un accesso immediato a quello che legge, ovvero che il componimento gli fornisca almeno un aggancio, un sospetto di comprensione alla prima lettura, che poi magari si rivelerà parziale, incompleto, o addirittura erroneo a una lettura più approfondita, ma che gli permetta sin dall’inizio un accesso ritmico, un ingresso in sintonia con il testo e le sue letture. In assenza di questa ricompensa immediata, per quale motivo il lettore dovrebbe impegnarsi, andare a cercare ulteriori ragioni di interesse, che si trovano soltanto con un vero e proprio lavoro di tipo critico, per quanto personale? L’impegno interpretativo è un investimento, che vale la pena di fare se il testo promette un’adeguata ricompensa, ovvero se abbiamo ragione di pensare che, oltrepassando l’ostica apparenza di prima lettura, troveremo un universo di affascinanti nessi significanti, con correlata emozione estetica. Ma se il testo non promette, oppure – peggio – se promette e poi non mantiene, perché dovremmo investire in termini di impegno e fatica interpretativa? In tempi di vincente ideologia, come sono stati i decenni tra i Cinquanta e gli Ottanta del secolo scorso, questa disposizione all’impegno da parte del pubblico era più diffusa, perché più diffusa era l’idea che si dovesse investire intellettualmente per ottenere un risultato in termini di comprensione. Ma poi è stato il fallimento stesso di questo programma, che ha coinciso con il tramonto delle ideologie, che ha deluso il pubblico. Poetiche della complicazione sintattica o della citazione neo-dadaista, come furono quelle della neo-avanguardia, potevano funzionare in un contesto in cui l’impegno intellettuale era moneta corrente; ma funzionano molto meno quando questa stessa moneta è arrivata a svalutarsi pesantemente. Queste strategie erano dunque scorciatoie per ottenere un’arte non pacificata, che funzionavano in quelle condizioni culturali. Oggi quelle condizioni non ci sono più, e la scorciatoia mi nausea un po’. La rispetto negli autori che l’hanno utilizzata in quegli anni in cui aveva senso utilizzarla. Ne diffido acutamente in chi continua a utilizzarla oggi. Eccomi quindi di fronte al problema, che dovrebbe essere, io credo, il problema di chiunque scriva poesia oggi, anche se poi, la mia soluzione è semplicemente la mia, senza pretese di generalizzazione. Ma il problema, che è lo stesso per tutti, che uno se ne renda conto o no, è: come costruire un’arte non pacificata, senza utilizzare la scorciatoia asintattica o neodadaista? Come fornire un aggancio di comprensibilità al lettore senza rientrare nelle banalità di una tradizione, la quale non era banale in sé quando veniva prodotta, ma lo sarebbe oggi se riproposta nei medesimi termini? Comprensibilità per il lettore non vuol dire soltanto che il lettore possa più o meno seguire la sequenza sintattica, ma che riceva anche la sensazione di essere di fronte a un testo poetico. Un esempio di strategia alternativa (e un po’ meno scorciatoia) è quello dei poeti cosiddetti neo-metrici. In vari modi, con molte differenze tra loro, autori come Valduga, Frasca, Nove, costruiscono la poeticità con un esplicito riferimento al metro tradizionale, ma si mostrano non pacificati associando a questo recupero del metro tematiche e/o sintassi tutt’altro che tradizionali, in modo che il conseguente straniamento costruisca un effetto complessivo paradossale e un po’ provocatorio. Strategia interessante, che dà anche dei buoni risultati, ma che si lega comunque alla presenza di uno spirito dichiaratamente intellettualistico, quale quello che accompagna inevitabilmente le parodie. Restano escluse, da questa scelta, molte possibilità di registro, tra cui anche varie che interessano a me. Altri poeti ancora si rifanno alla metrica tradizionale, in particolare all’endecasillabo, con spirito meno provocatorio, ma ugualmente utilizzandolo in maniera non convenzionale, come una sorta di macchina ossessiva e senza uscita. E’ il caso, per esempio, di Piersanti e di Fedele (ne parlo ampiamente nel saggio “Il vincolo e il rito”, sulla metrica della recente poesia italiana, uscito su L’Ulisse n.16 – anche più direttamente accessibile su Academia.edu). Pur apprezzando molto certi loro lavori, personalmente provo una certa paura nei confronti dell’endecasillabo, un verso troppo bello e troppo tradizionale per utilizzarlo senza un controllo continuo e faticoso, una continua attenzione al non renderlo tramite di forme antiquate e pacificate, nel senso adorniano di Cepollaro. Proprio per questo, io ho fatto sì una scelta metrica, ma studiata appositamente per non cadere inavvertitamente nelle maglie dell’endecasillabo, pur potendolo utilizzare trasversalmente, ma solo con studiata consapevolezza. Il rapporto con la poeticità può riguardare temi, ricorrenza di formule, costruzioni ritmiche a qualsiasi livello (prosodico, fonetico, sintattico, lessicale, narrativo…). Il problema è che non se ne può fare a meno, se si vuole che il proprio testo possa essere riconosciuto come poetico, e possa entrare nel dialogo con altri testi poetici. D’altra parte, queste stesse forme portano con sé il rischio di un ritorno all’ingenuo, al pacificato, all’illusione dell’innocenza. La via per farne uso senza cadere nella trappola è stretta, e le scorciatoie non funzionano più. Personalmente, ho fatto una scelta metrica, come riferimento di fondo; ma mi sono costruito un metro che potesse suonare non familiare a un orecchio italiano, un esadecasillabo che non è un doppio ottonario, ma che porta un accento obbligato sulla settima sillaba, oltre che, ovviamente, sulla quindicesima. Si costruisce in questo modo una regolarità prosodica che può essere recepita come tale, senza portare relazioni dirette con le sonorità dei versi tradizionali italiani. Il verso può essere usato sia come struttura chiusa e ossessivamente ripetuta, sia come struttura aperta con enjambement anche estremi, alla Rosselli, sia alternando i due modelli, a seconda delle necessità espressive, come una struttura musicale. Su questa base, il discorso cerca di essere rigorosamente sintattico (anche se con possibilità occasionali di non chiusura di periodi, specie se lunghi e complessi), ma distaccato. Il lessico cerca di essere basso, colloquiale, o di innalzarsi verso lessici specialistici se necessario, ma evitando quelli poetichesi, a meno che una qualche formula tradizionalmente poetica non voglia diventare cuore stesso del discorso, e allora il distacco va manifestato straniandola, ripetendola, rendendola cellula di un’ossessione ritmica che la snatura. Questo permette di fare uso anche delle parole vietate e persino delle rime in cuore-fiore-amore-dolore. L’esercizio sta in un periglioso equilibrio tra l’abbandono emotivo e il controllo intellettuale, tra il gioco stilistico e la partecipazione appassionata e profonda. Un’arte non pacificata, io credo, non è un’arte che evita le forme pacificate, standard, stereotipate, anche esaurite, ma che le usa mostrandole al contempo come tali, e sapendone estrarre quella cellula di vita vera che comunque ancora rimane in loro, come in ciascuno di noi, per quanto pervertito sia dalla vita nell’universo delle comunicazioni di massa di una società capitalistica avanzata. Insomma, nella dicotomia adorniana tra Schoenberg e Strawinsky, là dove Adorno vedeva in Schoenberg il progressista, colui che si mantiene al di fuori della corruzione dell’industria culturale, e in Strawinsky un peccatore corrotto e contaminato, io vedo piuttosto nel primo un (comunque affascinante) aristocratico innamorato del passato e della tradizione, che cerca a tutti i costi le vie per innovarla conservandone l’essenza (quale Adorno stesso era, in fin dei conti), e nel secondo colui che ha davvero saputo costruire un’arte non pacificata, sporcandosi le mani con tutto quello con cui se le poteva sporcare, ma rimanendo sempre originale e in fin dei conti non compromesso, giocoso e appassionato. Un altro pensierino. Quando ho visto questa foto, ho capito perché Omero era cieco. La foto me l’ha fatta Valentina Gaglione, a una lettura-performance di Claudia Zironi, in cui intervenivo in veste di critico. Non sapevo di essere fotografato, non era in nessun modo nella mia mente in quel momento di poter apparire in un’immagine. La mia mente era interamente concentrata nel difficile compito di recitare a memoria un testo poetico in latino, che faceva parte del mio discorso. I miei occhi erano chiusi e l’espressione concentrata perché la mia attenzione era tutta lì, alle parole difficili che dovevano uscire una dopo l’altra con il ritmo giusto e la giusta espressione. Credo che, agli occhi dei presenti, più o meno la stessa espressione la dovesse avere anche Omero, o gli aedi suoi compari, quando ricordavano semi-improvvisando i versi epici, tutti concentrati al proprio interno, sulla parola a venire e sulla sua espressione. E’ per questo che Omero era cieco: poeta non meno mitologico dei personaggi da lui cantati, non era possibile rappresentarselo che così, privo della vista, un organo inutile, anzi inutilmente distraente per qualcuno che esiste (almeno nel mito) solo per cantare versi. |
||
|
Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti