François Jullien, la poesia, la critica
di Daniele Barbieri
Quando leggo François Jullien mi trovo frequentemente in convergenza col suo pensiero, riconoscendo comunque in lui l’invidiabile vantaggio di poter basare le proprie riflessioni su duemilacinquecento anni di pensiero cinese, nella sua fondamentale diversità dal nostro. L’assunto (wittgensteiniano) di base delle osservazioni di Jullien è che ciò che ci è troppo vicino, ciò che è alle basi stesse del nostro pensiero, ci sia per questo stesso motivo invisibile; ma che la sostanziale diversità del pensiero cinese (al di là del suo maggiore o minore valore rispetto al nostro, che non è in questione) ci può servire proprio come punto di vista esterno, dal quale vedere il nostro modo di pensare con maggiore chiarezza (e anche viceversa, ovviamente – però questo ci interessa di meno). Si tratta di un’operazione non così dissimile da quella che compiva a suo tempo Michel Foucault, cercando il proprio punto di appoggio in quell’altrove che sono le altre epoche storiche, ciascuna con il proprio episteme. Ma, proprio in questi termini, il punto di appoggio di Jullien si rivela più efficace di quello di Foucault, perché ci permette di cogliere la relatività culturale di nozioni che condividiamo con Platone e/o con Aristotele, al di là della (comunque presente) variazione storica che esse hanno subito.
Si tratta di un numero non piccolo di nozioni cruciali, e altrimenti difficilmente pensabili, perlomeno in termini filosofici, poiché rappresentano spesso proprio ciò che in Occidente è rimasto impensato da parte della ragione, a vantaggio delle nozioni che sono state poi effettivamente sviluppate. Queste nozioni di origine o ispirazione cinese si trovano argomentate nei numerosi libri che Jullien ha pubblicato negli ultimi vent’anni, ma anche molto utilmente raccolte nel suo ultimo: De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinoise de la pensée (Gallimard 2015). Proprio perché si tratta di una sorta di lessico (filosofico), il libro è organizzato per coppie oppositive, dove a un termine sviluppato dal pensiero cinese si oppone quello che ha avuto successo in Occidente: propensione (vs causalità), potenziale di situazione (vs iniziativa del soggetto), disponibilità (vs libertà), affidabilità (vs sincerità) ecc.
Non è mia intenzione qui fare un rendiconto dei contenuti del volume, cosa che sarebbe davvero difficile, visto che si tratta a sua volta di una sorta di compendio di vent’anni di riflessioni in trenta altri volumi. Mi limiterò a concentrarmi su tre coppie oppositive, e sulle conseguenze che la loro presa in carico da parte del pensiero occidentale può avere sulla riflessione sul testo poetico e sulla critica che lo riguarda:influenza (vs persuasione), coerenza (vs senso), connivenza (vs conoscenza).
La struttura della lingua cinese non permette l’oggettivazione dell’essere. Il pensiero tradizionale cinese è quindi estraneo ai concetti di ente e di essenza che sono stati, da Aristotele in poi, alla base del pensiero filosofico e teologico occidentale…
Prosegue qui, su Nazione Indiana
 Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti… Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti…
prosegue su Versante ripido, esattamente qui.
3 Dicembre 2013 | Tags: critica, estetica, fumetto | Category: estetica, fumetto |  Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande: Gli amici de Lo Spazio Bianco, stanchi di interventi e commenti demenziali sul tema della critica ai fumetti, hanno richiesto la mia autorevole voce, e mi hanno intervistato sul tema, facendomi le seguenti domande:
Nella critica fumettistica Italiana ci sembra si viva un po’ il seguente paradosso: se non hai mai fatto fumetti, non li puoi giudicare; e al contempo, se fai fumetti non puoi avere l’onestà intellettuale di criticarli. Cosa ne pensi?
Hai mai provato a scrivere o a disegnare un fumetto? Con che risultati?
Chi si occupa di critica sul fumetto quali strumenti reali deve sviluppare? È importante saper disegnare o scrivere fumetti? O ritieni sia possibile sviluppare altre competenza da altri punti di vista?
Il fumetto è un mezzo di comunicazione ricco e complesso. Non tutto è riconducibile solo al saper disegnare o sceneggiare. Cosa c’è oltre la sola dimensione tecnica, secondo te?
Quali conoscenze e competenze è importante padroneggiare per poter fare critica sul fumetto?
È possibile una critica intellettualmente onesta da parte di professionisti del fumetto? O ci vedi vincoli sul piano della “deontologia professionale”?
Quali azioni, iniziative vedresti come cruciali in questo momento per poter far crescere la credibilità e il riconoscimento della critica fumettistica in Italia?
Le risposte si trovano qui.
6 Marzo 2013 | Tags: Arte, arti, cinema, critica, estetica, fumetto, musica, poesia | Category: estetica, fumetto, musica, poesia |  Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente. Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.
Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo.
La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale.
Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo.
E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a.
(In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato)
Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito.
L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?
Visto che mi occupo di ambedue le cose, il fatto mi salta inevitabilmente all’occhio. E il fatto non è che tra l’universo della critica poetica e quello della critica fumettistica ci siano, come è ovvio, numerose differenze. Semmai è che in mezzo a queste ce ne sia una meno ovvia delle altre, su cui vale la pena di indagare.
Non è difficile osservare che nell’universo della critica poetica è frequente un genere di critica che potremmo denominare prescrittiva, che è invece del tutto assente nella critica del fumetto. Non si tratta solo che chi scrive esprima più o meno esplicitamente delle preferenze personali: anche il critico dei fumetti è inevitabilmente schierato (chi con maggiore, chi con minore virulenza) nei confronti di un genere o di alcuni autori. Non esiste la critica oggettiva: il critico parla di ciò che conosce, giustamente; e conosce quello che gli interessa, giustamente. Persino se nutre ambizioni di esperto complessivo, o magari di storico, è naturale che finisca per propendere in qualche direzione, pur cercando di tenersi aggiornato a tutto campo.
Tuttavia nessun critico di fumetti, per quanto schierato, si sognerà mai di dichiarare che il fumetto vero si fa in un certo modo e non in altri; e che tutto il resto è inautentico, inattuale, sorpassato e, in ultima istanza, falso o mistificante. In altre parole, a nessun critico di fumetti è mai venuto in mente di scrivere in termini prescrittivi, dichiarando quale sia il modo giusto, corretto ed esclusivo di fare fumetti; oppure (versione appena più blanda della precedente) quali siano i modi sbagliati, scorretti e da abbandonare, indipendentemente dalla qualità degli autori e delle loro opere.
Sarà perché la critica del fumetto è giovane, o sarà perché quasi mai i critici sono anche gli autori stessi, o perché la posta culturale in gioco appare meno impegnativa. La critica poetica ha una lunga storia; molti critici sono anche autori, che si sentono in dovere di sostenere teoricamente le proprie scelte di poetica; la posta in gioco si presenta come altissima, perché, anche se i lettori di poesia in Italia sono molti meno dei lettori di fumetti, ancora, per chi se ne occupa, “quel che resta lo fondano i poeti”, come ebbe a dire Hölderlin una ventina di decenni fa.
O sarà anche perché, data la sua giovane età, il fumetto vive un’epoca felice in cui tra le produzioni più popolari e quelle più di elite esiste una continuità di produzioni intermedie e uno scambio continuo; e se pur qualche volta è chiaro cosa sia popolare e cosa sia di elite, in altri casi è, felicemente, impossibile (e inutile) distinguere davvero. La poesia (e quella italiana in particolare) ha tagliato i ponti da secoli con la sua versione popolare, al punto di escluderla dal campo stesso che la definisce, lasciandoci persino il dubbio rispetto a che cosa, oggi, potrebbe essere definita come tale: la canzone, forse? Basta leggere i dibattiti in rete al proposito (ad esempio qui) per capire quanto problematicamente sia vissuta questa ipotesi.
La critica prescrittiva non è ovviamente sempre così becera da dire esplicitamente “si fa così” o “così non si può fare”, ma non è, in ogni caso, affatto difficile ritrovare nel suo discorso queste morali. A titolo di esempio, uno per tutti, si può citare intervento e dibattito (specialmente il dibattito) tenuto in questa sede a proposito della poesia di Milo De Angelis. Nel dibattito vi sono anche numerosi interventi interessanti, e una lodevolissima documentazione su interventi critici di difficile riperimento, riportati interamente o in parte, pro o contro De Angelis (cui è seguita nel medesimo sito/blog poesia2punto0, nei giorni successivi, la pubblicazione di altri interventi critici su De Angelis, e sul post in oggetto, e altre polemiche ancora altrove); mi vi è anche un’interminabile serie di interventi volti a dimostrare (quasi more matematico) che la poesia di De Angelis è sbagliata, e che così non si fa, sino ad affermare testualmente (Laura Canciani): “NO, la poesia deangelisiana non può essere affatto utile all’obiettivo da conseguire, integralmente tardo novecentesca nella sua impostazione di fondo e nella sua costituzione, non ci può dire nulla di nuovo di ciò che sapevamo già”.
Parlare in questi termini (tutto sommato piuttosto frequenti nella critica poetica) vuol dire condannare De Angelis non tanto per la qualità della sua poesia, quanto perché le prescrizioni che da essa sarebbero ricavabili non sono utili all’obiettivo da conseguire, anzi controproducenti. L’intervento è rivelatorio proprio a causa della sua rozzezza, perché esplicita quello che critici più raffinati stanno attenti a non esplicitare, o danno per scontato: cioè che ci siano degli obiettivi da conseguire, e che tali obiettivi siano sufficientemente chiari.
Ora, è evidente che una critica prescrittiva si giustifica soltanto se ci sono degli obiettivi chiari e condivisi da conseguire. Quali sono questi obiettivi? E, per quanto riguarda il fumetto, tali obiettivi non esistono, oppure esistono ma la critica preferisce ignorarli, o non scontrarsi sul loro campo?
Cerchiamo di far qualche luce sulla prima delle due questioni, lasciando la seconda a una riflessione futura. Quali possono essere gli obiettivi della poesia, così chiari e condivisi da poter pensare di dimostrare che la poesia di De Angelis non è adatta a dare indicazioni per conseguirli? Suppongo che siano qualcosa come: testimoniare il proprio tempo, esprimere la condizione umana nel presente (nella fattispecie nell’epoca dell’abbrutimento e dell’alienazione tardo-capitalista). Qualcosa di questo genere salta fuori in generale sempre quando si cerca di capire a cosa serva la poesia.
Sono asserzioni generiche, anche la seconda (pur se meno della prima). Da sole non giustificherebbero né potrebbero sostenere alcun livello di critica prescrittiva. È perciò necessario che il critico, che egli lo espliciti o meno, abbia opinioni molto più dettagliate di queste. Nel post citato, per esempio, l’autore Giorgio Linguaglossa cerca di esplicitarle almeno in parte in uno dei commenti, come spiegazione a posteriori delle ragioni del suo attacco a De Angelis.
Quello che mi colpisce, di queste esplicitazioni, o di quello che si può intuire di implicito ogni volta che la critica assume colorazioni prescrittive, è che il critico mostra di avere un’idea molto chiara di quello che è il nostro tempo, di quale sia il suo problema, e di conseguenza di come la poesia dovrebbe fare per esprimerlo. Personalmente, in questi casi, sono sempre incerto tra l’essere ammirato e l’essere imbarazzato: ammirato perché piacerebbe tanto anche a me possedere certezze del medesimo livello; imbarazzato perché ho la sensazione netta di vedere quello che il critico in questione non vede, ovvero i limiti abissali delle sue certezze.
Giusto per fare un esempio. È un luogo comune della critica poetica che noi si viva in una società alienata e inautentica, e che la poesia che non esprima questo sia per forza necessariamente inautentica (anche di questo si accusa, per esempio, De Angelis, in molti dei commenti di cui sopra). La neoavanguardia italiana, come tanta arte cresciuta sulle teorizzazioni di Adorno, vive integralmente su questo presupposto; e vi continuano a vivere tanti suoi epigoni.
Ora, non si tratta di negare che esista l’alienazione e l’inautenticità, perché basta accendere il televisore per accorgersene; o nemmeno di negare l’importanza sociale di questa condizione disumanante. Ma sostenere che la poesia debba necessariamente confrontarsi con questa condizione, e tacciare di inautenticità la poesia che parla d’altro, significa pensare che, poiché il centro è importante, le periferie non esistono. È probabile che nel nostro tempo l’autenticità (qualunque cosa si voglia intendere con questa brutta e oscura e intollerante parola) sia relegata davvero nella periferia dell’esperienza: ma per quale ragione la poesia non dovrebbe convivere ed esprimere questa periferia?
Si dice anche che l’inautenticità abbia pervaso tutto, e che non siamo in grado di provare nessun sentimento autentico. Mi piacerebbe però sapere se ci sia qualcuno in grado davvero di riconoscere un sentimento autentico da uno che non lo è. Ma se non siamo in grado di operare questo riconoscimento, come possiamo permetterci di dire che l’autenticità è stata scacciata, e che la poesia, dopo Auschwitz, non può che esprimere quel male? Come potrà permettersi di parlare di autenticità chi non sia in grado di riconoscerla? Non sarà, l’autenticità, proprio quel mito oscuro e impossibile, che è utile perché ci permette di dire che il nostro mondo non è così, e che bisogna operare, di conseguenza, in un determinato modo, per recuperarne almeno l’espressione (l’espressione autentica di un mondo inautentico!)?
In alternativa, il mito oscuro potrà trovarsi anche nel politico, anzi in una precisa concezione del politico. Poiché De Angelis, in generale, parla d’altro, De Angelis allora non ci servirà. Ammesso e non concesso che il centro del nostro tempo sia correttamente identificato in questo modo, anche in questo caso, che diritto avrebbe il centro di escludere le sue periferie dall’esercizio poetico? Mi importa assai poco, in verità, di decidere quale sia il centro. Personalmente, poiché apprezzo De Angelis, ritengo che un qualche centro le sue poesie lo colgano. E poiché apprezzo Fortini, ritengo che un qualche altro centro sia colto pure da lui. E continuo a non capire perché se l’uno è giusto l’altro debba essere sbagliato.
Ho già difeso De Angelis altrove (qui e qui, per esempio), e non è per difendere la sua poesia che ho scritto queste righe. Il punto è che trovo qualcosa di insopportabile nel sentirmi dire che cosa sia giusto fare, senza che vengano esplicitati gli obiettivi di questo fare (e quindi senza discuterne). Con i miei versi (come con quelli di chiunque altro) io mi auguro che i lettori possano trovarsi in sintonia, e quindi giudicarli belli; mentre magari, al contrario, non riusciranno a trovare nessuna sintonia, e li riterranno brutti. I miei versi, come quelli di chiunque altro, sono belli, oppure sono brutti; ma non sono giusti o sbagliati. Quello che potrà essere giusto o sbagliato sarà un intervento critico, non un’operazione artistica – e parlare di un’operazione artistica in termini di giusto o sbagliato è perciò parlarne come se si trattasse di un intervento critico.
La critica del fumetto, pur nella sua pochezza (quantitativa), mi sembra che resti ancora estranea a questo fraintendimento. Per quanto mi riguarda continuerò a fare il critico di fumetti anche di fronte alla poesia. Non mi piace rendermi ridicolo.
Avevo programmato di scrivere questo post da un po’ di tempo, e buttato giù qualche appunto in attesa di stenderlo per bene. Poi c’è stato il dibattito sul post di Andrea Inglese su Nazione Indiana a proposito del libro di Alessandro Broggi, nel corso del quale sono uscite una serie di questioni interessanti, e non solo tra Andrea a me. Inevitabile quindi partire da lì.
Il tema è il ruolo della critica o, in altre parole, che cosa ci si debba aspettare dalla critica. Un tema trasversale: anche se l’intervento di Inglese riguarda un testo poetico, la questione della critica riguarda la poesia come il fumetto come qualsiasi altra forma espressiva su cui la critica si esprima. Sto parlando della critica, in senso ampio, “militante”, quella, cioè, che propone testi all’attenzione del pubblico – che ha un ruolo del tutto diverso dalla storiografia di settore (storia dell’arte, del fumetto, della poesia…) o dalle analisi testuali.
Ritrovo nei miei appunti la stessa parola chiave con cui Inglese a un certo punto del dibattito cerca di focalizzare la questione: rilevanza. Dice Andrea: “trovo molto azzeccato il termine ‘rilevanza’. Il critico non può che persuadere, attraverso prove specifiche – che sono le trame di relazioni, ecc. -, della rilevanza di un certo testo, come ‘testo poetico’, di un certo insieme di colori, come ‘dipinto’, ecc. Il lettore potrà poi farsi portare da questo tessuto ‘ricostruito’ verso il testo stesso, e sperimentare in proprio quanto può accadere. E qui può avvenire o non avvenire una risonanza tra testo e lettore, che in nessun modo può essere anticipata, inclusa, governata dal discorso critico.”
Il discorso di Inglese mi sembra sensato e condivisibile, ma si basa su una nozione a rischio, quella, appunto, di rilevanza. Che cosa vuol dire che un testo è rilevante? Rilevante per che cosa, insomma?
Le risposte possibili sono diverse. Ce n’è una, più diffusa di quanto non sembri a uno sguardo superficiale, che dipende ed è legata alla concezione storicista che la nostra cultura tende ad avere di se stessa, la stessa concezione, per intendersi, a cui è legata la nozione di progresso, o quella di crescita. Non intendo attaccare lo storicismo. È la stessa visione del mondo in cui mi muovo anch’io. Ogni concezione alternativa mi pare più primitiva e grossolana. E tuttavia non posso fare a meno anche di vederne i limiti e i problemi.
All’interno di una concezione storicista un testo artistico (permettetemi di usare qui questa nozione generica e imprecisa per intendere in un sol colpo i testi poetici, letterari, fumettistici, pittorici, filmici…) ha valore se contiene qualche elemento di novità rispetto al passato, o meglio di novità rilevante. Nel fare la storia di un ambito artistico (poesia, fumetto o quant’altro) è inevitabile e doveroso mettere in primo piano non tanto le opere (e i rispettivi autori) che sono state più apprezzate dal pubblico, bensì quelle che più hanno influenzato le opere (e gli autori) successivi, modificando il corso della storia. Spesso, ma non sempre, le opere più apprezzate sono state anche le più influenti; o perlomeno è difficile che un’opera molto apprezzata non sia anche in qualche modo influente. Ma capita anche che vi siano opere influenti che pur non hanno goduto di un grande apprezzamento. I due campi sono ampiamente sovrapposti, ma ben lontani dal coincidere.
Le opere influenti sono quelle che hanno introdotto molte novità rilevanti, quelle novità che poi sono diventate merce consueta negli autori successivi. Le opere apprezzate sono quelle che, in contesti più generali o più specifici, hanno avuto successo. L’atteggiamento storiografico non esclude le seconde solo perché esse di solito stanno anche tra le prime; ma non è raro il caso di autori baciati dal successo in vita, che poi la storia ha quasi dimenticato, non sapendo come posizionarli nella linea dello sviluppo evolutivo.
In un contesto culturale storicista, quando facciamo critica militante, tendiamo spesso a comportarci un po’ come degli storici. La rilevanza che attribuiamo al nostro oggetto di presentazione è, appunto, una supposta rilevanza storica, basata sulla presunzione di una qualche novità significativa, e quindi di un qualche apporto originale al dibattito complessivo. Presentiamo il nostro oggetto, insomma, come una migliore risposta a un qualche problema espressivo, almeno da un qualche punto di vista: certo non si tratta ogni volta di inventarsi un novello Dante Alighieri. La novità che pretendiamo di stare individuando può essere piccola, locale, minore, particolare; ma in quell’ambito così ristretto è nondimeno una novità, e il lavoro di cui parliamo è rilevante in quanto presenta una rilevante (piccola) novità.
Il problema, rispetto allo storico vero e proprio, è che il critico militante lavora sul presente. La novità, e tantopiù la novità rilevante, è qualcosa che può essere riconosciuto solo a patto che la direzione in cui si sta andando sia sufficientemente chiara al critico. Anche quando si sta facendo della storiografia, individuare le tendenze di un epoca artistica non è un fatto pacifico, ma almeno in questo caso esistono dei precedenti di riferimento, e qualche certezza è legittima (almeno sino al prossimo ribaltamento di paradigma). Ma se parliamo del presente, la tendenza rispetto alla quale decidiamo che qualcosa costituisce una novità non può che essere un’assunzione rischiosa, talora arbitraria. Sarà molto facile (e assai spesso accade proprio così) estrapolare una qualche tendenza della storia recente, estendendola al presente e all’immediato futuro; vedendo dunque come progressisti coloro che immettono qualche novità all’interno di un discorso già avviato e sostanzialmente assestato, ma magari essendo incapaci di riconoscere delle nuove e influenti tendenze, in quanto estranee o addirittura contrarie alla tendenza che stiamo privilegiando.
Tanto più saremo critici “di parte”, e tanto più questo rischio sarà forte, sino al caso limite del restare ciechi di fronte alle novità effettive, e ai cambiamenti storici veri e forti. Per questo, pure il critico “di parte” dovrebbe fare attenzione non solo alla novità rilevante, ma anche all’apprezzamento effettivo ottenuto da parte del pubblico, sforzandosi di comprenderne le ragioni, anche a costo di mettere in crisi le proprie ipotesi evolutive.
Ma questo significherà che il critico non può fare a meno di considerare l’apprezzamento, il successo, come indici di rilevanza. Non potrà ignorare se un certo testo piace o non piace al pubblico cui è destinato. Tuttavia, come si porrà se, da critico militante, sta presentando al pubblico un testo di fresca uscita, del quale evidentemente non potrà già conoscere l’esito di pubblico? Dovrà in questo caso basarsi solo sulla (ipotetica) tendenza, e valutare, ideologicamente, sulla base di ciò che ritiene progressivo? Un buon critico dovrà dunque, necessariamente, essere di parte? avere un’ideologia, qualunque essa sia, che lo guidi e lo illumini nelle sue scelte?
È evidente, comunque, che non esiste una critica neutra, cioè non esiste una critica che non abbia dei presupposti ideologici, perlomeno impliciti. Il punto non è quello di cercare di neutralizzare la critica, operazione che non farebbe che nascondere sotto il tappeto degli inevitabili presupposti ideologici. Il punto è semmai cercare di capire attraverso quale operazione questi presupposti possano diventare il più possibile espliciti, ed essere espressi insieme alle valutazioni specifiche che ne conseguono, a proposito del nostro oggetto di critica.
Tornando alla breve citazione di Andrea Inglese riportata sopra, si può osservare che viene fatta una netta opposizione tra critico e lettore: al critico spetta ricostruire le trame di relazioni che stanno alla base della rilevanza del testo, mentre il lettore troverà (o non troverà) una risonanza nel testo. Certo i ruoli sono diversi; ma il critico, prima di essere critico, non dovrà essere stato anche lettore, vivendo (o non vivendo) a sua volta quella risonanza? Se rispondiamo di no, decidendo di separare nettamente la lettura del critico da quella del lettore, dovremo rispondere a un’ulteriore domanda: visto che il critico non può basarsi sulla risonanza col testo per valutarne la rilevanza, su che cosa si baserà? In questo caso, non vedo altre risposte possibili: si baserà sull’aderenza del testo oggetto a un qualche canone che (ideologicamente) viene ritenuto valido. Se separiamo completamente l’azione del critico da quella del lettore, dunque, ricadiamo inevitabilmente nel caso descritto sopra, quello che facilmente sfocia nella cecità ideologica, malattia piuttosto diffusa nel XX secolo (e anche dopo).
Postulando dunque che critico e lettore siano sì figure diverse, ma che in qualche modo il ruolo di lettore debba far parte di quello di critico, si tratterà allora di cercare di capire in che modo questo debba o possa accadere. Suppongo che ci possano essere non uno, ma una serie di modus operandi positivi. Mi limiterò a esporre quello a cui io stesso cerco (non sempre con facilità, non sempre con coerenza) di attenermi.
Prima di tutto mi considero un lettore, e come lettore cerco una risonanza nel testo. Ma poiché so di essere un critico, e che prima o poi dovrò produrne una valutazione, il mio tentativo, costante e a monte, è quello di costruirmi come un lettore il più generico e aperto possibile, pronto a cogliere nell’opera aspetti positivi di qualsiasi tipo. Per fare questo cerco di aver già letto molto, e cose molto diversificate; cerco di aver già costruito il mio gusto come un potenziale gusto del pubblico. È ovvio che un compito di questo genere non può arrivare davvero a compimento, perché per quanto riesca ad ampliare i miei orizzonti, essi resteranno comunque i miei, inevitabilmente. E tuttavia la tensione verso questo (pur intattingibile) fine non è inutile, perché mi porterà sempre a domandarmi se non ci sia altro da prendere in considerazione.
Supponiamo che, in qualche modo, io trovi una risonanza nel testo, come lettore. A questo punto ha inizio il lavoro di critico, perché ora io ho l’obbligo di capire su che cosa si basi questa risonanza, e di trovare un modo di descrivere il testo che mi renda ragione di quello che provo leggendolo. Sarà questo, poi, che cercherò di trasmettere al mio lettore per presentargli il testo di cui sto parlando. Nel farlo, dovrò anche esplicitare i miei presupposti ideologici del caso, perché pure loro sono oggetto dell’analisi.
Se non trovo la risonanza, posso decidere che il testo è banale, senza scampo; posso decidere che il testo è banale, con riserva – perché non sono certo del mio giudizio e dovrò, prima o poi, provare a tornarci su; posso decidere che non capisco, e sospendere il giudizio. Quello che personalmente, in ogni caso, mi rifiuto di fare è promuovere un testo solo perché ideologicamente mi è sufficientemente vicino; se si trattasse di un testo critico, questa sarebbe invece, ovviamente, la cosa che conta di più – ma per un testo artistico non è una condizione sufficiente.
Questo metodo non è esente da errori. Per quanto io cerchi di affinare la mia sensibilità, posso trovarmi oggi in sintonia con testi che magari in seguito riconoscerò come banali, o non trovare sintonia con testi che in seguito mi si imporranno come interessanti. Mi è già successo e mi succederà ancora. Per questo è poi così importante la successiva fase di analisi ed esposizione, che costringe a riflettere sulla sensazione iniziale.
Ma questo metodo mi mette un po’ di più al sicuro dagli aspetti peggiori di una visione storicista del mondo, ovvero dal ritenere che ci sia una linea evolutiva vincente, progressiva, rispetto ad altre perdenti e regressive, e che sia la mia. Questo è stato (tra gli altri) il male del materialismo storico e il male delle avanguardie, che ha gettato forti ombre anche sul bene che materialismo storico e avanguardie hanno comunque portato. In altre parole, cerco di sfruttare il fatto di non essere un io, ma – come tutti – una costellazione di io che trovano, ciascuno, il proprio momento di espressione, per ritrovare in me delle differenze di giudizio e di impostazione ideologica che mi permettano di capire e di trovare risonanza anche al di là dell’accordo ideologico.
Una critica di questo genere segnalerà dunque la rilevanza di un testo, ma cercando di fornire al lettore ragioni per trovare a sua volta la risonanza che il critico ha trovato. Poi, certo, il lettore è libero; ed è diverso da me. Posso tentare di essere tanti. Non posso sperare di essere tutti.
22 Dicembre 2011 | Tags: critica, Marco Giovenale, poesia | Category: poesia | .
La lepre scalcia per rientrare nella tana
Fumo degli odori, insetti, niente si accorge.
In realtà aperta nel centro della strada,
la strada assorbe il rosso, occhi, crema.
Entra la Notte, si sparge.
_________________________________________________________
.
.
Quando sono finite le siepi
sversano la foto delle siepi.
Teste, fai il sigillo autentico,
cola cera. (Dal sole).
Argomento e destinazione.
Ma al muro dei due arsi
sotto il camminamento a castello
che curva le edere, potus, l’olivo largo
abbracciabile poco, ricorda la traccia all’olfatto
di umido, la gabbia-finestra di croci
come la osservava dal vetro verde grasso
essendo ancora pochi gli anni del corpo
gli anni del principio
– lì la cucina ingrandisce ricordata
ma la spende la polvere, la raggia.
Stamattina entra, ha ritorno con le lingue
di memoria. Nel nero di mura, nel viola
che forza o sfiora serrature poi travi
orizzontali di ferro, a vuoto. Sente
Allora sarà bello quando noi
che qui abbiamo abitato (amato)
saremo tutti nomi morti
saremo tutti dai nostri stessi
semi – gli ultimi esiti pieni –
perfettamente finiti, senza resti
in nessuno che abbia
– sia pure irriflessa – parola
____________________________________________________
.
.
Il freezer perde acqua, già, funziona ancora –
il tubo butta nella ruggine,
servono soldi per cambiare.
Il fetore si sente a trenta metri.
La casa tutta la notte è al buio
fuori; sono fulminati i fari,
la scala altissima da qualche anno è marcia,
non ha sostituzione.
Lui stesso non vorrebbe dirne.
C’è il nero delle api, si vergogna.
Non sopportabile ne sciama – altro
buio dentro, per chi distingue ancora.
Il 19 è la sua festa ma sta senza
telefono. Interrotto, o: sogno opaco.
I rami morti spuntano da quelli vivi
e prendono tutta la luce dando
in cambio niente. Così fanno le ombre
sotto, ai pochi quasi nuovi fiori
che respirano forte nel vetro
bianco del sonno
__________________________________________________
Tre poesie da La casa esposta, di Marco Giovenale, Le lettere, 2007
.
.
Per parlare della poesia di Marco Giovenale devo fare attentamente astrazione dal suo discorso critico. Questo è naturalmente vero in generale, è cioè un principio valido per qualsiasi poeta; ma per Giovenale la cosa è particolarmente difficile, perché la presenza e il peso del suo discorso critico sono forti. In generale, certo, la poesia è più profonda e pesante del discorso critico, ma il discorso critico è per sua natura più accessibile, più facile. Per questo la tentazione di rivolgersi a questo come chiave interpretativa per comprendere quella è sempre forte, là dove quella si presenti difficile, difficilmente appetibile. Ma si tratterebbe di uno sbaglio.
È sbagliata infatti l’idea stessa che il punto di vista critico interno sia privilegiato rispetto a quelli esterni, e che il poeta, rispetto alla propria poesia, ne sappia di più di quanto ne potrebbe comprendere un altro, un esterno. Quello che all’autore si può certamente concedere, in generale, è una buona conoscenza dell’oggetto del proprio discorso, se non altro perché quando si trova in veste di critico sa bene che cosa abbia fatto in veste di poeta. Ma questa ottima conoscenza dei dettagli spesso gli nasconde l’effetto d’insieme, e il poeta che fa il critico di se stesso (attraverso, per esempio, dichiarazioni di poetica – o anche il poeta che, onestamente, non fa il critico di se stesso, ma che, pur parlando solo di altri, viene letto alla ricerca di una chiave per la sua stessa poesia) ha un punto di vista troppo ravvicinato e coinvolto per potere davvero vedere quello che fa.
La chiave per comprendere la poesia va cercata unicamente nella poesia stessa, ed è solo quando ne siamo in possesso che ci possono essere utili eventuali indizi provenienti dal discorso critico dell’autore. Sin quando ci rivolgiamo a questo per comprendere quella, e interpretiamo il discorso poetico sulla base di quello critico, stiamo facendo un lavoro superficiale, schiacciando quello che la poesia è su quello che il suo autore vorrebbe che fosse.
Anche per questo intendo parlare qui solo della poesia e non delle prose di Marco Giovenale, visto che le prose continuano ad apparirmi, inesorabilmente, astruse e costruite a tavolino (quasi che chiedessero il supporto del voler essere fornito dal discorso critico). Data la qualità dei componimenti in versi, posso sospettare che la carenza stia in me, che ancora non ho trovato la chiave delle prose, e non nell’autore. Capisco bene quanta importanza attribuisca Giovenale alle proprie prose (alla propria Prosa in prosa, tanto per citare sino in fondo l’operazione), visto che il suo discorso critico insiste moltissimo sul tema; ma anche questa insistenza mi fa sospettare che il nodo vero si trovi nei versi, proprio in quanto più lontani dal voler essere.
Ho letto e riletto con piacere La casa esposta, e quanto sono riuscito a trovare di Shelter e di Storia dei minuti. Mi dispiace di non essere riuscito a completare il quadro (prima o poi accadrà), ma l’impressione che ho intanto ricevuto è quella di una produzione sufficientemente coerente nel suo sviluppo da lasciarmi pensare che l’idea che mi sono fatto della poesia di Giovenale continuerebbe a valere sino in fondo.
I componimenti di Giovenale non esibiscono in sé nulla di asemantic o di googlism; si fatica persino a riconoscere in loro le tracce del passaggio, in Italia, di una Neo-avanguardia, se non, tangenzialmente, del più atipico tra i Novissimi, Antonio Porta. Sono liriche sentimentali, nel senso migliore della parola, quello che non ha a che fare con il sentimentalismo; poesie da cui emergono cioè emozioni profonde, trattenute, difficili da esprimere proprio per la loro intensità.
In verità, l’accostamento a Porta potrebbe derivare anche dal comune utilizzo di un dispositivo ricorrente, quello del correlativo oggettivo di eliotiana memoria; pure se, nel leggere questi versi, io ci vedevo in trasparenza assai più Montale che Eliot.
Il Montale che continua a risuonarmi nelle orecchie, leggendo Giovenale, è quello dei Mottetti, quello del suo particolare ed oggettuale ermetismo; ma anche, in particolare ne La casa esposta, probabilmente per la vicinanza tematica, quello specifico di Notizie dall’Amiata, con la sua casa isolata e antica e le sue presenze sulfuree. A uno sguardo più attento, questa vicinanza si concretizza in una certa ricorrenza di termini montaliani, o di scelte lessicali ricercate (alla maniera di Montale) nei punti cruciali – ma soprattutto nella sonorità del verso, libero ma continuamente riassestato nella figura dell’endecasillabo, o in altre misure musicali classiche.
Non c’è solo Montale, perché Giovenale, evidentemente, non è Montale. Si tratta di echi, così come echeggia nei suoi versi un certo uso dell’allitterazione molto inglese, e persino della paronomasia, che magari gli arrivano dalla Rosselli, che l’inglese ce l’aveva (letteralmente) nel sangue.
Ora, il riconoscere la natura di questi echi non spiega, in sé, la qualità delle poesie di Giovenale. Però mi spiega almeno in parte come mai, essendo cresciuto sui medesimi poeti, a pelle io mi ritrovi, per così dire, intonato con questi versi, e come mai possano risuonare al mio interno con tanta forza.
È solo su questa rispondenza di base, su questa sapienza di ritmi di immagini e suoni verbali con la quale la mia competenza e la mia passione entra in sintonia, che può venirmi voglia di scoprire lo specifico del discorso del poeta; nel quale poi, qui, nuovamente mi ritrovo, proprio per l’accostamento continuo, che vi incontro, dell’intensità emotiva con la reticenza, per quel suo dire che non può essere detto sino in fondo perché dire sino in fondo equivarrebbe a banalizzare, a ridurre l’indicibile al detto.
È dalla critica, semmai, che ci aspettiamo una simile riduzione; la critica deve fare il possibile per dire, spiegando, anche quello che non sembra possibile dire. La poesia, al contrario, non deve dire: deve piuttosto farci entrare, attraverso le sue parole (fatte di suono non meno che di senso), in un piccolo mondo, e poi lasciarci lì, di fronte alle sue cose, ai suoi andamenti, ai suoi limiti, dolori, piaceri, incomprensibilità. La qualità dell’esperienza che facciamo in questo mondo è la qualità del componimento poetico, al di là (e spesso persino indipendentemente) da quello che il suo autore vuole dire.
Quando agisco come critico, il mio compito non è dunque quello di tirar fuori il voler dire. Spesso le cose che la poesia vuole dire sono del tutto banali: e sto parlando anche della buona poesia. Come critico, io devo cercare di capire piuttosto, e poi di dire, come sia costruito quel piccolo mondo; come io ci venga fatto entrare, e perché mi colpisca. Non credo che quello che ho detto renda sufficiente merito alle poesie di Giovenale. Gli elementi che ho elencato sono indubbiamente presenti e indubbiamente hanno un ruolo importante – almeno per quel lettore che sono io e per chi mi può somigliare. Ma sono acutamente consapevole che non esauriscono affatto, nemmeno per me, il meccanismo del mio coinvolgimento.
Per questo continuerò a cercare, qui e altrove, delle chiavi migliori del mio sentire, per coglierne il più possibile la natura. E magari, nel farlo, troverò anche la chiave per entrare nelle prose di Giovenale, se c’è.
___________________________________________
.
.
Non si libera dagli aghi, se ne veste.
Vive nell’ultima stanza – ogni volta
sta varando il vascello con lo sguardo
nella fontana fuori, dove la potrebbero
condurre ma non vuole, dai sette anni
mentali e non mentali non si strecciano
il colore cenere – la testa, gli occhi.
Non possono trovarla assiderata.
Piuttosto a contare sul balcone, che sarebbe
il margine alfa della storia, da dove
la contesta e può ascoltarla; due
fibbie alle scarpe slacciate, rientra
sempre e cammina sempre scalza contro
la parete. Lì sta bene. Lì – dice alla fine
della casa – mi riconoscete.
Chi manca è più nitido,
si prende la ragione
___________________________da Shelter, Donzelli, 2010
.
.
L’ultima colonna in fondo
nel quadro – svela: una piccola
riga di donna che (spórta
nel bordo buio una elle di fiaccola)
illumina l’uscita per lo sguardo.
È la Contemplazione, che si nega,
dice la guida dotta, che è identica
a chi vede, perché passa – ma diversa
perché è persuasa e spiega.
Rimasta indietro, sua figlia non si è persa.
È albina e condannata a ridere
rapida. (Chiaro, dimentica).
_________________________da Storia dei minuti, Transeuropa, 2010
22 Settembre 2011 | Tags: Alessandro Broggi, avanguardie, critica, poesia | Category: poesia | La raccolta consta di ventisei quartine regolari, costruite giuntando e armonizzando ad sensum versi stringa che sono sintagmi-stemmi (per lo più nominali) ripresi dai media di consumo, e insieme limpidi esempi di liricità esausta da luogo comune della qualità di massa.
Ne risulta un dettato di superficie semplice e falsamente seducente, che cela un’ironia critica ultrasottile.
Sto citando dal blog Slowforward, che a sua volta cita la presentazione del libro di Alessandro Broggi Coffee Table Book (Transeuropa 2009) sul sito dell’editore. Il libro non l’ho letto, e magari è bellissimo. Ma non è di quello che voglio parlare. Mi interessa la presentazione editoriale, che è un genere di messaggio pubblicitario, il cui scopo è, evidentemente, quello di risvegliare l’attenzione del potenziale lettore. Spesso, ma non sempre, la presentazione viene scritta dall’autore medesimo. In ogni caso, certamente, gli deve andar bene.
L’immagine che ricavo del libro di Broggi da questa presentazione è quella di un collage di materiali linguistici esausti, luoghi comuni della qualità di massa, montati con attenzione per costruire un discorso dall’apparenza semplice e falsamente seducente, a rivelare, quando li si legga con profonda attenzione, un’intenzione ironica. È vero che una presentazione deve essere apprezzativa, e che, per mostrare apprezzamento, il testo in oggetto deve essere implicitamente avvicinato a qualcosa di culturalmente già apprezzato (a meno che non se ne dichiari platealmente la novità – ma sarebbe un discorso poco credibile, perché non sufficientemente giustificabile nelle poche righe a disposizione). Solo che qui il riferimento è alle operazioni – anni Sessanta e Settanta – della Neoavanguardia italiana, e in particolare al citazionismo di Balestrini.
È singolare come questo tipo di operazioni, certamente nuove e importanti quando le facevano i Novissimi, non abbiano mai smesso di essere spacciate per nuove da cinquant’anni a questa parte. Oppure anche, quando non necessariamente nuove, come le uniche eticamente ammissibili a una poesia che, di questi tempi, come ci insegnarono Brecht e Adorno, non avrebbe il diritto di parlare di alberi.
Questa poesia post-neo-avanguardista ha ovviamente tutto il diritto di esistere, e di produrre i propri fiori, che per fortuna qualche volta ci sono davvero. Ma io non posso fare a meno di dichiarare la mia stanchezza per un’estetica del negativo di adorniana memoria, come se la nostra vita non fosse fatta d’altro che di formule pubblicitarie e ritornelli di bassa lega, e come se il nostro compito come poeti o lettori non potesse essere altro che quello di farne (lukácsianamente) la critica. È falso, del tutto falso, che al di fuori di questa linea ci siano soltanto il banale e l’inautentico. Se troviamo bella una poesia (o qualsiasi altro prodotto culturale), a qualunque scuola appartenga e comunque sia costruita, è anche perché riconosciamo già il suo sottrarsi – in qualche modo e almeno in parte – proprio al banale e all’inautentico.
D’altra parte non basta davvero dichiarare di farlo per farlo veramente. Se leggete tra le righe della presentazione del libro di Broggi, quello che si vuol dire è proprio questo: questo libro si sottrae al banale e all’inautentico mettendoli in mostra attraverso l’ironia. Non è così facile in verità, e mi auguro che il libro di Broggi ci riesca davvero. In questi cinquant’anni il banale e l’inautentico hanno invaso e colonizzato anche il campo che fu delle avanguardie.
Riconoscere questo non autorizza a condannare automaticamente qualsiasi produzione che si rifaccia a quel campo, ma autorizza a diffidarne, e ad utilizzare nei suoi confronti la stessa prudenza con cui approcciamo ogni ennesima banalissima Vispa Teresa – salvo poi essere anche sempre pronti, ove sia il caso una volta entrati nel testo, ad abbandonarla. Per questo motivo questa presentazione, almeno nei miei confronti, non fa il suo mestiere, e suscita molto più la mia diffidenza che il mio interesse – cercando magari di farmi credere che esiste ancora un’egemonia che, persino nella nicchia in cui davvero c’è stata, si è esaurita ormai da tempo.
Due libri sui fumetti
Il Sole 24 Ore, 12 novembre 1995
Scrivere sui fumetti non è facile come si potrebbe credere. Quando si producono analisi sociologiche o semiotiche attente e puntuali, si corre sempre il rischio di “mancare” il proprio pubblico, o di parlare a una platea che capisce solo metà del proprio discorso. Il problema è che il fumetto è ancora così poco letto e così poco conosciuto – al di là di pochi fenomeni eclatanti, spesso assai poco rappresentativi dello stato complessivo delle cose – che il pubblico che potrebbe apprezzare le analisi conosce troppo superficialmente il loro oggetto, mentre chi lo conosce bene spesso non comprende appieno l’importanza di queste indagini.
D’altro canto, è solo producendo studi sul fumetto che questo problema culturale può essere superato, educando alla riflessione il pubblico del fumetto ed educando al fumetto il pubblico colto dei libri di riflessione massmediologica. L’uscita, quest’anno, di ben due volumi di questo genere deve essere perciò salutata come un evento importante – e, comunque, di buon auspicio.
Fumetti. Guida ai comics nel sistema dei media, di Sergio Brancato, si presenta come un’introduzione al fumetto, con un occhio particolare per la contemporaneità, ma senza trascurare la storia e l’evoluzione del mezzo. Non si tratta comunque di una storia del fumetto come ne sono uscite tante. L’interesse di Brancato non è per la completezza storica a trecentosessanta gradi e nemmeno per la divulgazione. Le varie storie di altrettanti settori del fumetto – dal fumetto popolare italiano all’avanguardia, dal nuovo fumetto americano al macchinismo dei manga giapponesi – hanno per centro non tanto il fumetto in sé quanto il suo ruolo nel contesto globale delle comunicazioni di massa. Il fumetto si trova dunque accostato al cinema, alla pubblicità e alle arti visive, in un’esplorazione attenta delle reciproche interrelazioni. Come in ogni operazione storiografica originale non è tanto la novità delle informazioni che importa (anche se molti lettori vi troveranno pure questo) quanto il tipo di relazioni che viene delineato tra gli eventi, che ci permettono di vedere l’evoluzione di diversi settori del fumetto con occhi nuovi, e di comprendere molte cose a cui non avevamo posto sufficiente attenzione, o che ci erano rimaste oscure.
Diversa è invece l’operazione di Gino Frezza ne La macchina del mito tra cinema e fumetto, nel quale la dissezione cui il fumetto viene sottoposto è marcatamente trasversale e centrata su un tema, quello del mito del doppio. Attraverso il percorso dello sdoppiamento, della doppia identità e della metamorfosi, l’universo mitologico del fumetto rivela una coerenza tematica di fondo, intrecciandosi continuamente con letteratura e cinema.
Personaggio prototipico di questo intreccio e di questi temi è Tarzan, nobiluomo britannico e signore delle scimmie al tempo stesso, cultura e natura coniugate, eroe di romanzi scritti non solo del suo autore originario, di film antichi e recenti, di un’ininterrotta serie di fumetti, storicamente la prima in assoluto, tra l’altro, del genere avventuroso. Il tema dello sdoppiamento è dominante nei fumetti degli anni Trenta, come quello della doppia identità dominerà gli anni dai Quaranta ai Sessanta, a partire dal prototipo Superman/Clark Kent, fino ad arrivare (ma senza che si sostituiscano agli altri) agli eroi della metamorfosi, quei mutanti che, nati nei Sessanta, trionferanno poi nei decenni successivi.
I due testi, pur nella loro diversità ed evidente autonomia, si rimandano implicitamente l’un l’altro, parlando degli stessi oggetti da due prospettive complementari. Il mito di cui parla Frezza si inquadra evidentemente nella prospettiva massmediologica e più interessata ad analizzare le forme della comunicazione espressa da Brancato, apparendone a sua volta come un potenziale sviluppo. Alla narrazione a fumetti, una volta tanto, si trova restituita la sua complessità di rimandi culturali, e la sua dignità di strumento di espressione a tanti livelli.
Sergio Brancato, Fumetti. Guida ai comics nel sistema dei media, Roma, Datanews. 148 pp. £. 20.000
Gino Frezza, La macchina del mito tra film e fumetti, Firenze, La Nuova Italia. 250 pp. £. 24.000
4 Agosto 2011 | Tags: critica, fumetto | Category: fumetto |  Will Eisner, Il Complotto Diverse cose mi riportano in questi giorni al bel libro di Will Eisner, tra gli ultimi da lui realizzati. Non ultima il fatto di ritrovarmelo citato in nota a un interessante libro che ho la ventura di tradurre per Bompiani, che con i fumetti non c’entra nulla: il titolo italiano sarà (probabilmente) Razza e destino, di Maurice Olender, e il tema è la storia (o le storie) dell’idea di “razza”, ovvero come sia nata e come si sia diffusa negli ultimi due secoli l’idea che esistono delle “razze” umane, diverse per natura, e per natura legate al proprio specifico destino (di dominatori o di dominati, per esempio). L’idea di “razza” è servita per giustificare moralmente il colonialismo, e lo sterminio degli Ebrei e degli Zingari.
C’è un capitolo, in questo libro, dove si parla, appunto, della storia di questo falso: I Protocolli dei Savi di Sion, che, come ci racconta anche Eisner, viene confezionato presumibilmente a Parigi verso la fine dell’Ottocento dalla polizia segreta russa, scopiazzando un libello antibonapartista di qualche anno prima. L’aspetto più affascinante delle cose che racconta Olender è il modo in cui la pubblicistica razzista di quegli anni difende l’opera e soprattutto risponde alle documentate critiche di chi ne dimostrava la falsità. Vi si trovano dei veri gioielli di paralogismo, ovvero di ragionamento fallace, in cui tipicamente la verità delle premesse è fondata implicitamente sulla verità della conclusione, che viene comunque data per scontata; oppure in cui vengono date per buone delle premesse che sono tutte da dimostrare. Ecco un esempio, tratto dal libro, di un argomento di Hermann de Vries de Heekelingen (un ex professore di paleografia dell’Università Cattolica di Nimega divenuto uno dei pilastri del pensiero del fascismo e del nazismo) pubblicato nel 1938 in un pamphlet intitolato Les Protocoles des Sages de Sion constituent-ils un faux? (I Protocolli dei Savi di Sion sono un falso?):
nel corso delle epoche s’incontra dappertutto questa forza organizzata dell’Anti-Chiesa […]. In seguito questa forza occulta parla del libero esame […], essa si identifica con il marxismo, con il bolscevismo. […] Potete credere che questa lotta che dura da duemila anni […] sia opera di individui isolati? Non è forse più logico credere a un’organizzazione segreta!!! La Storia ci dimostra l’esistenza di un’organizzazione segreta che scompare ogni volta che si crede di tenerla […][e] a ogni rivelazione, gli interessati hanno un’unica risposta: è un falso, è menzogna, è invenzione…
Nel 1938, le premesse su cui il discorso di de Vries si basa erano false e indimostrabili né più né meno di oggi: che sia sempre esistita la forza occulta dell’Anti-Chiesa, che (anche ammesso che sia esistita) la si possa identificare col marxismo e col bolscevismo, che possa esistere una forza organizzata che dura da duemila anni. E anche ammettendo queste premesse deliranti, ne consegue davvero che ci debba essere una singola organizzazione segreta dietro? E se pur ci fosse, per quale ragione dovrebbero esserne responsabili gli Ebrei? Eppure, questi deliri, in quegli anni, avevano un seguito, perché queste paure trovavano rispondenza nei timori diffusi tra la gente, e i demagoghi come de Vries sapevano bene a chi stavano parlando.
Olender parla a più riprese di complottite, una sorta di malattia socialmente diffusa, che vede complotti dappertutto, e in particolare dietro a tutti i problemi dell’epoca. Gli anni tra le due guerre sono particolarmente malati di complottite, e pseudoargomentazioni come quella di de Vries trovano terreno fertile su cui crescere. Ma anche oggi non siamo affatto immuni da questa malattia, e vi sono giornali che basano la propria fortuna sulle stesse strategie retoriche di coloro che difendevano il valore dei Protocolli dei Savi di Sion.
Due esempi eclatanti sono nelle nostre edicole tutti i giorni. Basta leggere i titoli e il loro tono per rendersene conto. Libero di oggi titola, per esempio “Anche l’amico di D’Alema corteggiava la P4”: non mi interessa in questa sede la verità della notizia (e anche su questo tema la quantità di denunce ricevute da Libero potrebbe essere un interessante indizio), ma soltanto il modo in cui viene presentata. L’espressione “l’amico di d’Alema” ha non a caso una velata valenza erotica, che rimanda comunque a un nascosto rapporto preferenziale. La valenza erotica viene confermata dal verbo “corteggiare” che rimanda in questo caso a un’attività frequente e legata a un desiderio di partnership. E l’oggetto del corteggiamento è infine la P4, una loggia massonica, ovvero un complottante per eccellenza, “storicamente” riconosciuto come la Massoneria, pur se tradizionalmente associato ai poteri di destra. Ecco che si allude dunque al fatto che la P4 non sia davvero di destra, visto che il complotto riguarda così direttamente “l’amico di D’alema”.
Da parte su Il Giornale titola invece “Crisi, il Cav vede le parti sociali / E avverte: ‘Serve l’aiuto di tutti'”. Il Cav, appellato in maniera così familiare (altrettanto spesso è, infatti, Silvio) è evidentemente invece un amico, uno quasi di famiglia, che proprio grazie a questa conoscenza ravvicinata può essere da noi tranquillamente considerato al di fuori di qualsiasi complotto. Uno come Silvio, che vede le parti sociali, è certamente di un’altra pasta dall’amico di D’Alema, che corteggia la P4.
Non mi verrebbe voglia di parlare di questi squallori se non me ne trovassi davanti agli occhi uno dello stesso tipo, nel minuscolo mondo della critica del fumetto, dove gli interessi in gioco sono talmente piccoli che non si capisce nemmeno perché uno debba prendersi la briga di gettare fango inutile su altri quando ha così poco da guadagnarci. Non espliciterò di chi sto parlando: già gli faccio troppa pubblicità accennando alla sua esistenza. Credo che chi conosce quel blog piuttosto squallido che vive sulla diffusione di notizie non confermate (proprio come le voci che, storicamente, servivano per discreditare gli ebrei, creando il consenso e giustificando poi i massacri), che non pubblica le eventuali smentite e allude continuamente a chissà quali colpe, possa capire molto facilmente a chi faccio riferimento. E se non lo conoscete non perdete nulla; anzi un po’ vi invidio.
La mia opinione è che chi si occupa di fumetti dovrebbe osservare d’ora in poi il silenzio su qualunque cosa scrivano queste persone: niente commenti su di loro, niente link (neanche se siete imbufaliti perché vi stanno calunniando – in particolare in questo caso, perché è di questo che vivono). Nessuna censura: il diritto di parola è un diritto sacrosanto, che non si nega nemmeno a chi vive di calunnie. Ma il diritto a essere ascoltati è qualcosa che ciascuno di noi si conquista con l’intelligenza e l’onestà, e là dove queste qualità non hanno casa è giusto non andare, e non mandarci più nessuno.
E scusate lo sfogo, ma quando si sorpassano certe soglie non si può restare indifferenti. Qualche anticorpo l’abbiamo ancora.
Andrea Queirolo mi domanda di dire la mia sul suo sempre interessante blog a proposito della critica fumettistica, facendo seguito all’intervento di Marco Pellitteri pubblicato il 20 giugno. Posso partire proprio da lì, perché le cose che dice Marco mi sembrano…
Il post di oggi ha cambiato blog: è qui, su Conversazioni sul fumetto.
2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.
Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.
Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.
Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.
Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.
Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.
Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.
Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.
Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.
Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.
Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.
Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.
Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.
19 Gennaio 2011 | Tags: critica, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Mi guardo intorno, anzi sarebbe meglio dire mi leggo intorno. Leggo su questo schermo blog di diversi tipi, di diversi argomenti. Nei blog dove si ragiona di poesia mi colpiscono in questi giorni tre post differenti, ma che girano attorno a un tema solo, o forse (meglio) a temi diversi con una radice unificante; uno è quello di Paolo Zublena su punto critico, Esiste (ancora) la poesia in prosa?, un altro è quello di Massimiliano Manganelli su Absoluteville, La poesia contro il romanzo, e il terzo, ancora su Absoluteville, solo in apparenza di tema differente, è quello di Rosaria Lo Russo, Scrivere sotto dittatura; tutti con i relativi commenti.
Il tema unificante a cui girano attorno è che cosa sia questa roba che chiamiamo poesia, e in particolare che cosa sia rispetto a quell’altra roba che, per contrasto, si chiama prosa, ed è soprattutto, nel mondo di oggi, romanzo. Non è, io credo, una questione di vincoli maggiori o minori; semmai di quali vincoli. Un commentatore del post di Zublena (Gianluca Garrapa) suggerisce di assumere una regola arbitraria, tipo i 140 caratteri di Twitter “come fosse una regola (quasi oulipo) di versificazione e stare quindi nella ‘poesia’ in una più ampia, però, struttura narrativa_di_prosa. come se insomma ‘macroscopicamente’ fosse prosa e ‘microscopicamente’ poesia”. Mi pare una proposta che può essere magari interessante per fare degli esperimenti (tipo Oulipo, appunto), ma che con la poesia non ha niente a che spartire, in sé (anche se ci si può porre come sfida di scrivere poesia sottostando pure a un vincolo come quello).
Mi sento semmai più in sintonia con Rosaria Lo Russo, che parla di dettatura (o dittatura) del corpo ispirato. Forse la Lo Russo pone troppo l’accento sul corpo (ma lo scrive in un post, non in un trattato, e non si può sottilizzare troppo in poche righe), perché la poesia, da diversi secoli a questa parte, non è solo vocalità. Però io trovo che sostanzialmente abbia ragione, e che nella poesia sia presente una dinamica fisica, o fisiologica, di carattere principalmente vocale-sonoro, ma anche secondariamente (a mio parere) grafico-visivo, che non si può eliminare, se non uscendo dai suoi confini.
Lo dice bene Paul Valery, citato da un altro commentatore del post di Zublena (Luigi Bosco): “L’essenza della prosa è di perire, – cioè di essere «compresa», – cioè di essere dissolta, distrutta in modo irreparabile, del tutto sostituita dall’immagine o dall’impulso che essa significa secondo la convenzione del linguaggio. Infatti la prosa sottintende sempre l’universo dell’esperienza e degli atti, – universo nel quale, – o grazie al quale, – le nostre percezioni e le nostre azioni o emozioni devono alla fine corrispondersi o rispondersi in un solo modo, – uniformemente. L’universo pratico si riduce a un insieme di scopi. Ottenuto tale scopo, la parola muore”. Come dire che, nella prosa, la parola si esaurisce nella trasmissione del proprio significato, e si legge unicamente per capire: tutto il resto, compreso tutto il sentire emotivo che eventualmente ne deriva, passa completamente da lì, dalla comprensione della sequenza di parole. Viceversa, nella poesia la parola resiste alla comprensione del suo significato, e il suo suono traccia altre relazioni, che si accompagnano a quelle del significato, e non si esauriscono in quelle.
La comprensione (anche profonda) del significato di una poesia è ben lontana dall’esaurirla. Con forme differenti, la poesia condivide con la musica l’irriducibilità al senso – pur essendogli più vicina di quanto non gli sia la musica, per la sua natura ovviamente verbale. Qualche giorno fa scrivevo (qui) che “la poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni”. Potrei aggiungere, esagerando e semplificando, che il sentire personale è legato al senso, al significato, mentre quello collettivo è legato agli aspetti ritmici e sonori. Starei esagerando e semplificando perché le relazioni sono molto più complesse di così, ma non starei mancando del tutto il bersaglio.
In altri termini, potrei anche dire che la poesia è un meccanismo che mette in relazione il significato verbale con altre reti di relazioni, non necessariamente riducibili, nemmeno in ultima istanza, al significato verbale stesso. Se tale riduzione fosse possibile, una buona interpretazione di un testo poetico lo esaurirebbe (come sembra aver ipotizzato qualcuno in epoca neoavanguardista, secondo il racconto, ancora su punto critico, di Antonio Loreto).
In verità, anche Valery sta esagerando e semplificando. Persino la prosa non si esaurisce del tutto nel suo significato, anche se certo il valore sonoro (o visivo) delle parole è estremamente minore di quello della poesia. Proprio per questo è virtualmente possibile costruire della prosa che conservi i valori della poesia di non riducibilità al significato. Ma non ha tutti i torti Zublena a ritenere la poesia in prosa un’operazione che ha avuto valore storico, un valore oggi del tutto superato (i grassetti della citazione sono miei):
Questo non vuol dire ovviamente che i generi letterari dagli anni ’60 in poi si siano dissolti. Anzi. Sarebbe però ingenuo allo stato attuale considerarli qualcosa di più di dispositivi pragmatici che inquadrano un patto di lettura tra autore e lettore, o ancor meglio tra autore e lettore implicito nell’orizzonte di attesa contemporaneo. Ma questi dispositivi pragmatici sono in primo luogo sopravvivenze di istituti teorici (e normativi) del passato la cui portata si è spostata dal campo letterario (e quindi, se proprio volessimo seguire Bourdieu, da ragioni di conflitto circa il capitale culturale) a quello economico dell’industria culturale: oggi i generi si definiscono in funzione degli interessi del mercato editoriale.
In questo senso, se la nozione di poesia in prosa poteva avere un tempo – e certamente ha avuto – una funzione liberante di ibridismo rispetto a generi ancora fortemente canonizzati, oggi che i generi sono soprattutto etichette in libreria, e la poesia in primo luogo un concetto la cui ipostatizzazione ideologica inverte – appunto ideologicamente – la marginalizzazione che la letteratura che non si vende subisce dal mercato editoriale elevandola nel migliore dei casi a luogo anodino di resistenza etico-politica, nel peggiore a squisito rifugio irresponsabile da anime belle: se insomma la poesia non ha più bisogno di libertà perché il mercato le lascia tutta l’indifferente libertà che vuole, allora questa nozione (la poesia in prosa) è oggi probabilmente inutile.
In questo predominio dell’industria editoriale, la prosa – cioè il romanzo – è diventato davvero pienamente quello che descriveva Valery, cioè qualcosa il cui linguaggio si risolve nel proprio significato: in altre parole, la trama, il plot, la struttura del raccontato. Per Massimiliano Manganelli, su Absoluteville, proprio grazie alla sua marginalità, la poesia “è diventata il terreno più fertile della scrittura letteraria, quello dove si consumano gli esperimenti, dove l’invenzione conta ancora qualcosa, contro l’infinita ripetizione del romanzo”. Alla luce delle sconsolate parole di Zublena, questa fertilità sembrerebbe tuttavia dovuta proprio a quella “indifferente libertà” lasciatale dal mercato.
Nell’un caso come nell’altro, non è però chiaro perché il mercato abbia scelto il romanzo. Non dobbiamo dimenticare che il mercato non ha affatto demonizzato, per esempio, la musica, che è l’altro polo che influisce sulla poesia. In altri termini, il mercato ha puntato da un lato su una parola narrativa che si esaurisce nel racconto, e dall’altro su una struttura ritmico-sonora che si tiene ben lontana dal senso (basti pensare alla banalità media o irrilevanza dei testi delle canzoni, quando ci sono). La poesia, dal canto suo, ha percorso i sentieri aspri delle avanguardie, e si è adornianamente tirata fuori da quella dialettica, enfatizzando l’inevitabile complessità che deriva dal mettere assieme i due campi, quando si cerca di giocare insieme all’interno e all’esterno del senso. La separazione tra mercato e poesia è stata dunque per molti versi consensuale.
Il problema, a questo punto, è concretizzare davvero la non coincidenza tra la cultura e il mercato culturale. Non possiamo lamentarci che la poesia non venda. Dovremmo lamentarci piuttosto che il vendere sia l’unico criterio di valore riconosciuto pubblicamente, e agire di conseguenza. Dovremmo perciò renderci conto che la pubblicazione a stampa non può più essere il discrimine tra poeti da considerare criticamente e poeti da ignorare. La pubblicazione è comunque qualcosa che si paga, vuoi che la paghi il mercato, l’editore o l’autore stesso. Se non crediamo nel valore del mercato dobbiamo coerentemente squalificare anche il valore della pubblicazione a stampa.
In altre parole, sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani. Naturalmente è molto più scomodo analizzare un campo così vasto, non previamente scremato dalle scelte degli editori. Ma non ci sono alternative, oggi, io credo. Se il criterio seguito da Cucchi e Giovanardi per la loro nota antologia mondadoriana (di prendere in considerazione soltanto autori pubblicati, e da editori veri) era discutibile nel 1996, e pericoloso nel 2004 (le date delle due edizioni dell’opera), credo che sarebbe semplicemente sbagliato, o falso, oggi.
P.S. Sto partecipando al Premio Turoldo.
Se volete leggere i testi (anzi il lungo testo) che ho inviato, e magari lasciare qualche commento, mi potete trovare qui: http://www.poiein.it/premi_letterari/Turoldo2010/aaa_elenco.htm.
 Taniguchi Jiro, Quartieri lontani, p.200 Questo post vuole essere la continuazione del post precedente, ma ora parlerò di fumetti. Voglio scrivere di Jiro Taniguchi e del suo ultimo libro pubblicato in Italia: Quartieri lontani (Coconino Press, 2010 – l’originale giapponese è del 1998, ma Coconino l’aveva già stampato in due parti, nel 2002 e 2003, con il titolo In una lontana città).
Due parole sul suo tema le devo spendere, per permettere un minimo di orientamento a chi ancora non lo ha letto. Un uomo di 48 anni si trova – come in una sorta di sogno incredibilmente realistico – a rivivere i propri 14 anni, ma con la consapevolezza dell’adulto. Ritornare a scuola, rivedere i propri genitori, proprio nel periodo in cui il padre è andato via, rivivere i rapporti con i compagni di scuola, il primo innamoramento…
Però niente è come prima, perché prima di tutto lui, nel corpo del quattordicenne, è un adulto gettato nel passato, che cerca di nascondere agli altri le proprie conoscenze sul loro futuro, non sempre riuscendoci del tutto.
L’idea di base forse non è originale, ma, come sempre, Taniguchi è un maestro a svilupparla e a portarla sino alle ultime conseguenze. Il risultato è così un racconto sospeso tra la sensazione del già visto e la tormentosa inquietudine del non capire come possa andare a finire: guarda casa, le stesse sensazioni del protagonista della storia!
Taniguchi ha un disegno lineare e chiaro, piuttosto statico, ma questa semplicità si rivela poi adatta a meglio trasmettere le emozioni dei volti e dei corpi, sempre molto vere. E, insieme, c’è una sapiente costruzione dell’insieme, con un gioco di accostamenti/contrapposizioni tra la costruzione ortogonale della pagina, creata dalla serie delle vignette rettangolari, e lo sviluppo delle linee delle figure in esse contenute, che sono spesso anch’esse ortogonali, ma a volte organizzate sugli assi diagonali. Questa piccola vivacità costruttiva è sufficiente a dare vita alle pagine di Taniguchi, anche nel loro insieme – mentre al tempo stesso raccontano con espressività quello che sta succedendo.
Se stessimo parlando di uno scrittore, staremmo lodando la raffinatezza del linguaggio verbale e insieme la sua capacità di usarlo efficacemente per raccontare le emozioni – due qualità diverse, e non sempre compresenti. In un disegnatore di fumetti il corrispondente è ovviamente il rapporto tra il tratto grafico e la composizione, oltre che il modo di farne uso.
La strategia di semplificazione visiva agisce, in Taniguchi, anche al livello narrativo. La storia è semplice, assai lineare: tutto gira attorno a pochissimi elementi. Ma proprio come con la linearità del disegno, la linearità del racconto finisce per mettere fortemente in luce gli elementi chiave. Pagina dopo pagina, l’assurdità di quello che capita al protagonista svanisce anche per il lettore, e la vita del quattordicenne di 48 anni procede nella sua normalità, nelle sue piccole sorprese, nei suoi grandi timori.
Ho letto le 414 pagine di Quartieri lontani tutto di un fiato. Ci vogliono un paio di ore. L’immersione che mi ha prodotto non era così dissimile – come ho già detto – da quella del suo protagonista. In più di un momento della lettura mi sono sentito vivamente emozionato.
Certo, il romanzo di Taniguchi gioca su temi profondi: la memoria, il rimpianto, il sogno di rivivere il passato. Ma proprio perché sono temi così intensi, il rischio di essere banali è estremo. La semplicità del disegno e del racconto di Taniguchi è per forza quindi soltanto apparente. Il ritmo che qui l’autore costruisce è magari quello del sogno – ma non si ha mai l’impressione di trovarsi dentro un sogno. Tutto è reale, e anche il racconto è quello di qualcosa di reale. Forse è proprio questo straniamento a portare avanti il lettore – ma nella capacità che ha Taniguchi di farci dimenticare che stiamo leggendo una storia (e una storia di Giapponesi, tanto differenti da noi!) c’è qualcosa di davvero straordinario.
Come ho detto nel post precedente, non mi interessa trovare una verità del testo, e non credo che la critica debba concentrarsi su quello. Se il messaggio di Taniguchi è efficace su di me, in questo caso è perché già lo conosco e lo condivido. Non è il messaggio la parte interessante di un testo artistico, bensì l’esperienza su cui il testo ci conduce, il percorso di scoperta o riscoperta di qualcosa, che già lo conosciamo o no. Il messaggio, in questo, farà anche la sua parte – e ci sono sicuramente testi in cui è una parte importante, e davvero impariamo qualcosa di nuovo. Ma lo impariamo solo perché il testo ci ha condotto attraverso un’esperienza coinvolgente.
P.S. Giusto un’osservazione per la Coconino. Ristampare In una lontana città è certamente una buona operazione, che ha tutta la mia approvazione. E capisco anche che la concomitanza con il film di Sam Garbarsky sia una buona occasione per un’operazione commercialmente positiva (cosa da non disprezzare per un editore di questi tempi) e insieme culturalmente utile. Ma non apprezzo il fatto che da nessuna parte del volume compaia il riferimento alla precedente edizione, con il titolo mutato: la trovo anche una piccola truffa ai danni dei lettori che già possedevano In una lontana città, e che ora acquisteranno Quartieri lontani credendo che si tratti di un lavoro nuovo.
(dopo)
questo sopra quello sotto,
e poi il geranio e il filo di ferro,
gli esterni gli interni e sfondamenti,
e poi il sale sul gambo,
il tonfo dietro, il battito dentro,
la notte nel giardino tenue,
e poi le labbra e la nebbia… e poi…
e poi altro… a perdersi, in ritorni e fughe,
finché ci saranno coordinazioni (e poi…)
per allineare nella paratassi (e poi… )
altro ancora, malvisto, poi visto fin troppo,
andremo e verremo, e poi ancora, e poi piano
più forte, più intensamente, poi meno
e ancora, in successione, trovando
un posto, anche noi, tra i fatti :
il posto dell’ostacolo,
rallentando di traverso
quasi a tenere, a prendere,
in un abbraccio,
le ombre onde, lo scatto dei denti
sugli echi (e poi ?)
Le poesie riportate in questo post sono di Andrea Inglese, tratte da L’indomestico (2005, scaricabile per intero da qui). Le riporto non solo perché mi piacciono, ma perché mi hanno suggerito una riflessione sul senso della lettura e, soprattutto, sul senso della critica – una riflessione che prende come spunto la poesia, ma che vuole avere valore più generale, per qualsiasi oggetto di carattere estetico/artistico di cui si voglia parlare.
Mi riferisco non tanto alla critica storica, non tanto a quella che tira le somme, ma piuttosto a quella che legge e propone, cercando di indurre i propri lettori a un apprezzamento (o non apprezzamento) dei testi in oggetto. Quella che deve dire (nel caso) se un testo è bello e perché. Lo può fare perché sta scrivendo una recensione, oppure perché sta cercando di spiegare (in una prospettiva più storica) le ragioni della qualità o del successo di un testo.
Ora: teniamo presente che quando riteniamo che il ruolo della critica sia quello di spiegare il testo, rendendone evidenti i contenuti nascosti, stiamo già presupponendo che il testo possa essere spiegato, e che valga la pena di farlo. Se vale la pena di farlo è perché siamo convinti che il testo abbia valore, e che questo valore stia nel suo significato (e dove altrimenti?): aiutare il lettore a cogliere meglio questo significato sarebbe dunque un compito principe della critica.
Non metto in dubbio, né qui né in generale, l’utilità di una spiegazione del significato dei testi. Certo non si tratterà mai di una spiegazione definitiva (un buon testo estetico non dà mai fondo alle sue possibili interpretazioni), tuttavia già fornire al lettore qualche chiave di lettura in più (magari per discuterla o addirittura – criticamente – rifiutarla) è certamente qualcosa di positivo.
Il punto della mia riflessione è piuttosto se la funzione della critica debba limitarsi a questo basilare “fornire una chiave in più” alla lettura, oppure se essa possa ambire anche a qualcos’altro. Cosa potrebbe essere questo “qualcos’altro”? E pure limitandosi magari alla semplice funzione di base, in che modo essa dovrebbe essere espletata?
Potrei, tanto per cominciare da una procedura molto basilare, prendere questi testi e sottoporli a parafrasi, proprio come si fa a scuola, ma temo che nel loro caso non otterrei molto. La parafrasi è utile quando la sintassi è complicata – cosa che non succede nelle poesie di Inglese. Il risultato non sarebbe molto diverso dall’originale: solo più brutto, presumibilmente.
Potrei allora prendere questi testi ed esplorarli andando a fondo nella rete interna dei significati. Se io sono davvero un critico di poesia, non trascurerò, nel farlo, le dimensioni metriche e in generale ritmiche, cercando di individuare il loro specifico contributo al senso complessivo. Analizzarò i campi semantici e le ricorrenze isotopiche, magari identificando relazioni sottili e imprevedibili tra le parti. Alla fine otterrò magari anche un’interpretazione coerente, un senso complessivo sufficientemente unitario. Se lo volessi fare su questi testi, sarei perfettamente in grado di farlo. Serve lavoro, anche parecchio, ma alla fine si ottiene un oggetto critico molto soddisfacente: una specie di sostituto del testo iniziale, certo parziale, ma molto più coerente e conchiuso. È un lavoro che, da bravo semiologo, ho compiuto tantissime volte, sia su testi poetici che su tanti altri tipi di testi (in primis i testi a fumetti, ovviamente).
Il problema che mi trovo di fronte in questo momento è che anche se un lavoro di questo genere mi insegna di solito moltissime cose sul testo che ho di fronte, nulla mi dice invece sul perché questo testo mi piace, e sul perché debba eventualmente piacere anche ad altri (cioè ai miei lettori, cui lo sto proponendo). Semmai questo lavoro è esso stesso una conseguenza e manifestazione del fatto che il testo mi piace, e può al contempo fornire una serie di stimoli tali per cui il testo potrà più facilmente piacere a qualcun altro (cioè ai miei lettori). Insomma, il mio lavoro non dice del testo “è bello” in maniera critica, spiegando il perché lo sia; ma si limita a suggerire che, se io, critico, vi ho individuato tanti aspetti interessanti è perché l’ho trovato, nel suo complesso, bello, e che lo stesso potrebbe dunque accadere a te, lettore.
Non che questo sia poco, ovviamente; ma continuiamo a trovarci al livello della descrizione del testo, e non del perché esso sia interessante.
Facendo un passo più in là, un altro strumento di cui si può fare uso sono le considerazioni di carattere storico-critico. Non la storia vera e propria – che è un altro genere, parente ma diverso dalla critica – bensì il tentativo di trovare il senso nel testo attraverso il rapporto che esso intrattiene con testi antecendenti. Per esempio, potrei argomentare che io trovo un rapporto piuttosto stretto tra le poesie di Inglese e quella di Antonio Porta, specie le sue prime e le ultime (ovvero lasciando in subordine quelle della fase più strettamente legata al gruppo ’63). Affinché un’affermazione del genere abbia davvero valore storico andrebbe sostenuta da qualche riscontro maggiormente oggettivo. Così come la pongo io, invece, non si tratta che di un’ipotesi, avente valore più dal lato del consumo (mio) che dal lato della produzione (dell’autore). Andrea Inglese, infatti, per quanto ne so, è un francesista – per cui magari, più che Porta, andrebbe chiamato in gioco qualche autore francese, che io però non conosco o non conosco abbastanza. Nonostante questo, il riferimento a Porta non è privo di senso. Esso significa, per me, che il piacere che provo leggendo i testi di Inglese è in qualche modo simile a quello che provo leggendo i testi di Porta. Certo non si tratta che di uno spostamento: mi piace Inglese perché mi piace Porta; e Porta, a sua volta, perché mi piace? Tuttavia, per coloro tra i miei lettori che già conoscono e apprezzano Porta, lo spostamento risulta utile, e rappresenta un’indicazione piuttosto chiara: essi possono apprezzare questi testi perché già apprezzano quelli di Porta. Si tratta però, inevitabilmente, di un’indicazione parziale: Inglese non è Porta e (per fortuna) nemmeno lo copia. È un autore differente che porta una qualche somiglianza di famiglia.
Ma le considerazioni storico-critiche possono costituire la base anche di un diverso tipo di apprezzamento. Per esempio, se esiste una nostra scelta di campo ideologica che riteniamo debba essere sostenuta, la collocazione del nostro testo all’interno di quel campo potrà costituire una ragione sufficiente per apprezzarlo. Nel nostro caso, per esempio, se fossimo sostenitori di una certa posizione avanguardista o delle sue conseguenze, avvicinare Inglese a Porta potrebbe essere una mossa per valorizzarlo come prosecutore di una determinata tradizione che riteniamo apprezzabile in sé. Agire in questo modo, insomma, sarebbe un po’ come dire che Inglese è dei nostri, e va apprezzato e sostenuto anche solo per questo. Più che critica, questa mi pare comunque attivismo politico. Più che apprezzamento estetico, la definirei militanza. Non è necessariamente un atteggiamento negativo, ma ha in sé poco a che fare con la critica, persino con il suo compito di base di aiutare la comprensione.
Nonostante qualche piccolo passo in avanti, sostanzialmente non stiamo uscendo dal dare un senso al testo, e restiamo lontani dallo spiegare perché il testo sia di valore, perché mi piaccia e dovrebbe piacere anche ai miei lettori.
Un’altra e differente soluzione mi appare più ingenua e controproducente delle precedenti: è quella che potremmo definire critica impressionista, ovvero il tentativo di rendere l’impressione che il testo produce su di me. Ma come si rende un’impressione? Be’, per esempio in versi, o attraverso una prosa letteraria… Dovrei dunque costruire un secondo testo estetico, che abbia come tema l’esperienza percettiva del primo. Il lettore che apprezzasse il mio testo dovrebbe sentirsi invitato ad apprezzare anche quello di Inglese. Naturalmente, se io fossi un grande scrittore, potrebbe anche capitarmi di produrre un testo critico assai più interessante del testo oggetto. Più frequentemente, invece, accade proprio il contrario, e la critica impressionista non invoglia affatto alla lettura. Gran parte dei commenti ai post dei blog di poesia sono di questo tipo, e lo sono perché l’autore del commento sta cercando un modo per esprimere gli elementi del proprio apprezzamento.
Perché dunque (quando non vi siano presupposti ideologici di scelta di campo a sostenerlo) è così difficile spiegare le ragioni del proprio apprezzamento estetico? Dire “mi piace” è facile. Anche dire “non mi piace” è facile, però è più semplice giustificarlo. Per esempio, non mi piacciono le cose banali, che sono quelle in cui ritrovo troppo facilmente delle strutture che già conosco: per dichiarare banale un testo, dunque, non ho che da trovargli degli antecedenti sufficientemente simili. Di conseguenza, trovandomi ora nella situazione opposta, dovrei spiegare nei termini della loro non banalità il perché questi testi mi piacciono. Tuttavia, mentre dire a che cosa qualcosa somiglia può essere facile, è molto più difficile metterne in luce la diversità – tantopiù che c’è sempre qualcosa a cui un qualsiasi testo somiglia, e questo non lo rende ipso facto banale. I testi di Inglese mi ricordano quelli di Porta, ma ne sono comunque sufficientemente lontani da non apparirmi affatto banali.
Se si resta fuori dalle scelte di campo ideologiche, l’apprezzamento estetico è qualcosa di sottile e personale. Questo non vuol dire che non sia condivisibile o trasmissibile, poiché – nella diversità individuale – siamo tutti comunque sufficientemente simili da poter avere a volte gli stessi gusti. Ma è comunque questione di sintonia. In altre parole, non riconosciamo che un testo è bello allo stesso modo in cui riconosciamo il suo significato; piuttosto, entriamo in sintonia con esso, e riconosciamo la nostra condizione di sintonia. Per questo, possiamo dare spiegazioni sul significato, ma non possiamo spiegare il bello. Al massimo possiamo aiutare gli altri ad entrare nella nostra medesima condizione di sintonia.
Mi resta dunque ancora una possibilità, proprio assumendo questa soggettività dell’esperienza del bello. Quello che posso fare è provare a descrivere l’esperienza, ovvero semplicemente testimoniare il mio vissuto, nell’ipotesi che questo vissuto possa essere, per lo meno, contagioso, e confidando nel fatto che il mio gusto non sia troppo esclusivo. Non è un’operazione facile, perché nel corso della lettura di un testo la nostra attenzione è ovviamente concentrata sul testo stesso, e non sulla nostra esperienza.
« Entra nell’ascensore, poi scendi. »
« Mi servirà davvero ? Avranno custodito
il groviglio, il segreto, la mano porgerà
la chiave, saprò dove nasce
il movente?» « Sei nella colonna
vuota, in caduta, passi i piani della memoria
finché ricorderai non ciò che vedevi
con imprecisi contorni e richiami,
ma lo spessore di tavoli e sedie,
l’impugnatura dei recipienti,
le piastrelle scalfite, i mattoni
a nudo, i sacchi di plastica in aria,
ed altre tattili inezie che sotto
le dita non hai percepito
nell’urgenza di tanto sognare. »
Che cosa posso dire, dunque, in concreto, di queste poesie di Andrea Inglese? Mi colpisce, per esempio, il ritmo con cui vengono elencati i concetti, un ritmo piuttosto stringente, ossessivo, con cui mi arrivano una serie di oggetti ed eventi che sono insieme elementi di quotidianità e correlativi di inquietudine. Non ci sono metafore in questi versi, ma solo questo stillicidio di cose, di eventi, di riflessioni, il cui ricorrere cadenzato mi costringe a comparare, ad accostare, come se io stessi percorrendo gli elementi di un racconto, il quale insieme però c’è e non c’è: non succede nulla in verità, eppure le cose appaiono cariche di storia, quasi di presagi.
Esco dalla lettura di ciascuno di questi testi con una sensazione inquieta, come se il mondo che mi circonda quotidianamente si fosse riempito di indizi, come se ciascuno degli oggetti mi stesse dicendo “attento, io ho un segreto”, ma poi il segreto non viene disvelato. Lo snocciolarsi degli oggetti del mondo nello snocciolarsi delle proposizioni e dei versi costruisce in me un ritmo di piccoli brividi.
Fra poco torneranno. Tutte quante. Le cose.
Come ai bei vecchi tempi. Nella dimora
del cuore. Ad una ad una. Col raffio,
il bastone curvo, la rete, pian piano.
Con il loro blues, il mormorio roco
di fondo, in umida mota, dal fondo
sorgeranno. E meditano, nel sommo,
una calma definitiva adunata.
Persino quando, a volte, un accenno di racconto si trova davvero, non è che poi cambi molto le cose. Mi appare quasi come un ordinamento apparente, un modo per organizzare in superficie una dinamica espositiva che rimane comunque quella dell’elenco ossessivo, quella dell’emergenza progressiva di figure inquietanti. Il racconto stesso, in fin dei conti, non è che una di queste figure, e non più importante delle altre.
Mi picerebbe scoprire, ora, come fa Inglese a produrre questa sequenza di piccoli brividi. A partire dalle mie sensazioni dovrei dunque analizzare il linguaggio, il metro, le figure, e il modo in cui tutto questo viene messo in successione. Ne otterrei, auspicabilmente, non un’interpretazione critica del testo, non cioè la mia versione della sua verità, ma semplicemente un’ipotesi sul suo funzionamento retorico, cioè sul modo in cui riesce a essere così efficace – efficace su di me, ovviamente, ma forse anche su altri lettori.
Desiderio
Le reti erano quelle alte del tennis
dietro a cui colava un’acqua
dubbia, tra argini d’erba.
Tu imparavi a ipnotizzare
le rane, io sganciavo cauto
il tuo reggiseno, e le menti buie
schiarivano, in sogno nessuno
ha fretta, potevo passarti
ogni tanto la lingua sulla schiena,
tra le scapole, mentre la festa
in giardino continuava.
Portavo bicchieri sempre doppi,
pieni di sangue, che rovesciavo
a terra, al riparo da bocche
assetate, indiscrete,
ancora non ti decidevi
a sfilarlo il vestito scollato,
ci spostavamo sui fondali
senza mai doverlo consumare
il desiderio, ed esso si eternava
davanti a noi, nitido nell’aria,
come un fiore crudo, una galassia.
La chiamiamo ancora “critica” un’operazione di questo tipo? Io sono convinto di sì. Ma bisogna capire che c’è differenza tra pensare i testi come portatori di una qualche verità, e pensarli piuttosto come meccanismi estetici, o retorici, dove anche la loro eventuale verità non è che un elemento tra gli altri per costruirne l’efficacia.
Due consideraioni conclusive:
1. il discorso è ben lontano dal potersi concludere qui, e vorrei tornarci sopra presto, magari anche parlando di oggetti diversi dalla poesia; e
2. analizzare davvero le poesie di Andrea Inglese nei termini di cui si è detto potrebbe essere davvero interessante, ma è un’operazione che richiederebbe troppo spazio per il post di un blog, persino per un blog logorroico come questo. Ci vorrebbe un articolo dedicato, e un po’ di tempo a disposizione per scriverlo. Per ora spero che il poco che sono riuscito a dire almeno aiuti ad apprezzare meglio queste belle poesie.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|






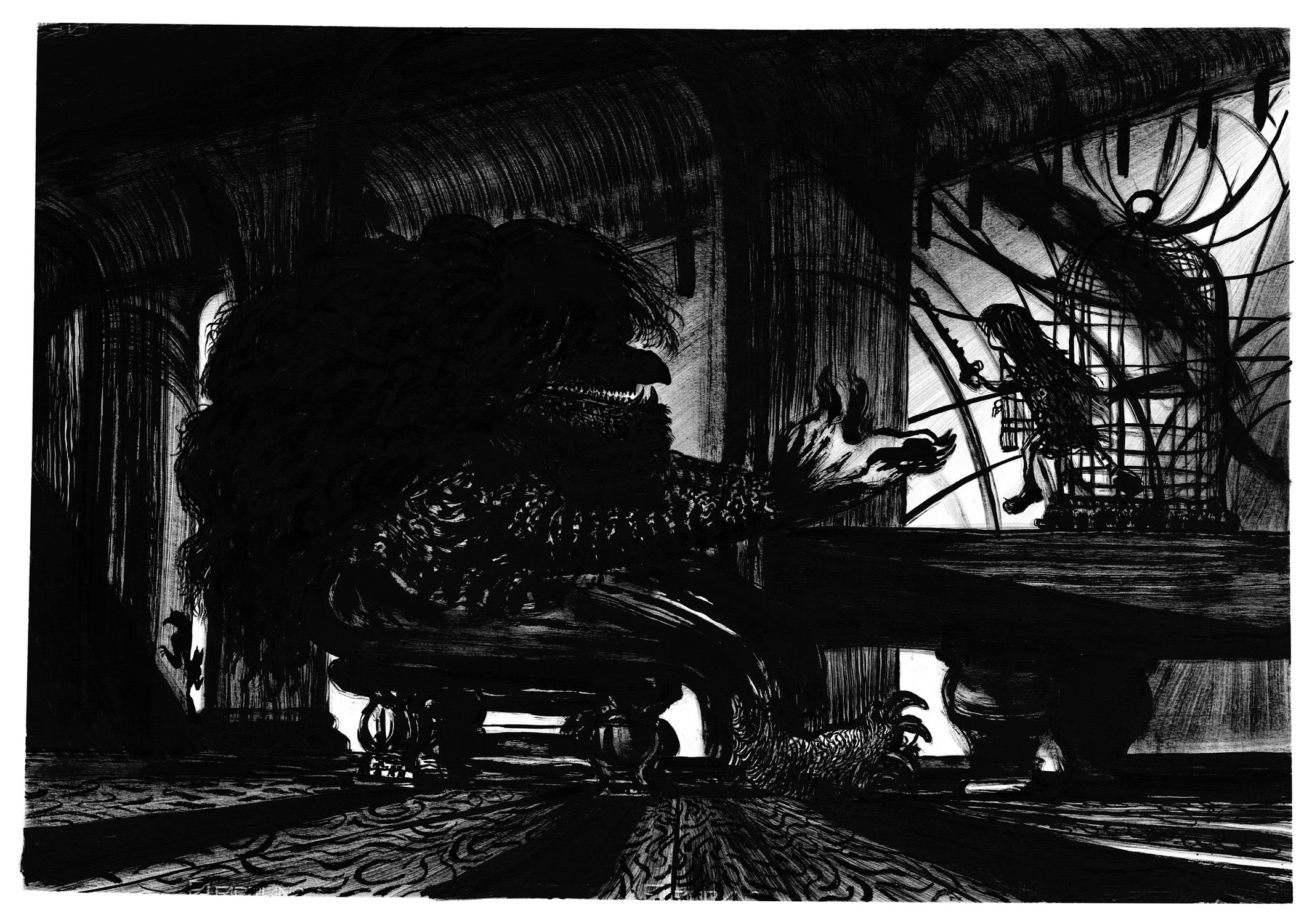



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti…
Uno spettro si aggira per il mondo della poesia; è lo spettro della Bellezza. Si tratta di una parola e di un concetto davvero irritanti…





















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco




Commenti recenti