Fantascienza, il fumetto osa di più
Il Sole 24 Ore, 25 aprile 1999
Non c’è dubbio che la fantascienza sia figlia di un’epoca che della scienza ha fatto il proprio mito. Quando il Pianeta è già tutto inesorabilmente esplorato, e ai folletti dei boschi non fa caso più nessuno – perché più nessuno ha paura del bosco – quando dei, cavalieri e principesse rimangono soltanto per farci sorridere… la nuova frontiera del mito si sposta allora più in là, e gli esploratori attraversano il cosmo, e gli spiriti maligni sono quelli che stanno nelle macchine, e la frontiera è quella del cyberspazio…
Non c’è nemmeno dubbio, d’altra parte, che esploratori, spiriti, dei, cavalieri e principesse non sono affatto scomparsi. La fantascienza, neonata o matura, li ha fatti tutti propri, ridisegnandoli con la propria penna. L’iconografia tradizionale ritorna ammantata di metallo e di silicio. Il golem e lo spirito del male che ha preso forma umana ritornano nell’automa di Metropolis. Il cavaliere che libera la principessa combatte con la spada laser contro un impero dai caratteri medievali. Gli dei sono entità mangiamondi contro cui combattono Quattro Fantastici umani…
A fumetti, la fantascienza nasce, ufficialmente, appena tre anni dopo la sua origine letteraria, sempre quella ufficiale, s’intende. Ufficiosamente, letteratura e grafica di anticipazione esistevano da oltre un secolo, e lo stesso cinema arriva sulla luna ben prima di questi fatidici 1926 e 1929. Ma è solo in questa coppia di anni che accade qualcosa che rende riconoscibile il genere: nel 1926 viene fondata la rivista Amazing Stories, che raccoglierà da allora la narrativa fantascientifica (ben presto seguita da una pletora di imitatori); tre anni dopo viene pubblicato “Buck Rogers in the Year 2429”, un fumetto ispirato a un racconto di fantascienza di grande successo.
Siamo nell’ambito del pulp, è noto, quel fenomeno che vede, negli anni Venti e Trenta, la produzione di una quantità di romanzi (e poi di fumetti) di basso prezzo e generalmente di bassa qualità, tirati e venduti con numeri da capogiro. Ma anche all’interno del pulp si sono verificati fenomeni di interesse non solamente massmediologico, e la fantascienza ha occasionalmente prodotto delle opere interessanti, crescendo nei decenni successivi verso una maturità artistica che altri generi coevi non hanno mai raggiunto.
“La fantascienza” ci fa notare Daniele Brolli “è quel genere che rinnova le sue regole a ogni storia”. O meglio, prosegue poi, lo sarebbe se non fosse bloccata da un pubblico conservatore, che ama ritrovare le stesse situazioni, e fatica ad accettare i grandi sconvolgimenti. “Ma la fantascienza a fumetti è un’altra cosa, forse esattamente l’opposto”: è il disegno a mantenere alto il suo livello di credibilità, e a permetterle di osare assai più spesso.
Lo si vede bene visitando la mostra “Fantascienza. Ritorno alla terra. Il fumetto e la grafica della fantascienza come anticipatori di visioni”, aperta a Trento sino al 9 maggio, e dal cui catalogo sono tratte le osservazioni di Brolli. Settant’anni di fantascienza a fumetti sono preceduti da due secoli di approssimazioni e tentativi, occasionali o sistematici; e la mostra spazia tanto sulla storia di questo genere come sulla sua preistoria.
Si può scoprire così come, dopo la grande avventura grafica di Flash Gordon negli anni Trenta, ancora narrativamente legata agli schemi della fiaba, si possa arrivare, negli anni Cinquanta, alla nascita di un fumetto come Jeff Hawke, dell’inglese Sydney Jordan, forse la saga di fantascienza più profonda, colta e appassionante che sia mai stata prodotta. Ed è dalla rilettura di un autore delirante, e legatissimo alle problematiche sociali, come Philip Dick, che nel corso degli anni Sessanta la fantascienza a fumetti inizia a prendere una piega politicamente impegnata, e un umore complessivo assai più serio e riflessivo di quanto non avesse avuto prima.
L’epoca delle space operas è finita. I fermenti degli anni Sessanta sfociano nell’esplosione fumettistica degli anni Settanta: da un certo momento in poi la stragrande maggioranza dei fumetti interessanti, innovativi, che vengono prodotti, hanno un tema fantascientifico. Il genere si allarga, si diversifica, moltiplica le proprie diramazioni…
Il primo autore della nuova fantascienza è un francese, e si chiama Philippe Druillet. Ma la sua capacità grafica è inferiore alla sua inventività formale, e il suo destino finisce per essere quello di aprire la strada a Moebius, oggi considerato il maestro della fantascienza a fumetti. Per Moebius e Druillet la fantascienza è un pretesto per parlare della società e del mondo, ma anche per farlo in maniera visionaria e graficamente barocca. Dopo un po’ che si leggono le loro invenzioni è facile dimenticare il genere a cui appartengono. La fantascienza è più forte che mai, negli anni Settanta, ma in un certo senso è scomparsa, è diventata soltanto un modo obliquo per raccontare il presente.
E’ noto che Moebius avrebbe dovuto collaborare (e in piccola parte lo fece) alle scenografie del film di Ridley Scott Alien. Il suo posto fu preso da un disegnatore svizzero, Hans Rudolf Giger, a cui si deve l’aspetto da zoomorfismo metallizzato protoindustriale del mostro e delle sue architetture. Così come da una riflessione sul ribellismo narrativo di Moebius nasce invece il racconto di Enki Bilal, il fumettista serbo-francese che ha creato le più belle storie di fantascienza a fumetti degli ultimi vent’anni, mescolando misticismo, incubo e tecnologia.
L’idea della metropoli malata da allora non ha più abbandonato la fantascienza a fumetti. In Italia Stefano Tamburini, giocando sui disegni di Tanino Liberatore, l’ha portata ancora più lontano, rendendola sporca, volgare, violenta; rendendo, con Ranxerox, iperreale quello che prima era stilizzato e simbolico.
Questa idea nella fantascienza, così diversa e lontana da quella originaria americana, è ritornata al suo paese di origine solo negli anni Ottanta, per riformare e rilanciare il fumetto più classicamente americano, quello di supereroi. La troviamo in Ronin, di Frank Miller, nel 1983, e poi sempre più diffusa e influente. In buon accordo con l’arrivo dal Giappone di una visione della fantascienza in perfetta sintonia.
Catastrofismo, millenarismo, misticismo. Con queste caratteristiche giunge a noi oggi un genere nato sull’onda dell’ottimismo per la scienza. Una storia che intreccia varie culture si ritrova integralmente nel prodotto seriale fantascientifico più venduto in Europa, Nathan Never, delle edizioni Bonelli. Pur legato – come rimpiange il suo autore Antonio Serra – ai vincoli della struttura seriale, Nathan Never spazia su tutti i temi di cui la fantascienza si è caricata nei suoi settant’anni e due secoli di storia…
La mostra di Trento ci permette di vedere tutto questo, dalla protofantascienza alle visioni di Moebius, Giger, Bilal, alla mensilità densa di Nathan Never e di Legs Weaver, l’altro fumetto Bonelli nato da una costola del primo. Un’occasione per attraversare una fetta cruciale dell’immaginario del nostro secolo, occasione che si ripresenterà, dopo Trento, anche a Torino, dove la mostra sarà visibile dal 21 maggio al 27 giugno.
Il catalogo, assai ricco, a cura di Roberto Festi, contiene interventi di Daniele Brolli, Gianni Canova, Alfredo Castelli, Stefano Della Casa, Gianfranco De Turris, Sergio Pignatone, Maurizio Scudiero e Antonio Serra.
Fantascienza. Ritorno alla terra.
Il fumetto e la grafica della fantascienza come anticipatori di visioni.
Trento. Spazio Foyer del Centro Servizi Culturali S.Chiara (tel. 0461/884286)
31 marzo – 9 maggio 1999.
Eisner, storie di uomini invisibili
Il Sole 24 Ore, 7 marzo 1999
Ha 82 anni, ed è una leggenda da quasi sessanta. Quando, all’inizio degli anni Quaranta, Will Eisner creò The Spirit, creò un prodotto di grande successo e prorompente innovatività. Aspetti avventurosi e aspetti umoristici si sposavano con arguzia, ma quello che colpiva era la finezza della descrizione psicologica dei personaggi, insieme alla magistrale invenzione grafica. The Spirit non ha mai smesso di fare scuola, da allora; e il mondo del fumetto continua a riscoprirlo, generazione dopo generazione.
Fu Eisner invece a smettere di fare fumetti, negli anni Cinquanta, per tanto tempo che sembrava una scelta definitiva. Solo negli anni Ottanta, infatti, la sua vena creativa ritornò a scorrere. Incontrato di persona durante una sua visita in Italia nell’autunno scorso, durante la quale ha partecipato a una serie di dibattiti con il pubblico, Will Eisner dimostrava nello spirito e nell’arguzia la metà dei suoi anni.
Questa seconda fase della produzione di Eisner consiste (oltre che di un fondamentale manuale, tradotto in italiano con il titolo di Fumetto e arte sequenziale) di storie di vita, che hanno per protagonisti persone comuni. E come ogni persona comune, anche queste quando sono viste da vicino rivelano un intero universo di motivi di interesse.
Gente invisibile, realizzato nel 1992, e pubblicato in italiano negli ultimi mesi, raccoglie tre storie di persone che non si vedono, celate dalla loro normalità e dalla loro solitudine nella grande città. Ciascuno di loro fallisce l’occasione per essere un po’ meno invisibile, non per nequizia o sfortuna, ma perché, ci sembra dire Eisner, nella grande città l’invisibilità è la condizione normale.
Pincus, che fin da bambino aveva sempre cercato di nascondersi, trova il proprio annuncio mortuario sul giornale. Un errore, certo, ma la catena di conseguenze è devastante per lui.
Morris è un guaritore, con un potere sanatorio vero. Ma l’unica strada che le circostanze gli permettono di seguire, suo malgrado, è quella del ciarlatano.
E il bibliotecario Herman, che nonostante la mezza età vive con la madre, si ritrova innamorato e costretto a scegliere tra due situazioni, adesso, entrambe frustranti.
Se cercate eroi, nei fumetti, questo non è certamente il libro per voi. Ma se cercate uno specchio di voi stessi (che è ciò che la letteratura sa costruire meglio di tutto – indipendentemente dal linguaggio con cui viene realizzata), queste storie, raccontate con la vena di ironia che ci permette di guardare ad occhi bene aperti anche i drammi più neri, sono un sincero e attento campione.
Will Eisner
Gente invisibile
Editrice PuntoZero, Bologna, 1998
pp. 120, £.18.000
I tre Adolf di Tezuka
Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 1999
In Italia, il fumetto giapponese gode di cattiva fama, perlomeno nell’opinione comune. L’immaginazione evoca facilmente frotte di ragazzini fanatici per cartoni animati e pubblicazioni dalla qualità discutibile. Ma in Giappone si producono più fumetti forse che nel resto del mondo, e anche se è probabilmente vero che la qualità della gran parte del fumetto giapponese corrisponde all’opinione diffusa, esistono anche le manifestazioni di una letteratura per immagini di grande valore.
Osamu Tezuka, scomparso a sessant’anni nel 1989, è considerato il padre del moderno fumetto giapponese. La storia dei tre Adolf, realizzata nel 1983, è un racconto sull’intolleranza, sulla guerra e su come lo stato può schiacciare l’individuo. E’ la storia intrecciata di alcune persone: un giornalista giapponese, a cui i nazisti hanno ucciso il fratello in Germania, un bambino ebreo che vive in Giappone, di nome Adolf, un altro bambino di padre tedesco e madre giapponese, anche lui di nome Adolf, e infine Adolf Hitler. Un Hitler visto singolarmente da vicino, che finirà per impazzire per il timore che vengano rivelati i documenti intorno a cui gira tutta la storia, e che potrebbero provare una sua ascendenza ebraica.
Per un lettore occidentale poco avvezzo al modo di raccontare giapponese, certi modi di rendere le scene potranno sembrare strani, o poco seri, come la frequente consuetudine di situare situazioni comiche nel bel mezzo di una scena drammatica. Ma a lungo andare anche queste che a noi possono apparire come disparità finiscono per essere assorbite dall’intensità della storia. Il giornalista rischierà più volte di essere ammazzato, per proteggere i documenti; il padre dell’Adolf ebreo, partito per la Lituania per salvare dei correligionari, sarà imprigionato dai nazisti; mentre al secondo Adolf toccherà il destino più infame, diventando egli stesso – dopo aver rinnegato i buoni propositi della sua infanzia – un ufficiale delle SS e uno sterminatore.
Non è una lettura breve. Nella migliore tradizione del fumetto giapponese La storia dei tre Adolf si avvicina alle 1500 pagine complessive, divise in cinque volumi. Per chi lamenta che la lettura di una storia a fumetti duri sempre troppo poco, è il testo ideale.
Osamu Tezuka
La storia dei tre Adolf
Hazard Edizioni, Milano
Voll. 1-5, ogni volume 270 pagg. £. 20.000
Il Ridley Scott della biacca e del pastello
Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 1998
Se Enki Bilal ci aveva abituato, in passato, a trame complesse e fantasiose, messe in scena con un disegno che del realismo ha solo l’apparenza – un po’ alla Toulouse-Lautrec – con Il sonno del mostro ci troviamo improvvisamente un passo ancora più in là nelle medesime direzioni. Nella New York del 2026, l’informatico Nike Hatzfeld riesce a mettere a punto una tecnica per ricordare i suoi primissimi giorni di vita, trentatré anni prima, a Sarajevo, quando giaceva, da subito orfano, in un lettino di un ospedale semidistrutto, a fianco di altri due neonati nelle sue stesse condizioni. Nike ricorda il diciottesimo giorno di vita, e andrà ancora più indietro; ma vuole soprattutto ritrovare i suoi due confratelli, che la vita ha destinato a storie del tutto diverse. La storia di Nike si incrocia con quella di una setta integralista plurireligiosa, che ha acquisito un enorme potere e intende acquisirne ancora di più, soggiogando i corpi e le menti.
Si potrebbe definire una storia degna del Blade Runner di Ridley Scott, se non fosse Scott ad essere profondamente in debito col Bilal di qualche anno fa, e non viceversa. Ma qui, oltre alla storia coinvolgente, a dispetto o forse proprio grazie alla sua stranezza, c’è il disegno di Bilal a fare la parte del leone. Un disegno pienamente e sontuosamente narrativo, ricco di linee e di colori per definire una realtà incerta e sfuggente, continuamente debordante nell’allucinazione. Un disegno di matite e pastelli e biacca e carboncino e pennello per costruire una storia visiva dal ritmo al tempo stesso lento e incalzante.
Un po’ un peccato che l’edizione italiana di questo ennesimo capolavoro del grande parigino slavo Enki Bilal lasci un po’ a desiderare quanto a traduzione e lettering. Piccoli difetti che si dimenticano volentieri – anche se non proprio del tutto.
Enki Bilal
Il sonno del mostro
Alessandro Editore, Bologna 1998
pp. 70, £. 32.000
La letteratura a strisce
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 1998
Stagione di festival, nel mondo del fumetto. In attesa del salone di Lucca, che aprirà il prossimo mese, Napoli ha avuto il suo primo Comicon, Salone Internazionale del Fumetto, con una bella mostra dedicata a Lorenzo Mattotti; e a Padova si è svolta la seconda edizione di Padova Fumetto, che prosegue la tradizione ormai più che ventennale di Treviso Comics, con lo stesso staff e la medesima impostazione. L’edizione di quest’anno (4-25 ottobre) è dedicata al rapporto tra fumetto e letteratura, col titolo “Letteraria”.
Cinque belle mostre illustrano vari aspetti di questo rapporto controverso, dai 30 anni di fumetti del Messaggero dei Ragazzi, alle versioni a fumetti del capolavoro di Melville, Moby Dick, tra le quali spicca quella recente di Will Eisner. E poi le Grandi Parodie dei fumetti Disney, che in cinquant’anni hanno rivisitato in chiave paperinesca tutti i classici delle letterature europee. La mostra Romanzi a fumetti ripropone sette disegnatori di oggi che alla letteratura si ispirano più per lo spirito che per l’argomento dei loro lavori (Davide Fabbri, Gabriella Giandelli, Vittorio Giardino, Lorenzo Mattotti, José Muñoz, Filippo Scòzzari, Sergio Toppi); infine, la mostra più vasta e fascinosa ci ripropone le tavole di Dino Battaglia, che della traduzione a fumetti dei classici della letteratura aveva fatto un’arte da autentico virtuoso, con risultati di altissimo valore espressivo.
A fianco delle mostre, gli incontri e i dibattiti con autori e critici. I primi hanno raccontato il proprio rapporto con romanzi e racconti, i secondi hanno cercato di valutare da diversi punti di vista che cosa lega e che cosa separa il fumetto e la letteratura. Insieme con chi scrive, Ivano Paccagnella e Alberto Abruzzese hanno discusso di bassa e alta cultura, di rapporto tra parola e immagine narrativa, di funzione culturale della letteratura a fumetti.
Come ogni anno, sono stati premiati due volumi. Per il fumetto umoristico il premio Signor Bonaventura è andato a Leonardo Ortolani, con il suo Rat-Man, assegnato oltre che per la qualità del lavoro, anche per la tenacia con cui l’autore si è autopubblicato e autopromosso. Per il fumetto “serio” il premio è andato a José Muñoz e Jerome Charin, con il loro Il morso del serpente.
Così morde il serpente
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 1998
A raccontarla, la trama può sembrare una delle tante storie poliziesche: una donna poliziotto a New York cerca il fratello scomparso, perché coinvolto nel traffico di droga. Per liberarlo arriva sino in Cile.
Ma quando si inizia a leggere Il morso del serpente, i disegni di José Muñoz iniziano dalla primissima vignetta a tagliar fuori i luoghi comuni, impostando un ritmo narrativo secco, fatto di brevissimi flash e improvvise pause meditative. Poi, nel giro di poche pagine, anche la sceneggiatura di Jerome Charyn incomincia a catturare il lettore, e sulle mille situazioni già note di una trama di questo genere si innestano personaggi inconsueti, piccole imprevedibili variazioni sul tema – così che persino una conclusione scontata per questo genere di storia finisce per assumere un sapore che di scontato non ha proprio nulla.
Con tutti i meriti dello scrittore Charyn (non nuovo, peraltro alla sceneggiatura del fumetto), la felicità di questo racconto è però in larga misura dovuta alla china di Muñoz. Non si tratta solo della qualità del segno grafico, personale e inimitabile, ma anche della capacità di tagliare il tempo in una maniera che evoca il cinema senza imitarlo affatto. Muñoz sfrutta, del fumetto, persino la sua assenza di sonoro: le grida e i colpi di aria da fuoco, per esempio, vengono mostrati senza alcun effetto di rumore, appaiono distanti anche se sono vicini, e il loro tempo si dilata proprio nel momento in cui l’azione concitata farebbe aspettare un’accelerazione.
Il ribaltamento temporale coincide con quello emotivo. Parte del fascino di questa storia sta proprio nel fatto che le emozioni che i personaggi esprimono sono assai diverse da quelle che il genere lascerebbe ipotizzare, e la stessa protagonista si trova a combattere una battaglia che non appare affatto così come essa stessa si aspettava che fosse.
Tutto è diverso, insomma, da quello che appare. Miss America del Nord non è una ragazzina con patetiche mire hollywoodiane, ma un sergente di polizia, che torna a casa da solo dopo la premiazione. La violenza, quando c’è, non è una serie di barocche evoluzioni, ma un attimo secco, un lampo di luce o di ombra. La salvezza appare un atto dovuto, o una condanna, o un evento del tutto inutile e scontato, o una concessione…
Era da tempo che ci si aspettava un nuovo volume di Muñoz, dopo che da qualche anno uscivano solo ristampe, per quanto graditissime. Con questo Morso del serpente speriamo che si inauguri una nuova stagione; e non soltanto in Francia, dove – come troppo spesso accade – le storie di Muñoz trovano generalmente un pubblico assai più attento che da noi.
Jerome Charin, José Muñoz
Il morso del serpente
Hazard Edizioni, Milano, 1998
96 pagg., £. 20.000
Sconosciuto, o quasi
Il Sole 24 Ore, 30 agosto 1998
Una carriera unica, quella di Magnus. I più lo ricordano per le sue produzioni degli anni Sessanta – Kriminal e Satanik prima, Alan Ford poi – storie che hanno segnato l’ immaginario degli italiani. Ma nell’ ambiente del fumetto hanno colpito ancora di più le sue produzioni degli anni Ottanta e Novanta, quando Magnus, abbandonata definitivamente la vocazione “popolare”, si è dedicato a costruire storie di un esotismo immaginario, caratterizzate da intrecci complessi e da un’ impressionante capacità grafica.
A cavallo tra questi due periodi, uscita originariamente tra il 1975 e il ’76, sta la prima serie de Lo Sconosciuto, pubblicato allora in albetti mensili dallo stesso editore che pubblicava anche le storie erotiche di Magnus. La veste era dunque decisamente “popolare”, ma il contenuto, pur restando ancora di facile leggibilità per tutti, mostrava piuttosto chiaramente gli aspetti della svolta che stava per prendere la produzione dell’ autore.
Storie intricate, intricatissime, in cui interessi diversi ordiscono trame che si intrecciano, spesso condotte dal caso, e all’interno delle quali il protagonista, lo Sconosciuto, si muove come un sopravvissuto, ex mercenario con l’animo pieno di amarezza. Le situazioni di quelle cinque storie mostrano altrettante assurdità politiche dell’epoca: traffico d’armi in Marocco, eversione neofascista a Roma, deliri di reduci della Seconda guerra mondiale, guerriglia in America latina, e le vacanze del “Cummenda” milanese in una Beirut già sconvolta da una guerra selvaggia.
Numerose sono state da allora le ristampe di questa prima serie de Lo sconosciuto (cui fecero seguito, negli anni Ottanta, altri episodi su riviste “d’ autore” di grande formato), ma la caratteristica peculiare di quest’ultima, oltre a raggruppare i sei fascicoli originari in un solo volume, è che l’editore è Einaudi, il quale, per la prima volta fa apparire una storia a fumetti nella serie dei suoi Tascabili.
Magnus, “Lo Sconosciuto”, Einaudi, Torino 1998, pagg. 670, L. 28.000.
Dick Fulmine
Il Sole 24 Ore, inedito 1998
Singolare e interessante appare che la casa editrice Federico Motta dedichi a un personaggio dei fumetti il volume che celebra il centenario della nascita del suo fondatore. Ma la ragione è presto evidente, poiché Dick Fulmine ha accompagnato a lungo la vita di Federico Motta, che ne è stato prima lo stampatore, e poi, dopo la guerra, anche l’editore, iniziando proprio in questa occasione tale attività.
Dick Fulmine è stato uno dei primi personaggi italiani avventurosi originali, nato quando il regime fascista, nel 1938, vietò la pubblicazione dei prodotti americani, mentre il pubblico continuava a richiedere storie di quel tipo. Nel volume Dick Fumine. L’avventura e le avventure di un eroe italiano si racconta con precisione e dovizia di particolari quale fosse il clima della cultura popolare di quegli anni.
Il primo dei quattro saggi che ci raccontano la storia del personaggio, a firma di Giulio Cesare Cuccolini, descrive quale fosse negli anni Trenta l’immagine dell’America nei lettori italiani di fumetti, e di quanto sia stato determinante l’impatto della cultura americana nel formare l’immaginario giovanile. Lo stesso Dick Fulmine, nato come risposta italiana a quella (ormai vietata) cultura, ne fu evidentemente il risultato, negato nel momento stesso in cui si trovava sotto gli occhi di tutti con il suo nome e le sue attività.
Dick Fulmine nasce dunque con questa ambigua vocazione di (assai fascista) italianità. Ci raccontano Gianni Bono e Leonardo Gori (anche curatori del volume) come il gusto del pubblico dell’epoca fosse in evidente sintonia con gli eroi semplici e muscolosi. Evidentemente da noi le cose non erano così diverse da quello che accadeva in quello stesso anno negli Stati Uniti, dove Superman aveva appena iniziato ad impazzare.
Il ruolo di Fulmine nella guerra – ce lo racconta Ernesto G. Laura – è assai ambiguo: ora del tutto dimentico, ora impegnatissimo contro il nemico. E dopo l’armistizio, improvvisamente e prudentemente, il suo campo di azione si sposta al di fuori dell’Italia, dove resterà quasi regolarmente sino alla fine della sua vita di personaggio, verso la fine del decennio successivo.
L’aspetto più affascinante di questo volume celebrativo, iconograficamente molto ricco e curato, è l’immagine che esso ci fornisce della cultura popolare italiana e della sua evoluzione dagli anni Trenta ai Sessanta. Nessuno potrà mai sostenere che Dick Fulmine sia stato un personaggio di valore artistico o culturale, eppure in questa minuziosa indagine sull’Italia dei decenni centrali del nostro secolo questo personaggio rozzo, mediocremente disegnato e sceneggiato, amato dal pubblico più di tantissimi altri, spesso migliori, è il pretesto ideale per mostrarci come eravamo, perché eravamo così e come abbiamo fatto a diventare ciò che siamo.
Dick Fumine. L’avventura e le avventure di un eroe italiano
a cura di Gianni Bono e Leonardo Gori
Federico Motta Editore, Milano
pp. 240, £. 220.000
Storie di solitudine e kafkiana alienazione
Il Sole 24 Ore, 19 aprile 1998
Non è un periodo facile per il fumetto, questo. E tantomeno lo è per il fumetto italiano, ma gli difetta forse più il pubblico che i talenti, più la circolazione del denaro che quella dell’inventiva. E’ per questo che, nonostante l’atmosfera complessivamente asfittica, ci sono momenti in cui compaiono tutte assieme varie cose degne di interesse, e che davvero meriterebbero un pubblico più interessato di quello che mediamente paiono avere.
Tra queste, colpiscono le produzioni recenti di due autrici, diverse per origine e formazione, ma accomunate dalla profondità e originalità dello stile, la cui uscita in libreria dedica evidentemente il risultato del loro lavoro a un pubblico più riflessivo di quello dell’edicola. Si tratta di Gabriella Giandelli, autrice di “Hanno aspettato un po’, poi se ne sono andate”, uscito come terzo numero della rivista Mano (di cui già abbiamo avuto occasione di parlare); e di Vanna Vinci, autrice di Ombre, pubblicato da Kappa Edizioni di Bologna.
“Hanno aspettato un po’…” è, come altri racconti della Giandelli, la storia/non-storia di una solitudine. Un uomo in un momento cruciale della propria vita (ma quale momento non è cruciale? pare sottintendere l’autrice) è in preda alle proprie emozioni, causate da fatti spesso all’apparenza banali. Un racconto di sfumature, in cui gli eventi, uno dopo l’altro, sembrano essere assorbiti dall’impossibilità della vita; scatenano emozioni, desideri, rimpianti, timori, ma non spostano nulla, non risolvono situazioni che appaiono dall’inizio alla fine senza uscita.
Eppure non c’è nessuna retorica della disperazione, e nemmeno nessun “minimalista” annegare nella piattezza della vita quotidinana. Al contrario, il disegno netto e pulito della Giandelli sembra fare di ogni immagine un’incisione su legno, donando al racconto delicatezza e ansietà, insieme con un senso profondo della concretezza della vita, anche quando l’irrealtà le si mescola insensibilmente.
Più marcatamente nel segno dell’irrealtà sono le tre storie che Vanna Vinci raccoglie in Ombre. La storia d’amore tra una ragazza e un giovane rumeno dai lunghi canini, la cui immagine non è rimandata dagli specchi, è seguita dall’incubo della giovane che, assunta al lavoro in un luogo lontano da casa, vede sfaldarsi una dopo l’altra tutte le certezze sulla propria identità, e come in un film espressionista la realtà si contorce sempre più attorno a lei. Infine una strana storia di truffe e omicidi si risolve nell’amore tra i due inquieti protagonisti.
In comune con Gabriella Giandelli, Vanna Vinci ha la capacità di raccontare storie di solitudini e difficili contatti. Storie che assomigliano forse a tante altre storie che già conosciamo; ma la capacità di un narratore è proprio quella di farci godere di una storia già sentita come se fosse nuova. In questo il segno della Vinci – nonostante sia forse ancora un po’ più ingenuo di quello della Giandelli – riesce a condurci per mano attraverso le passioni dei suoi personaggi, rendendole tanto più vere quanto più è assurdo il contesto in cui vengono generate. E l’incubo di Ines Saudade, che arrivata sul posto di lavoro si ritrova con i documenti e l’identità di una certa Vera Caligari, procede con l’esattezza inarrestabile di una storia di Kafka, in cui l’alienazione procede per gradi, ma è tanto più terribile proprio per questo.
Si tratta di due autrici e due esempi che mostrano, a chi avrà l’ardire di leggerle, che esiste una letteratura a fumetti di cui molto meno si parla ed è molto meno premiata della letteratura tout court. Ma da cui proprio diversi autori di questa stessa letteratura potrebbero trarre non indifferenti lezioni di originalità e di stile.
Gabriella Giandelli
Hanno aspettato un po’, poi se ne sono andate
Mano, n. 3
Mano Edizioni, Bologna
pp. 96, £. 16.000
Vanna Vinci
Ombre
Kappa Edizioni, Bologna
pp. 174, £. 20.000
Penthotal preso con filologia
Il Sole 24 Ore, 8 marzo 1998
Un raccontare seguendo l’emergenza delle suggestioni, assemblando immagini e frammenti ispirati a narrazioni di genere, diversissimi, lontanissimi, carico di quotidianità come di fantastico, di ironia e di passione. Questo era stato Pentothal, opera prima di Andrea Pazienza, creata a frammenti (progressivamente più radi) tra il 1977 e il 1980.
Allora fu pubblicata a puntate sull’Alter Alter di Oreste del Buono, e in seguito raccolta in un volume ormai introvabile. Oggi è stata ripubblicata da Baldini & Castoldi, in occasione della mostra bolognese su Pazienza.
Il lettore ideale di Pentothal non è quello che ama le narrazioni costruite su un’idea stringente e rigorosa, che si dipanano come meccanismi senza una sbavatura dall’inizio alla fine. Com’è doveroso per una storia centrata su un personaggio che ha il nome di una droga, le straordinarie avventure di Pentothal sono un susseguirsi onirico o psichedelico di situazioni diverse, dalla quotidianità della fila in mensa dello studente fuori sede alle situazioni hard boiled, all’esplorazione di luoghi esotici e di mondi. Ma stranamente, e piacevolmente, in questo calderone di idee, di fughe oniriche e di citazioni, tutto si tiene, e la strabordante incoerenza narrativa viene trasformata – dal disegno e dalle modalità di transizione tra situazioni diverse – in un viaggio affettivo e culturale incredibilmente accattivante.
Insomma, se si dovesse dire in poche parole di che cosa parla l’opera prima di Pazienza, si dovrebbe rispondere con un ambiguo e insoddisfacente “di tutto”, ma appena dalla considerazione dell’insieme si passa a quella delle parti e del loro succedersi, questo “tutto” si sfalda in una miriade di invenzioni, di richiami, di ironie, di raffinatezze grafiche, di provocazioni piccole e grandi… L’ironia e l’emozione sembrano viaggiare appaiate, in un autore capace di renderci favolosa la vita quotidiana, e sarcastica l’avventura – senza perdere una briciola del suo fascino.
La grandezza di Pazienza è stata, sin dal suo inizio, probabilmente in questa capacità grandiosamente mitopoietica, associata a uno spirito ironico e a un’attenzione vivissima al quotidiano, alla microosservazione del personale e del sociale, all’invenzione linguistica.
A questa nuova edizione di Pentothal va riconosciuto il merito di far conoscere ai lettori di oggi un’opera fondamentale (e non solo per il mondo del fumetto), associando alla storia vera e propria un’ampia sezione filologica, in cui si trovano raccolte una quantità di tavole tra prove, pagine scartate, esperimenti di colorazione, disegni collaterali o associati, schizzi e abbozzi. Nel complesso, inoltre, si potrebbe definire filologica la stessa presentazione della storia: non si tratta infatti di una ristampa delle edizioni precedenti. Le tavole originali sono state riprese una per una e riprodotte con l’attenzione a non perderne nemmeno un dettaglio, nemmeno una sfumatura.
E sta forse qui il limite, o il problema di questa edizione. Come spesso accade nel fumetto, le tavole di Pazienza sono state create dal suo autore per una riproduzione a stampa “al tratto”, la quale, legata alla nettezza del bianco e del nero, fa di solito tranquillamente giustizia di tratti di matita, campiture non omogenee, leggere sbavature, e insomma di tutto quello che, tonalmente, sta a metà tra le due tinte estreme. In questa edizione, la cura della riproduzione mette impietosamente in luce le non uniformità delle campiture, i tratti di matita preparatoria lasciati lì, i profili dei tasselli di carta appiccicati per correggere ampi errori; tutto quello insomma che l’autore non si è curato di portare a perfezione perché contava sull’imperfezione del mezzo di riproduzione per ottenere l’effetto che lui desiderava.
Insomma, l’edizione Baldini & Castoldi di Pentothal sembra dedicata più a chi sia interessato a capire come lavorava Pazienza (e scoprire tavole meravigliosamente complesse senza l’ombra di una matita preparatoria è davvero qualcosa che fa venire i brividi) che non a chi voglia onestamente leggersi un testo di altissima qualità.
Andrea Pazienza
Le straordinarie avventure di Pentothal
Milano, Baldini & Castoldi 1997
pp. 192, £. 30.000
Due paperi, una coppia esplosiva
Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 1997
Il papero dal becco lungo, dal carattere superficiale e dispettoso e dalla voce caratteristica, comparso per la prima volta in un cartone animato di Topolino nel 1934, ricevette un aspetto grafico definitivo e corrispondente all’attuale solo tre anni dopo, quando Al Taliaferro diede vita alle tavole di Donald Duck, Paperino. Nelle storie di Taliaferro Paperino era un borghese casalingo, alle prese con problemi di tutti i giorni, impestato da un certo momento in poi dall’arrivo di tre terribili nipotini.
Taliaferro portò avanti il suo personaggio per alcuni anni, caratterizzando Paperino come il più autentico uomo della strada, con tutti i suoi difetti (e anche un buon numero di pregi). Le brevi storielle rappresentavano un ambiente familiare o di piccolo vicinato; piccola satira personale e sociale.
Quando nel 1943 a Taliaferro subentrò Carl Barks, lo spirito delle storie iniziò subito a risentire della nuova mano. Le storie di Barks dei primi anni sono caratterizzate da un ritmo narrativo forsennato, in cui l’ambiente ancora e sempre più o meno casalingo viene stravolto da ridicole incomprensioni con animali, vicini, o con gli stessi nipotini. Paperino si anima di una vitalità che Taliaferro (che di qualità, come autore, ne aveva comunque avute parecchie) non era riuscito a donargli. In qualche modo Barks recupera lo spirito del cinema di animazione e del suo vitalismo paradossale, riproducendolo sulla carta con un’abilità senza precedenti.
Ma l’abito incomincia presto ad andargli stretto. Le storie dal ritmo forsennato ma con la logica elementare di botta e risposta, azione e reazione, pur nella loro estrema godibilità non sono sufficienti a Carl Barks. Grosso modo, il cambio di registro coincide con la creazione di un nuovo personaggio, Uncle Scrooge, Paperon de’ Paperoni.
L’ingresso di un riccastro nel mondo piccolo borghese di Paperino cambia per sempre la sua vita di personaggio. Il semplice confronto con la smisurata ricchezza dello zio modifica alla base il contesto di riferimento narrativo: dal 1947 in poi le storie di Barks non possono più essere semplici vicende di casa e giardino (per quanto tornino spesso ad abitare anche questi semplici luoghi). La differenza di stato sociale, il problema del guadagnarsi da vivere, la sete di ricchezza, diventano temi ricorrenti e dominanti.
Certo, trattati con leggerezza e arguzia. Ma lo zio Scrooge, che in italiano perde il riferimento al famoso avaro del Natale di Dickens, è il prototipo del capitalista, disposto a tutto pur di racimolare anche solo qualche spicciolo in più; talmente stereotipico nel suo assatanato desiderio di denaro da riuscire persino simpatico, alla lunga. Dalle primissime storie, infatti, in cui zio Paperone è un personaggio veramente avido e assai poco simpatico, piano piano Barks ne fa uscire tutto il suo spirito di avventura. Così l’avaro riccastro rivela la parte migliore della vocazione di imprenditore a tutto campo: ovvero la capacità di non tirarsi mai indietro davanti a nessuna impresa.
Presto dunque, con Paperone, le storie di Barks diventano storie di avventura, ambientate in luoghi esotici e fantasiosi, anche se con riferimenti più o meno evidenti al mondo reale. Paperino non è più il piccolo borghese che vive un’esistenza legata alla casa, ma il contraltare comico di un avventuriero fanatico, il Leporello di un don Giovanni della ricchezza. La coppia Paperino-Paperone gira per i luoghi più assurdi e dimenticati del mondo, percorrendo in parodistici rovesciamenti tutti i luoghi tipici della letteratura di avventura – senza tuttavia perdere in questi ribaltamenti umoristici il senso del meraviglioso. Anzi aggiungendo, con i limiti più ampi che si concedono allo scherzo, meraviglia alla meraviglia.
La capacità di Carl Barks è stata soprattutto quella di averci fatto gustare l’avventura senza toglierci la possibilità di riderne; la sua abilità quella di concatenare eventi che da un’apparente banalità all’altra finivano per sfociare (spesso insensibilmente) nel grandioso – e tuttavia ancora con humor. Salvo poi ripescare, alla fine delle storie, quei dettagli dall’apparenza iniziale così insignificante, ora tanto più carichi di significato, ma anche di comicità.
Barks ci ha fatto ridere dei problemi della società americana senza nessuna pesantezza. Che di questo gli si possa imputare di essere stato il suo limite – perché talvolta una simile leggerezza finisce per far dimenticare il problema che pur viene posto, a vantaggio del divertimento della storia – credo non si possa negare. Ma d’altro canto difficilmente a un personaggio nato con lo spirito di Paperino si sarebbe potuto chiedere di più: anzi in questo senso Barks ha riempito di critica sociale i suoi fumetti più della maggior parte dei suoi contemporanei, e la loro leggerezza ha permesso che venissero letti da tutti.
Così Paperino ha potuto essere l’eroe negativo di una nazione che crede fermamente negli eroi, quelli positivi, senza nessuna apologia della negatività. La sua sfortuna ha fatto ridere tutti, e probabilmente ha fatto sì che qualcuno si rendesse conto che il pur simpatico zio Paperone qualche responsabilità in merito dovrà pure averla avuta.
La salamitudine aguzza l’umorismo
Il Sole 24 Ore, 7 dicembre 1997
“Salamitudine” potrebbe essere la parola che esprime la condizione esistenziale dei personaggi di Jacovitti: contornati da uno spazio ossessivamente pieno di dettagli, condannati a comportarsi secondo lo stereotipo narrativo di cui erano la parodia, ossessionati dalla presenza impertinente di salami mozzati (talora con le ali), di piedi senza padrone che spuntano dalla terra come singolari cactus e di resche di pesce, simbolo geniale e demenziale del dio delirante che organizzava il loro mondo. Jacovitti, come ogni vero grande umorista, è riuscito a farci ridere (e spesso fino alle lacrime) anche ripetendo mille volte la stessa battuta, la stessa gag, la stessa situazione narrativa. Magicamente, ogni volta era nuova, ma ogni volta aveva anche l’aspetto di una rassicurante conferma della stabilità del mondo – di un mondo, quello disegnato da lui, che pareva deragliare continuamente verso dimensioni imprevedibili.
Ma queste imprevedibili alterità, a loro volta, avevano forme riconoscibili e consuete (per quanto deformate dal contesto e dall’inventività di Jac): il governatore “della Cosa, della California”, don Pedro Magnapoco, esprime in dialetto napoletano le proprie istruzioni a don Perfidio Malandero, capitano delle guardie, per far fuori Zorry Kid. Il turbine coinvolge nel medesimo gioco le strutture narrative del serial disneyano di Zorro e l’Italia ancora dei dialetti, del miracolo economico, del dopoguerra passato ma per nulla dimenticato. L’americanità dei miti infantili di Zorro, del western, dei gangster, della fantascienza, viene filtrata da un’inventività dal gusto strapaesano e cocciutamente e sarcasticamente nazionale, regionale, campanilistico talvolta.
Per noi, bambini negli anni Sessanta, Jacovitti era la giocosa irrisione dei miti televisivi, qualcosa che li rendeva meno sacri ed eroici, avvicinandoli non solo alla quotidianità, ma anche alla realtà irrimediabilmente provinciale che, rispetto a quei modelli, ci pareva di vivere. L’indimenticabile Cocco Bill, che beveva camomilla al burro invece di whiskey, era al tempo stesso un pistolero del west (che viveva avventure non meno emozionanti di quelle che si vedevano in televisione e al cinema) e una persona familiare, con caratteristiche riconoscibili in quelle del vicino di casa, o del parente che abitava in un’altra regione.
Più drasticamente ancora, nella ripresentazione rivisitata di quegli eroi, non si poteva non riconoscere uno spirito di irrisione dal gusto squisitamente e appassionatamente infantile, pur condotto con una sapienza narrativa da adulto. Jacovitti ci si mostrava complice di scherzi ed irrisioni, e quindi gustoso cattivo esempio da seguire (i buoni esempi non sono mai gustosi). Si riconosceva in lui quello che oggi potremmo definire lo spirito di un Peter Pan deciso a non far crescere il proprio mondo fantastico interiore – ma cresciuto, e quanto!, nella capacità di esprimerlo.
Anche quando – anni dopo, e trasformata l’etica nazionale verso una maggiore permissività sessuale – Jacovitti si era cimentato con l’universo adulto dell’erotismo, i suoi risultati non erano stati da meno. Il suo Kamasultra è un inventario delle situazioni erotiche più assurdamente barocche e demenzialmente irrealizzabili, dove corpi in nodi gordiani mescolano oltre i limiti dell’immaginabile attributi sessuali e non.
Oggi che Jac è scomparso, la notizia sembra ancora un’altra delle sue burle, e che il suo defungere non sia che il preludio a una risata ancora più nera e dissacrante delle precedenti. Insieme a lui, vorrei rendere omaggio anche a un altro dei numi tutelari della mia infanzia, il maestro della televisione Alberto Manzi, protagonista educativo di quella stessa Italia, sospesa nel difficile (ma quanto risibile – potrebbe sogghignare Jacovitti) travaglio tra il villaggio e il villaggio globale.
La storia di Bonelli e di suo figlio ‘Tex’
Il Sole 24 Ore, 23 novembre 1997
Cinquant’anni di Tex sono, non c’è dubbio, un traguardo considerevole. Il primo a stupirsene è lo stesso Sergio Bonelli, sceneggiatore ed editore, figlio di quel Gianluigi che, con Aurelio Galleppini alle matite, creò il personaggio nel 1948. Un personaggio tra i tanti che venivano creati, all’inizio, destinato con ogni probabilità a vivere qualche anno di relativo successo, e poi ad essere dimenticato per sempre.
E invece Tex resse, e poi continuò a reggere, aumentando il suo successo, e iniziando, con il trascorrere degli anni, ad ammantarsi di mito. Sono molti anni ormai che, insieme con Topolino, mantiene la testa delle vendite mensili, e persino in un periodo di crisi del settore come quello che stiamo vivendo oggi i lettori di Tex restano diverse centinaia di migliaia.
Altri personaggi furono creati nel corso del tempo da Sergio, mentre Gianluigi restava fedele al ranger. Zagor (1961) e Mister No (1975) sono quelli che hanno superato la prova degli anni. Ancora altri sono venuti dopo, per opera di sceneggiatori e disegnatori che la scuderia Bonelli ha acquisito o cresciuto: Martin Mystère, di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini, è nato nel 1982; Nick Raider, di Claudio Nizzi, nel 1988; Nathan Never, di Medda, Serra e Vigna, nel 1991. Mentre per Bonelli Tiziano Sclavi ha inventato Dylan Dog nel 1986, rilanciando una volta di più le sorti già fortunate dell’azienda.
Ultmi nati, in questi ultimissimi mesi, Magico Vento, di Gianfranco Manfredi (già noto come cantautore e scrittore) e Napoleone, di Carlo Ambrosini.
A Bonelli e alla sua storia è stata dedicata in questi giorni la prima edizione di Padova Fumetto, continuazione ideale di Treviso Comics, un festival molto amato dagli addetti ai lavori. Diverse mostre, dal 5 al 19 ottobre, hanno illustrato la storia e i diversi generi cui i personaggi di Bonelli appartengono, riempiendo il caffè Pedrocchi e altri luoghi storici della città di figure inconsuete. Un convegno, tenutosi l’11 ottobre, ha analizzato il ruolo dei fumetti Bonelli nel costruire numerosi luoghi del nostro immaginario, e, talvolta, anche del nostro linguaggio.
Ne è uscita un’immagine abbastanza atipica di queste creazioni. Magari per pure ragioni di sopravvivenza nel lungo periodo, e forse al solo scopo di trovare variazioni a temi che alla lunga finiscono inevitabilmente per essere monotoni, Sergio Bonelli e i suoi hanno finito per inventare un modo del tutto originale di contaminare e mescolare i generi – non di rado ispirandosi a vicende realmente accadute. E’ stato Giulio Giorello, nel corso del convegno, a evocare un’avventura di Tex in cui lo scontro avviene con dei beduini muniti di cammelli nel deserto del Texas. E’ del tutto legittimo pensare a una bella e fantasiosa mescolanza di generi; ma la storia si ispira a una vicenda realmente accaduta, e i cammelli del deserto texano esistono davvero.
Comunque sia, cinquant’anni di storia della casa editrice milanese hanno lasciato il segno nella cultura e nel comportamento degli italiani. E con Tex, o Dylan Dog o con altri personaggi questa storia pare destinata a durare.
Fumetti d’imPazienza
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 1997
Venti anni fa, 1977, mentre le università italiane ribollivano degli ultimi, scoppiettanti bagliori della stagione nata con il ’68, e la sinistra studentesca iniziava a morire tra tossicodipendenze e Brigate Rosse, il fumetto italiano stava iniziando un viaggio che lo avrebbe segnato e trascinato lontano. Per almeno 10 anni gli autori che si stavano formando allora avrebbero dominato il campo, lasciando tracce un po’ su tutta la scena culturale italiana, dalla letteratura alle arti visive, dalla satira al teatro, al costume.
Non c’era solo un manipolo di ragazzi geniali. C’era un ambiente culturale che si riconosceva nel fumetto come in una forma espressiva non compromessa con l’ufficialità editoriale o commerciale; un’ufficialità peraltro inutilmente combattuta e detestata, ma contrastata, almeno simbolicamente, con ogni mezzo possibile. L’ambiente culturale riconosceva nei ragazzi geniali del “nuovo fumetto italiano” coloro che più compiutamente esprimevano il sentire diffuso, e li eleggevano a loro portavoce.
All’inizio era stato Cannibale, rivista troppo aperiodica e managerialmente dilettantesca per durare, ma radicale e innovativa, e di qualità straordinaria, tanto più se si pensa che gli autori erano tutti giovanissimi, e tutti alla prima esperienza editoriale, o quasi. Da quegli stessi autori, insieme ad altri con qualche capacità amministrativa in più, era subito dopo arrivato Il male, la rivista di satira più cattiva (e intelligente) che si possa immaginare, di cui resta memoria, nel pubblico, soprattutto per le false copertine di quotidiani nazionali che strillavano notizie straordinarie, da “Lo stato si è estinto” di Repubblica a “Annullati i mondiali” de La Gazzetta dello Sport.
Sono gli stessi ragazzi, nel 1980, a fondare Frigidaire, rivista di tendenza e di culto della prima metà degli anni Ottanta, mescolando un giornalismo aggressivo e controcorrente all’inventività grafica e letteraria. E producendo, naturalmente, fumetti tra i migliori che si siano mai visti in Italia.
Vent’anni dopo, cosa resta di questo? Che cosa fanno i protagonisti di questa storia? Due di loro sono morti: il corpo di Stefano Tamburini, motore grafico e ideologico di Cannibale e Frigidaire, fu trovato parecchi giorni dopo il decesso, nel 1986; e due anni dopo, nel 1988, morì di overdose Andrea Pazienza, l’autore più prolifico e amato della sua generazione. Tanino Liberatore e Massimo Mattioli continuano ancora oggi a pubblicare ottimi fumetti tra Parigi e Roma. Filippo Scòzzari non disegna quasi più, ma in compenso scrive, penna caustica e irriverente, non di rado avventata, quasi volgare – ma sempre gustosa, gustosissima, e tanto di più quanto più dice quello che di solito le lingue forbite usano tacere.
E’ proprio sulla storia che abbiamo accennato sin qui che Scòzzari ha pubblicato da poco un racconto autobiografico, dove gli entusiasmi e i drammi di quegli anni appaiono vissuti intensamente da dentro, da protagonista, inventore e trascinatore di autori destinati talvolta a un successo maggiore del suo. Un libro, Prima pagare poi ricordare, appassionato e sgarbato come il suo autore, composto con uno stile acutamente originale – da superba, irrefrenabile “malalingua”.
Il ritratto che appare più nitido, nelle pagine di Scòzzari, è quello di Andrea Pazienza, amato e ferocemente invidiato (da lui come da tutti) per la sua capacità grafica straordinaria. Scòzzari ci racconta come lo conobbe, come lo frequentò, come si concluse il sodalizio, prima – come spesso accade – per semplice esaurimento, e poi, inaspettatamente, in tragedia. Pazienza, nei suoi pochi anni, ha davvero attraversato come una bomba gli anni Ottanta, senza fare scuola e senza riconoscimenti all’estero: troppo originale e troppo calato in una realtà giovanile profondamente italiana, nella quale ha creato opere in cui il suo pubblico si è riconosciuto e immedesimato.
A Pazienza, in questo ventennale senza celebrazioni (ma che fa evidentemente riscontrare un diffuso risveglio di interesse per le vicende che ebbero inizio allora) troviamo dedicati in questi giorni un CD-Rom e una mostra. Il CD-Rom, Andrea Pazienza. L’antologia illimitata, a cura di Ferruccio Giromini, fa abbastanza fede al suo titolo, presentando nel non agevole formato dello schermo del computer (640×480 pixel) le tavole di tutti i fumetti di Pazienza, più una discreta scelta di vignette, dipinti e altro. Vi si trova una bibliografia delle sue opere che si può presumere completa, un’antologia di commenti della critica e una breve biografia, con filmati e foto del giovane e meno giovane Andrea dalla prima comunione in poi. Con gradita discrezione, gli autori non aggiungono altro: né commenti, che infatti meglio troverebbero posto in un volume cartaceo, né gratuite divagazioni multimediali, con l’eccezione di alcuni inutili giochi – ma pare che non si possano fare CD-Rom senza di loro.
La mostra, Andrea Pazienza. Antologica, promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Bologna, è aperta nel capoluogo emiliano a Palazzo Re Enzo dal 5 ottobre al 16 novembre, e presenta circa 250 originali, di cui la metà tavole di fumetti e il resto illustrazioni e dipinti, alcuni inediti. Il catalogo, curato dai fratelli di Pazienza e da Vincenzo Mollica, contiene una nutrita serie di interventi.
Filippo Scòzzari
Prima pagare poi ricordare. Da “Cannibale” a “Frigidaire”. Storia di un manipolo di ragazzi geniali
Roma, Castelvecchi 1977
pp. 232, £.18.000
Andrea Pazienza. L’antologia illimitata (CD-Rom)
Imagica – L’Unità iniziative editoriali n.5
£. 30.000
Ipertrofici muscoli da fumetto
Il Sole 24 Ore, 10 agosto 1997
Prima era un’entità di scarso rilievo: solo il necessario supporto materiale di un personaggio. Appena in alcune figure femminili la descrizione grafica sottolineava il corpo con qualche compiacimento. Del resto, poiché i fumetti erano sostanzialmente comics, funnies, roba fatta per ridere, il corpo era un’entità puramente funzionale al racconto e alle situazioni umoristiche.
Dal 1929 le cose iniziano a cambiare, e il protagonista di questo cambiamento si chiama Tarzan. Disegnato da Harold Foster, un autore di notevole talento grafico, il seminudo signore delle scimmie porta nel fumetto (così come nel cinema, all’incirca negli stessi anni) un gusto per le forme corporee che prima di allora era del tutto alieno a quel mondo. Forme maschili, con muscoli tesi e grazie acrobatiche, e forme femminili, languide e quasi altrettanto discinte.
Da Tarzan in poi, il corpo dei personaggi del fumetto non sarà più lo stesso. Alex Raymond, sulla scia di Foster, riempirà dal 1934 il suo Flash Gordon di atleti e conturbanti principesse, provocanti al punto che le edizioni italiane di questo fumetto non riuscivano sino a tutti gli anni Sessanta a evitare di coprire il loro corpo di improbabili tessuti colorati.
E’ ancora Tarzan a rilanciare il corpo maschile, quando, verso la fine degli anni Trenta, il suo disegno passa a Burne Hogart, un disegnatore innamorato di Michelangelo e dei suoi nudi muscolosi. Il Tarzan di Hogart è un’apoteosi del nudo – sempre coperto là dove si deve, beninteso, ma addirittura sfacciato nella sua atletica sensualità.
E’ nello stesso periodo che sulla scena del fumetto americano fa la sua comparsa Superman, con la sua corte di eroi superdotati. Il modello tarzanico è evidente in questi personaggi, ma nessuno può vantare autori con le capacità grafiche di Foster, Raymond o Hogart. I corpi dei supereroi sono possenti, sì, ma non è certo la muscolatura, o l’esposizione dei bicipiti, a poter giustificare la loro potenza – legata a provenienze aliene o a esperimenti segreti.
E poi questi nuovi eroi, a differenza dei vecchi, sono sempre vestiti da aderenti calzamaglie, e nemmeno si accorgono delle signore attorno a loro, le quali, vittime di questi sguardi neutri, non possono per nulla competere con le esotiche ed esibite grazie delle altre, le compagne o antagoniste degli eroi senza il prefisso “super”. Ed è così che il corpo femminile più sognato nei fumetti degli anni Quaranta è quello sinuoso e inguainato della Dragon Lady di Terry e i Piraty, disegnata da Milton Caniff, un contesto decisamente diverso da quello degli eroi “super”.
Il corpo dei supereroi, vigoroso ma eroticamente neutro, torna alla riscossa negli anni Sessanta, con le apoteosi muscolari di Jack Kirby, l’inventore grafico dei supereroi della Marvel, dai Fantastici Quattro all’Uomo Ragno. Muscoli, muscoli e muscoli. Scatenati in lotte furibonde contro altri muscoli appartenenti agli avversari. Disegnati, ora come non mai, con uno stile che ha assai pochi riferimenti nella storia del disegno, fatto di tratti di pennello grossi e angolati, estremamente antinaturale, certamente assai meno erotico di quello di Hogart o di Raymond, ma originalissimo e di grande efficacia. Con il segno grafico di Kirby, è un po’ come se il corpo del supereroe assomigliasse di più al corpo di una macchina: un carro armato potente e invincibile.
Ma gli anni Sessanta sono anche gli anni in cui Frank Frazetta riprende la sensualità dei corpi di Raymond, per disegnare storie di selvaggi e magie – dalle quali avrà origine, di lì a qualche anno, la saga infinita di Conan il Barbaro, creatura più corporea e sensuale che mai, dovuta al pennello di un altro raymondiano, John Buscema. Muscoli maschili e curve femminili ne sono evidentemente il piatto forte, con una ricetta che non ha ancora smesso oggi di funzionare.
Anche i supereroi, presto o tardi, abbandonano il corpo modello Kirby. Alla struttura da carro armato, di cui Hulk e la Cosa erano gli esemplari migliori, negli anni Settanta Neal Adams contrappone un corpo atletico sì ma allungato, fino quasi, talvolta, a un eleganza che nasconde i muscoli. L’eroe diventa un bel tenebroso, cui si affiancano bellezze femminili singolari: il corpo è sempre lì, al centro del discorso, ma una volta tanto senza ostentazione di muscoli o di curve.
Il ritorno del modello Kirby è evidente in Frank Miller e nei suoi eroi rivisitati degli anni Ottanta, ma lo spirito di Miller è tutt’altro da quello di Kirby, e i corpi ipertrofici dei suoi personaggi sono del tutto assorbiti da un meccanismo narrativo che non lascia tempo per soffermarsi a riflettere su di loro. I corpi ci sono, insomma, ostentati e grandiosi; ma tutto nel racconto ci spinge ad ignorarne la fisicità.
E’ invece ed infine Todd McFarlane, all’inizio degli anni Novanta, a fare del corpo degli eroi l’oggetto stesso del racconto. Muscoli maschili e curve femminili disegnati con un segno grafico che sembra disegnare carni anche quando disegna oggetti – e tuttavia carni e oggetti quasi dematerializzati, di un erotismo statuario e ginnico, con eroine degne della passerella di miss Universo, ed eroi che potrebbero fare i modelli per Vogue, tutti e sempre eleganti e perfetti.
Corpi bellissimi di cera, su cui si immagina appoggiare una mano senza trovare la lieve cedevolezza della carne, ma una fredda ed eterna levigatezza. Non diversi, in questo, dagli eroi del fumetto giapponese, che a questo arrivano però con una storia assai differente. Diversi, certamente, dai corpi che si preferirebbe poter desiderare nel mondo incantato del mito, sia pure un mito da $ 2.50 mensili.
Concrete
Inedito per Il Sole 24 Ore, 1997
Qualche volta il vetusto schema di generazione dei supereroi americani può anche servire per dare vita a un fumetto il cui tema principale non sono scazzottate cosmiche o lotte (spesso ridicolmente) epiche per salvare il pianeta dal cattivo di turno. E almeno in un caso lo schema non dà nemmeno vita a una storia di critica dei supereroi, dove la dominante opposizione tra bene e male viene messa in crisi e la figura dell’eroe si trova sbalzata dagli altari alla polvere.
In Concrete, infatti, di supereroico c’è solo l’occasione che ha reso il protagonista diverso. Del resto, l’andamento lento, riflessivo, il tono cortese delle storie e dei suoi personaggi, l’insistenza su temi quotidiani e tutto il resto non hanno proprio nulla a che fare né con gli eroi rilucenti né con le loro critiche o parodie.
Concrete è un essere mostruoso, fatto di una specie di pietra, o di cemento, molto forte e quasi invulnerabile – ma anche goffo e impedito nei movimenti dalla sua stazza e dal suo peso, oltre che per sempre reso dolorosamente neutro dal punto di vista sessuale. Giovane dalle aspirazioni intellettuali, catturato dagli alieni, il suo cervello era stato trapiantato in questo corpo incredibile. Solo la fuga lo aveva salvato da ulteriori esperimenti devastanti. Tenuto in seguito segreto dal governo americano, riesce a conquistare la libertà e la possibilità di vivere una vita tendente alla normalità.
La sua condizione straordinaria non ne fa un salvamondo. Anzi, com’è in realtà assai più ovvio, lo rende un escluso, un diverso nonostante la notorietà. Quando prova – assai di rado in verità – a compiere delle imprese straordinarie, le cose vanno e non vanno: viene cooptato per salvare dei minatori rimasti intrappolati sottoterra, e il suo successo parziale diventa motivo di accusa da parte dei suoi avversari. Da un essere potente ci si aspetterebbe ben altra salvezza: ma Concrete, nonostante la sua forza e la sua robustezza, è più una vittima che un privilegiato.
La sua timidezza e il suo carattere meditativo ne fanno uno strano personaggio, interessato più a capire come la gente lo vede che non a farsi vedere dalla gente. Piano piano, il suo interesse si focalizza intorno ai problemi dell’ambiente, sino ad arrivare, nelle ultime storie pubblicate negli Stati Uniti e ancora inedite in Italia, a fargli stringere una problematica e combattuta alleanza con gruppi ecologisti radicali.
Paul Chadwick lo ha creato intorno alla metà degli anni Ottanta, conquistandosi in breve tempo le simpatie di un pubblico colto, poco amante del mainstream superomistico. In Italia lo si è visto poco, sino a quando, qualche mese fa, la casa editrice Phoenix lo ha reso protagonista di una rivista mensile che porta il suo nome, Concrete, e il patrocinio di Legambiente; e che sta ristampando, in sequenza cronologica, le storie che sono uscite dagli anni Ottanta ad oggi.
E’ una rara occasione per conoscere uno dei fumetti americani più atipici, più vicino, come spirito, alla meditata scarnezza di un Art Spiegelman, con il suo Maus, che non ad altro – anche se del tutto lontano, come spirito, dalla provocatorietà degli intellettuali newyorkesi.
Scott McCloud
Inedito per Il Sole 24 Ore, 1997
Tra i non numerosi saggi teorici intellettualmente eccitanti che si occupano di fumetti, ce n’è uno – ed è decisamente tra i migliori – che ha la singolare caratteristica di essere esso stesso realizzato a fumetti. Si tratta di Capire il fumetto. L’arte invisibile, dell’americano Scott McCloud, pubblicato in versione originale nel 1993 e da alcuni mesi disponibile anche in italiano grazie alle edizioni Vittorio Pavesio Production.
Si dice, nell’ambiente del fumetto, che questo libro abbia scatenato un grosso dibattito tra i giovani americani appassionati di comics. Certamente, per chiarezza e ampiezza dei temi trattati, e per la simpatia e l’intelligenza con cui McCloud li affronta, il libro è destinato a lasciare il segno, anche quando non si condividono le opinioni dell’autore.
L’oggetto del discorso è il linguaggio del fumetto, visto davvero, per quanto è possibile, “da dentro”. Il vantaggio di affrontare a fumetti un argomento del genere è che scompare del tutto quella divisione artificiosa tra teoria ed esempi, cui è condannato qualsiasi saggio puramente verbale che tratti di struttura delle immagini. Provate a pensare a quante parole servono in uno scritto per specificare con precisione a quale particolare dell’immagine ci si sta riferendo, e di quale degli aspetti di quel particolare si sta tentando l’analisi. Le immagini si riempiono di lettere e numeri (zona A, particolare 4…) cui il testo fa continuo e pedante riferimento, e l’occhio del lettore corre e ricorre faticosamente dalle parole all’immagine e viceversa; le descrizioni si dilungano… Un saggio a fumetti presenta al lettore ciò di cui parla proprio mentre ne parla, semplicemente mostrandolo, permettendosi di scherzare, di parodiare se stesso mentre lo fa, con piccoli effetti borgesiani di “mise en abîme” che rendono più piacevole la lettura, e talvolta sono essi stessi utili a chiarire l’oggetto del discorso.
Con un’opera di questo tipo, McCloud si trova d’altro canto anche a tentare un’impresa nuova e nient’affatto facile, dando vita a un genere senza passato né tradizione – di cui forse questo resterà l’unica esemplificazione, ma non meno valida per questo. Qua e là, il testo lascia infati un po’ spiazzato il lettore abituato alla saggistica, semplicemente per mancanza di riferimenti per formulare un giudizio; e certamente questo aspetto di straniamento accattivante contribuisce non poco a far accettare al lettore le tesi dell’autore, un po’ distraendolo – almeno alla prima lettura – da una più severa valutazione dei contenuti.
E purtuttavia, non si tratta poi di un gran male. Quello che McCloud dice sulla semantica del fumetto sarebbe interessante anche se fosse trasmesso con strumenti linguistici più consueti. Si tratta, nel complesso, di un autentico breve trattato di semiotica del fumetto, che si preoccupa di dare una definizione precisa del linguaggio, di quali ne siano i segni caratteristici, di come venga fatto scorrere il tempo tra le vignette di una sequenza narrativa, e di come venga, per così dire, “battuto il ritmo” dell’azione. C’è un’analisi attenta di come può essere usata la linea grafica, del rapporto tra immagini e parole e di come cambiano gli effetti a seconda dei vari privilegi che il testo dà alle due principali componenti del linguaggio. Il colore è un altro oggetto di indagine, a metà tra nozioni di psicologia della percezione visiva e teoria dell’arte.
Negli ultimi capitoli McCloud mette tutto assieme, e dopo aver percorso i sei passi necessari per la creazione di una storia a fumetti (idea, forma, “idioma”, struttura, abilità manuale, superficie – ma, come autore, si impara a padroneggiarli nell’ordine inverso) ci presenta, nella migliore tradizione della saggistica anglo-americana, un coinvolgente compendio dei principali concetti esposti nel volume – sempre a fumetti, come è ovvio.
Una lettura insolita, anche per chi non si occupa specificamente di fumetti, visto che non di rado le intuizioni semantiche di McCloud sono di interesse per tutto l’ambito della visività, dal disegno alla pittura al cinema.
Il libro, purtroppo, non è di facile reperibilità. Lo si può trovare presso le librerie specializzate oppure richiedendolo all’editore. L’originale americano (Understanding Comics) è pubblicato da Kitchen Sink Press.
La corta vita del nuovo fumetto
Il Sole 24 Ore, 6 luglio 1997
Vent’anni fa nasceva in Italia quello che sarebbe stato in seguito chiamato “Nuovo fumetto italiano”, e contestualmente nasceva in Italia il “fumetto d’autore”. Nasceva, certo, non nel senso che prima di allora non vi fossero stati “autori”, colti o popolari che fossero: nasceva come consapevolezza culturale, come dibattito, come spazio editoriale diffuso. Nasceva sull’onda di una produzione fumettistica italiana di quantità e qualità elevatissime, legata a una cruciale e appassionata risposta del pubblico.
Meno di dieci anni è durata la passione. Poi le riviste hanno chiuso o cambiato ambito di interesse. E faticosamente altri dieci anni sono passati, con gli autori italiani emigrati in Francia, o costretti, in patria, a ritagliarsi un soffertissimo spazio tra supereroi americani e manga giapponesi. Quando si arriva, leggendo Frigo, valvole e balloons di Luca Boschi, al resoconto della fine degli anni Ottanta, ci si imbatte in un’improvvisa e inaspettata accelerazione: sembrava di essere a metà della storia e invece si era pressoché alla fine.
Nel volume di Boschi non può non colpire un’osservazione: gli editori francofoni mantengono le loro librerie costantemente fornite delle storie dei loro eroi più famosi, da Tintin ad Asterix, da Spirou a Lucky Luke. Gli eroi che hanno entusiasmato le generazioni precedenti vengono costantemente ripresentati, e ritornano buoni, come classici, anche per le generazioni a venire. In questo modo si conserva una tradizione, si mantiene la costanza di una consapevolezza stilistica, anche nell’inevitabile mutare delle nuove creazioni. E’ lo stesso principio per cui, in Italia e in ambito letterario, si deve continuare e si continua a pubblicare e leggere Verga e Svevo e Gadda a fianco dell’ultima uscita editoriale.
Ma in Italia il fumetto sembra non avere memoria, non avere storia. Con rare ed editorialmente pericolanti eccezioni, il fumetto italiano sembra vivere esclusivamente al presente, condannandosi all’effimero, alla dimenticanza. Lo scarso rilievo del fumetto nella considerazione della cultura italiana si paga così; e davvero i giovani lettori che con fatica trovano oggi fumetti italiani di valore tipicamente ignorano quello che è successo ancora così pochi anni fa.
Per questo il libro stesso di Boschi, dedicato a narrare la storia di vent’anni di fumetto italiano d’autore, è un’operazione importante; e non certo perché in esso si voglia rivendicare un’alterità qualitativa del fumetto cosiddetto “d’autore” sul fumetto cosiddetto “popolare”. Anzi, è evidente a lui come a tutti che il “popolare” Dylan Dog di Tiziano Sclavi è stato il fumetto più significativo degli ultimi dieci anni. Piuttosto, potrebbe forse oggi apparire strano e interessante agli stessi giovani lettori di Dylan Dog che il suo autore sia stato una figura significativa di un’epoca in cui Dylan Dog non esisteva ancora, e il fumetto flirtava con le arti visive, con la televisione e con la moda, imponendo tendenze culturali, invece di subirle, come era accaduto prima, o di viverne al margine, come accade oggi.
Certo, rimpiangere un'”età d’oro” è un’operazione che solleva sempre legittimi sospetti. Tuttavia, pur tagliando corto sulla storia del decennio più prossimo a noi, Boschi correda il volume con alcune preziose appendici, dove si dà notizia, in asettico e storicamente poco impegnativo ordine alfabetico, delle realtà editoriali degli ultimi anni, comprese quelle introvabili nelle edicole, che devono all’esistenza delle librerie specializzate la possibilità di esistere – e nelle quali sembra essersi rifugiato quanto in Italia del fumetto d’autore continua oggi ad esistere. Non manca un utile e aggiornata bibliografia delle opere apparse in italiano sul fumetto.
Protagonista egli stesso, come autore, critico, saggista, redattore, consulente editoriale, del ventennio di cui racconta, Boschi ci fa la storia dell’editoria fumettistica più che dei fumetti stessi. Una storia vista da vicino, talvolta anche troppo – ma da raccomandare comunque sia a chi conserva di quegli anni una qualche memoria, sia a chi, per anagrafiche o altre ragioni, quella memoria ha bisogno di farsela.
Luca Boschi
Frigo, valvole e balloons. Viaggio in vent’anni di fumetto italiano d’autore
Edizioni Theoria, Roma-Napoli 1997
Caboto al pastello
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 1997
Raccontare la storia di Sebastian Caboto, cartografo e pilota spagnolo nei primi anni dell’esplorazione dell’America Meridionale, è per Jorge Zentner l’occasione per riflettere sulla difficoltà stessa del raccontare. Le notizie su Caboto sono così incerte e frammentate, così confuse dall’accumularsi delle voci, che non è possibile costruire su di lui un romanzo vero e proprio, un vero e proprio racconto che abbia qualche pretesa di verosimiglianza storica.
D’altra parte, questa incertezza ricostruttiva fa parte ormai del fascino del personaggio stesso. E l’autore non può che riflettere e ammettere di dover immaginare un racconto, il quale di davvero storico non potrà che avere il profumo, o la probabilità. Non sappiamo come davvero siano andate le cose, quando Sebastian Caboto risalì per primo il Rio della Plata e il fiume Paraguay alla ricerca di uno dei tanti Eldoradi di cui la fantasia dei colonizzatori popolava il nuovo continente. Non sappiamo nemmeno che volto avesse, Caboto, e quale ambizione lo spingesse ad affrontare mille pericoli, cambiando la rotta stabilita e lo scopo della sua spedizione, salpata in origine verso le isole Molucche.
Zentner racconta comunicandoci insieme la sua incertezza, o la difficoltà della sua presa di decisione narrativa; un’operazione rischiosa, che non gli riesce davvero sino in fondo, lasciando sospeso non solo il narrato, ma anche il modo di narrare, in una lentezza un po’ faticosa. Tuttavia Caboto non è un romanzo, bensì una storia a fumetti, e dove lo sceneggiatore non riesce ad arrivare arriva invece il disegnatore, Lorenzo Mattotti.
Partendo ora dalle suggestioni (tutt’altro che assenti) ora persino dai limiti della storia di Zentner, Mattotti, con la capacità evocativa straordinaria del suo segno di pastello, costruisce una sequenza di immagini che potrebbero vivere e raccontare anche senza le parole che le accompagnano, gravide come sono di emozione. Dalla Spagna incantata delle primissime tavole, alla ricerca del volto e dell’immaginario del cartografo, al mare e alla costa americana, sino alle difficoltà e alle tragedie dell’esplorazione dell’interno, è un trasmutare di colori, un giustapporsi di campi di luce e ombre notturne.
Il mare e il fiume sono i luoghi della luce e delle campiture appena sfumate, mentre la foresta è l’occasione per battaglie cromatiche tra le tinte più accese e più diverse – una tragica festività di colori. Lo stile di Mattotti è una volta di più l’occasione per riflettere su che cosa significhi narrare con le immagini. Non è solo, infatti, la qualità delle singole immagini a valere: né più né meno che per un film, in un fumetto non bastano singole raffigurazioni di straordinaria qualità a dare qualità all’opera nel suo insieme. E’ la tessitura complessiva a valere, le modalità dell’accostamento e della successione, il modo in cui l’immagine racconta ciò che racconta nel momento in cui lo racconta.
Le immagini di Mattotti sembrano trascinare avanti il racconto di Zentner, farlo volare, fargli raggiungere singolari profondità, persino quando il racconto ha l’aria di inciampare, di zoppicare un poco. Gli fanno oltrepassare la frammentazione, l’indecisione di un narrare che non si ritrova, attraverso la loro magica materialità: sono comunque lì, vive, calde, incisive, anche dove il racconto sfuma, si fa evanescente. Sono esse stesse sensazione, emozione, esperienza, narrazione. Sono visione in una misura che l’immagine fotografica del cinema non è in grado di raggiungere, nemmeno nelle fantasmagorie herzoghiane di Fitzcarraldo e di Aguirre, che comunque indubbiamente vivono e traspirano in queste stesse immagini.
In qualche modo, come nell’immaginario degli esploratori spagnoli c’era il mito di un Eldorado, così per noi, oggi, c’è il mito di un mondo che nella loro azione ha iniziato a disperdersi, e anche la loro azione fa parte di questo mito. Zentner e Mattotti ce ne restituiscono il profumo, remoto ed incerto, ma nella sua incertezza intensissimo.
Nel segno della paura. Ricordo di Roland Topor
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 1997
Genio del male, nel senso poco usato – ma non meno pregnante – di genio di ciò che fa male, Roland Topor ha cessato in questi giorni di elaborare le sue divertite angoscie, le sue leggerissime tragedie mortali.
Davanti agli occhi abbiamo ancora le immagini di una mostra che Palazzo Reale di Milano gli dedicò dieci anni fa. Pittore? Illustratore? Come pittore, decisamente al di fuori di ogni corrente, se non, come vaga ascendenza o ricordo, il surrealismo. Come illustratore, illustratore di che, se non delle proprie affascinantissime paure?
Narratore per immagini potrebbe essere la sua definizione, che lo accosta implicitamente al mondo del fumetto, da lui poco o per nulla attivamente frequentato, ma oggettivamente vicino a lui, per lo meno in alcuni settori. E narratore Roland Topor lo è anche stato con le parole: autore di racconti tradotti in parte anche in Italia, leggeri e impietosi, cui un romanziere certamente maggiore di lui come Daniel Pennac ha comunque continuato a dovere non poco. E autore di teatro poi, autore di programmi televisivi, regista e scenografo teatrale, per se stesso e per altri.
Anche il cinema lo ricorda, tra l’altro, come coautore (con René Laloux) di un film di animazione premiato a Cannes, Le planet sauvage, inquieto apologo sulla differenza tra razze ambientato in un pianeta fantastico, dove gli uomini vivono un po’ alla stregua dei topi. Più volte attore, richiesto per quel viso sardonico e un po’ mortifero – davvero così in linea con tutta la sua produzione artistica.
Possono forse stupire gli accostamenti creati dall’arte di Topor. Il nome del movimento Frou-frou, da lui sostenuto, può evocare leggerezze e superficialità che in Topor sono tutt’altro che assenti. Ma sono quelle stesse leggerezze che guardate con appena più attenzione lasciano scoprire dettagli che ci fanno correre uno strano brivido lungo la schiena. E’ un po’ qui il cuore, il fascino dell’arte di Topor: quest’aria di prendere poco sul serio le cose, proprio quando queste cose rappresentano le nostre angoscie peggiori.
È lo stesso segno grafico, un po’ desueto, a tradirci. Topor disegna con l’aria di fare degli schizzi, dei bozzetti, delle prove, non di rado semplificando in maniera quasi infantile; così che si è portati a non dare troppo peso, a sottrarre l’occhio con rapidità all’immagine. Poi, come per caso, ci si accorge che l’immagine contiene qualcosa di strano, un particolare fuori posto, un dettaglio che non è come dovrebbe. E allora tutto improvvisamente sembra cambiare significato, e l’occhio che era sul punto di fuggire non riesce più ad abbandonare quelle forme, adesso sì, evidentemente, mostruose.
Come le sue immagini, i suoi testi. Racconti dall’aria innocente, dove con ingannevole tranquillità le nefandezze si susseguono, ora minuscole ora mostruose: sempre senza redenzione.
Cinquantanovenne, una vita di successi, Roland Topor ci lascia oggi a riflettere sui suoi e sui nostri incubi; senza pretendere, nella sua leggerezza, di averci insegnato qualcosa; non so bene quanto consapevole, nella sua intensità, di avere aperto una strada alla rappresentazione visiva di quello che, di solito, siamo appena capaci di nominare a parole.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|



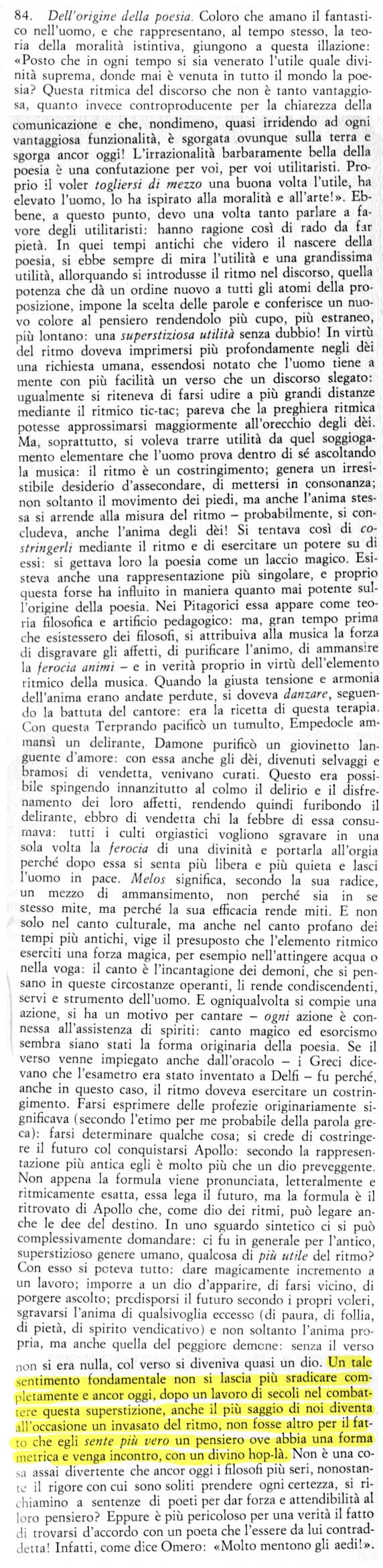





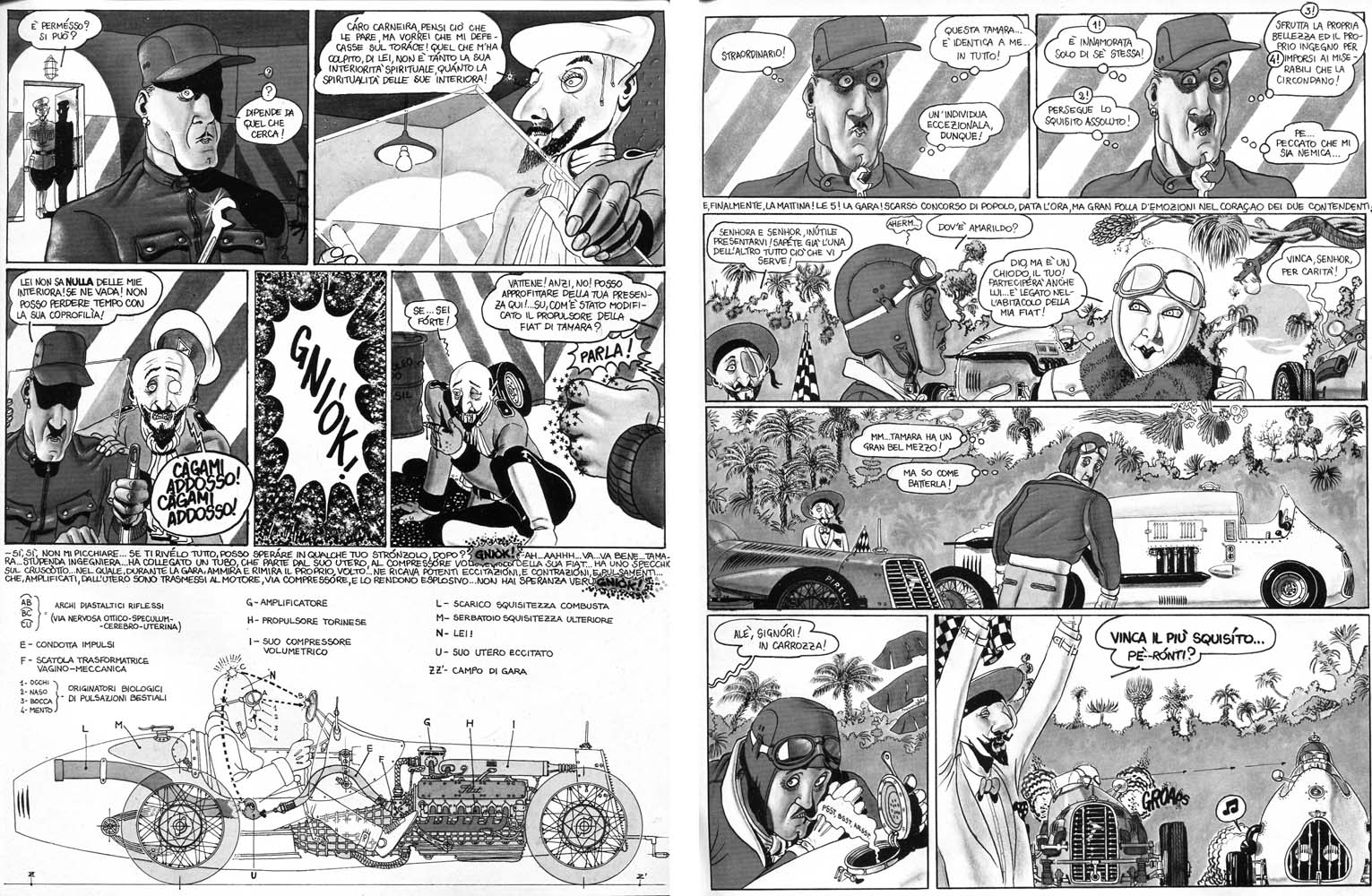


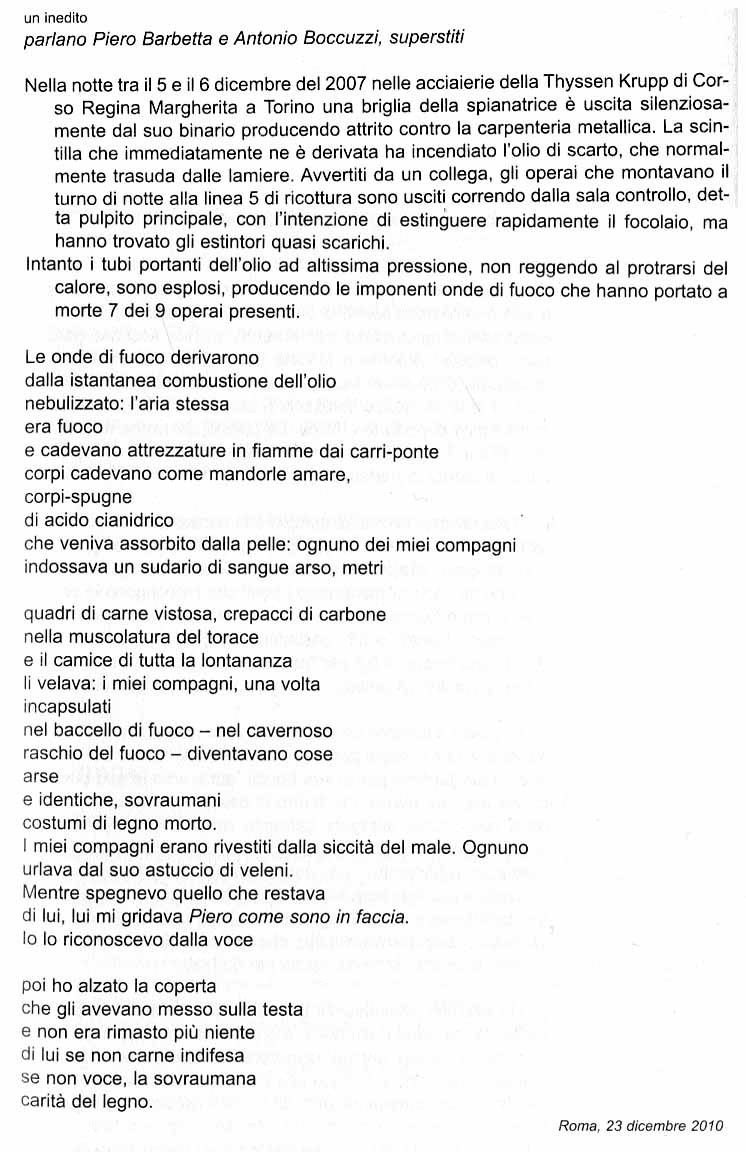
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco

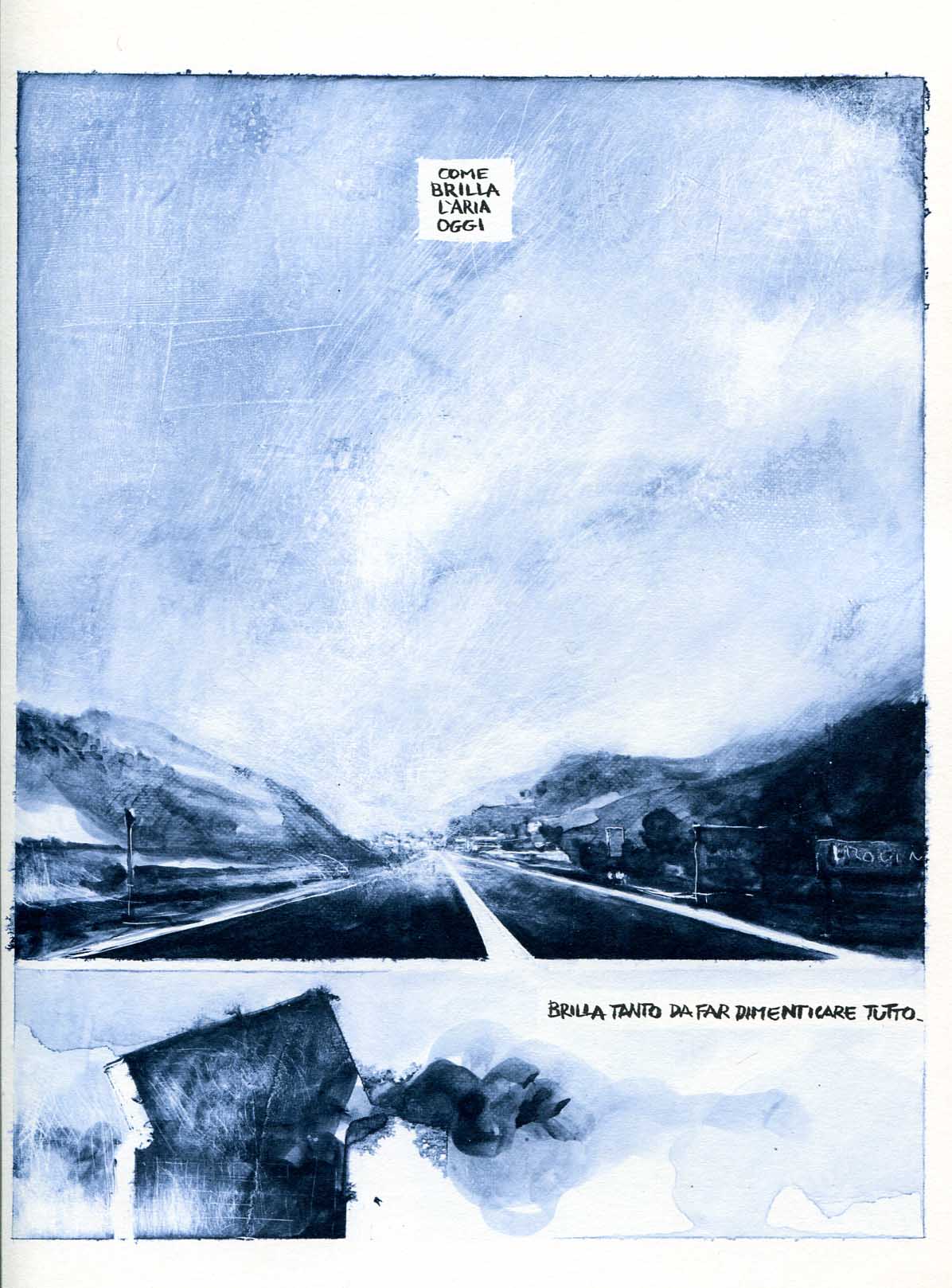


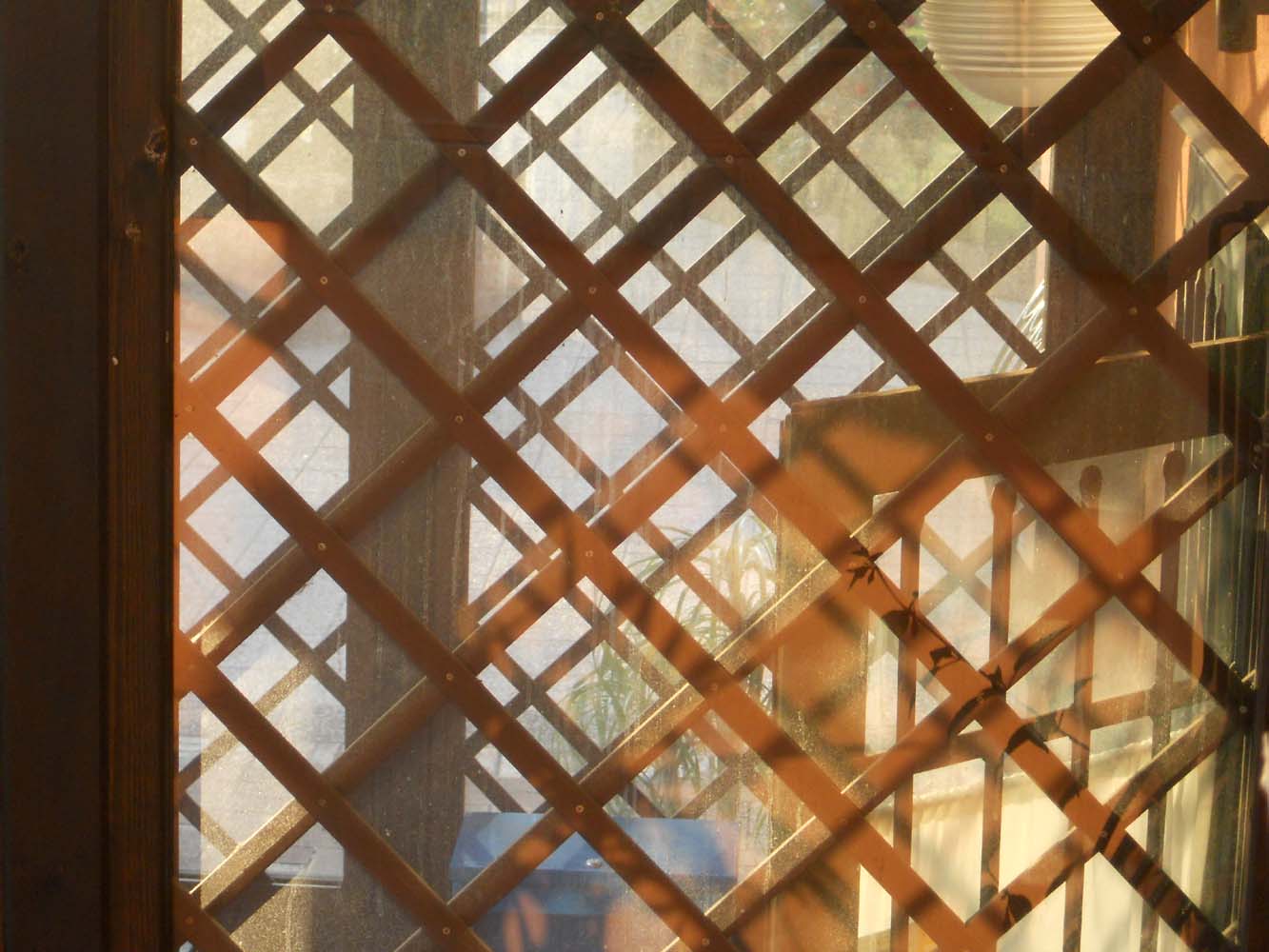


Commenti recenti