Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tempo, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Nicola Pesce, Scuola di fumetto. 
Credo che, per capire Moebius, sia necessario ripartire da Alex Raymond, e in particolare da quello che ne dicevo 4 mesi fa (su SdF 109, insomma). Molto in breve (ché potete comunque riaprire quel numero e rileggervi con comodo il tutto), sostenevo che il fascino di Flash Gordon non sta certo nella quasi-dimenticabile vicenda, bensì nella costruzione del mito che su quella fragile vicenda pone le basi, e quella costruzione è tutta fondata sulla straordinaria capacità grafica e sull’invenzione di luoghi, costumi, posture, espressioni… Alex Raymond ci fa sognare mettendo in scena mondi carichi di evocazioni, per farci immergere con lui, all’epoca, settimana dopo settimana in un immaginario carico di favola (ovvero di storia del nostro stesso immaginario).
Negli anni Settanta Moebius procede in maniera non del tutto dissimile: da Arzach al Garage ermetico di Jerry Cornelius è tutta un’invenzione di situazioni favolose, straordinariamente evocative, piene di echi a mitologie lontane e vicine. Anche qui la sceneggiatura è abbastanza trascurabile: le storie di Arzach sono volutamente senza capo né coda (per non dire di altre storie brevi assolutamente ermetiche, come Absoluten calfeutrail), mentre il Garage ermetico veniva improvvisato episodio dopo episodio, volutamente evitando di prevedere come sarebbe andato a finire (se non proprio alla fine, evidentemente).
Sottolineate le analogie, le differenze sono sufficientemente evidenti: il punto è che l’immaginario di un colto autore francese degli anni Settanta, che si rivolge a un pubblico nutrito ad avanguardie e a nouvelle vague, è inevitabilmente diverso da quello di un disegnatore americano dei Trenta, il cui pubblico – se va bene – è nutrito a pellicole hollywoodiane e classicismo di recupero. La fantascienza che costituisce il quadro di riferimento di Raymond arriva a Moebius profondamente trasformata dalle narrazioni distopiche degli anni Cinquanta e Sessanta, con i mondi allucinati di Philip K. Dick in testa. L’altrove non ha affatto smesso di essere il luogo del meraviglioso, solo che adesso quel meraviglioso ha assunto un alone inquietante che prima non aveva. Si andrebbe così rapidamente verso il drammatico o addirittura il tragico, che una solida vena di ironia o sarcasmo diventa necessaria per rendere digeribile il tutto.
A Raymond potevano bastare delle storie banalotte, purché coerenti, per reggere il meccanismo. Moebius deve invece proprio annullare la storia; trasformarla a sua volta in una serie di evocazioni fantastiche, reduplicando sul coté narrativo quello che già fa su quello visivo. Non importa che le storie siano coerenti; anzi, meglio se non lo sono. Del racconto deve bastare il profumo, l’illusione, la vaga impressione: quello che conta è anche qui l’effetto di immersione in un altrove leggendario, e pieno di miti. Poi, questi miti sono a loro volta spesso evidenti metafore di problematiche sociali, psicologiche, o addirittura politiche del presente: e qui la differenza tra la cultura francese dei Settanta e quella americana dei Trenta emerge prepotentemente.
A un certo punto della sua carriera Moebius incontra Alejandro Jodorowsky. Jodó ha già fatto un sacco di cose, partecipando a movimenti artistici e girando come regista due film. Ma i film, per quanto lodati dalla critica, sono stati commercialmente dei flop, e nessuno gli dà più soldi per girarne ancora. Jodó ha la testa piena di storie, ma sono storie che a Moebius potrebbero andare assai bene, tanto stralunato, assurdo, impossibile è il mondo in cui sono ambientate, e tanto complesse e imprevedibili sono le trame. Aggiungiamoci una vena di (agnostico) misticismo, che si sposa molto bene con le poetiche degli Humanoides (Druillet in questo era già andato molto più in là di Moebius stesso): e nasce così L’Incal, al principio degli Ottanta.
Quelle che vediamo qui sono rispettivamente la seconda e la terza pagina del primo episodio. Nella prima pagina (quattro vignette) John Difool, “titolare di una licenza di detective privato di classe R”, viene malmenato da quattro uomini mascherati e gettato giù da un ponte. Si tratta di un inizio violentemente in medias res: non sappiamo né il perché né il percome, e solo con la seconda pagina, che vedete qui, viene esplicitato il contesto.
Poiché Jodó è un grande inventore di storie, questo attacco intrigante avrà un seguito degno e coerente (oltre che a più riprese sorprendente), ma già in queste sole due pagine ci ritroviamo gettati a capofitto nel mito – e senza il salvataggio estremo di cui gode Difool. La città pozzo, l’epidemia di suicidi, il grande mare acido, l’interrogatorio durante la caduta… e poi aggiungete il vestito e la pettinatura un po’ sette-ottocentesche del protagonista, un po’ da pirata (cinematografico).
La città pozzo proviene da un racconto breve di Moebius di qualche anno prima, The Long Tomorrow, una storia di genere hard boiled, chandleriana anche nel titolo. E, pure qui, il ruolo di detective dichiarato da subito di Difool ci fa attendere un racconto di tipo hard boiled, insomma un poliziesco violento e pieno di azione. Solo che, qui come là, il contesto è tutt’altro che classico.
La vertiginosa prospettiva che ci introduce all’immagine della città ci mostra un mondo futuristico e minaccioso, ma costellato di quotidianità. Solo che fa parte di questa quotidianità la possibilità di fare il tiro a segno sui suicidi, o anche quella di limitarsi ad assistere allo spettacolo. Cinquant’anni di illustrazioni di fantascienza (Flash Gordon compreso) hanno costruito il mito di un futuro tecnologico e meraviglioso che qui si ribalta di colpo in (spettacolosa) angoscia.










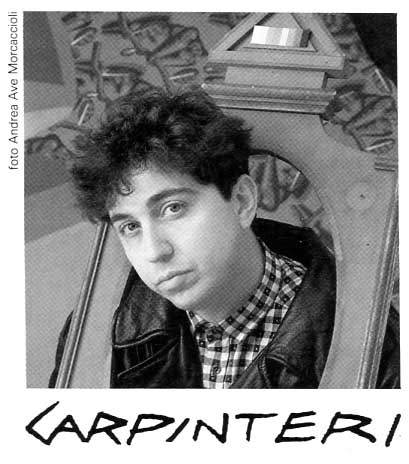
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti