20 Aprile 2010 | Tags: Charles M. Schulz, comunicazione visiva, Floyd Gottfredson, fumetto, graphic design, José Muñoz, marchio, semiotica, sistemi di scrittura, stilizzazione, Will Eisner | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, semiotica, sistemi di scrittura | Colgo l’occasione del dialogo seguito al mio post precedente (Della comunicazione visiva e della lista) per ricollegarmi ai temi di un libro importante appena uscito: è il libro di Will Eisner, L’arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei grandi disegnatori (a cura di Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis, BUR Rizzoli). Si tratta dell’edizione italiana congiunta di due libri diversi (ma evidentemente collegati) nei quali Eisner spiega le regole di base dell’arte sequenziale, ovvero della letteratura a fumetti. Per chi fa fumetti o aspira a farne, è una lettura obbligatoria. Per chi li legge con un interesse che vada al di là della risata o del sapere come va a finire la storia, è comunque una lettura fortemente consigliata – e anche piacevole, non foss’altro che per l’ampia quantità di esempi (anche storie intere) che vi vengono presentati.
Nel dialogo con Stefanelli e “un ospite”, quello che emerge è il tema della semplificazione, o meglio stilizzazione. Alla fine sembra che ci ritroviamo tutti d’accordo su questa frase: “da un lato si deve poter riconoscere con facilità i personaggi e le situazioni, dall’altra essi devono rimanere espressivi e vivaci”. Il manuale di Eisner è molto ricco, ma lo si potrebbe riportare, come morale di fondo, proprio a un principio di questo genere: da un lato il fumetto richiede una stilizzazione grafica e narrativa di personaggi e situazioni che permetta al suo lettore di riconoscerli (sia come esemplari di una casistica nota, sia nelle loro varie ricomparse nella sequenza di una vicenda narrata a fumetti); dall’altro, senza una complessità espressiva sufficiente non si producono fumetti interessanti.
Il principio non riguarda solo il fumetto. In ambito narrativo troviamo da sempre la stessa polarità tra stilizzazione ed espressività. Ma è interessante osservare che in ambito visivo il problema inizia a porsi con maggiore decisione nel corso dell’Ottocento, proprio quando la diffusione di una cultura visiva di massa (nella stampa e nella comunicazione aziendale) segna un punto di svolta rispetto alla visività tradizionale, espressa soprattutto attraverso la pittura e le belle arti in genere.
Non che in pittura il problema non si ponga, ma un oggetto visivo che deve rispondere sostanzialmente a una limitata committenza può contare su una specificità di competenze su cui non può contare un oggetto visivo pensato per una fruizione di massa. Sappiamo bene che il limite della stilizzazione grafica possibile è rappresentato dalla parola scritta: qualunque parlante italiano legga (per esempio) queste parole scritte, le riconosce al medesimo modo (poi magari le interpreterà in mille modi diversi, ma questo non è più un problema di stilizzazione visiva). I marchi aziendali che iniziano a diffondersi dalla fine dell’Ottocento tendono a una stilizzazione/standardizzazione di questo genere: vogliono essere una sorta di “parole visive”, che rimandano direttamente e univocamente all’azienda che rappresentano. Il linguaggio della pubblicità, che inizia a diffondersi in quei medesimi anni, nella misura in cui esibisce componenti visive (quelle verbali sono state per parecchio tempo dominanti), gioca su queste medesime stilizzazioni e immediate riconoscibilità.
Graficamente, il fumetto (e tutti i suoi predecessori ottocenteschi di letteratura per immagini) nasce e si sviluppa in un contesto di questo genere, e i suoi autori delle origini sono ben consapevoli del fatto che i loro personaggi possono diventare dei veri e propri marchi, immediatamente riconoscibili, purché siano progettati opportunamente. Questo aspetto è indubbiamente presente nel progetto di Yellow Kid (e in particolare di Buster Brown), ma anche dei Katzenjammer Kids, di Little Tiger e di Mutt & Jeff.
Ma non è questo l’unico motivo per cui il disegno del fumetto nasce in questa forma così semplificata. L’immagine stilizzata e facilmente riconoscibile permette una lettura più veloce, e quindi una scansione ritmica del testo che sarebbe messa in forte difficoltà da immagini più realistiche e più incertamente riconoscibili. Su questa dimensione ritmica del racconto a fumetti Eisner insiste diffusamente: una buona scansione ritmica è il requisito essenziale di una storia di qualità, ancora di più della qualità grafica delle immagini.
 L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 2  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 3 Un esempio straordinario, più vicino a noi, di quanto la stilizzazione grafica abbia contribuito al successo e alla qualità di una serie a fumetti (e anche, va certamente detto, al suo sfruttamento in termini di branding) è quello dei Peanuts di Charles M. Schulz. C’è un articolo del 1976 (“Les Peanuts: un graphisme idiomatique” Communications, 24) in cui Guy Gauthier mostra come le figure dei personaggi dei Peanuts possano essere costruite articolando un piccolo numero di elementi grafici, corrispondenti alle teste, ad alcuni tipi di espressioni facciali, ad alcune posizioni del corpo e delle sue estremità, secondo un procedimento di articolazione che ricorda quello del linguaggio verbale. Ne otteniamo una sorta di grammatica grafica dei Peanuts, ovvero un sistema degli elementi di base e delle combinazioni permesse e vietate.
Seguendo questa metafora sino in fondo (e anche oltre le intenzioni di Gauthier) si potrebbe pensare che i Peanuts siano un sistema di scrittura, dove poi tutta la ricchezza interpretativa (che, come sappiamo, è in questo caso enorme) si dispiega al livello del significato – proprio come con la scrittura verbale: le parole sono in numero limitato, e si possono combinare in un numero limitato di modi; quello che si legge è, al livello del significante, immediatamente comprensibile e semplicissimo; tutta la complessità e la ricchezza semantica si dispiegano a livello del significato.
Le cose, di fatto, non stanno sempre così neanche con la scrittura verbale, nel cui ambito la dimensione poetica costituisce già un controesempio. Ma neppure il disegno dei Peanuts può essere davvero ridotto alla grammatica di Gauthier: per quanto Schulz giochi il più possibile sulla semplificazione e standardizzazione, già le stesse variazioni minime del suo segno grafico producono differenze espressive enormi. E se invece di Schulz prendiamo Floyd Gottfredson come oggetto di analisi, non solo la “grammatica” di base diventa talmente complessa che non vale la pena di descriverla, ma sono soprattutto gli scarti espressivi rispetto alle regole a farcelo apprezzare e amare: Mickey Mouse va rappresentato certamente in questo e questo modo (anche perché è – lui più di tutti – un marchio), tuttavia, una volta fatta salva la riconoscibilità, è l’espressività grafica che conta! Questo, ovviamente, non taglia fuori tutta quella complessità che appartiene alla dimensione del significato e che, come abbiamo visto, caratterizza la scrittura verbale: essa ci può essere anche qui, nel medesimo modo, ma è anticipata, percettivamente, da una complessità espressiva di carattere grafico che la parola non può avere (se non nelle sue dimensioni calligrafiche, o di tipografia espressiva – ma con modalità molto diverse, e non ne parleremo qui).
Eisner appare, nel suo libro, ugualmente preoccupato di costruire la riconoscibilità (attraverso forme di stilizzazione e standardizzazione) e di garantire l’espressività (attraverso opportune deviazioni dalla norma). Comunque sia, il realismo, o naturalismo, rimane del tutto fuori gioco: una storia che ci appare come realistica è una storia che si basa su delle stilizzazioni che noi riconosciamo perché sono le stesse che applichiamo al mondo reale per comprenderlo; e che poi si allontana da quelle stilizzazioni in una maniera che è grosso modo imprevedibile quanto lo è la realtà rispetto alle nostre aspettative – in altre parole, che è imprevedibile in misura che possiamo prevedere e accettare. Se ci si allontana da questo standard si va o verso il noioso (l’eccessivamente prevedibile) o verso il difficile (l’eccessivamente imprevedibile).
Tutte le raccomandazioni di Eisner vanno verso la ricerca di questa difficile via di mezzo. E il libro è, proprio per questo, prezioso – anche se non tutte le sue affermazioni vanno prese come oro colato. Per esempio, da qualche parte Eisner raccomanda di non usare i balloon collegati per far dialogare di personaggi nella medesima vignetta. Gli esempi che propone sono convincenti. Ma noi sappiamo bene che, per esempio, Andrea Pazienza è riuscito a ottenere effetti di grande espressività proprio con questa tecnica. Evidentemente esistono dei casi, sfuggiti all’esperienza di Eisner, in cui la si può utilizzare con profitto.
Allo stesso modo, è anche possibile rendere il gioco più complesso di quello di Eisner dal punto di vista grafico: il lavoro di Muñoz e Sampayo di cui ho parlato pochi giorni fa qui ne è un esempio. Tuttavia il lavoro grafico di Muñoz non è un esempio di realismo: la stilizzazione è in opera, e fortemente, pure lì. Anzi, la sua deviazione grafica appare così fantasticamente espressiva proprio perché si basa su una stilizzazione evidente.
Insomma – e questo lo dico in particolare agli autori esordienti che devono leggere questo libro – i principi di base della proposta di Eisner sono quelli cruciali. Sulla loro applicazione specifica bisogna invece ragionare. Eisner ha trovato un modo esemplare di applicarli; ma esistono molti altri modi per farlo.
16 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, fumetto, Google, graphic design, immagini, liste, Pieter Bruegel il vecchio, poesia, ricerca, semiotica, sistemi di scrittura, tabelle, Web | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, poesia, semiotica, sistemi di scrittura | Ritorno dal congresso di Venezia dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva con alcune idee che provo qui a metter giù. Lo spunto me lo danno due delle diverse relazioni interessanti che ho ascoltato. La prima, di Vincenza Del Marco, riguardava la ricerca delle immagini sul Web e le difficoltà affrontate dai motori di ricerca per renderla possibile, con la conclusione che, tutto sommato, i motori che si basano sulle parole che accompagnano le immagini restano ancora più efficaci di quelli che si basano sulla somiglianza formale (eidetica e/o cromatica). La seconda, di Omar Calabrese, riguardava la natura di ”lista” (sulla scorta del libro recente di Eco) di diversi (non tutti) dipinti di Bruegel il vecchio, in particolare I proverbi fiamminghi e I giochi di bimbi.
Del discorso di Calabrese (che ha toccato più punti di quelli di cui mi occupo qui) mi interessa l’osservazione che, affinché il contenuto del dipinto possa essere concepito come lista (di proverbi, di giochi…) è necessario che gli elementi che costituiscono la lista siano ben riconoscibili e chiaramente concettualizzati: non a caso, infatti, sia dei proverbi che dei giochi (come dei diversi tipi di cecità che si possono osservare ne I ciechi) esistono liste verbali dell’epoca, da cui si vede chiaramente che i singoli elementi sono ben definiti. L’altra osservazione importante riguarda invece il modo di organizzare lo spazio, secondo una sorta di griglia di base prospettica, che permette di posizionare chiaramente ciascun elemento singolo, ponendolo in relazione con gli altri – e che deriverebbe, secondo la plausibile ipotesi di Calabrese, dalla frequentazione di Bruegel con il disegno delle carte geografiche dell’epoca, sulle quali era frequente non solo la visione assiale, ma anche quella assonometrica.
Ho già ragionato, in un post precedente di questo blog (e anche, in generale, su tutti i post etichettati con il tag sistemi di scrittura), sul legame che esiste tra la lista/tabella e la dimensione grafica. Dagli studi sull’antichità mesopotamica sappiamo che le liste sono precedenti alla scrittura intesa come trascrizione della parola orale, e che tutta una serie di capacità classificatorie (e matematiche) provengono da questa capacità di organizzazione grafica che ancora precede la parola scritta.
Insomma, le liste sono strumenti di organizzazione concettuale del mondo precedenti alla parola scritta, e che permettono di classificare, ordinare e contare su base grafica. Naturalmente, quando entra in gioco la parola, le liste si trovano ulteriormente avvantaggiate, perché la parola soddisfa con facilità il primo dei due requisiti elencati sopra: la riconoscibilità univoca e la chiarezza concettuale. Così, la lista (o tabella) di parole (o anche numeri, ovviamente) diventa facilmente il prototipo di un’organizzazione spaziale rigorosa (in questo caso, cartesiana) di concetti ben distinti e sufficientemente univoci.
Si noti che esiste un tipo particolare di lista che gode di un privilegio particolarissimo: quello di rendere graficamente la successione del discorso orale. Ne avete un esempio sotto gli occhi: questa lista di parole che state scorrendo in questo istante, organizzata secondo semplici regole che ne assicurano la sequenzialità (sinistra-destra, poi alto-basso), ha la proprietà di corrispondere, con sufficiente approssimazione, a una sequenza di discorso orale. Solo la sua natura grafica ci permette di coglierne la natura di lista: nell’oralità primaria la lista pura e semplice non c’è. Il passaggio attraverso la scrittura ci permette però di coglierla.
Voglio provare ora a fare un esperimento concettuale. Immaginiamo una tabella o diagramma cartesiano dove, nell’angolo in alto a sinistra posizioniamo le liste e tabelle fatte di parole (scrittura sequenziale compresa), intese come esempi (1) di massima chiarezza e distinzione dei singoli elementi e (2) di più rigorosa e definita organizzazione dello spazio che li organizza. Da questo massimo, procedendo orizzontalmente verso destra, immaginiamo di diminuire il valore (1), ovvero di porre artefatti visivi i cui singoli elementi sono, andando verso destra, progressivamente meno ben definiti. Andando verso il basso, invece faremo diminuire il valore (2) ponendo artefatti visivi con un’organizzazione complessiva sempre meno chiara. In questo modo, nell’angolo in basso a destra dovrebbero finire gli scarabocchi, ovvero le organizzazioni spaziali più confuse di oggetti per nulla definiti (quali sono infatti le unità di uno scarabocchio? lo scarabocchio è tale proprio perché non c’è nessuna chiara suddivisione possibile).
Tra i due estremi della lista/tabella verbale e dello scarabocchio può essere posizionata tutta la comunicazione visiva: verbale, non verbale e combinata. Una buona segnaletica, per esempio, come può essere quella che si trova ormai in tutti gli aeroporti, va posizionata praticamente nel medesimo angolo in alto a sinistra delle liste verbali: vi troviamo degli elementi ben distinti, univocamente significativi, organizzati secondo una griglia. È facile su questa base riconoscere alla segnaletica lo statuto di scrittura non verbale.
Tuttavia (e questo vale ancor di più per la scrittura verbale) le cose sono un po’ diverse quando la natura dei singoli elementi non ci è ancora del tutto chiara, perché ci troviamo ancora in una fase di apprendimento. Le segnaletiche sono create per essere autoapprese, e sono quindi molto più facili da acquisire della scrittura verbale; tuttavia al primo contatto con una segnaletica non è detto che i singoli elementi ci appaiano già del tutto chiari. In questo caso dovremo dunque posizionarla nel nostro diagramma un po’ spostata verso destra.
Un dipinto figurativo si trova invece posizionato di una certa e non piccola misura ancora più in basso e più a destra. Quanto spostato dall’origine esso sia dipenderà dalla qualità dell’organizzazione spaziale e dalla riconoscibilità dei singoli elementi. Tra i dipinti figurativi, quelli di Bruegel analizzati da Calabrese sono presumibilmente i più vicini all’angolo in alto a sinistra – ma certamente non possono arrivare a coincidere con la posizione delle liste verbali. Nella pittura è infatti necessariamente presente proprio una resistenza all’organizzazione troppo stringente e alla troppo semplice definizione degli elementi: un dipinto interessante non può assomigliare al tabellone di una stazione, il cui pregio è proprio quello di evitare di procurarci sorprese. Il valore di un dipinto, viceversa, sta proprio nel sorprenderci.
D’altra parte, il dipinto non può nemmeno raggiungere la posizione dello scarabocchio: neppure quello ci procura sorprese: la sua assenza di qualsiasi struttura lo impedisce.
Una tavola a fumetti, da parte sua, tende tende più del dipinto ad avvicinarsi all’angolo in alto a sinistra. Essa gode di un’organizzazione tabulare chiara (la gabbia grafica) e di elementi ben distinti (le singole vignette); tuttavia questi sono a loro volta al loro interno organizzati secondo una logica che è parente di quella del dipinto figurativo. Le tavole a fumetti tendono dunque a tenersi non lontano dal lato superiore, ma spaziano abbastanza nella dimensione orizzontale: l’elementarità delle figure dei Peanuts, per esempio, tende a posizionare il lavoro di Schulz piuttosto a sinistra nella nostra tabella, mentre la complessità di quello di Dave McKean o di Lorenzo Mattotti posizionerà il loro lavoro più a destra. Questo significa anche che McKean e Mattotti sono visivamente più interessanti (e meno semplici) di Schulz: il che, ovviamente, è sotto gli occhi di tutti.
Si potrebbe continuare il gioco, provando a posizionare lavori del mondo della grafica, della fotografia, del disegno tecnico e di vari generi illustrativi. Ma qual è l’utilità di questo gioco? Certo, il posizionamento è spesso difficile e quasi sempre discutibile. Ma il fatto di poter confrontare tutte le possibili comunicazioni visive nella medesima tabella ci permette (visivamente e tabularmente) di considerarle come istanze diverse di un medesimo principio, evitando o lasciando in subordine la tradizionale opposizione tra parole e immagini. Nel nostro diagramma le parole sono semplicemente immagini definite in modo molto chiaro, proprio come gli elementi di una buona segnaletica.
Naturalmente, la chiarezza e definizione di cui parliamo è una chiarezza e definizione, per così dire, di primo livello. Qualunque parlante italiano è in grado di riconoscere univocamente le parole del testo che avete sotto gli occhi – e il grande vantaggio della scrittura, specie se tipografica, è proprio questo. Quanto a interpretarne il senso, poi, l’univocità non c’è più. Tant’è vero che la scrittura poetica, prototipo dell’ambiguità e inafferrabilità completa del senso, segue di solito un’organizzazione spaziale che è ancora più regolata di quella della prosa: parte dell’effetto che produce deriva assai probabilmente dal contrasto tra questa organizzazione tabulare particolarmente rigorosa e l’abbondanza delle sorprese interpretative che ne saltano fuori. (E anche i Peanuts di Schulz, così semplici visivamente, trasmettono in realtà interpretazioni molto complesse)
Poi esiste anche la poesia visiva, che gioca proprio sull’allontanamento dalla posizione standard verso il basso, e talvolta persino verso destra, come accade, per esempio, negli Zeroglifici di Adriano Spatola, ai confini tra poesia e arti visive. L’accento sulla rilevanza della dimensione visuale significa infatti anche complicare il gioco sulla riconoscibilità dei singoli elementi e sull’organizzazione spaziale – e giustifica le perplessità di chi si domanda se questa si possa chiamare ancora poesia.
Che cosa ha a che fare tutto questo con i motori di ricerca per le immagini? Riflettiamo un attimo: la ricerca, o almeno quella che si fa sul Web, è un’operazione concettuale, ovvero si cerca qualcosa, e questo qualcosa dev’essere sufficientemente definito. Insomma, la ricerca stessa, così concepita, gode delle stesse proprietà delle liste (ed è pure internamente basata su quelle grandi liste che sono i database). Non c’è da stupirsi che funzioni bene per quelle cose che stanno sull’angolo in alto a sinistra del nostro diagramma, e sempre meno bene man mano che ci se ne allontana. Temo che dunque non si tratti solo di un problema tecnico, destinato a essere risolto in pochi anni.
P.S. Perché non inserisco un’immagine, che dia una chiara idea visiva del mio diagramma? La risposta è che si tratta di un esperimento concettuale, e non di un modo per creare una vera e propria mappa. Se mostrassi il diagramma dovrei per forza dare un posto preciso alle cose, e l’attenzione di chi legge questo post si sposterebbe sul dove metterle (un po’ più in alto, un po’ più in basso, più a sinistra, più a destra…). È poi un esperimento anche nel senso che si tratta di un’idea appena abbozzata, che mi appare suggestiva perché permette di mettere insieme tutto il campo del visivo. Ma richiede certamente ancora molto raffinamento per poter diventare una teoria.
Carlos Gardel fu un cantante straordinario. Non saprei dire se le canzoni che lui cantava erano davvero belle. Ascoltate oggi, poi, rivelano tutta la loro età, e le mode, le consuetudini, le idiosincrasie di un’epoca così lontana. Però, cantate dalla sua voce mi restano nelle orecchie (anzi, mi sono nelle orecchie, proprio ora mentre scrivo) come momenti di emotività straordinaria. Poco importa che io mi ripeta che appartengono a un mondo a me lontano nello spazio e nel tempo, e lontano pure ideologicamente e culturalmente. Persino io, italiano del 2010, non riesco a non fremere di strane emozioni al sentire questa voce che proviene dall’Argentina degli anni Trenta. Magari la ragione per cui non posso dire se quelle canzoni fossero belle in sé, è che è talmente forte l’impronta della sua voce che finisce per essere quella l’unica cosa che conta.
C’è poco da stupirsi dunque del fatto che, nella sua epoca e nel suo paese, Gardel fosse già un mito quando era vivo. Poi, la consacrazione della morte improvvisa, in un incidente aereo in Colombia nel 1935, lo proiettò per sempre nella dimensione del simbolico: non solo una voce mitica, capace di provocare straordinarie emozioni in chi la ascolti, ma il mito stesso dell’Argentina, l’incredibile simbolo di un’identità nazionale basata sul tango, sulla virilità, sulla capacità seduttiva, e sulla capacità di produrre e di provare emozioni. (Assai meglio che in Italia, comunque, dove, quando va bene, l’identità nazionale si fonda sul calcio, e quando va male… meglio lasciar perdere…)
A parte Maradona, l’Argentina non ha prodotto solo Gardel. Già solo nei campi per cui ho qualche interesse dovrei elencare tanti nomi. Stranamente, tutti condividono con il nome di Gardel una qualche impronta di tipo mitico e simbolico. Certo nessuno quanto lui, ma per chi ha qualche amore per la letteratura il nome di Jorge Luis Borges produce un effetto analogo. E per chi ama la letteratura a fumetti, l’Argentina è stata particolarmente generosa: se dico Hector Oesterheld o se dico Alberto Breccia, chi sa di che cosa parlo sente passare un fremito.
Non so se succeda a tutti. Come europeo, o forse magari proprio come italiano (e credo che succederebbe anche se io fossi spagnolo), la sensazione che provo è che in Argentina sia ancora presente nell’aria una dimensione mitica che è esistita anche qui, ma che nel corso del Novecento si è progressivamente estinta – o, meglio sarebbe dire, si è progressivamente banalizzata. È come se la cultura Argentina apparisse come la versione rimasta giovane di qualcosa che qui è irreparabilmente invecchiato.
Questo non significa che la cultura argentina (sto parlando di cultura in senso antropologico) sia qualcosa di universalmente apprezzabile. Certi suoi aspetti (come il machismo, per esempio) mi appaiono volgari e persino ridicoli. Ma il mito non è qualcosa di etico: è un respiro brutale, fascinoso per la sua brutalità, che è tale nel bene come nel male. È qualcosa che rimpiangiamo anche quando non rimpiangiamo i suoi contenuti. Lo rimpiangiamo perché contiene un’energia, un piacere di vivere, che è sconosciuto in sua assenza. Se potessimo, vorremmo vivere in presenza del mito, senza subirne le conseguenze brutali. Sembra che non sia possibile, e che siamo condannati a oscillare eternamente tra la valutazione razionale che ci salva la vita, e la passione mitica che ce la riempie di senso.
Per chi è appassionati di letteratura a fumetti, c’è almeno un altro nome mitico che proviene dall’Argentina, anzi due, quello della coppia di autori José Muñoz e Carlos Sampayo. Il fumetto italiano deve loro moltissimo, persino quello popolare alla Bonelli. Ma la loro produzione è certamente una produzione colta, non foss’altro per la non facilità della lettura, tanto visiva quanto narrativa, delle loro opere.
Non sono un mito per questo, tuttavia. Chi, come me, ne segue il lavoro dalle prime pubblicazione italiane degli anni Settanta, conosce bene lo strano groviglio di emozioni che persino le storie hard boiled del primo Alack Sinner sono in grado di produrre. A quell’epoca sia lo stile grafico di Muñoz che quello narrativo di Sampayo erano ancora decisamente più lineari di quello che sarebbero stati poi, ma era già presente un gioco polifonico di voci, di punti di vista, di vicende interallacciate che facevano di Alack Sinner un fumetto particolare e notevole.
Forse quello che era proprio di Muñoz e Sampayo sin dall’inizio era la capacità di vivere (e trasmettere) il mito con tutta la violenza che esso ancora vive nell’aria di Buenos Aires, e di fornircene una versione critica, mediata dall’occhio di chi si rende conto della sua problematicità etica. Ma questo non viene fatto discutendo il problema, bensì presentandolo attraverso la pluralità delle voci e dei punti di vista. In questo modo, anche se il mito viene messo in discussione, e lo sguardo critico dell’intellettuale razionale si sente soddisfatto, in realtà non c’è nessuna vera e propria razionalizzazione del mito; c’è piuttosto uno scontro tra mitologie differenti, che continuano a conservare il loro fascino terribile, la loro negatività sinistra, e la loro feroce vitalità.
Non c’è nessuna soluzione, nessuna ideologia razionale e positiva, nel discorso di Muñoz e Sampayo. Non c’è nemmeno l’utopia socialista, che promette la soluzione di tutti i problemi, ma a costo proprio di uccidere il mito. Ovviamente non c’è nemmeno l’utopia capitalista, che maschera di razionalità l’emersione di altri miti, ben meno soddisfacenti di quelli antichi. Semmai Muñoz e Sampayo si permettono di prendere questi (poveri) nuovi miti, e di metterli a contrasto con quelli tradizionali: in questo modo la dimensione etica (e la condanna implicita delle atrocità) emerge con forza, ma senza cancellare, senza diminuire nemmeno di un soffio la vitalità perversa e fascinosa del mito. Sin dall’inizio, leggere le storie scritte da Carlos Sampayo e disegnate da José Muñoz è stato un atto di confronto con una dimensione profonda e contraddittoria, dotata dello stesso fascino che possiedono i miti greci, terribili e meravigliosi proprio per la loro commistione di giustizia e di orrori.
Cosa succede quando il mito attuale e impietoso di Muñoz e Sampayo si confronta col mito stesso dell’identità argentina, Carlos Gardel? "Carlos Gardel" di José Muñoz e Carlos Sampayo, Nuages 2010
Non c’è un racconto vero e proprio della vita di Gardel, in questo romanzo. La falsariga è data da un dibattito televisivo sul cantante e sull’identità nazionale argentina, combattuto da due antipaticissimi contendenti, fieramente avversi l’un l’altro: l’uno nel difendere tutte le doti (tipicamente argentine) che si attribuiscono a Gardel, l’altro nel metterle tutte in discussione, una dopo l’altra. Ma il loro dialogo si intreccia con gli episodi stessi della vita di Gardel, e con le tante visioni delle persone che lo hanno accompagnato: il tutto quindi in una composizione corale, polifonica, che, nell’effetto complessivo, ha una struttura che è più simile a quella di un brano musicale (magari proprio un tango) che non a un racconto tradizionale.
Non è il cantante Carlos Gardel a essere messo in discussione: su quello e sulla sua capacità strepitosa nessuno esprime mai il benché minimo dubbio. Gardel è davvero il mito argentino, per tutti, allora come ora. Ma cos’è questo mito? Muñoz e Sampayo lo perpetuano, paradossalmente, proprio conducendoci ad osservarne, a patirne, tutti i lati oscuri – ma anche a godere di quelli luminosi, vitali. Persino quando non è possibile separarli.
Ho letto e riletto il loro libro. Poi non potevo non riascoltare Gardel.
7 Aprile 2010 | Tags: Bauhaus, carattere tipografico, caratteri lineari, comunicazione visiva, estetica, Futura, Georg Kurt Schauer, graphic design, James Mosley, Paul Renner, Romanticismo, sistemi di scrittura, sublime, tipografia | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design, sistemi di scrittura | Anche studiando la storia della tipografia si fanno strane scoperte sui percorsi di senso delle forme di cui facciamo quotidianamente uso. Prendiamo i caratteri lineari, o senza grazie (variamente chiamati, a seconda della lingua o tradizione o periodo, sans-serif, grotesque, antiqua, gothic o anche egyptian). Il dibattito tra i professionisti della grafica sulla loro leggibilità è tuttora in corso, senza che si possano assegnare vantaggi decisivi né a chi sostiene che i caratteri aggraziati sono comunque più leggibili, né a chi sostiene il contrario – salvo che per quanto riguarda la lettura su monitor, rispetto alla quale è largamente accettata la posizione secondo cui, a causa della bassa risoluzione, i caratteri lineari sarebbero più leggibili di quelli aggraziati. E questa è una delle ragioni per cui state leggendo queste medesime parole in un Verdana anziché in un Times New Roman.
Ma non è di leggibilità che voglio parlare. Un’altra posizione largamente condivisa è che i caratteri aggraziati siano, in linea di massima, più tradizionali, e quelli lineari più moderni. Di conseguenza l’uso dei caratteri lineari sarà in generale preferibile in tutte quelle situazioni in cui l’impostazione grafica vuole trasmettere un’idea di contemporaneità e di progresso. Si noti che ho insistito sull’“in linea di massima” e sull’“in generale”, perché ovviamente vi sono font di caratteri specifici e situazioni specifiche in cui il principio generale può trovarsi del tutto ribaltato. Inteso come un principio generale, comunque, quello della maggiore modernità dei caratteri lineari è praticamente un luogo comune – ormai talmente diffuso e acritico che non mi stupirei se si trovasse oggi sul punto di essere ribaltato.
Come si è arrivati a questo luogo comune? In altre parole che cos’hanno i caratteri lineari che li renda più moderni di quelli aggraziati? La strana scoperta si fa proprio quando si va a esplorare l’origine di questa concezione. Mi fa da conduttore un bellissimo saggio di James Mosley, “La ninfa e la grotta. La rinascita dei caratteri senza grazie”, contenuto nel volume Radici della scrittura moderna (Stampa Alternativa & Graffiti, 2001).
Per molto tempo si è ritenuto che il carattere lineare faccia la sua prima uscita moderna intorno al 1816, data attribuita alla sua più antica testimonianza tipografica. Da quel momento e per circa un secolo la sua sorte è legata unicamente ai contesti di segnaletica, insegne e manifesti. Solo con l’inizio del Novecento qualcosa nel suo destino inizia a cambiare.
 L'iscrizione lineare del Grotto di Stourhead (circa 1750) trovata da Mosley Mosley ci mostra invece come, al suo ingresso nell’universo tipografico, il carattere lineare sia già presente nella scrittura da oltre sessant’anni, soprattutto in ambito britannico, come carattere lapidario. Lo si trova nelle iscrizioni funerarie, ma anche in certi fregi architettonici, così come nei frontespizi di volumi che fanno riferimento a quei medesimi contesti.
Visto così, questo ingresso in scena del carattere lineare appare ancora più strano. Il carattere lapidario per eccellenza è infatti, nella nostra tradizione, quello romano classico, con tutte le variazioni moderne sul modello della capitale traianea: non solo un aggraziato dunque, ma il prototipo stesso del carattere con le grazie.
Se aggiungiamo che il periodo in cui avviene questa trasformazione è anche il periodo del ritorno in voga degli stili classici, nella forma – appunto – del neo-classicismo, l’ingresso in scena dei caratteri lineari può apparire ancora più incomprensibile.
 Thomas Banks Iscrizione funeraria, 1791 Non è però un caso che gli eventi di cui stiamo parlando avvengano sostanzialmente in Inghilterra. Nel mio post del 17 febbraio ho raccontato come il concetto di sublime abbia trasformato il modo di considerare l’arte nell’Inghilterra del Settecento e poi in tutta Europa sino a noi. C’è un altro aspetto importante di quella trasformazione, a cui là non ho accennato: si tratta dell’arcaicismo, del primitivismo, della ricerca di forme anticlassiche (quella stessa che porta, alla fine del secolo, a preferire l’anticlassico Michelangelo al classicissimo Raffaello). Questa tendenza si sposerà facilmente con l’imminente recupero del gotico, e già si sposa in quegli anni con la moda del romanzo gotico, ovvero dell’horror settecentesco.
Insomma, l’Inghilterra del Settecento si presenta come un laboratorio dei temi che poi esploderanno con il Romanticismo al volgere del secolo. Per quanto singolare possa apparire, il carattere lineare, con la sua povertà e geometricità, appare in questo contesto come un carattere dotato dei pregi di primitività e arcaicità – e quindi non di rado adeguato a esprimere lo spirito nuovo. I riferimenti sono le scritture lapidarie greche classiche, quelle etrusche e quelle romane antiche, precedenti alla grandiosità imperiale. Ma c’è un singolare riferimento anche alla scrittura egiziana: Egyptian vengono infatti definiti questi nuovi caratteri, nonostante di egiziano non possano ovviamente avere nulla.
A questo proposito fa notare Mosley come la moda dell’Egitto stia in quel periodo imperversando in Europa, e di come i francesi, ritornando in Grecia dopo la spedizione egiziana del 1802, si stupiscano di ritrovare l’arte greca deludente, dopo l’esperienza diretta dei semplici e massicci templi egizi, così dotati di “una nobile semplicità, e una maestosità che riempie lo spirito” (Description de l’Egypte, 1809-28). I caratteri lineari condividono con l’architettura egiziana questa medesima nobile semplicità, e il medesimo spirito arcaico.
Anche per questo, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, essi diventano di moda. Non entrano ancora nei libri (al massimo, raramente, nei frontespizi) perché comunque si tratta di caratteri ancora troppo grezzi per competere con quelli tradizionali, ma si impongono in una molteplicità di combinazioni pubbliche. Così, paradossalmente, il fatto di essere considerati forme arcaiche diventa il motivo della loro modernità: arcaismo e modernità si fondono, nel comune anticlassicismo. Ecco come conclude Mosley il suo saggio, con una citazione da Georg Kurt Schauer (che ritiene comunque l’ispiratore della sua ricerca):
Questi caratteri senza grazie possono ben essere stati pensati per scopi puramente accademici, ma una tale evidenza delle forze elementari del passato deve aver avuto un fascino assai diverso per la Sensibilità coltivata dagli ammiratori dei poemi di Ossian e da quel primo Romanticsmo che era un anelito al ritorno a un passato puro, semplice e forte. Le richieste della pubblicità, la ricerca del sensazionale e la spinta commerciale alla novità possono ben essere state le ragioni immediate per la realizzazione dei caratteri tipografici “lineari”, senza grazie e a grazie squadrate; ma queste sono osservazioni superficiali, che oscurano piuttosto che rivelare le vere cause sottostanti. Il rifiuto della leggerezza e dell’armonia classiche è un impulso romantico. Lo spirito romantico considera la sobria semplicità un valore positivo. La forza barbarica è da ammirare, e così l’assenza di decorazioni superficiali. L’essenza del Romanticismo è nel desiderio di purezza e di forza. Queste qualità, che non possono essere trovate nel presente, vengono cercate nei movimenti arcaici, o in ogni passato per quanto lontano, assunto come più elementare. La rozzezza primitiva, nella sua lotta per il ritorno alla natura, era per i romantici tanto eccitante quanto era invece offensiva per chi aveva attitudini ortodosse e civilizzate. (Schauer, Über die Herkunft der Linearschriften, 1959)
Questo richiamo alla semplicità come valore ricorda facilmente l’equiparazione tra ornamento e delitto operata da Adolf Loos nell’inaugurare l’architettura e il design del Novecento. Non è difficile osservare come la storia successiva dei caratteri lineari si ponga tutta su questa linea, sia nella versione avanguardista (ispirata, più o meno da vicino, dal Bauhaus) di Paul Renner, Max Miedinger e Adrian Frutiger sia in quella umanistica di Edward Johnston ed Eric Gill.
 Paul Renner, il carattere Futura, 1927 È forse più difficile accorgersi di come l’idea del sublime continui a operare in queste creazioni, specialmente in quella di Renner. Il carattere Futura (1927), da lui disegnato, è infatti la migliore realizzazione in campo tipografico dell’utopia del Bauhaus e dei funzionalisti, l’idea di forme che siano al tempo stesso pubblicamente utili e graficamente semplici, senza bisogno di alcun riferimento alla tradizione. Una sublime semplicità, insomma, che esprime l’utopia del progetto di un’umanità non condizionata del proprio passato: primitiva dunque, almeno nel senso di un’umanità che può essere nuova, che può ricominciare di nuovo la propria storia.
Non posso comunque non essere colpito da questa singolare contiguità tra piramidi, horror e funzionalismo, che da questa storia salta fuori. E dovremmo aggiungerci pure la pubblicità, che dei caratteri lineari è stata poi di fatto la principale beneficiaria – quasi a farsi gioco di quella medesima utopia a cui essi devono l’esistenza.
5 Aprile 2010 | Tags: Alan Moore, Algirdas J. Greimas, ermeneutica, estetica, fumetto, poesia, principio del parallelismo, Roman Jakobson, semiotica, Watchmen | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Sia riflettendo sul testo poetico che su quello fumettistico mi ritrovo ricorrentemente di fronte a quel principio formulato da Roman Jakobson che va sotto il nome di principio del parallelismo. Jakobson afferma al proposito che la funzione poetica “proietta il principio di equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa al grado di elemento costitutivo della sequenza”. In parole più povere, per Jakobson quelle relazioni di equivalenza e somiglianza che nell’uso normale del discorso agiscono soltanto come substrato di riferimento delle nostre scelte (ovvero si ritrovano solo a livello paradigmatico), si ritroverebbero in poesia anche a livello del discorso stesso, che sarebbe in parte organizzato secondo queste stesse relazioni (che quindi si ritroverebbero anche al livello sintagmatico). Le equivalenze fonetiche o prosodiche (rime e ritmi) sarebbero dunque parallele a equivalenze semantiche, e andrebbero interpretate in questo senso, riempiendo la poesia di una straordinaria densità di sensi allusivi. E ancora: “La concezione che Valéry ha della poesia come hésitation prolongée entre le son e le sens, è molto più realistica e scientifica di tutte le forme d’isolazionismo fonetico”.
L’idea di Jakobson è cruciale, e si manifesta magistralmente, per esempio, nell’analisi realizzata insieme a Claude Lévi-Strauss del sonetto Les Chats di Charles Baudelaire, dove si espone bene la grande complessità di rimandi che l’organizzazione dei suoni produce. Nonostante questo, anche nel leggere le pagine di quell’articolo mi rimane la sensazione che Jakobson (o, forse, i suoi esegeti) abbia generalizzato troppo, e che si possa continuare a prendere per buone le parole di Valéry anche senza dover cogliere continuamente una relazione tra i parallelismi (prosodici, fonetici, lessicali, semantici…) e il senso di quello che viene detto là dove il parallelismo si manifesta.
La poesia è più antica della prosa. Lo è per le ragioni ben spiegate da Eric Havelock di migliore memorizzabilità in un mondo in cui la scrittura non esiste o è comunque troppo poco diffusa. Ma questa maggiore antichità mal si concilia con la sua maggiore complessità – e non è che Omero sia particolarmente più elementare di Baudelaire, nonostante i duemilacinquecento anni e passa che li separano.
Voglio provare a vedere le cose in un modo un poco diverso, un modo che giustifichi un’applicazione meno compulsiva di un principio comunque importante come quello del parallelismo.
Supponiamo di trovarci in un ambiente naturale, per esempio in montagna, di fronte a un’ampia veduta. Si tratta di qualcosa che di solito apprezziamo, anche se non pensiamo che quello che vediamo e in generale percepiamo debba avere per forza un significato. Naturalmente la dimensione del significato rimane lo stesso profondamente in gioco, ed è proprio per questo che ciò che stiamo percependo ci appare bello: osserviamo le cose e le relazioni tra loro, vi sono cose simili che avvicinano luoghi diversi, vi sono cose che ricordano altre cose viste altrove, vi sono cose che rinviano a discorsi fatti, ad altre esperienze vissute, vi sono relazioni di somiglianza o dissomiglianza tra cose che a loro volte rinviano a discorsi fatti o a esperienze vissute. E così via, in una rete inesauribile di significati, senza che tutto questo debba per forza coagularsi in una dimensione unitaria di discorso, cioè in un significato unitario, in un “messaggio”.
Se questo medesimo paesaggio fosse dipinto, o anche solo fotografato, avremmo invece ragione di pensare che un discorso, e quindi un senso unitario, ci sia; perché anche solo la scelta di dipingere (o fotografare) quel pezzetto di mondo è già un inizio di discorso, per non dire di tutte le altre scelte che il pittore (o il fotografo) fa. Tuttavia, io credo che sbaglieremmo nel risolvere tutta la ricchezza semantica della fruizione ambientale nella strumentalità al discorso da parte del pittore (o del fotografo). Certo, non c’è dubbio che l’artista abbia utilizzato strumentalmente il paesaggio per trasmettere il proprio discorso, e che dunque sia possibile anche interpretarlo così, ma in molti casi la nostra ammirazione per l’artista (in particolare se si tratta di un fotografo) sta soprattutto nel suo aver saputo cogliere un dettaglio di mondo così di per sé significativo, e di averci detto: eccolo! A volte, il discorso dell’autore si può risolvere semplicemente in quell’eccolo!
Se interpretiamo in quest’ultimo modo, stiamo considerando il testo un po’ come un ambiente, e non solo come uno strumento. Non che l’autore scompaia, ma è sicuramente un po’ meno ingombrante, e il suo ruolo non è quello di chi ci trasmette un profondo messaggio, ma semplicemente quello di chi ci dice: guarda qui, questo sembra interessante!
Noi siamo abituati a pensare al linguaggio in maniera strumentale, come un modo per trasmettere messaggi. Ma questa razionalità funzionalista presuppone un contesto in cui gli scopi comunicativi siano già chiari; e, certo, nella misura in cui gli scopi sono chiari, il linguaggio può davvero essere utilizzato funzionalmente, come uno strumento per raggiungerli. Tuttavia, a monte di qualsiasi altro scopo, il linguaggio ne ha uno che di solito, pur onnipresente, non ha alcun bisogno di essere chiaro: si tratta di uno scopo fatico, di contatto. A questo scopo, il guarda lì è già sufficiente, nella misura in cui chi parla e chi ascolta vengono avvicinati dalla comune attenzione.
E il guarda lì può anche essere semplicemente un guarda qui, ovvero guarda (o meglio, ascolta) come questa successione di suoni è armoniosa, come quello rimanda a questo, come quello ricorda quell’altra cosa là, e come il rapporto tra questo e quello ne ricordi un’altra ancora. Il testo può essere fruito come un ambiente, ancor prima che nella sua funzione strumentale, e anche indipendentemente da quella.
La poesia è ovviamente il luogo tradizionale in cui fenomeni di questo genere accadono, il luogo in cui chi parla (o scrive) non sta solo dicendo qualcosa, ma anche dicendo guarda qui: le mie parole non sono interessanti solo per quello che dicono, ma anche perché sono interessanti di per loro, come gli aspetti di un paesaggio. Va bene che se ne cerchi un significato complessivo unitario, ma va anche bene che agiscano come un semplice ambiente, al di là di qualsiasi funzionalità espressiva. Solo il lettore che entri in sintonia con questo paesaggio verbale coglie davvero il fascino di quello che c’è dentro, e allora l’ammirazione per il poeta non sarà per colui che dice cose straordinarie, ma per quella persona che mi sa indicare le cose giuste, le quali significano poi per conto proprio, a dispetto del fatto che un significato complessivo e unitario magari non ci sia, o che sia così difficile da trovare da lasciarci perplessi.
Una versione debole (e per me accettabile) del principio di Jakobson è che tutte le relazioni presenti in un testo poetico siano significative. Quello che trovo problematico è che tutte siano da ricondurre a un nucleo semantico fondamentale – ma questo è forse già più Greimas che Jakobson, e magari proietto la lettura dell’uno sulle parole dell’altro.
Pensare i testi come ambienti non ci impedisce di vederne la natura strumentale (di strumenti comunicativi) ma ci aiuta a non risolverli in quella. Ci invita a visitarli più che a farne un’ermeneutica, ma anche a capire i limiti stessi dell’ermeneutica.
In termini diversi, questo discorso vale anche per il romanzo. Trascuriamo, per semplicità, la rilevanza degli aspetti fonetici e prosodici (che comunque ci sono anche lì), e facciamo finta che la parola, nel romanzo, abbia davvero una funzione puramente strumentale, come veicolo del racconto. Si potrà osservare che, in un romanzo ben costruito, la fruizione ambientale, esclusa dal livello del significante, si ripresenta al livello del racconto. In altre parole, nel leggere un buon romanzo non ci domandiamo continuamente cosa stia volendo dire l’autore con quelle vicende narrate: sostanzialmente vi ci immergiamo, proprio come nel paesaggio, e diamo all’autore il ruolo di colui che ce le ha messe sotto gli occhi, essendogliene grati.
La differenza tra poesia e prosa narrativa è dunque una differenza di livello; ovvero sino a che punto è possibile considerare come ambiente quello che abbiamo sotto gli occhi: sino al livello del racconto o sino a quello della sequenza delle singole parole?
Nel campo del fumetto non c’è una distinzione di genere così netta come quella che esiste tra poesia e prosa, ma possiamo trovare ugualmente queste differenze tra testi leggibili come ambienti a livelli differenti. In gran parte del fumetto popolare, per esempio, il disegno e l’articolazione delle parti grafiche e verbali sono del tutto (o quasi) funzionali al racconto, e solo a questo livello il lettore può avere (e di solito ha) una fruizione di tipo ambientale.
Ma ci sono anche testi a fumetti in cui le cose funzionano nel modo opposto. Prendiamo Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons, per esempio. Sappiamo tutti benissimo quanto questo testo sia costruito, fitto di riferimenti interni, di rime grafiche e narrative, di riferimenti esterni. Tutti aspetti che contribuiscono radicalmente al fascino straordinario che ne promana.
Certo, potremmo ricondurre tutti questi aspetti al racconto, e vederli come efficacissimi condimenti di una storia che è una metafora amara del potere, persino quando questo potere sia utilizzato con le migliori intenzioni del mondo. Questo si può fare, e va fatto.
Però potremmo anche seguire la strategia inversa e immergerci nel testo, lasciandoci attraversare da questa rete inesauribile di rimandi, e considerare che il racconto nel suo insieme non sia che uno di questi elementi – magari più grande e importante degli altri, ma non quello a cui tutto va ricondotto! Se leggiamo Watchmen così, ne perdiamo forse la morale, però lo stiamo percorrendo da dentro, abitando, vivendo come un’esperienza condotta dal suo autore, che ci indica, via via, che cosa è significativo: ci dice, continuamente, guarda qui!
Non per questo, è ovvio, Watchmen va considerata come un’opera di poesia. La poesia è un genere di scrittura verbale. Non esiste la poesia a fumetti. Esiste però un modo di fare fumetti che esibisce lo stesso livello di complessità e di ambientalità della poesia.
1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.
Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.
Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)
Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.
Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.
Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.
Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.
E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.
1. La parola poetica e la sua natura collettiva
È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:
Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.
La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.
La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.
L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.
La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.
Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.
Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:
Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.
Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.
D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.
Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.
Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.
Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.
Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.
30 Marzo 2010 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto, politica | Category: fumetto | Andrea Pazienza è nell’aria (grazie all’infelice riedizione del suo Astarte) ed è nell’aria anche la politica (grazie all’infelice esito delle elezioni, e a tutto quello che ci sta attorno). Per questo, mi salta sotto gli occhi questo articoletto che ho scritto nel 2005 non ricordo più per chi, e la coincidenza è troppo bella per non approfittarne. Quando leggo di quella politica, buona o cattiva che fosse, mi domando davvero come abbiamo fatto ad arrivare a questa, che buona certamente non è.
Una sera di aprile
Una sera di aprile del 1977 mi trovavo in un locale alternativo di Bologna, che aveva nome La talpa, per quella che veniva chiamata allora una riunione politica. Si trattava indubbiamente di una riunione, perché il luogo riuniva numerose persone, ed era sicuramente politica perché la politica era ciò che in quei giorni ci teneva assieme. Ma quando si pensa a una riunione politica oggi si pensa a un gruppo di persone dotato di una qualche omogeneità e di un qualche fine comune che discutono una strategia di azione. Quella sera, più che altro, l’omogeneità e i fini comuni erano una meta, anziché dei presupposti, e una meta nemmeno troppo ambita.
Più che altro, potrei dire oggi, quello che ci teneva insieme, nonostante divergenze ideologiche profondissime dividessero i presenti, era la consapevolezza di far parte di un medesimo ambiente, di un medesimo ambito culturale, di essere comunque un “noi” molto forte e compatto. Allora credevamo che il nocciolo di questo “noi” stesse nella politica, ma quello che si intendeva allora per politica aveva davvero poco a che fare con quello che si intende oggi. Basti pensare allo slogan in cui ci si riconosceva, che recitava “il personale è politico”, ma che si sarebbe potuto anche declinare all’inverso: “il politico è personale”.
La serata tardava a prendere il volo. Si chiacchierava e non c’erano interventi che monopolizzassero l’attenzione. L’interesse comune si coagulò a un certo punto attorno a un mazzo di foglietti che passavano di mano in mano, suscitando grasse risate. C’erano delle vignette umoristiche, disegnate a pennarello su quei foglietti, in cui riconoscevamo facilmente la situazione bolognese di quei giorni. Erano gli originali, non delle riproduzioni, e l’autore era lì tra noi, che si godeva i commenti divertiti e i complimenti del pubblico. Io, però, non riuscii a identificarlo, e nemmeno mi rimase memoria del suo nome.
Fu solo numerosi anni dopo, sfogliando una qualche pubblicazione di quel periodo, che riconobbi chiaramente le vignette che avevo visto quella sera, e capii che, di Andrea Pazienza, avevo assistito, inconsapevole, a uno dei primi successi pubblici bolognesi. In realtà un suo successo assai maggiore stava iniziando a esplodere sulla rivista Alter Alter proprio in quei medesimi giorni di aprile, che vedevano pubblicato il primo episodio de Le straordinarie avventure di Pentothal.
Io scoprii Pentothal ben un anno dopo, mentre scontavo in ospedale i postumi di un viaggio nel deserto. Sarà forse solo cronaca il far sapere che il mio desiderio di occuparmi di fumetti in maniera più approfondita è dovuto in buona parte a quella scoperta. Ma non è solo un fatto di cronaca la ragione di questo mio innamoramento. Il fatto è che Pazienza esprimeva davvero con Pentothal l’anima creativa e contraddittoria di quello che stavamo tutti vivendo; e la esprimeva con una ricchezza, una fantasia e una precisione emotiva che erano davvero impressionanti.
Io credo che la fortuna del fumetto italiano di quegli anni, tra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta, sia stata dovuta alla presenza di un ambiente culturale giovanile diffuso e molto ben definito, di cui il movimento bolognese rappresentava probabilmente una delle realtà più significative, ma che trovava riconoscimento ovunque. Per molti giovani autori, così come per tutti i nuovi lettori di quegli anni, il fumetto rappresentava una forma espressiva ideale, perché era potente, versatile, economica, e soprattutto perché non aveva alle spalle una storia di connivenza con l’industria culturale, con il potere economico costituito: era, insomma, ai nostri occhi, un medium sufficientemente vergine, almeno in Italia, da poter essere colonizzato, e dichiarato nostro.
Questa rinascita del fumetto non era dunque dovuta né a una proposta rischiosa di autori innovativi, né alla risposta di editori astuti alle richieste del pubblico. Ovviamente, entrambe queste componenti erano davvero presenti, ma quello che esisteva prima di tutto era un ambiente culturale, di cui autori e lettori si riconoscevano come parte, un discorso, una conversazione diffusa su temi che sentivamo pregnanti – e il fumetto ne era il mezzo di espressione privilegiato.
Credo che il primo ad accorgersi di quello che stava succedendo e a fare del proprio fumetto la voce fantasmagorica di quella conversazione sia stato Filippo Scozzari. Ma poi Pazienza ha rappresentato quella voce più e meglio di chiunque altro, facendo storia e leggenda della vita di quegli anni.
Rileggendo Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, chi ha vissuto quegli anni non apprezza solo l’esame di storia del cinema su Apocalypse Now. Perché Pazienza non era solo un grande umorista e un disegnatore strabiliante; era anche un prodigioso narratore, capace di individuare l’anima profonda delle relazioni personali e degli eventi, e di costruire racconti apparentemente senza né capo né coda, ma in realtà così ricchi e trascinanti da lasciare attoniti.
A chi lo ricorda soprattutto come umorista regalerei Gli ultimi giorni di Pompeo, la testimonianza più drammatica di quello che succede una volta che i miti si infrangono, e il personale e il politico si separano drasticamente, e per sempre. Proprio come Pompeo, Andrea si è buttato via, un po’ per indolenza, un po’ per sbaglio, un po’ perché le epoche storiche in cui invece di sentirsi soli ci si sente in tanti finiscono, e per troppo tempo non ritornano più.
28 Marzo 2010 | Tags: comunicazione visiva, Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert, fotografia, fotoromanzo, fumetto, narrazione per immagini, reportage, semiotica | Category: comunicazione visiva, fotografia, fumetto | Vorrei parlare del libro di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier, Il fotografo (Coconino Press e Fandango 2010), non solo perché è un bellissimo libro di reportage a fumetti (nella tradizione inaugurata a suo tempo da Joe Sacco), ma anche perché presenta un modo del tutto originale di accostare l’immagine disegnata a quella fotografica per raccontare a fumetti. Ovviamente, è il tema stesso a fornire l’occasione: trattandosi del racconto dell’esperienza di un fotografo (Lefèvre) nel realizzare un reportage, il reportage stesso è giustamente parte del racconto, e il racconto è a sua volta un modo per dare ancora più senso e più gusto al reportage medesimo.
 Guibert, Lefèvre, Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Parlando in generale, l’immagine fotografica non è narrativamente autonoma: poiché essa consiste di un frammento visivo di mondo sottratto al suo contesto, ha bisogno che il contesto le venga in qualche modo ricostruito per acquistare significato (a meno che non si tratti di un gioco fotografico formale – il che va benissimo, ma in questo caso la fotografia non è così diversa dalla pittura, e il fatto di essere fotografia anziché pittura incide solo nella misura in cui aggiunge l’informazione che quelle forme lì che stiamo guardando esistono davvero nel mondo da qualche parte, e che bisogna solo saperle vedere). Il contesto viene ricostruito tipicamente attraverso titoli, didascalie, oppure inserendo le immagini come accompagnamento di un testo verbale narrativo (per esempio, un articolo sugli eventi che le foto mostrano).
I tentativi di fare racconto per immagini utilizzando direttamente le immagini fotografiche approdano di solito ai grotteschi risultati del fotoromanzo – riscattato solo in rarissimi casi da produzioni comunque di carattere intellettualistico e ostentatamente provocatorio. Il problema è che l’effetto realistico dell’immagine fotografica (in fondo si tratta davvero di un frammento visivo di mondo strappato al suo contesto) mal si armonizza con la natura grafica e convenzionale del balloon (qualsiasi forma esso prenda); mentre la scelta di accompagnare le foto con un racconto a pié di immagine (oltre a ricordare troppo le pratiche editoriali dei rotocalchi) non fa che sancire la separazione tra la funzione del raccontare (destinata alle parole) e quella del testimoniare-documentare (destinata alle immagini).
Anche ne Il fotografo è evidente che esistono parti con funzione di narrazione e parti con funzione di testimonianza; tuttavia la natura sostanzialmente visiva delle parti narrative rende lo scarto con le parti di testimonianza molto più piccolo. Così, le fotografie, pur essendo chiaramente testimonianza, riescono a essere insieme anche racconto, armonizzandosi con le vignette disegnate. L’effetto è quello di un racconto che costantemente ci sbatte di fronte alla realtà di quello che racconta, senza più la mediazione del disegno. Certo, c’è la mediazione della fotografia, ma Lefèvre è un reporter, ovvero qualcuno che (pur non negando, certo, la rilevanza del proprio punto di vista e delle proprie scelte) mira a rendere il più possibile il senso stesso della scena che sta riprendendo, e usa i propri strumenti per calibrare la foto in modo da trasmettere il più possibile il senso di quello che sta vedendo.
La fotografia è uno strano strumento comunicativo, che associa l’indubbia oggettività di quello che viene colto (immagini del mondo che impressionano la pellicola in maniera meccanica) con l’indubbia soggettività delle scelte che si fanno per coglierlo (dove puntare, in che momento scattare, che obiettivo e quanto zoom utilizzare…). L’accostamento con le vignette disegnate da Guibert sottolinea gli aspetti soggettivi delle foto di Lefèvre, rendendole parte della narrazione a tutti gli effetti. Tuttavia, questa parte stessa della narrazione è insieme anche la testimonianza, il documento, e l’oggettività di quello che Lefèvre ha visto ne viene fuori con una forza straordinaria.
Per diversi giorni dopo aver letto Il fotografo mi sono ritrovato a ripensarlo dentro di me come un grande film, perché l’effetto di coinvolgimento che aveva prodotto su di me era del medesimo tipo di quello del cinema. Il fotografo non è però un testo a fumetti particolarmente cinematografico in sé: è proprio la combinata di racconto e immagine fotografica a suscitare un tipo di coinvolgimento non dissimile da quello del cinema.
Parliamo di Santoro e del suo Raiperunanotte di ieri sera. Giovanna Cosenza ne contesta l’ossessione antiberlusconiana, condividendo l’opinione di Aldo Grasso, e facendoci presente che l’elefante è sempre stato seduto (e progressivamente ogni minuto di più) al centro della conversazione. Il riferimento citato da lei stessa, da George Lakoff, è questo (link e neretti suoi): «Ricordarsi di “non pensare all’elefante”. Se accettate il loro linguaggio e i loro frame [degli avversari] e vi limitate a controbattere, sarete sempre perdenti perché rafforzerete il loro punto di vista» (trovi le altre regole QUI).
Le regole di Lakoff sono sensate, ma sono riferite a un contesto politico in cui la situazione dei contendenti è grosso modo paritaria. È del tutto ragionevole che, in un contesto in cui è possibile non mettere al centro del discorso i valori degli altri, farlo sia una pessima scelta. Ma le cose in Italia non stanno così.
Anche se in Italia ci sono una destra e una sinistra divise da dei valori differenti, la partita non si gioca su questo. Qui abbiamo di fronte un elefante a cui non è possibile non pensare, perché ha colonizzato tutti gli spazi del dialogo con la forza del suo denaro, delle sue televisioni, del suo fascino personale e del suo potere usato senza nessuna remora. Poter non pensare all’elefante sarebbe fantastico, ma è l’elefante stesso che provvede continuamente a far sì che lo pensiamo, e non abbiamo la forza mediatica per opporci a questo!
Non pensare all’elefante potrebbe essere una strategia vincente se fosse una strategia possibile, ma in Italia al momento non lo è. Di conseguenza o siamo destinati sino alla morte dell’elefante a vivere nella condizione dell’infelice metafora luttazziana (già peraltro anticipata da lungo tempo dall’ombrello di Altan), oppure dobbiamo trovare una strategia che permetta di indebolire l’elefante sino a far sì che sia divorato dai suoi stessi complici – dopodiché davvero potremo forse trovarci nella situazione di non pensarlo.
L’elefante è fortissimo, ma traballa. È vecchio. È troppo incazzato. Fa errori. Più è incazzato e più ne fa. Io credo che farlo incazzare sia la strategia migliore. Finché non saranno i suoi a scaricarlo, travolti dall’impossibilità di reggere la sua psicopatia, io credo che per la sinistra in Italia non ci siano speranze. Solo quando questo succederà il gioco tornerà ad assumere le sue regole normali.
Spulciando nei blog di poesia, mi colpisce il fatto che la grande maggioranza dei commenti contengono sostanzialmente dichiarazioni di accordo con quello che la poesia dice (al massimo con l’aggiunta: “Come lo dici bene!”). Ho sempre trovato la cosa piuttosto irritante, sino a quando, con qualche riflessione, non ne ho capito il perché.
La cosa è irritante perché in questi commenti la poesia viene trattata come se fosse l’espressione di un’opinione, di un punto di vista; o come se rivelasse qualche verità nascosta. In altre parole, un post di poesia viene commentato esattamente come se fosse un post qualsiasi, proprio come questo che state leggendo (e rispetto al quale, se vi trovate d’accordo, io sarei ben contento che mi scriveste che lo siete). Ma queste parole che state leggendo ora sono state pensate per una relazione di scrittura-lettura parzialmente reciproca, dialogica, come quella di un blog; mentre la poesia non nasce per stare all’interno di una conversazione (piuttosto diretta) di questo tipo, e si trova pubblicata su un post semplicemente perché quello è un modo per pubblicarla – e potrebbe trovarsi pubblicata in mille altri modi (anche migliori, come sulle pagine di una raccolta a stampa).
Per dire la cosa in un altro modo, e con un paragone irriverente, è come se io raccontassi una barzelletta, e gli amici invece di ridere mi dicessero, con aria serissima, di trovarsi del tutto d’accordo con me (e che l’ho raccontata proprio bene!).
È invece più difficile da spiegare perché la mia irritazione al leggere questi commenti debba essere contenuta (e i commenti di approvazione tematica delle poesie debbano essere tutto sommato accettati). Una spiegazione che si basa su un’analogia interessante mi è balzata agli occhi stamattina, dopo che, attraverso Google Reader, mi erano arrivate due interessanti poesie, una dal blog specifico della sua autrice, l’altra citata da Luisa Carrada con sorpresa e complimenti.
Proviamo a pensare alla situazione di visitare un luogo condotti da un’altra persona. Se il luogo è davvero interessante possiamo tollerare anche che chi ci accompagna non lo sia ugualmente; se lo è, tutto è meglio, ma l’interesse del luogo in sé può essere sufficiente. Viceversa, se la persona che ci conduce è davvero interessante, può capitare che riesca a farci apparire a sua volta interessante persino un luogo che altrimenti non lo sarebbe; anzi può darsi che riesca a farci apparire interessante persino un luogo che conosciamo già benissimo, e che ritenevamo in precedenza privo di interesse proprio per questo.
Il luogo, nella nostra analogia, è ciò di cui un testo parla. In un testo di prosa critica (proprio come questo post) quello che cerchiamo è l’interesse del tema e delle riflessioni al proposito: il modo in cui è scritto (ovvero, nella nostra analogia, chi ci accompagna) può aiutare o può respingere, ma l’attenzione di chi legge non è rivolta lì. I testi poetici, viceversa, ci mostrano non di rado luoghi (cioè temi) che conosciamo benissimo (e sappiamo tutti perfettamente che è bello ricordare quando eravamo bambini e correvamo in giro, e chi scrive sa benissimo quali siano i propri entusiasmi e i propri scoramenti), ma è la scrittura che ci accompagna laggiù a fare tutta la differenza: è la scrittura a farci percepire come nuovi e interessanti quei luoghi stranoti!
È molto più facile commentare dei luoghi che della scrittura. Dire, nel commento di un post, che siamo d’accordo è come dire che quel luogo ci piace. Chi scrive poesia, viceversa, si aspetta che sia apprezzata la propria conduzione, la propria scrittura, il proprio stile. Ma la maggior parte dei commentatori vedono solo il tema, e si sentono d’accordo con quello. Spesso nemmeno si accorgono che quel medesimo tema, espresso con altre e meno interessanti parole, non avrebbe sollevato in loro il minimo interesse: sono capacissimo anch’io – si direbbero – di ricordare la mia infanzia, e di comprendere le mie emozioni di scrittore!
Bisognerebbe lodare l’accompagnatore, e invece si celebra il luogo. Ma noi che leggiamo quei commenti dobbiamo capire che il luogo è piaciuto perché chi vi ha portato il lettore ha saputo mostrarglielo come il lettore non l’aveva mai visto.
Peccato che talvolta i medesimi apprezzamenti vengano espressi dai lettori nei confronti di versi dove ci sarebbe davvero poco da apprezzare! Magari in quei contesti si loda il luogo semplicemente per non doversi esprimere sull’accompagnatore? E come distinguere allora questo caso dal precedente?
L’analogia, sviluppata qui sulla contrapposizione tra prosa critica e poesia, è facilmente allargabile alla prosa letteraria, al raccontare a fumetti, al cinema, e così via. Chi sa usare il proprio linguaggio, e sa far sì che i propri segni (verbali o visivi che siano) mostrino un’altra faccia delle cose, può davvero raccontare qualsiasi cosa, e farne emergere i motivi di interesse!
Appartengo a una generazione che ha avuto un rapporto controverso con l’opera di Charles M. Schulz: da un lato non si poteva non riconoscere il grande talento, la sottigliezza e la delicatezza, e insieme la profondità, con cui costruiva il suo mondo. Dall’altro, i nostri miti erano altrove.
Ben ricordo quando, sul finire dei Settanta o nei primi anni Ottanta, Oreste del Buono si scandalizzò per un’affermazione di Renato Giovannoli, il quale diceva (mi pare) qualcosa come: che i Peanuts erano una metafora della vita, mentre Doonesbury centrava la nostra condizione contemporanea, e per questo lo preferivamo. Giovannoli, all’epoca, voleva certamente essere provocatorio; ma la sua provocazione riguardava un po’ tutti noi giovinastri, che ci sentivamo rappresentati al momento più da Trudeau che da Schulz.
Il motivo di tutto questo, io credo, non riguardava tanto chi fosse più bravo tra Schulz e Trudeau, ma, molto più banalmente, che Schulz rappresentava per noi i nostri padri (quelli intelligenti), e noi comunque dovevamo distaccarcene.
A tutt’oggi continuo a percepire i Peanuts come un lavoro perfetto, così completo, coerente, coeso, che quasi non lo si può toccare. Continua a ergersi davanti a me come la norma che definisce il fumetto ideale, così ideale che fatico anche a parlarne, perché non si può parlare che per differenze, ed è rispetto a Peanuts che si definiscono le differenze di tutti gli altri.
E’ ovvio che non è così, e che il lavoro di Schulz si basa su un’ossessività e un minimalismo che lo tengono ben lontano dalla monumentalità. Quando mi immergo nella lettura delle sue strisce, è comunque un piacere. Ma quando ci penso in astratto, quello che prevale è questo senso di intoccabilità. Forse, benché se lo sia meritato, Schulz è stato davvero troppo celebrato.
O forse è stato troppo celebrato dalla generazione dei miei padri; e Freud ci insegna che non si finisce mai di ucciderli – tantopiù quanto più li si ama.
Charlie Brown ha sessant’anni. Domani Eco lo celebra insieme alla moglie di Schulz. I miei migliori auguri al mito dei miei padri dentro cui sono cresciuto anch’io!
19 Marzo 2010 | Tags: audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, mito, mitologia, oralità, radio, rito, scrittura, sistemi di scrittura, televisione, Theodor H. Nelson, Tim Berners-Lee, visivo/sonoro, Web 2.0, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, sistemi di scrittura, Web e multimedia | A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono.
La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia.
Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa.
L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro.
L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro.
Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte.
Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci.
Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane.
Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei.
Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere!
(questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura)
Ricevo da Fandango Libri, fresco di stampa, Astarte, di Andrea Pazienza. Anche se non vorrei dedicare i post di questo blog a fare recensioni, questo è un caso particolare. a cui vale la pena di dedicare qualche riga. Lo è perché Pazienza è stato un grande fumettista, è morto giovane, e questa accoppiata lo ha reso un mito mediatico. Per questo, qualunque cosa si pubblichi o ripubblichi di suo sembra destinato a vendere.
Pazienza è stato un fumettista di grande originalità, non un semplice disegnatore, uno che aveva non solo un segno spettacolare e una stupefacente capacità narrativa, ma anche doti di impaginazione e costruzione grafica della pagina. E il fumetto è fatto anche di questo.
E’ proprio per questo che trovo che il libro pubblicato da Fandango sia un’offesa a Pazienza e al fumetto. Il mitico Apaz non ha mai disegnato quelle robe che vediamo pubblicate lì: è come se si pubblicasse la Divina Commedia mettendo un verso per pagina, e si pretendesse di fare un servizio a Dante!
Dividere così le pagine significa uccidere il lavoro di Pazienza. Certo che emerge il disegno! Ma ci sono tanti altri modi rispettosi per farlo. Meno pagine, e molto più grandi, per esempio, in modo da contenere le tavole intere! Ma poi, certo, i librai non sanno dove metterlo, e non si vende.
Che questo libro sia fatto prima di tutto per vendere lo mostra benissimo la confezione, certamente accurata, con la prefazione ben ostentata di Roberto Saviano, che è uno i cui meriti sono innegabili, ma cosa ci azzecca con Pazienza? E a che serve la lunga appendice sulla storia di Annibale, se non a fare un po’ di pagine, visto che persino ridotto così, una vignetta per pagina, il lavoro del povero Pazienza non è lungo a sufficienza per giustificare la spesa dell’acquisto?
Che idea si farà di Pazienza chi non avesse mai visto l’originale, pubblicato a suo tempo sulla rivista Comic Art? Visto che già in Pompeo aveva fatto pagine di una sola vignetta, probabilmente starà facendo lo stesso anche qui. Ma come mai qui il segno è più grosso in un disegno e più sottile in un altro? E come mai certi disegni sono fatti di poche grosse righe, e altri sono pieni di dettagli e di linee? Potenza degli ingrandimenti e delle riduzioni, per cui cose che nell’originale erano molto piccole o molto grandi, qui si trovano ad avere la stessa dimensione!
Insomma, si tratta semplicemente di un falso, e solo nell’ultima riga della postfazione di Marina Comandini, nell’ultima pagina, si dice che “in questa edizione ci siamo permessi di scorporare la struttura originale delle tavole”. Ma se si fosse onesti, e davvero interessati a valorizzare il lavoro di Pazienza – e non potendo, per ragioni commerciali, utilizzare un formato troppo grande – perché non usare lo spazio dedicato a quell’inutile biografia di Annibale per far vedere, almeno in piccolo, la struttura originale delle pagine? Si sarebbe salvata la qualità del segno grafico, ma almeno si sarebbe avvertito il lettore del prezzo che si stava pagando.
I post di Luca Boschi avevano creato in me molte aspettative. Ma ho troppa stima di lui per pensare che li abbia scritti avendo già visto il libro. Presumibilmente avrà avuto la notizia e avrà pensato bene di divulgarla, come avrei fatto anch’io al suo posto, e chiunque altro ami il lavoro di Pazienza.
L’impressione, decisamente sgradevole, che mi resta, è che le spoglie di Pazienza siano un po’ come quelle del maiale: non se ne butta via nulla.
17 Marzo 2010 | Tags: Amelia Rosselli, Dante Alighieri, endecasillabo, enjambement, Francesco Petrarca, Giovanni Della Casa, metrica, petrarchismo, poesia, risoluzione, tensione, Ugo Foscolo, verso | Category: poesia | Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro?
La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no).
La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:
- l’inizio e (soprattutto) la fine di un verso sono luoghi di rilievo: quello che capita in queste posizioni viene enfatizzato rispetto a quello che si trova nella parte centrale del verso;
- di conseguenza, un verso molto breve enfatizza molto il suo contenuto (che si trova al contempo all’inizio e alla fine del verso);
- la coincidenza tra la clausola metrica (data dal verso) e quella sintattica (data dal periodo, dalla proposizione o dal sintagma compiuto) ha impostazione conclusiva: ne farò uso se voglio enfatizzare la cesura tra un verso e l’altro (e tra una clausola sintattica e l’altra), ottenendo un ritmo diviso; la eviterò se invece voglio minimizzare le cesure, ottenendo un ritmo più fluido;
- le forme regolari sono come la tonica nella musica tonale: un luogo di risoluzione della tensione; finché voglio mantenere la tensione devo mantenere irregolare la forma, e spezzare il verso in modo che lo sia; la regolarità, viceversa, è conclusiva. Posso fare uso dei versi più anomali in una poesia, ma un bell’endecasillabo con accenti sulle sillabe 4 e 6 darà l’impressione di un punto di arrivo, parziale se la sintassi non lo conferma, totale se anche sintatticamente si arriva in fondo;
- quest’ultima regola è particolarmente importante quando si fa uso di versi della stessa lunghezza (cioè non versi liberi): il gioco tra le versioni non canoniche e quelle canoniche del verso che stiamo usando crea tutta la tensione metrico-sintattica della poesia. In questo senso la presenza dell’enjambement permette di rendere forme irregolari anche i versi più canonici, inserendo nel gioco un’ulteriore variabile.
Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso.
Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558):
Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due
brevi e notturne ore trapassa, oscura
e fredda; involto avea fin qui la pura
parte di me ne l’atre nubi sue.
Or a mirar le grazie tante tue
prendo: ché frutti e fior, gelo ed arsura,
e sí dolce del ciel legge e misura,
eterno Dio, tuo magisterio fue.
Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce
chiara, che ‘l mondo a gli occhi nostri scopre,
traesti tu d’abissi oscuri e misti.
E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce,
di tenebre era chiuso, e tu ‘apristi;
e ‘l giorno e ‘l Sol de le tue man son opre.
Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato.
Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73):
Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a
graffiare la mia porta d’entrata, a
guarire il mio misterioso non andare
non potere andare in alcun modo con
gli altri. Come fai? Mi sorvegli e
nel passo che ci congiunge v’è soprattutto
quintessenza di Dio; il suo farneticare
se non proprio amore qualcosa di più
grande: il tuo corpo la tua mente e
i tuoi muscoli tutti affaticati: da
un messaggio che restò lì nel vuoto
come se ad ombra non portasse messaggio
augurale l’inquilino che sono io: tua
figlia, in una foresta pietrificata.
In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario.
(come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui)
Il genere musicale del Notturno fu inventato da John Field (1782-1837), ma fu il “plagiario” Frederik Chopin (1810-1849) a passare alla storia per i suoi Notturni. Basta ascoltarli e non è difficile capire il perché: davvero plagio?
Harold Bloom ha scritto nel 1973 un bellissimo libro (The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry) sul difficile rapporto che ogni autore ha con gli autori che lo hanno ispirato: e, ovviamente, degli ispiratori ci sono sempre.
 Job vs McCay (da Fumettologicamente) Riallacciandosi alla polemica di qualche giorno fa sull’origine del fumetto, Matteo Stefanelli rende nota una scoperta sul plagio operato da Winsor McCay nei confronti di (almeno) due autori francesi di qualche anno prima: Rip e Job. Le immagini che vengono mostrate sul suo blog esibiscono una somiglianza che non si può contestare: penso che non ci siano dubbi sul fatto che McCay si sia fortemente ispirato a quelle pagine. Tanto più che, sul suolo americano, le probabilità che qualcuno si accorgesse della somiglianza con una pagina di giornale francese di venti anni prima erano davvero irrilevanti.
Ma fa bene Stefanelli a insistere sul fatto che nulla di tutto questo sminuisce il valore di McCay. Basta osservare la comparazione stessa di immagini che ci dimostra il plagio, per rendersi conto perché McCay sia passato alla storia e Job no.
Continua a essere dominante la convinzione che il cuore di un testo narrativo sia la storia raccontata, e che chi copia la storia copia il testo stesso. A partire da Shakespeare, dunque, gran parte degli scrittori e commediografi di tutte le epoche sarebbero dei plagiari. In verità, la storia raccontata è solo uno degli elementi che contribuiscono al fascino di un’opera, e spesso nemmeno il principale. La medesima storia è interessante nella pagina di Job e favolosa in quella di McCay. E la differenza sta in una concezione radicalmente diversa del rapporto tra sequenza di vignette e spazio della pagina, del tutto tradizionale in Job, ed estremamente innovativo in McCay. (Meglio, da questo punto di vista, il lavoro di Rip: ma l’abisso rimane)
Puntualizzato questo, l’influenza c’è, indubbiamente. E McCay ha indubbiamente visto quei lavori e li ha utilizzati come punto di partenza dei suoi. Il che non sposta di una virgola i termini della polemica sulla nascita del fumetto.
Anzi, forse li sposta. Mi viene voglia di proporre di posticipare di 10 anni la data convenzionale di origine del fumetto, dal 1895 (o ’96) al 1905, anno dell’uscita di Little Nemo. Lì sì che succede qualcosa di nuovo, e non solo nel sistema di produzione e consumo!
Permettetemi una (sentita) divagazione. Incrocio questo articolo interessante su Nazione Indiana, e, pur approvando incondizionatamente quello che c’è scritto (compresa l’ammirazione per l’impegno sociale di Émile Zola), mi permetto di aggiungere una piccola riflessione personale sul miracolo e sulla religione.
Zola dubitava (ragionevolmente) della verità dei miracoli che avvenivano (e avvengono) a Lourdes. Ne dubito anch’io. Ma supponiamo per un attimo che siano veri, e che ci siano veramente delle guarigioni inspiegabili in quel luogo. Che cosa ne consegue? Che esiste Dio? Non sappiamo neanche come facciano a esistere i buchi neri, ma nessuno prende questo come prova dell’esistenza di Dio.
Allora il miracolo sarebbe non solo qualcosa per cui non abbiamo una spiegazione naturale, ma qualcosa per cui non abbiamo una spiegazione naturale e che non appartiene a una categoria di fatti inspiegati del medesimo tipo? Come dire, se succede regolarmente non è un miracolo (è solo qualcosa per cui non è ancora stata trovata una spiegazione), mentre se succede una tantum lo è. Ma le guarigioni di Lourdes appartengono a una categoria: sono tutte guarigioni che accadono a Lourdes.
Prima di tirare in ballo la divinità, bisognerebbe saperne molto di più di quanto ne sappiamo sui processi naturali. C’è stato un tempo in cui i vulcani e i terremoti erano manifestazioni del divino: come facciamo a dire che un domani non potremo spiegare naturalisticamente le guarigioni improvvise? (sempre che esistano, certo) Magari a Lourdes valgono alcune regole fisiche differenti; e magari ci sono altri posti in cui succede lo stesso.. Che oggi qualcosa ci appaia inspiegabile non comporta che sempre quel qualcosa resterà inspiegabile.
Il fatto è che le guarigioni improvvise colpiscono l’immaginario popolare assai più dei buchi neri; e hanno un legame mitico con un’idea primitiva di divinità, che si manifesta frequentemente nel mondo. Ma una divinità che si manifesta frequentemente nel mondo mi pare più vicina a Zeus e Apollo che non al Dio delle religioni monoteiste. Una divinità che si manifesta nel mondo ne è inevitabilmente parte, e quindi può certamente essere un dio che ci guarda dall’alto, ma non il Dio onnipotente e onnisciente.
Insomma, sempre che esistano, i miracoli di Lourdes sono la prova che ci sono un sacco di cose ancora da imparare del mondo che ci circonda, compreso – magari – che esistono gli dei dell’Olimpo, del Wahlalla, o di qualche altro empireo; o che magari a Lourdes stesso abita uno di questi dei. Non sono certo la prova che il papato dice la verità (e tutto questo indipendentemente dal fatto che il Dio monoteista esista o meno, e che ci crediamo o meno).
Oppure (tanto per restare in tema cristiano) se in realtà fosse il diavolo a compierli? Penso che molto dipenda da quello che noi vogliamo credere. D’altra parte, questo è anche il limite della stessa conoscenza scientifica.
14 Marzo 2010 | Tags: Alan Moore, episodi, fumetto, graphic novel, Hugo Pratt, romanzo, semiotica, serialità, Una ballata del mare salato, Watchmen | Category: fumetto, semiotica | Evidentemente non è la stessa cosa leggere una storia tutta di un fiato (come di solito facciamo guardando un film), o al massimo con pause che siamo noi a scegliere, anziché leggerla a episodi con cadenza mensile, settimanale, o magari quotidiana. La scansione periodica impone alla lettura una serie di iati, e richiede quindi al lettore che inizia a percorrere un nuovo episodio di ricordare per quanto possibile gli episodi precedenti.
Di conseguenza, evidentemente, non è la stessa cosa scrivere una storia che debba essere letta tutta di un fiato (o con le pause che il lettore stesso si sceglie), e scrivere una storia che debba essere fruita a episodi. Per quanto inserito nel percorso narrativo sia un episodio, esso deve avere anche elementi di autonomia: non deve magari racchiudere un’intera storia, ma deve però racchiuderne una fase che il lettore percepisca come dotata di senso. In altre parole, una buona organizzazione in episodi a uscita periodica non può tagliare il racconto a caso, ma solo in certi tipi di momenti, corrispondenti alla chiusura di fasi narrative: il lettore deve comunque uscire dalla lettura di un episodio con un certo senso di compiutezza – anche se la compiutezza completa richiede la fine della storia.
Questo requisito può valere anche per i capitoli di un romanzo a lettura continuata; ma solo in misura più debole. La divisione in capitoli è infatti solo un suggerimento di interruzione che viene proposto al lettore, il quale può seguirlo oppure no – mentre quando la pubblicazione stessa è a episodi, il lettore non ha scelta.
Sappiamo che la pubblicazione di storie a episodi ha ragioni editoriali e storiche. Dall’epoca del romanzo d’appendice ottocentesco, ogni editore sa che il lettore è spesso più disposto a pagare una cifra minima periodicamente che non una cifra più considerevole una volta tanto. E l’editore sa anche che il medesimo romanzo pubblicato a episodi può poi essere ristampato in volume per raggiungere anche un diverso tipo di pubblico.
Così l’autore di un romanzo a episodi sa che deve rivolgersi a due pubblici diversi, caratterizzati da due modalità di fruizione differenti: periodica l’uno, unitaria l’altro. Dev’essere molto bravo per riuscire a costruire una narrazione in cui gli elementi che servono al primo tipo di pubblico (che ha bisogno di ripetizioni all’inizio di ogni episodio che gli rammentino il già accaduto, e che si attende un qualche tipo di chiusura a ogni fine di episodio) non infastidiscano il secondo (che invece chiede al racconto di fluire, e non ha bisogno di enfatizzare le conclusioni di capitolo). Il bravo narratore, in situazioni di questo genere, è quello che riesce a costruire un ritmo narrativo che regga entrambe le possibili letture.
In subordine, è possibile decidere di privilegiare una situazione rispetto all’altra. Prima che venisse di moda la graphic novel, il fumetto di supereroi americano ha tranquillamente privilegiato la lettura periodica. D’altra parte, tanto per restare nell’universo del fumetto, tante storie pubblicate a suo tempo con scansione settimanale o mensile sono ormai da molti anni fruite solo in modalità unitaria, ed è quasi impossibile dire dove si trovassero le cesure originarie: valga per tutte l’esempio della Ballata del mare salato di Hugo Pratt.
Il migliore esempio a fumetti, però, di scansione a episodi riciclabile in romanzo unitario è sicuramente Watchmen, di Alan Moore. Lo cito anche per inserirmi in una polemica che ho incrociato andando per blog non lontano da qui. Non c’è dubbio infatti che Watchmen sia una miniserie di dodici episodi a scansione mensile, che rispetta pienamente i requisiti del raccontare per episodi. Ma è proprio l’argomento del racconto a permettere a Moore di far sì che il pubblico possa reinterpretare e accettare positivamente la scansione anche in una lettura continuata. “Watchmen” non vuol dire solo “guardiani”, ma anche “uomini dell’orologio”, e la scansione del tempo è il vero leitmotiv, o tormentone, del racconto di Alan Moore. La scansione degli episodi diventa scansione delle fasi narrative nella versione graphic novel, e il ripercorrere continuamente, da diversi punti di vista, i medesimi episodi del passato dei personaggi, assolve alla funzione mnemonica per i lettori periodici, ma introduce comunque continuamente elementi di novità, in modo da essere appassionante anche per il lettore unitario. Il fatto di avere non un protagonista, bensì un gruppo di protagonisti, permette ad ogni episodio di avere una sua unità, essendo centrato su un personaggio specifico – ma questo continua ad avere senso anche quando gli episodi vengono letti di seguito.
Magari proprio lavorando su Watchmen, ci si potrebbe rendere conto che il fascino di questo testo non sta solo nel racconto che contiene, ma anche (e soprattutto) nel modo in cui questo racconto viene disvelato ai lettori (dell’un tipo come dell’altro). Rendersi conto di questo significa già rendersi conto che, per quanto importante il racconto sia, non è che un mezzo, e che il fascino e il senso complessivo di un romanzo si trovano altrove. A parità di racconto, dunque, le diverse modalità di lettura possono produrre effetti di senso molto differenti. Magari ugualmente validi, come nel caso del nostro esempio, ma nondimeno differenti.
In risposta a Marco D., che mi ha mandato un commento al post precedente sollevando il tema di cui si parla qui, posso dire che sì, certo, la natura del formato incide, e come. E bisognerebbe studiarlo di più. Un po’ l’avevo fatto anch’io per il tema della temporalità nel comic book di supereroi, nella mia tesi di dottorato Tempo, immagine, ritmo e racconto, che si può comunque scaricare da qui.
9 Marzo 2010 | Tags: comunicazione visiva, Denise Schmandt-Besserat, fumetto, graphic design, graphic novel, I linguaggi del fumetto, Mesopotamia, musica, oralità, origine della scrittura, poesia, romanzo, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, musica, poesia, sistemi di scrittura |  Denise Schmandt-Besserat, "How Writing Came About", University of Texas Press 1996 C’è un bellissimo libro di Denise Schmandt-Besserat leggendo il quale si fanno delle singolari scoperte sulla natura della comunicazione visiva, sulla sua origine e sul rapporto con la scrittura. Sostanzialmente, vi si racconta come, a partire dal IX millennio a.C., in Mesopotamia venga adottato un sistema di contrassegni di creta, di semplice fattura e forme diverse (ci troviamo ancora nel Neolitico!) per contabilizzare i beni (pecore, grano, olio ecc.). Qualche millennio dopo, per ragioni di organizzazione della contabilità, si inizia a rinchiudere questi contrassegni, a gruppetti, in bullae di creta. E poiché queste sono chiuse e si possono aprire solo rompendole, si incomincia a disegnare sulla loro superficie la forma e il numero dei contrassegni contenuti.
 Alcuni dei contrassegni di cui si parla  Una tavola di classificazione dei contrassegni Qualche secolo dopo, qualcuno si accorge che non c’è bisogno in verità né delle bullae né dei contrassegni per operare registrazioni, ma è sufficiente utilizzare su una tavoletta piana di terracotta quei medesimi segni disegnati. Si noti che i contrassegni (e quindi i segni che li rappresentano sulla superficie), non sono figurativi, se non in pochi casi. Per contabilizzare tre pecore, si marcano dunque tre cerchi crociati (immagini del dischetto crociato che era il contrassegno per una pecora).
 Un esempio di tavola, che registra 33 misure di olio Intorno all’anno 3.100 a.C. qualcuno si accorge che può essere più comodo registrare i beni in un altro modo: invece di disegnare p.e. 23 segni di pecora, si può fare un solo segno di pecora, accompagnato da due segni rotondi (ciascuno corrispondente a una decina) e tre segni lineari (ciascuno corrispondente all’unità). Si verificano così due fatti cruciali al tempo stesso: per la prima volta si dà espressione al numero come concetto astratto (cioè “23” e non “23 pecore”), e il cerchietto crociato cambia significato (non vuol più dire “una pecora” bensì, più astrattamente “pecora” o “pecore”).
Nei secoli immediatamente successivi c’è un grande sviluppo, in Mesopotamia, della contabilità legata a questi principi. Ci sono rimaste, infatti, tantissime tavolette di creta con registrazioni di questo tipo.
Questo ci fa capire tre cose:
1. la scrittura nasce per risolvere problemi di amministrazione contabile
2. non si fa contabilità se non con un supporto visivo
3. la scrittura nasce attraverso un processo che è del tutto indipendente dalla parola orale.
Schmandt-Besserat ci racconta a questo punto che intorno al 3.000 a.C. qualcuno si accorge che esiste un modo per registrare i nomi dei possessori delle merci sulle tavolette di creta. Mi spiegherò con un esempio: “uomo”, in sumero, si dice lu e “bocca” si dice ca; se Luca fosse un nome sumero, lo si potrebbe registrare facendo uso del segno per uomo (pittografico o convenzionale che sia) seguito dal segno per bocca: lu-ca.
Questo è il punto di partenza della scrittura come registrazione della parola parlata. Ma il passo successivo non lo fanno più i contabili, bensì i sacerdoti, i quali, circa mezzo millennio dopo, iniziano a scrivere, con questo sistema, delle preghiere sulle offerte che accompagnano i defunti. Già nel 2.400 a.C. il sistema si trova però usato anche al di fuori dei riti mortuari, per registrazioni onorifiche di tipo storiografico.
Si noti che preghiere e litanie, che sono i primi tipi di testi che vengono trascritti, sono certamente all’epoca di cui stiamo parlando dei testi metrici, fatti per essere cantati. In una cultura orale, infatti, tutto quello che richiede di essere ricordato e tramandato ha questa forma.
La scrittura nasce dunque, in senso largo, in relazione alla contabilità; e, in senso stretto, in relazione alla musica. Nel primo caso permette davvero un nuovo tipo di organizzazione concettuale del mondo; nel secondo caso permette la memorizzazione di situazioni rituali con componenti ritmiche (e a questo proposito è esemplare il caso dei Greci, che nell’ottavo secolo a.C. adottano la scrittura dai Fenici per perpetuare i propri canti epici, primi tra tutti quelli omerici).
In tutti i casi, il racconto, che certamente come forma orale esiste già da lungo tempo, entra nella scrittura solamente dopo, e – almeno per un po’ – solo nella misura in cui si inserisce in dinamiche contabili o in situazioni rituali.
Dove voglio arrivare? Be’, intanto a far vedere come la scrittura possa esistere anche in maniera del tutto indipendente dalla parola, come un sistema diversamente potente e parallelo, un sistema unicamente grafico.
E poi, magari anche per questo, voglio arrivare a far vedere come, quando si racconta facendo uso di un sistema di scrittura, o comunque di un qualsiasi tipo di comunicazione visiva (e dunque tanto a parole, come per immagini, o complessivamente a fumetti), quello che leggiamo non si risolve affatto nel semplice racconto. Se domina la componente visiva (come nelle tavolette sumere sino al IV millennio) c’è comunque un effetto di organizzazione plastica dello spazio che non è detto possa essere interamente risolto nel racconto (anche quando per molti versi lo è); se domina la componente di registrazione della parola orale (come in tutta la scrittura in senso stretto dal 2.400 a.C. in poi), c’è comunque un rinvio a un elemento ritmico e implicitamente rituale che è tipico delle situazioni orali e a sua volta non si risolve nel racconto.
Insomma, il romanzo (né quello verbale, né quello per immagini, o graphic novel) non è un semplice strumento per raccontare storie. Inevitabilmente, nel raccontare storie, il romanzo ci mette dentro altre cose, che non di rado sono più influenti e suggestive delle storie stesse. Ovviamente, oltre a raccontare, un romanzo per immagini tenderà a trasmettere cose diverse da quelle trasmesse da un romanzo per parole; e questo dipende dalla diversa natura del suo tipo di “scrittura”.
Quando, nel 1991, iniziavo I linguaggi del fumetto dicendo che i linguaggi non sono solo strumenti (per comunicare) ma anche e soprattutto ambienti (dentro cui nascono anche le idee, cioè quello che poi viene comunicato), stavo facendo un’affermazione dello stesso tipo. Il romanzo (verbale o grafico che sia) non è solo (e forse nemmeno principalmente) uno strumento per raccontare. Il racconto è solo una delle forme con cui un romanzo ci mette in condivisione.
Se poi dal romanzo si passa ad altre forme comunicative, come la poesia o la pittura, la dimensione narrativa si trova ancora di più in secondo piano – senza mai, comunque, scomparire del tutto, presumibilmente.
I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.
Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:
La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte.
Col mantello tutto blu
noci e fichi butta giù.
o anche, come abbiamo visto con Rubino:
Ha la zia dimenticata
la credenza spalancata:
Quadratino di soppiatto
v’entra lesto come un gatto.
Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).
Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:
Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia!
Chi vuol essere lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:
Viene viene la Befana
vien dai monti a notte fonda.
Come è stanca! La circonda
neve, gelo e tramontana.
Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.
Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.
…
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
…
Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.
Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.
Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?
La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.
Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.
Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.
E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.
Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.
Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.
7 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Antonio Rubino, comunicazione visiva, Corriere dei Piccoli, Fabio Gadducci, fumetto, Igort, metrica, nascita del fumetto, ottonario, poesia, verso | Category: comunicazione visiva, fumetto, poesia | A Bilbolbul mi sono abbuffato di mostre e incontri (compreso quello sul mio libro). Tutto interessante e di alto livello; talvolta ancora meglio. Gli effetti di quello che ho visto e udito prima o poi salteranno fuori, magari anche in questo blog. Per adesso voglio concentrarmi su un tema solo, perché credo di aver fatto una piccola scoperta.
Ieri (6 marzo) pomeriggio, Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli presentavano, insieme con Igort, il loro volume Antonio Rubino. Gli anni del “Corriere dei Piccoli”. Bello il libro, interessante la spiegazione e la discussione. A un certo punto è uscito il tema dell’ossessione di Rubino per la geometria, per le simmetrie e per le ripetizioni, e Igort è intervenuto con un’osservazione sulla natura un po’ ossessiva di tutta la produzione di Rubino.
A questo punto sono intervenuto anch’io, con un’osservazione che mi era divenuta sempre più evidente man mano che il loro discorso procedeva, e che ora esporrò ed espanderò qui.
Si tratta delle rimette. Le rimette sono un’invenzione tutta italiana, anzi, del medesimo Rubino (che inoltre, a quanto mi hanno poi assicurato Stefanelli e Gadducci, per lungo tempo la ha scritte per tutte le serie a fumetti del Corrierino). Negli altri paesi europei, lo standard era la sequenza di immagini accompagnata da una narrazione in prosa (come nell’esempio di Ally Sloper che  abbiamo postato qualche giorno fa). abbiamo postato qualche giorno fa).
Ora, perché Rubino spinge così fortemente verso l’uso del verso anziché del più assestato racconto in prosa? La spiegazione più naturale è quella di far riferimento alla tradizione dei cantastorie, che raccontavano in versi accompagnandosi con delle figure. Ma la spiegazione vale solo in parte, perché i cantastorie facevano presumibilmente uso di un altro tipo di verso, cioè l’endecasillabo, che è il verso epico della tradizione italiana, e magari addirittura l’ottava rima, che è quella dell’Orlando Furioso e dei poemi cavallereschi. L’ottonario è piuttosto un verso da canzonetta o da burla, proprio per la sua natura ossessiva, che mal si presta a raccontare.
Credo che la scelta di Rubino sia dovuta invece proprio alla natura non solo popolare, ma soprattutto ossessiva e “quadrata” dell’ottonario. È una scelta, in realtà, tutt’altro che popolare e ingenua (se non magari in seconda istanza): il versus quadratus, o dimetro trocaico, era il metro che i latini usavano, in età classica, per indovinelli, cantilene infantili, scherzi popolari. È caratterizzato dall’espansione di un modulo binario, con accento sulla prima sillaba: Tàta. Se raddoppiate questo modulo e poi lo raddoppiate ancora (Tàta tàta Tàta tàta) avete l’ottonario; se prendete l’ottonario e lo raddoppiate e poi lo raddoppiate ancora, avete le quartine di Rubino: “Ha la zia dimenticata / la credenza spalancata: / Quadratino di soppiatto / v’entra lesto come un gatto.” Più quadrato e ossessivo di così è impossibile.
Nel contesto di questa struttura iper-regolare Rubino inserisce le sue  narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento. narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento.
Ora, se osserviamo le sue figure vi ritroviamo la stessa strategia: un universo di invenzioni strampalate, trasmesse attraverso uno studio, decisamente geometrico, sulla ripetizione, sulla regolarità e sulla rima visiva! Una strategia dell’anti-reale costruita assemblando elementi di carattere opposto: assurdi e irregolari narrativamente, geometrici e iper-regolari strutturalmente.
Il fascino di Rubino sta probabilmente proprio in questa fantasmagorica gestione di opposti. La si vede persino nel suo stile grafico, insieme floreale e liberty da un lato, e geometrico-futurista dall’altro. Credo che Rubino non si sia mai riconosciuto in nessuna di queste correnti. Era abbastanza complesso da sé, evidentemente!
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|







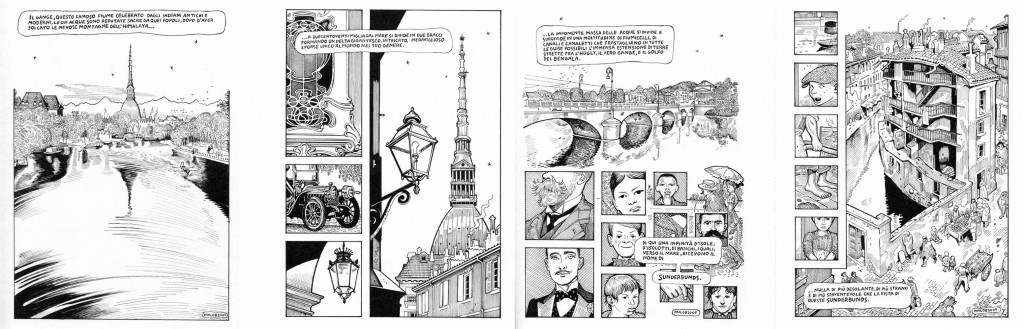
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco








Dei commenti sul contenuto (nei blog e altrove)
Spulciando nei blog di poesia, mi colpisce il fatto che la grande maggioranza dei commenti contengono sostanzialmente dichiarazioni di accordo con quello che la poesia dice (al massimo con l’aggiunta: “Come lo dici bene!”). Ho sempre trovato la cosa piuttosto irritante, sino a quando, con qualche riflessione, non ne ho capito il perché.
La cosa è irritante perché in questi commenti la poesia viene trattata come se fosse l’espressione di un’opinione, di un punto di vista; o come se rivelasse qualche verità nascosta. In altre parole, un post di poesia viene commentato esattamente come se fosse un post qualsiasi, proprio come questo che state leggendo (e rispetto al quale, se vi trovate d’accordo, io sarei ben contento che mi scriveste che lo siete). Ma queste parole che state leggendo ora sono state pensate per una relazione di scrittura-lettura parzialmente reciproca, dialogica, come quella di un blog; mentre la poesia non nasce per stare all’interno di una conversazione (piuttosto diretta) di questo tipo, e si trova pubblicata su un post semplicemente perché quello è un modo per pubblicarla – e potrebbe trovarsi pubblicata in mille altri modi (anche migliori, come sulle pagine di una raccolta a stampa).
Per dire la cosa in un altro modo, e con un paragone irriverente, è come se io raccontassi una barzelletta, e gli amici invece di ridere mi dicessero, con aria serissima, di trovarsi del tutto d’accordo con me (e che l’ho raccontata proprio bene!).
È invece più difficile da spiegare perché la mia irritazione al leggere questi commenti debba essere contenuta (e i commenti di approvazione tematica delle poesie debbano essere tutto sommato accettati). Una spiegazione che si basa su un’analogia interessante mi è balzata agli occhi stamattina, dopo che, attraverso Google Reader, mi erano arrivate due interessanti poesie, una dal blog specifico della sua autrice, l’altra citata da Luisa Carrada con sorpresa e complimenti.
Proviamo a pensare alla situazione di visitare un luogo condotti da un’altra persona. Se il luogo è davvero interessante possiamo tollerare anche che chi ci accompagna non lo sia ugualmente; se lo è, tutto è meglio, ma l’interesse del luogo in sé può essere sufficiente. Viceversa, se la persona che ci conduce è davvero interessante, può capitare che riesca a farci apparire a sua volta interessante persino un luogo che altrimenti non lo sarebbe; anzi può darsi che riesca a farci apparire interessante persino un luogo che conosciamo già benissimo, e che ritenevamo in precedenza privo di interesse proprio per questo.
Il luogo, nella nostra analogia, è ciò di cui un testo parla. In un testo di prosa critica (proprio come questo post) quello che cerchiamo è l’interesse del tema e delle riflessioni al proposito: il modo in cui è scritto (ovvero, nella nostra analogia, chi ci accompagna) può aiutare o può respingere, ma l’attenzione di chi legge non è rivolta lì. I testi poetici, viceversa, ci mostrano non di rado luoghi (cioè temi) che conosciamo benissimo (e sappiamo tutti perfettamente che è bello ricordare quando eravamo bambini e correvamo in giro, e chi scrive sa benissimo quali siano i propri entusiasmi e i propri scoramenti), ma è la scrittura che ci accompagna laggiù a fare tutta la differenza: è la scrittura a farci percepire come nuovi e interessanti quei luoghi stranoti!
È molto più facile commentare dei luoghi che della scrittura. Dire, nel commento di un post, che siamo d’accordo è come dire che quel luogo ci piace. Chi scrive poesia, viceversa, si aspetta che sia apprezzata la propria conduzione, la propria scrittura, il proprio stile. Ma la maggior parte dei commentatori vedono solo il tema, e si sentono d’accordo con quello. Spesso nemmeno si accorgono che quel medesimo tema, espresso con altre e meno interessanti parole, non avrebbe sollevato in loro il minimo interesse: sono capacissimo anch’io – si direbbero – di ricordare la mia infanzia, e di comprendere le mie emozioni di scrittore!
Bisognerebbe lodare l’accompagnatore, e invece si celebra il luogo. Ma noi che leggiamo quei commenti dobbiamo capire che il luogo è piaciuto perché chi vi ha portato il lettore ha saputo mostrarglielo come il lettore non l’aveva mai visto.
Peccato che talvolta i medesimi apprezzamenti vengano espressi dai lettori nei confronti di versi dove ci sarebbe davvero poco da apprezzare! Magari in quei contesti si loda il luogo semplicemente per non doversi esprimere sull’accompagnatore? E come distinguere allora questo caso dal precedente?
L’analogia, sviluppata qui sulla contrapposizione tra prosa critica e poesia, è facilmente allargabile alla prosa letteraria, al raccontare a fumetti, al cinema, e così via. Chi sa usare il proprio linguaggio, e sa far sì che i propri segni (verbali o visivi che siano) mostrino un’altra faccia delle cose, può davvero raccontare qualsiasi cosa, e farne emergere i motivi di interesse!