Difficile sfuggire al fascino delle storie e dei personaggi di Hugo Pratt, Corto Maltese per primo (ma tutt’altro che unico). Un fascino che si fa sentire persino nelle storie che non scriveva lui, nell’Argentina degli anni Cinquanta. Il sospetto che questo fascino si basi sulla sua capacità grafica ha, proprio per questo, evidentemente un fondamento. Ma non è tutto lì.
C’è un filo comune al Sgt. Kirk scritto da Hector Oesterheld e al Corto Maltese interamente prattiano. Sarà perché la sorte ha avvicinato Pratt a sceneggiatori che gli assomigliavano, o sarà perché da questa vicinanza Pratt ha imparato strategie non più in seguito dimenticate, e messe acutamente a frutto; o sarà forse un po’ l’una e un po’ l’altra cosa. Di fatto il disertore Kirk è un Occidentale che vive con gli Indiani, uno straniero, insomma, un po’ come il marinaio nato a Malta che fa l’avventuriero nei mari del sud, e che poi si ritroverà in sud-America, in Cina e Siberia, in Africa, in Irlanda, in Turchia e ancora altrove, ma mai e poi mai a Malta o davvero a Venezia, se non nei sogni.

Questa identità di escluso, di diverso, di appassionato dilettante della non appartenenza, amichevole con gente di ogni cultura, però mai davvero a casa propria, sempre sul punto di partire di nuovo e mai di ritornare, questa identità di irrimediabile straniero, insomma, si trova al centro dell’indagine di Stefano Cristante nel libro Corto Maltese e la poetica dello straniero. L’atelier carismatico di Hugo Pratt(Mimesis 2016).
Non ha naturalmente torto, Cristante, a iniziare…
Continua qui, su Fumettologica.
Le accurate e raggelate geometrie di Chris Ware mi hanno spinto più volte ad accostarlo a Piet Mondrian (per esempio qui, ma se volete leggere gli interventi in ordine partite dal fondo). C’è però una differenza cruciale tra i due.
Mondrian, che era uno spiritualista vicino all’antroposofia di Rudolf Steiner, concepiva positivamente le proprie astrazioni geometriche: le forme curve, e persino la diagonale, andavano escluse dalla composizione perché evocavano situazioni instabili, e quindi potenzialmente dinamiche. La composizione equilibrata di puri elementi formali garantiva, nella sua eterna immobilità, di esprimere una spiritualità umana che alla natura e alla sua imitazione artistica erano negate. Gli equilibri perfetti e immobili di Mondrian hanno quindi qualcosa di mistico, di ultraterreno, di divino. Ma attraverso di loro l’artista (e lo spettatore con lui) può contemplare la spiritualità, può innalzarsi a una dimensione superiore.

Piet Mondrian, Composition with Red, Blue, and Yellow, 1930, olio su tela, 46 x 46 cm (Kunsthaus Zürich)
Al di là delle analogie visive, Ware non potrebbe nemmeno ipotizzare una intemporalità così estrema. Per quanto particolari siano, i suoi lavori sono comunque fumetti, cioè narrazioni per immagini, e il tempo, lo sviluppo, il movimento, la tensione vi sono impliciti e intrinseci.
Il punto è che tra Mondrian e Ware sono passati parecchi decenni, e la stessa nozione di funzionalismo, cruciale per entrambi, ha cambiato faccia. Per Mondrian il funzionalismo poteva ancora essere un’utopia, da portare avanti e da realizzare insieme con i compagni di strada della rivista De Stijl, come punta avanzata di un processo diffuso in Occidente cui partecipavano architetti americani e francesi (da Lloyd Wright a Le Corbusier), pittori e grafici russi (da Malevich a Lissinsky), sino a tutta la grande impresa del Bauhaus. Era l’utopia del progresso guidato dalla razionalità umana, che si manifestava nell’idea del progetto, nell’abbandono degli stili tradizionali, nella presunzione di poter progettualmente costruire un mondo migliore.
Di fatto, i capolavori realizzati davvero…
Continua qui, su Fumettologica.
17 Novembre 2016 | Tags: fumetto, Fumettologica, Gipi | Category: fumetto |
Dopo la storia che non è una storia, ma due o più, di Unastoria, Gipi torna a raccontare una storia che è davvero una, e fila diritto dall’inizio alla fine. Solo che la fine, stavolta, c’è già stata. Anzi, la Fine, la Fine del mondo. La palude pure c’era già stata, nelle storie di Gipi, e anche già associata all’Apocalisse: ne Le facce nell’acqua, i protagonisti sono scappati dalla guerra, e stanno in un casotto in mezzo all’acqua, mentre sopra di loro passano i bombardieri che vanno a scaricarsi sulla città. Non è chiaro se le facce, che vengono scorte a mezzo metro sotto l’acqua, siano reali o frutto della suggestione del luogo.

Nel libro uscito a ridosso di Lucca Comics & Games 2016, la palude è La terra dei figli, un luogo terribile, abitato da una sfilacciata comunità di pochi sopravvissuti, che si guardano in cagnesco e diffidano l’uno dell’altro, perché le risorse sono scarse e spesso avvelenate. Non è chiaro in che cosa sia consistita l’apocalisse, ma il mondo che conosciamo noi non c’è più, e quello che resta è miseria, ignoranza e durezza. La durezza necessaria che il padre insegna ai figli affinché siano in grado di sopravvivere, e i figli – protagonisti della storia – non sanno nemmeno cosa sia una carezza, e non conoscendola credono di non sentirne il bisogno.
Questa volta la storia è davvero una storia…
Prosegue qui, su Fumettologica.
9 Novembre 2016 | Tags: Al Feldstein, Bernard Krigstein, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Bernard Krigstein e Al Feldstein, Master Race, pagina 8, 1955 Questo mese facciamo un netto salto nel tempo, e torniamo al 1955. È un momento drammatico nella storia del fumetto americano. Per evitare l’approvazione di una legge che poteva essere anche più repressiva, gli editori si inventano il comics code, un codice di autoregolamentazione che garantisce la moralità di quello che viene pubblicato. Ed è un momento drammatico in particolare per le edizioni E.C., che, sino a poco tempo prima, avevano costruito la propria fortuna sui fumetti di guerra dai contenuti crudi e soprattutto sugli horror.
Contenuti crudi e horror non vuol dire necessariamente bassa qualità. Al contrario, sulle testate di William Gaines disegnavano e raccontavano dal 1947 i migliori autori americani di quegli anni, a partire da Harvey Kurtzman, ben da prima di inventarsi Mad, poi, nel 1952. Non solo: Gaines era particolarmente attento a valorizzare i propri autori; ogni storia era firmata, e ogni numero delle varie riviste conteneva una pagina di approfondimento su un autore. Una bella differenza rispetto a quello che succedeva in altre case editrici, come la D.C. per esempio, nei cui fumetti bisognerà aspettare gli anni Ottanta per conoscerne i nomi degli autori!
Nel tentativo di crearsi un nuovo mercato (a parte Mad, che andava a gonfie vele) la E.C. decide dunque di buttarsi sulla qualità, e pubblica nel 1955 diverse nuove testate, chiaramente rivolte a un pubblico adulto e intellettuale. Il tentativo dura in verità pochi mesi. Alla fine Gaines rinuncerà definitivamente e si limiterà a pubblicare Mad.
È sul primo numero di una di queste testate, Impact, che esce la storia “Master Race”, firmata da Bernard Krigstein, di cui potete leggere qui a fianco l’ultima di otto pagine. Va detto, incidentalmente, che si tratta di una delle prime storie a fumetti in cui il tema è l’Olocausto, ma il merito di questo va all’autore del soggetto e dei testi, il capo-redattore Al Feldstein. In verità, Feldstein aveva preparato per Krigstein una struttura rigida di sei pagine, che Krigstein avrebbe dovuto semplicemente riempire con le immagini adeguate. Ma Krigstein non ci sta, non ci si ritrova proprio in quello schema. Dopo molte ambasce creative (e discussioni con Feldstein e Gaines) riesce a ottenere due pagine in più.
Il protagonista della storia è un ex-ufficiale nazista che si è rifatto una vita in America, dove nessuno lo conosce. La storia inizia con lui che sale sulla metro, mentre una voce da flusso di coscienza lo martella con le sue inquietudini e i suoi ricordi. È così che veniamo a sapere le prime notizie su di lui, e, con la disfatta tedesca, della sua fuga in borghese dall’esercito, approdata infine in America.
Alla prima fermata sale un uomo vestito di scuro con la bombetta e si siede leggendo il giornale. L’ex-nazi lo riconosce come qualcuno che potrebbe riconoscerlo, e fargli del male, ma non ne è certo e non sa cosa fare. E qui parte l’ossessione dei ricordi, e vediamo la Germania nazista, e le persecuzioni degli ebrei, e poi i campi di sterminio con le loro atrocità, sino al ricordo specifico, a guerra pressoché finita, con i sovietici alle porte, di un uomo che gli promette minacciosamente che lo ritroverà.
Il flashback si conclude e l’uomo con la bombetta alza gli occhi, riconoscendo effettivamente il tedesco. Questi, spaventatissimo, approfitta della fermata del treno e si butta fuori dalla porta, inseguito dall’altro. È solo adesso che il flusso di coscienza ci fa scoprire che il nostro protagonista era stato addirittura il comandante di un campo di sterminio.
L’inseguimento prosegue nell’ultima pagina, quella che avete davanti agli occhi (se leggete l’inglese non è difficile trovare – con poca ricerca – l’intera storia sul Web). Qui, come vedete, il tedesco scivola, nella sua corsa, su un foglio di carta e cade sui binari proprio mentre arriva il treno, sotto gli occhi dell’altro. Ai passeggeri che scendono e chiedono cos’è successo, l’uomo con la bombetta risponde “Non so. È saltato fuori davanti a me e ha iniziato a correre! Ha attraversato il marciapiede e poi è saltato sotto le ruote del treno che veniva in direzione inversa.” E poi alla domanda “L’aveva mai visto prima”, la risposta è “No! Era un perfetto sconosciuto…”
Credo di non aver mai capito bene cosa intenda dire Boris Battaglia quando sostiene che i fumetti si guardano, non si leggono. Quello di cui però sono convinto è che se non si impara a guardare le pagine (e le vignette), la lettura di un fumetto sarà sempre spaventosamente povera.
A guardare questa pagina, ancora prima di leggerne la sequenza, si vede subito che c’è differenza tra le prime due strisce, basate sulla ripetizione, e la terza, dove la ripetizione non c’è. Ancora prima di iniziare a leggere, sappiamo che l’evento cruciale si consuma nelle prime due strisce. La differenza è ulteriormente marcata dalla differenza cromatica: le prime due strisce sono caratterizzate dall’alternanza tra i colori ocra del vestito del tedesco, i colori freddi del treno e dell’ambiente, il nero dell’uomo con la bombetta; viceversa, la terza striscia, dopo la varietà cromatica della prima vignetta, è una progressione verso il nero.
Leggiamo ora la sequenza. Sino a un attimo prima l’uomo con la bombetta correva anche lui. Qui, invece, è fermo: è diventato un testimone. Ha scatenato gli eventi, ma ora non ne è più parte. Il tedesco fa ormai tutto da solo. L’arrivo del treno, ancora lontano nella prima vignetta, scandisce il tempo, ci dà la misura dei pochissimi secondi che passano.
Si noti, tra l’altro, l’attenzione che Krigstein ha messo nel far sì che le due immagini del treno nelle due prime vignette si trovino esattamente sopra le due immagini nella seconda striscia. È anche così che si fa diventare protagonista il treno; e la vignetta intercalata del tedesco a metà caduta appare avere molto meno peso di quelle precedente e successiva col treno sempre più incombente su di noi.
Mentre nella prima vignetta il testimone è l’uomo con la bombetta, e il punto di vista è sostanzialmente il suo, nella seconda il pdv si è spostato di colpo sotto la piattaforma, uno spazio che appartiene solo al treno; ed è da lì che vediamo l’inizio della caduta, con i piedi già scoordinati e il cappello che vola. Nella seconda striscia il medesimo pdv testimonierà poi sia l’arrivo del treno che la caduta dell’uomo.
Al fantastico rallenty che conclude la prima striscia è di sicuro profondamente debitore il Frank Miller di varie scene di The Dark Knight, prima fra tutte quella del ricordo dell’omicidio dei genitori di Bruce. Osserviamo, qui, come lo sforzo di recuperare l’equilibrio vi appaia progressivamente più disperato, vignetta dopo vignetta. Nell’ultima, poi, il vuoto sopra al nostro uomo è diventato ormai talmente tanto che è evidente che lui appartiene già allo spazio di sotto, quello del treno – come se venisse risucchiato da quella dimensione inferiore che ci è già stata presentata quattro vignette prima. Il montaggio alternato, secchissimo, delle quattro vignette successive, porta la vicenda alla conclusione.
Con l’ultima vignetta della seconda strisce il pdv è tornato all’uomo con la bombetta. La sua figura nera è l’unica ferma contro il treno che ancora si muove. A una ripetizione fortemente ansiogena come quella delle vignette precedenti, si sostituisce qui di colpo una ripetizione emotivamente del tutto neutra: volti, barre delle finestre…
Va notato, tra l’altro, che, a dispetto della sua grandissima efficacia, non è chiaro in che modo questa immagine evochi il movimento del treno. Non è esattamente questo che percepiamo all’arrivo di un treno.
La figura nera dell’uomo con la bombetta collega l’ultima vignetta della seconda striscia con la prima della terza. L’incubo è finito; siamo tornati nel mondo reale. Mi limito a far osservare, qui, la capacità di Krigstein di costruire, in sole tre vignette, questo mondo di oscurità verso cui l’uomo con la bombetta scompare.
7 Novembre 2016 | Tags: estetica, poesia, poesia civile | Category: estetica, poesia |  La mia testa continua a ronzare sulla questione della poesia civile, e continua a fare qualche passo più in là. Sto cercando di capire perché la nozione di poesia civile (mi) appaia tanto più problematica della nozione (per esempio) di romanzo civile. La mia testa continua a ronzare sulla questione della poesia civile, e continua a fare qualche passo più in là. Sto cercando di capire perché la nozione di poesia civile (mi) appaia tanto più problematica della nozione (per esempio) di romanzo civile.
Proviamo a seguire questa linea di pensiero: in principio c’era l’epica, Omero, insomma. Era poesia civile, quella? Non mi sembra un’espressione adeguata per parlare dei poemi omerici. Questi però, indubbiamente, esprimevano una serie di valori in cui i suoi fruitori si riconoscevano, e sappiamo bene quanto fosse importante la funzione anche didattica dell’epica omerica. Proviamo allora a definire quella della poesia omerica come una funzione sociale della poesia, nel senso che proprio perché i valori espressi da quella poesia erano valori condivisi e fondanti per la società greca, la definizione di sociale può essere accettabile. Sottolineo che non sono particolarmente legato a questa parola, sociale; potrebbe andar bene anche un altro termine, purché diverso da civile. Potremmo dire che era umana, nel senso di portatrice di valori umani, ma questo potrebbe implicare che si tratta di valori universali; mentre erano semplicemente greci. Potremmo dire che era culturale, nel senso che contribuiva a costruire la cultura greca, ovvero il modo che i Greci avevano di pensare il mondo; ma questo potrebbe apparire riduttivamente cognitivo. Per ora, sociale mi sembra il termine più adatto; ma sono pronto ad abbandonarlo di fronte a proposte migliori.
Quello che è interessante è che, in questi termini, la lirica di Saffo non era meno sociale dell’epica di Omero. Se godeva di successo, era proprio perché a sua volta esprimeva dei valori socialmente condivisi. Si noti che l’espressione socialmente condivisi non vuol dire universalmente condivisi, nemmeno nell’universo ristretto della cultura greca. In altre parole, affinché la poesia di Saffo come quella di Omero sia sociale non occorre che i valori che esprime siano condivisi da tutti: è sufficiente che ci sia un gruppo che li condivide, e tanto meglio se si tratta di un gruppo influente, perché vasto o perché forte, o perché sufficientemente compatto e duraturo.
Dovremo insomma ammettere che la poesia di qualità, ovvero la poesia che viene apprezzata da un gruppo in qualche modo influente, è comunque poesia sociale, anche se parla d’amore, perché l’amore stesso è un fatto sociale, ed è estremamente sociale il modo in cui se ne parla e lo si affronta.
Il fatto che tutta la poesia, nella misura in cui viene apprezzata, sia comunque poesia sociale, non è esente da problemi. Appena (cioè sempre) la società non è compatta, appena gruppi sociali diversi hanno valori diversi, si diversificherà anche la possibilità di apprezzare la poesia sulla base dei valori che esprime. Certo, ci saranno presumibilmente dei valori molto profondi e indiscussi che vengono riconosciuti più o meno da tutti, e che permetteranno un consenso molto più vasto di altri.
Questo non vuol dire che questi valori siano universali. L’epoca della Controriforma dà per esempio vita, specie in terra spagnola, a una straordinaria vena di poesia mistica. I suoi valori erano certamente all’epoca ampiamente condivisi. Tuttavia, per me, oggi, apprezzare la poesia, poniamo, di Juan de la Cruz, mi costringe a un esercizio di selezione dei valori, arrivando a vedere quelli più specificamente cattolici come prodotto della sua epoca, con una componente ineliminabile di persuasività pro-fede (propaganda cattolica controriformistica, insomma), e salvando invece gli altri, che comunque ci sono, e contribuiscono a mantenere grande e viva la sua poesia ancora oggi. Se la poesia è sociale, è anche terreno di scontro sociale, inevitabilmente.
Nel frammento 84 della Gaia Scienza (non finirò mai di citarlo), Nietzsche sottolinea la straordinaria capacità persuasiva della poesia, dovuta al ritmo, e alla conseguente capacità di costruire un accordo condiviso, una Stimmung. Non è un caso che la riflessione di Nietzsche arrivi proprio sul finire di un secolo, l’Ottocento, che ha visto il trionfo della retorica (nel peggior senso del termine), ovvero della poesia utilizzata come motore persuasivo per cause politiche, dove la nobiltà della causa doveva essere associata alla nobiltà (ovvero classicità) del linguaggio.
A questo modo (pessimamente) civile di intendere la poesia, il Novecento contrappone un’incapacità di certezze, un’indecisione sistematica, un’epica (se vogliamo chiamarla così) dell’impossibilità dell’epica. Questa nuova poesia non è meno sociale della precedente: è che tra i valori che esprime adesso ce n’è uno fondamentale, che prima restava molto più in ombra, ovvero la problematicità del rapporto tra l’individuale e il collettivo. Per quanto paradossale possa apparire, l’accordo collettivo che si viene a creare su questa nuova poesia si fonda proprio sul riconoscimento della difficoltà dell’accordo, sull’impossibilità di risolvere la coscienza individuale nei valori civili, qualunque essi siano.
Quello che diventa cruciale, nella poesia del Novecento, è qualcosa che prima stava molto più nell’ombra (pur essendo presente) ovvero la sua capacità di mettere in movimento ciò che è assestato, di mettere in dubbio le certezze, di attivare dei modi differenti di guardare alle cose (di attivarli, non di proporli!), perché solo in questo modo essa esprime il valore (ormai fondamentale per noi) della problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. La poesia non è ora né più né meno sociale di prima, ma lo è certamente in modo diverso, perché si trova a cavalcare una contraddizione che è assurta a valore fondamentale.
La proposta di Balestrini con cui concludevamo il post precedente va esattamente in questa direzione. Balestrini vede nello scardinamento del linguaggio lo strumento per attivare dei modi differenti di guardare alle cose, con spirito profondamente nietzschiano (ma ora è il Nietzsche del Crepuscolo).
Che cosa succede quando la poesia non si limita ad attivare, ma cerca piuttosto di proporre dei modi differenti di guardare le cose. La mia sensazione è che, così facendo, la poesia stia invadendo il campo di altre forme espressive, più legittimamente persuasive, e che indebolisca implicitamente, in questo modo, la sua capacità di esprimere il valore del rapporto complesso tra individuo e collettività. Lo fa perché, proponendo dei modi specifici di guardare, sta già proponendo direttamente dei valori, e in questo modo sta anche proponendo l’appartenenza a una comunità ben definita, per quanto magari alternativa a quella dominante.
In altre parole, la poesia che fa una scelta politica sta dichiarando un’appartenenza, e in questo senso può essere sentita come falsa (o addirittura propagandistica) da chi si riconosce nei valori della problematicità, dell’incertezza di appartenenza. Ecco quindi il problema della poesia civile: che per essere civile rischia di smettere di essere sociale. Che per sostenere un valore in cui io potrei pure riconoscermi, rischia di mettere in discussione un valore molto più profondo, in cui certamente io mi riconosco, perché è la base dell’idea stessa di libertà, che sta sotto a qualsiasi mozione civile.
Proprio perché la poesia è intimamente sociale, essa vive a monte di qualsiasi scelta politica. I valori di libertà, responsabilità individuale, capacità personale di arrivare a comprendere sono quelli che la nostra poesia implicitamente esprime, e lo fa attraverso il modo in cui essa è costruita ancora prima che attraverso ciò di cui parla. La poesia ci deve turbare, deve permetterci di vedere le cose come altrimenti non le vedremmo. Se cerca di darci soluzioni, non ci esprime più, nemmeno quando quelle soluzioni sono condivisibili da noi. Avrebbe scelto, in questo modo, la strada facile del consenso: ma il consenso per noi è la morte, la negazione della libertà.
Qualche volta riusciamo a chiamare civile una poesia che rispetta la problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. Si tratta probabilmente di una poesia che attiva dei dubbi di carattere civile, piuttosto che asserire delle certezze, piuttosto che fare delle proposte. Le proposte ideologiche e politiche sono certamente una cosa importante, ma non spettano alla poesia. Per entrare in poesia esse devono distruggere valori ben più importanti, e trascinarla verso la triste retorica della poesia dell’Ottocento.
Certo, tutto questo non varrebbe più se i valori della libertà fossero tramontati. Credo che, per fortuna, non sia ancora così. Se lo fosse, quella che a me appare pessima retorica civile potrebbe legittimamente apparire ad altri come espressione di valori condivisi e profondi.
31 Ottobre 2016 | Category: estetica, poesia | Rispondo ai commenti di Renata, Francesca e Leila al post precedente con un nuovo post, perché ho scoperto di avere ancora troppe cose da dire per stare nello spazio ristretto di un commento.
Con Renata direi che siamo sulla stessa linea. E trovo anch’io azzeccata, come Francesca, l’idea che “la poesia è civile quando è pensiero critico di un presente condiviso” – anche se mi sembra che le conseguenze di questa posizione allarghino molto il campo, il che non è detto che sia sbagliato. Ma sarà ciò di cui parlerò tra poco.
Inoltre, sì, ci sono state epoche (e ci sono anche oggi luoghi nel mondo) in cui la poesia civile poteva avere davvero un’azione (comunicativa) civile. Non, di sicuro, qui e ora. Anzi, temo che in termini di azione civile, il cattivo romanzo che Francesca non scriverà sarebbe comunque più efficace delle buone poesie che invece scrive. Del resto, basta non illudersi, non pensare di essersi lavati la coscienza per aver fatto “pensiero critico di un presente condiviso” (e mi scuso con Francesca per averle attribuito l’espressione desiderio di successo – ma penso che, nel giusto contesto, anche sei lettori lo possano essere, un successo; e comunque non vedo perché il poeta dovrebbe sentirsi in colpa di averne sei, o anche sei milioni). Le poesie di Francesca hanno certamente un peso e un’efficacia in quanto poesie, ma mi permetto di dubitare che ce l’abbiano in quanto azione civile. Da questo punto di vista serviranno a far discutere persone che sono già sensibili al tema, cui magari basterebbe una qualsiasi altra occasione per farlo.
Con Leila (dopo un’iniziale perplessità, perché il suo discorso è articolato, e inizialmente sembra sostenere il contrario) mi trovo d’accordo. Quando parlo di sincerità intendo più o meno le stesse cose che dice lei quando dice che le cose bisogna averle vissute per parlarne, oppure avere una capacità straordinaria di immedesimazione. Torno in leggera dissintonia sul finale: “poiché io so solo scrivere poesia, allora questo è il mio modo per fare azione civile”. Sì, certo. Peccato che, inteso in questo senso, non sia di nessuna utilità civile.
Il che non vuol dire di nessuna utilità. Tendo a pensare, anzi, che questa problematica relazione con il civile dipenda dal fatto che la poesia è, diciamo così, meta-civile. Ovvero, che tutta la poesia, quella buona, che in un modo o nell’altro ci tocca, ci riguarda tutti come collettività, in una maniera che sta alla base, ancora alle spalle, degli atteggiamenti che generalmente definiamo civili, anche se parla di cuore-amore-dolore (e magari pure fiore) – purché parlando di cuore-fiore sia in grado di mostrarci un aspetto di quella relazione che ci era sconosciuto, o nascosto. Così facendo, persino la poesia d’amore potrebbe avere un valore civile, perché abitua a guardare le cose del mondo in maniera diversa da quella che il nostro modo di vivere (e il sistema culturale) ci impone. Scrivere e leggere (buona) poesia è quindi comunque un (civilissimo) esercizio di libertà, più importante e precedente di qualsiasi retorica dell’uguaglianza.
In ogni caso, le orecchie mi ronzavano. Sono andato a rileggermi i testi critici che accompagnano l’antologia I Novissimi (1961), e ci ho ritrovato più o meno tutti i termini del dibattito dell’altra sera e di ora. Riconoscendomi nano sulle spalle di giganti, mi sono messo al lavoro di scansiona, taglia e incolla, e ho prodotto le citazioni che seguono, tutte, a mio parere, molto pertinenti.
La prima è presa dall’Introduzione di Alfredo Giuliani all’edizione Einaudi del 1965 (sono le pagg. 3 e 4 della ristampa del 72), e il tema del discorso è “perché è nato questo libro, visto da quattro anni dopo”. Il bersaglio polemico è presumibilmente Pasolini:
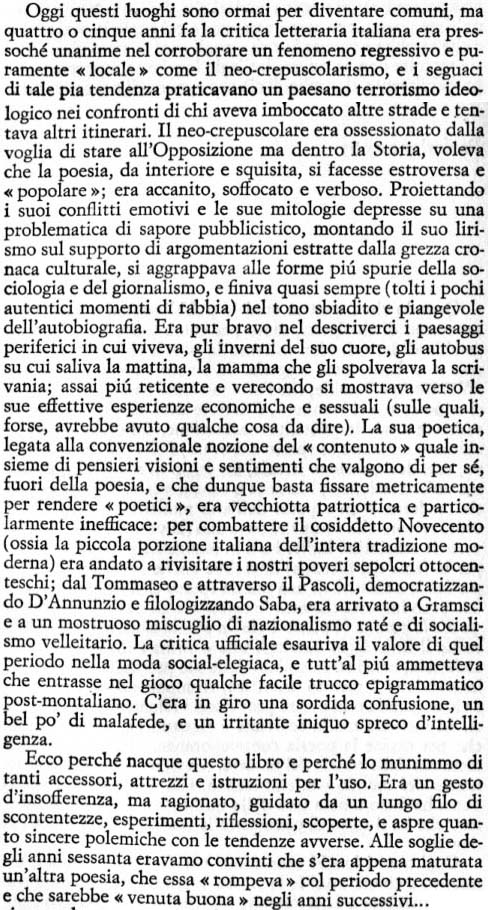
Si noti che quello che viene messo in discussione non è la vocazione civile dei”neo-crepuscolari”, bensì il loro rifarsi a una tradizione a cui non ci si può rifare, perché è il linguaggio stesso di quella tradizione a essere compromesso col potere. Detto in parole povere, parlare contro il potere utilizzando il suo stesso linguaggio, significa rafforzare le basi linguistiche su cui quel potere si fonda, e quindi in ultima analisi sostenerlo. Insomma: i neo-crepuscolari credono di fare poesia civile, mentre rafforzano ciò che credono di criticare.
Ancora va aggiunto che l’ermetismo non è tra i bersagli polemici di Giuliani, e non certo per connivenza. E’ semmai che in quel momento storico, e in quel dibattito, si dava per scontato che la poesia dovesse essere in qualche modo civile. Essere poesia in qualche modo civile è uno dei valori in gioco nel dibattito; mentre gli ermetisti ne sono già, solo per questo, evidentemente esclusi.
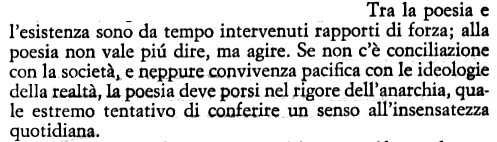
Qui siamo a pag. 5. Questa sembra essere una sorta di concessione a Balestrini, su cui arriveremo più sotto. E’ la posizione più estrema in merito che viene espressa da Giuliani: dove l’incidenza politica è di fatto impossibile, la poesia può (deve, per loro) scegliere la strada estrema dell’anarchia. Non so quanto Giuliani potesse essere consapevole dell’ulteriore isolamento che questa presa di posizione avrebbe portato alla poesia – ma si tratta comunque di una posizione civile. (Sull’eccesso di posizioni di questo genere ho parlato in un post di pochi giorni fa)
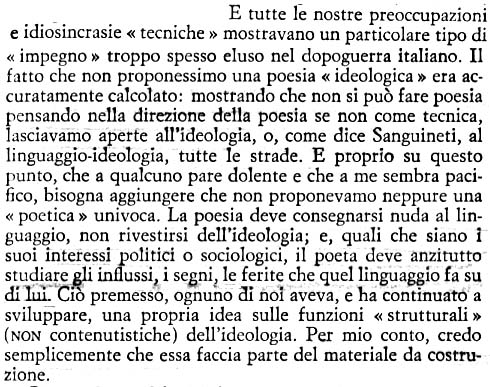
A pagina 11 (siamo sempre nell’introduzione del ’65) Giuliani esprime molto nettamente la sua posizione: non sono i contenuti che rendono ideologica (ovvero civile) una poesia, ma l’utilizzo che dell’ideologia si fa a livello di struttura (o, altrimenti detto, di linguaggio). Detto questo tra i cinque autori che partecipano alla raccolta, ciascuno si regola a modo proprio.
Le ragioni di questa posizione erano già state spiegate piuttosto chiaramente nell’Introduzione originale all’edizione del ’61. Eccole (pag. 18):
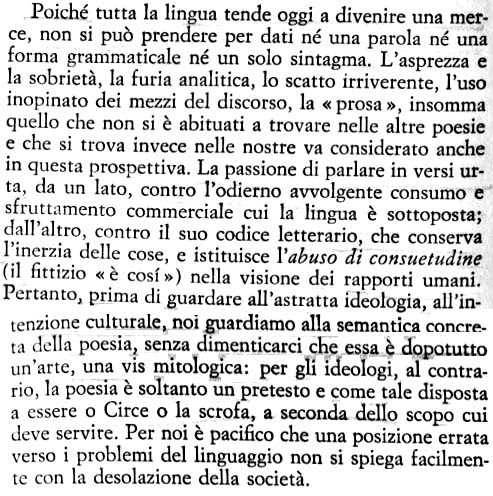
Guardare alla semantica concreta prima che all’astratta ideologia, e all’intenzione culturale, vuol dire proprio pensare che l’atteggiamento civile in poesia non riguarda i contenuti, ma un atteggiamento precedente, di natura strutturale. Insomma, lo specifico critico sociale della poesia sembra essere la critica del linguaggio, in una prospettiva fortemente nietzschiana. Nel frammento 84 della Gaia Scienza, Nietzsche parla proprio della truffa messa in atto dal linguaggio poetico, e poi, nel Crepuscolo degli idoli, della necessità di uccidere la grammatica per saltarne fuori.
All’atteggiamento neo-crepuscolare, Giuliani contrappone quello del suo compagno di viaggio Elio Pagliarani (pagg. 23-24):
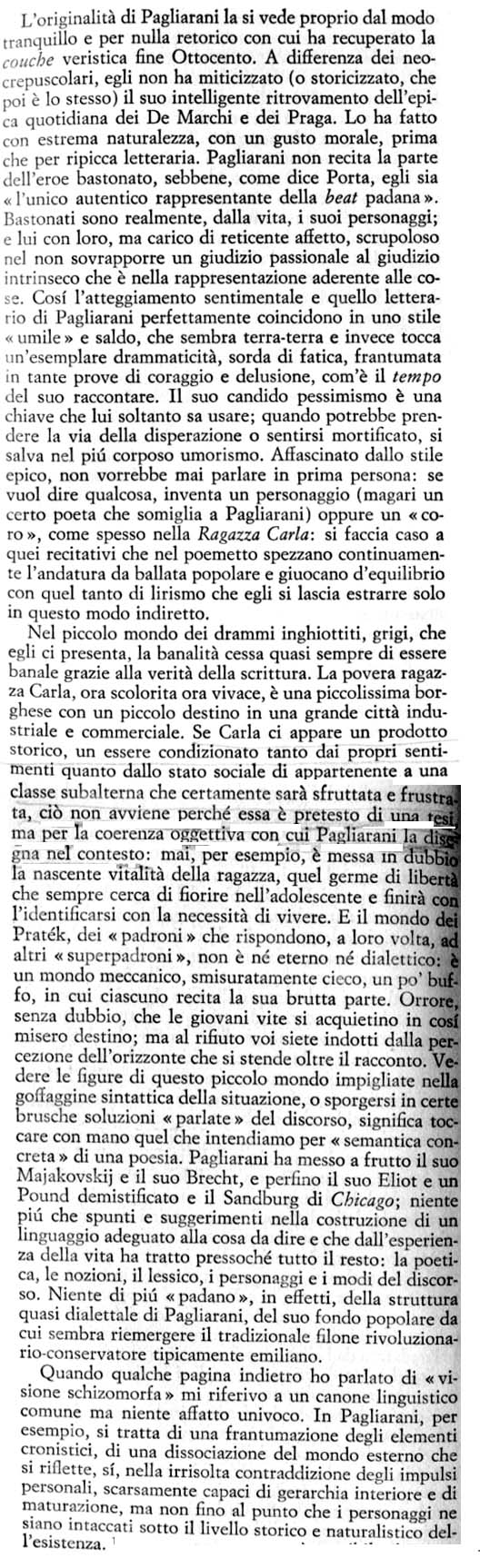
In Pagliarani, gli elementi ideologici si manifestano in questa scomparsa dell’io narrante/giudicante, oltre che nelle modalità di costruzione del suo poemetto. In verità, anche a livello di contenuti l’ideologia sembrerebbe non apparire (non c’è mai giudizio sui fatti, solo la loro presentazione); anche se, evidentemente, questo genere di contenuti appare più pacificamente civile.
Eppure, il poeta del gruppo che prende la posizione più schieratamente civile, non è Pagliarani, bensì l’apparentemente formalista Balestrini. Riporto qui l’intero intervento suo, in calce all’antologia (pagg. 196-198):
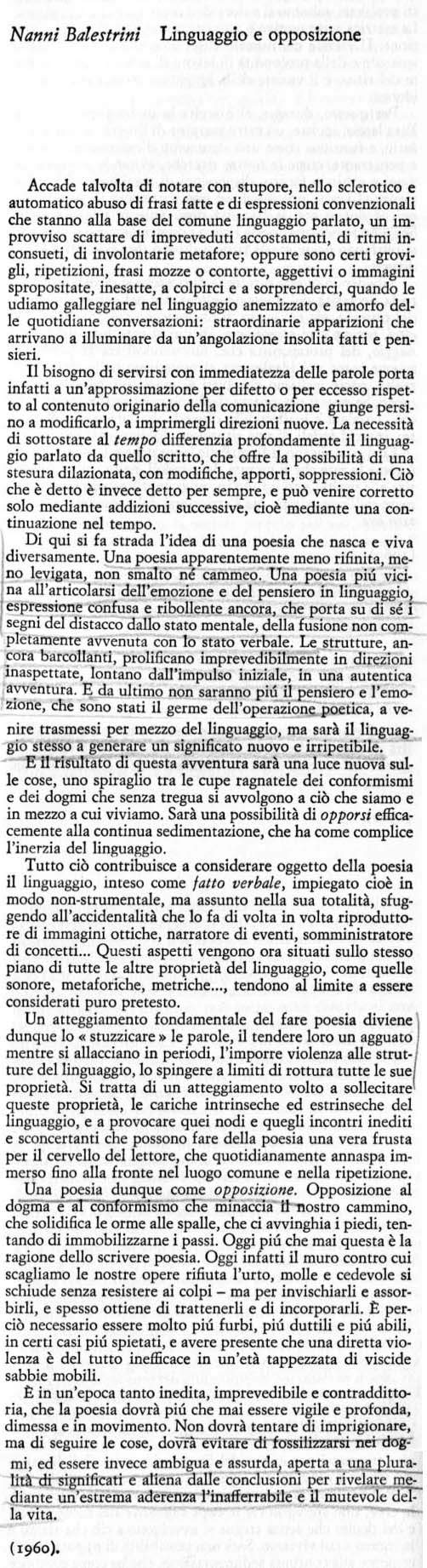
Fin dal titolo, la posizione di Balestrini è chiara: l’opposizione si fa con il linguaggio, e questo è lo specifico della poesia. Opposizione al dogma e al conformismo. Opposizione attraverso la distruzione della grammatica, prima base solida del potere.
Ora, siamo davvero lontani qui dall’idea di poesia civile come “pensiero critico di un presente condiviso”? Se assumiamo che il pensiero sia tale quando viene esplicitato, sicuramente lo siamo. Ma se riteniamo che il pensiero si possa manifestare anche attraverso le scelte strutturali, linguistiche, allora anche la poesia di Balestrini è certamente “pensiero critico di un presente condiviso”, e lo è in forma assai più radicale che in quei neo-crepuscolari in cui sembra così facile vedere la vocazione civile.
Spero di avere scompigliato a sufficienza le carte in tavola
28 Ottobre 2016 | Tags: estetica, poesia, poesia civile | Category: estetica, poesia | Ho partecipato ieri sera a uno degli incontri quasi settimanali che si tengono il giovedì presso l’osteria Vamolà, a Bologna, “I giovedì di/versi” (info qui). Ieri sera il tema dell’incontro era la poesia civile, con presentazione di alcune esperienze e dibattito aperto in seguito. Si tratta di una situazione semiinformale, con i pro e i contro del caso. Più strutturata la parte di presentazioni, più selvaggio il dibattito, attorno a un lungo tavolo di osteria (una trentina i partecipanti), con una gestione un po’ anarchica di molte voci desiderose di dire la propria – e, purtroppo, molto rumore di fondo. Ma anche così, il dibattito è stato acceso e fecondo.
Ho finito per non prendervi parte, un po’ subissato dal rumore di fondo che non favoriva la concentrazione, un po’ perché altri hanno detto una parte delle cose che avevo in mente, e un po’ perché non mi era del tutto chiaro quello che mi si è venuto poi chiarendo in seguito, e che voglio provare a esprimere qui. Della conversazione mi sono rimaste due voci (altre dicevano con meno chiarezza cose simili, ad altre ancora non ho avuto accesso acustico, per via del rumore di fondo). Mi perdonino le autrici degli interventi se sarò parziale; e mi perdonino maggiormente se farò loro dire qualcosa che non hanno detto: questo è quello che ho capito e che mi ricordo. Quindi me ne prendo tutta la responsabilità.
Marinella Polidori ha esposto, con molta verve, due tesi che faccio fatica a far stare insieme. In primo luogo quella, che almeno in parte condivido, secondo cui tutta la poesia è civile, purché si sottragga alla logica neoliberista del successo, del farsi vedere, del vendere – che ha ormai assoggettato quasi interamente la narrativa. Poi però, pressata dall’obiezione che così si perderebbe un po’ il senso dell’espressione poesia civile Polidori ha insistito sull’idea di cercare di salvare la parola “civile”, che per lei resta una parola nobile; e la poesia sarebbe civile, dunque, se collegata a un impegno di carattere sociale. A questa seconda versione, non del tutto compatibile con la prima, mi opporrò tra poco, e in parte anche alla prima.
Francesca Del Moro ha obiettato alla prima posizione che esiste anche un legittimo desiderio di riconoscimento e di successo da parte del poeta, e non lo si può ridurre a un asservimento al sistema. Ma soprattutto (su sollecitazione di qualcun altro) ha parlato del proprio recente volume Gli obbedienti, il cui tema è la vita in ufficio con le sue vessazioni. Riflessione sulla vita o denuncia civile?
Ora, io capisco e mi piacerebbe approvare l’idea che tutta la poesia che non si sporchi le mani con il sistema delle vendite è di fatto civile, ma capisco bene che così facendo si vanifica il senso di “civile”, perché non esisterebbe poesia che non sia civile. La poesia, in quanto tale, ha già scelto la strada della marginalizzazione rispetto alla grande editoria. Se voglio recuperarle un senso, legando la poesia civile all’impegno sociale, finisco per dire che non è così, perché anche tra i poeti non compromessi con l’industria ci sarà chi non si distingue per impegno sociale.
D’altra parte, anche la tesi secondo cui la poesia è civile se non si sporca le mani con il neoliberismo è difficile da sostenere. Supponiamo che un poeta che, come tutti, vive la sua situazione di marginalità culturale ed editoriale, diventi improvvisamente famoso, e i suoi libri inizino a vendere moltissime copie, creando un caso letterario. La stessa poesia sarebbe dunque civile prima e non civile dopo?
Proviamo a guardare le cose in un altro modo. Che cosa è azione civile nel campo della comunicazione? Io direi che è cercare di informare e convincere il maggior numero di persone rispetto a fatti e opinioni che consideriamo politicamente/civilmente rilevanti. In questo senso una graphic novel come Kobane Calling di Zerocalcare è certamente una riuscita operazione di letteratura civile. E’ fatta molto bene, fornisce informazioni e un modo intelligente e originale di vedere le cose sulla cultura dei Curdi e sul loro ruolo di combattenti nella guerra in Medio Oriente. E raggiungerà molta gente, compresi tanti che non si erano mai posti il problema, e che ora saranno magari più sensibili a questi temi.
Se vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto a una causa come quella del popolo curdo, la graphic novel può essere un ottimo canale, e lo è proprio in quanto inserito in quel sistema dell’editoria di successo cui la poesia è estranea. Tant’è vero che un buon servizio televisivo trasmesso nell’orario giusto potrebbe fare ancora di più (ed è infatti significativo che non lo si faccia). A quanto pare, per la massima efficacia di un’azione (comunicativa) civile la visibilità è essenziale, e quindi l’inserimento nel sistema (neoliberista) dei media.
Se vediamo le cose in questi termini, fare azione (comunicativa) civile attraverso la poesia appare davvero come tempo sprecato, in termini di sfruttamento delle risorse: tempo buttato. La poesia, come di solito accade, sarà letta solo dagli addetti ai lavori, di solito già sensibili ai temi in oggetto – e comunque davvero pochi. Insomma, se quello che ci interessa è fare azione civile, la poesia civile appare come una sorta di fallimento se non di truffa: se l’azione civile ci interessasse davvero utilizzeremmo altri mezzi. L’obiezione che farlo attraverso la poesia nobilita comunque il tema, cosa a cui forse qualcuno crederà ancora, non sposta le carte in tavole: si tratta di una nobiltà che interessa solo ai poeti. E io la trovo anche un po’ demodé, per non dire falsificatoria a sua volta.
E Pasolini, allora, non faceva poesia civile? Pasolini è un buon esempio: a mano a mano che si è reso conto che la poesia non era lo strumento davvero efficace per fare azione civile, la sua poesia si è disfatta in una sorta di prosa argomentativa in versi, che sceglieva contesti di pubblicazione, come i quotidiani, molto adatti all’azione civile e molto poco alla poesia. Alla fine sembra che della poesia gli importasse ben poco. Del resto, il cinema si prestava molto meglio a raggiungere un grande pubblico con temi civili.
Il libro di Francesca Del Moro che abbiamo citato sopra non sarebbe poesia civile, dunque. Io, per chiarezza, abolirei la nozione, che fa pensare che esista un genere specifico, nobilitato particolarmente dalla sua missione civile. Volendola conservare a tutti i costi, la nozione, ne propongo qui di seguito una versione minimale, ma dotata – almeno per me – di qualche senso (e che permette di conservare a Gli obbedienti la qualifica di poesia civile).
Proporsi di fare poesia civile, intesa come modo di usare la poesia per fare azione civile, è una falsificazione; un modo per lavarsi la coscienza, potendo dire di aver agito – mentre si è evitato di agire. Tuttavia fare poesia ha comunque un senso civile, che non è quello dell’azione civile, perché – come diceva inizialmente Polidori – è l’azione stessa di fare poesia anziché qualcos’altro di più compromesso con il potere a essere in sé civile. Proprio questo, secondo me, dovrebbe avere in mente il poeta: essere sincero con se stesso, non darsi fini di persuasione o propaganda (anche in senso positivo, come quella pro-Curdi di Zerocalcare). Potrà poi capitare, a posteriori, che una poesia scritta sinceramente possa essere riconosciuta da qualcuno come un intervento civile. E questo va bene; e questo potrà essere chiamato poesia civile.
Ma si tratta di una valutazione a posteriori, che non aggiunge (né certamente toglie) valore alla poesia. Insomma, la poesia civile potrebbe essere quella poesia che per qualcuno fa anche azione (comunicativa) civile, e che è buona o cattiva poesia in maniera del tutto indipendente da questo. Troppo spesso, l’entusiasmo per una causa condivisa ci porta a introdurre (se siamo autori) o a perdonare (se siamo lettori) eccessi di retorica che altrimenti eviteremmo. In questo senso, il civile fa frequentemente molto male alla poesia.
Ma ci sono stati grandi poeti nei cui versi echeggiano temi civili: poeti civili, dunque. Credo che la loro influenza sull’opinione pubblica sia stata comunque irrilevante. La poesia è di solito un discorso in cui ci si riconosce, e in cui si trova conferma. Per convincere chi ha opinioni diverse, la prosa argomentativa è già enormemente più efficace; ma anche la narrativa, verbale, filmica, fumettistica, teatrale che sia, funziona molto meglio. Diciamo che è bello incontrare buona poesia in cui scorrono idee civili in cui ci riconosciamo: questo è il massimo che all’idea di poesia civile posso concedere.
Le parole che seguono sono state scritte poco fa come commento a un articolo di Andrea Inglese pubblicato su Nazione Indiana, “Paesaggio e convenzioni figurative nella poesia italiana contemporanea”. Dopo aver inviato il commento, mi sono reso conto che la questione che affronta è in realtà più vasta dell’occasione per cui è – di getto – stato scritto, e ho deciso di pubblicarlo, come post autonomo, anche qui.
Il saggio, come sempre quando Inglese scrive, è acuto e pieno di spunti. Non posso che condividere l’idea del testo come paesaggio, visto che io stesso l’avevo buttata lì in un post del 2010. Tuttavia, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi, continuo a sentire una sorta di perplessità, di cui provo a spiegarmi il motivo in questo modo.
Sembra che questi testi testimonino l’impossibilità, in un mondo tardo-capitalistico, in cui la stessa parola è divenuta merce, di dire qualcosa che non sia l’impossibilità stessa di un rapporto sentimentale con il paesaggio. Quello che sarebbe rimasto possibile in questo contesto non sarebbe dunque il rapporto con il paesaggio, bensì quello con il film pubblicitario sul paesaggio. Di conseguenza, quello che la poesia può fare non sarebbe che “essere un prezioso strumento di rilevazione della realtà, ma in “negativo”, mostrando l’inadeguatezza dei nostri discorsi e delle nostre narrazioni e tenendo vivi la nostalgia e il desiderio di reale”. Insomma, l’unica possibilità sincera della poesia starebbe nel negativo, nel tener viva la nostalgia del reale. Il che mi ricorda molto le parole di Adorno a chiusura del saggio su Schoenberg nella “Filosofia della musica moderna”, e in generale il lamento di Adorno per l’impossibilità, oggi, di un’arte innocente, ovvero inconsapevole della corruzione (capitalistica) dell’immagine stessa del mondo (e del paesaggio).
Il mio disagio, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi qui citati, è dovuto probabilmente alla sensazione che essi mi mettano di fronte all’ineluttabilità e generalità di questa sola possibile negatività dell’approccio poetico, come se l’approccio diretto al paesaggio fosse davvero ormai reso impossibile dal dominio del film pubblicitario (e di tutto ciò che esso sta a simboleggiare). Come se l’emozione e il sentimento di fronte al paesaggio fossero ormai possibili solo come “nostalgia”, perché l’emozione autentica è negata, comunque, dalla mediazione ideologica dell’apparato mediatico e delle sue capillari conseguenze.
Ora, io non credo che sia così. Né ho mai ben tollerato la heideggeriana nozione di “autenticità”, fatta propria e utilizzata da Adorno. Ci sta, nella mia intolleranza, la consapevolezza del fatto che, per parlare di autenticità perduta, è necessario avere un’idea dell’autenticità posseduta; ovvero ipotizzare un’età dell’oro in cui l’arte poteva essere innocente, mentre ora non lo è più. L’idea che l’accesso diretto al paesaggio che si poteva avere ieri, oggi è reso impossibile dal fatto che esso è inevitabilmente negato dal film pubblicitario, mi fa credere che ieri esso non fosse negato, e che un’arte innocente fosse davvero possibile. E’ l’idea di una possibilità perduta (ma esistita) che giustifica la legittimità di un’arte come nostalgia del reale, in cui non sia possibile esprimere l’emozione del rapporto con il paesaggio se non nei termini della sua negazione.
A questa logica io mi sottraggo, non certo per difendere la mistificazione capitalistica, che c’è; ma perché essa non è che la forma moderna di una serie di mistificazioni che hanno sempre condizionato il rapporto con il paesaggio, plasmandolo epoca per epoca. Ritenere che la mistificazione specifica della nostra epoca sia l’unica o la più grande è a sua volta una mistificazione, perché ci induce a ritenerci alfieri di una verità altrimenti perduta.
La mia opinione è che la poesia non può ridursi alla nostalgia e al negativo che la può generare, perché una visione in qualche modo positiva del rapporto col paesaggio resta possibile oggi come in ogni tempo – purché consapevole della propria dimensione relativa e condizionata. Purché non ingenua insomma. L’arte di qualità non è mai stata innocente, e ha sempre posseduto una componente negativa, in grado di “tener viva la nostalgia e il desiderio di reale”; ma non si è nemmeno ridotta a soltanto questo.
14 Ottobre 2016 | Tags: Bob Dylan, Dario Fo, Nobel, poesia, teatro | Category: poesia |  Baluginano lampi d’ira tra i letterati per il Nobel assegnato a Bob Dylan. La canzone non è letteratura! E’ vero, infatti, così come è vero del teatro. Nella canzone il testo verbale fa parte di un discorso cui la musica concorre in maniera fondamentale, e i semplici testi verbali di Dylan sono solo mezzi testi, e dunque non testi letterari in senso stretto. Ma lo stesso si potrebbe dire del teatro, che non esiste senza la messa in scena (la quale, non di rado, conta assai di più delle parole scritte). Vogliamo dunque contestare anche il Nobel a Dario Fo? Baluginano lampi d’ira tra i letterati per il Nobel assegnato a Bob Dylan. La canzone non è letteratura! E’ vero, infatti, così come è vero del teatro. Nella canzone il testo verbale fa parte di un discorso cui la musica concorre in maniera fondamentale, e i semplici testi verbali di Dylan sono solo mezzi testi, e dunque non testi letterari in senso stretto. Ma lo stesso si potrebbe dire del teatro, che non esiste senza la messa in scena (la quale, non di rado, conta assai di più delle parole scritte). Vogliamo dunque contestare anche il Nobel a Dario Fo?
In realtà, avremmo ragione forse più di contestare il Nobel a un uomo di teatro che non a un cantautore. C’è stata un’epoca, sino a non molti secoli fa, in cui tutta la poesia nasceva per la musica. Parte di questa poesia era epica: quando questa recitazione cantata si è incrociata con la cerimonia, è nato quello che chiamiamo teatro. Duro sarebbe dimostrare che la cerimonia è una forma di letteratura, e un certo aspetto cerimoniale il teatro l’ha giustamente conservato.
Quindi, cari amici letterati, tenete presente che contestare il Nobel a Dylan in quanto la sua non è letteratura significa implicitamente avanzare un’istanza ben più forte nei confronti di Dario Fo. Chi si azzarda?
C’è una differenza di base tra la percezione visiva e quella sonora: quello che vediamo è là, di fronte a noi; quello che udiamo è qua, attorno se non addirittura dentro di noi (specie i bassi, che ci fanno vibrare la pancia). Fondamentalmente la percezione visiva è frontale, quella sonora è immersiva. Quando la percezione è frontale, ci troviamo di solito in una relazione cognitiva: il soggetto conosce l’oggetto davanti a lui. Quando è immersiva, soggetto e oggetto tendono a confondersi: non c’è tanto conoscenza, quanto compartecipazione (il filosofo francese François Jullien usa il termine connivenza, ma io credo che la connivenza sia già la consapevolezza – cioè la conoscenza – della compartecipazione, quindi un suo derivato). Ascoltando musica, sentiamo il ritmo, per esempio, e magari lo seguiamo e ci mettiamo a ballare; non è un’attività in sé cognitiva, è piuttosto il partecipare a un’attività cui partecipa chiunque ascolti quella musica. Qualcosa di simile succede ogni volta che fluiamo insieme con ciò che percepiamo attorno a noi.
Detto questo, si può ascoltare frontalmente la musica (come richiede la musica colta, pur mantenendo aspetti immersivi), o ci si può immergere in situazioni visive: il medesimo Jullien ha scritto un libro (Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, Gallimard, 2014) dove si parla essenzialmente della percezione del paesaggio, e del senso di connivenza che essa procura. Inoltre, anche se la compartecipazione non è in sé conoscenza, può essere comunque occasione per conoscere; e, d’altra parte, si può essere compartecipi o conniventi anche su qualcosa che prima abbiamo dovuto conoscere (come succede con tante arti, compresa la letteratura, e compreso il fumetto). Insomma, anche se conoscenza e compartecipazione, frontale e immersivo, sono dimensioni diverse, e diverse relazioni nei confronti del mondo, le troviamo continuamente intrecciate e mutuamente causate. Io credo che sia così perché noi stessi siamo fatti così: sino a un certo punto siamo dei soggetti (come ci voleva Cartesio) che conosciamo il mondo organizzandolo in oggetti; al di là di quel punto siamo noi stessi mondo, e lo siamo assai prima e assai più in profondità di quanto non possa arrivare la nostra soggettività.
Cosa c’entra tutto questo con il fumetto? Il fumetto è interamente visivo, non ha suoni né percezioni di altro tipo. Dovrebbe essere perciò interamente frontale, e quindi cognitivo…
Il fatto è che il fumetto fluisce, scorre, e ha perciò, inevitabilmente, dei ritmi. Con questi ritmi il lettore si può trovare in sintonia. Non che ci si possa ballare: un ritmo narrativo, per esempio, non è fatto per questo. Ma conosciamo tutti la fluida magia di un racconto che scorre bene, e il nostro vissuto del momento con lui.
Non è tuttavia di questo che voglio parlare, perché di questi temi ho già parlato in molte occasioni. Il fatto è che qualche giorno fa, mentre discutevo una tesi in corso di stesura a proposito del fumetto nel Web, opera di una mia allieva ISIA, Claudia Conti, lei salta fuori con un’osservazione che mi fa sobbalzare, dicendomi qualcosa sul fatto che mentre la singola vignetta in sequenza sarebbe sostanzialmente narrativa, frontale, la pagina nel suo insieme sarebbe invece immersiva. Sul momento ero perplesso: sarà davvero così? A una prima veloce riflessione le ho detto che poteva aver ragione; ma poi di riflessioni, più tardi, ne ho fatto molte altre. E, sì, credo che non solo sia davvero così, ma che si tratti di una considerazione importante, che spiega varie cose.
Leggevo qualche giorno fa, non ricordo dove, qualcosa su Mark Rothko, il quale pare che sostenesse che i suoi dipinti andrebbero guardati da una distanza ottimale di 60cm…
Continua qui, su Fumettologica.
Sulla pagina bianca lo strumento del disegnatore traccia linee che delimitano zone, che descrivono forme. Le aree bianche inglobate diventano a loro volta segni, distaccandosi dal fondo in virtù di quel margine continuo. Le aree bianche che inglobate non sono possono, in certi casi, subire la stessa sorte, secondo leggi percettive molto studiate dalla psicologia della Gestalt. Ma può restare comunque un residuo, un bianco che non è forma e appartiene in ogni caso allo sfondo – un bianco decisamente bianco, destituito di significato perché, banalmente, nessun significato percettivo specifico gli è stato attribuito. Un bianco il cui unico senso è puramente negativo: ciò in cui non sta quello che ha significato – al massimo, il vuoto che separa le varie aree significanti.

Nel fumetto, il tipico bianco di questo genere è quello che sta attorno e tra le vignette, escluso al senso dalla linea nera che le definisce. Ne esiste una variante ancora debolmente significativa: lo sfondo bianco indifferenziato che si trova talvolta dentro le vignette, senza con ciò voler simboleggiare un qualche sfondo uniforme (parete o cielo), ma soltanto un’assenza di sfondo, una pura negatività narrativa. Eppure un residuo di senso rimane attaccato a questo bianco dal suo trovarsi ancora all’interno dello spazio deputato al racconto, all’interno della vignetta: il margine regolare che lo separa dall’autentico fondo pagina gli conferisce comunque lo statuto di indicatore di un luogo del racconto, per quanto si tratti di un luogo la cui irrilevanza è sancita dall’assenza di descrizioni.
Ecco dunque i tre ruoli del bianco nel disegno del fumetto: come forma vera e propria, come sfondo neutro del raccontato, come sfondo neutro del raccontare. Vicini, ma non coincidenti, gli ultimi due, e tutti e tre accomunati dal potersi o doversi trovare al di fuori di linee chiuse, questi tre ruoli possono essere giocati anche in maniera da confondere le carte. Non solo è possibile attribuire qualche significato fino al più neutro dei ruoli del bianco, quello di sfondo del raccontare, ma si può anche fondare un intero stile sulla modulazione di tali ruoli e dei loro intrecci…
Continua qui, su Fumettologica.
(Segni bianchi fu pubblicato originariamente su Linea Grafica, n. 1, 1992)
12 Settembre 2016 | Tags: fumetto, Igort | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Igort – Sinfonia a Bombay – pagina 68  Igort – Sinfonia a Bombay – pagina 69 Dopo due passi in avanti, da maestro ad allievo (Pratt-Muñoz e Muñoz-Mattotti), stavolta ne facciamo uno di fianco in questa rubrica, a chiudere l’anno del trentennale di Valvoline, e parliamo di Igort, un altro che di debiti nei confronti di Muñoz e di Sampayo ne ha avuto parecchi – ma li aveva ben digeriti già qui. “Sinfonia a Bombay” viene pubblicato su AlterAlter, all’interno del supplemento Valvoline, nei primi mesi del 1983. La versione che prendiamo in esame qui non è però l’originale, bensì quella della riedizione Coconino di pochi mesi fa, colorata digitalmente dall’autore (l’originale era in bianconero).
Ho scelto di lavorare sulla nuova edizione per diverse ragioni. Intanto perché è stata proprio la nuova edizione a riportarmi all’attenzione questo testo. Poi perché la qualità della riproduzione è talmente migliore di quella dell’edizione AlterAlter da permettere di godere di una serie di dettagli e sottigliezze che là rimanevano facilmente inosservati. Infine anche proprio per la qualità dell’operazione di colorazione, effettuata da Igort con estrema delicatezza: per molte pagine si tratta di poco più dell’introduzione di una dominante tonale quasi insatura (invece di avere, per esempio, una puntinatura grigia ne abbiamo una leggermente ocra), ed è in maniera graduale e insensibile che i colori arrivano anche ad avere anche un ruolo di contrasto cromatico – sino a queste due pagine (le 68 e 69 del volume), che sono in assoluto tra le più colorate e cromaticamente contrastate. In questo modo il colore continua comunque ad avere un ruolo marginale, valorizzando i contorni neri delle figure, le ombre, e le relazioni tra forme nette, come e meglio che nell’edizione originale.
Ci sono ragioni diversificate di interesse in questo lavoro di Igort. Se mettiamo a confronto la sua ispirazione con quella del fratello di percorso Lorenzo Mattotti, ci accorgiamo che ciò che muove Mattotti è una sorta di senso panico nel rapporto con la natura e in generale con le cose, intese nella loro materialità. Anche in Igort c’è un fortissimo senso panico, ma quello che lo muove sono passioni culturali, radicate nella Storia o, meglio ancora, in una mitologizzazione della Storia o delle tendenze culturali (di alcune delle tendenze culturali) che l’hanno costruita. “Sinfonia a Bombay” si snoda dagli anni Venti ai Quaranta attraverso una serie di esotismi: l’India coloniale (e poi l’India indipendente), l’Unione Sovietica, il balletto e Nijinskij, le avanguardie astrattiste e suprematiste, persino Fantomas e l’immaginario fumettistico di quegli anni…
Tuttavia, mentre l’oggetto dell’ispirazione di Mattotti è un oggetto-oggetto che permette, se così possiamo dire, un’applicazione diretta della passione, l’oggetto dell’ispirazione di Igort è un oggetto che è a sua volta un sistema di passioni applicate al mondo. Igort sa benissimo di muoversi sul filo di un estetismo a cui basta poco per rendersi insopportabile, e per questo deve giocare in maniera molto più distaccata, introducendo qua e là elementi di ironia, o soluzioni narrative smaccatamente legate a un genere letterario. Ma, nel complesso, il bello qui è che, nonostante ciascuna singola soluzione, grafica o narrativa, possa essere riportata a un modello rintracciabile, e porti quindi addosso le stimmate del “manieristico”, del “costruito a tavolino”, la storia raccontata e il testo nel suo complesso rimangono una storia e un testo passionali e profondamente emotivi, pieni di coinvolgimento e di mistero.
Osserviamo adesso con attenzione queste due tavole. Siamo in una fase avanzata della vicenda che Othmar sta raccontando al giovane Helios; Othmar ha definitivamente salvato Apa dalla prigionia e sono rifugiati a Mosca. Negli anni della prigionia, un solo episodio aveva colpito Apa, sino a diventare rifugio della sua immaginazione inevitabilmente malata: l’incontro con Nijinskij, il ballerino. Ecco che qui, a Mosca, una pagina di giornale le riporta improvvisamente Nijinskij alla memoria, e Othmar si rende conto che non ha affatto conquistato il cuore di lei.
Le due pagine costituiscono insieme una sequenza e un organismo grafico complessivo. Guardate nel loro insieme delineano due grandi aree, che non coincidono con le pagine: un’area di sinistra, qui a dominante azzurra, che comprende le vignette 1, 2 e 4 della prima pagina; e un’area di destra, che avvicina le vignette 3 e 5 della prima pagina a tutte quelle della seconda. Non è solo questione di un montaggio alternato tra la realtà (vignette 2 e 4) e le visioni di Othmar e Apa (vignette 3 e 5): l’ingrandirsi dello spazio della visione prelude graficamente al suo diventare totale nella seconda pagina, sino al ripresentarsi come modalità grafica per un’altra sorta di realtà, in sé ancora irreale, e tuttavia destinata, nel giro di poche pagine, a produrre conseguenze reali.
Andiamo ora a vedere come è costruita questa visione. Anticipata dalle tre ironiche figurine danzanti in fondo alla dida con cui si apre la prima pagina, l’immagine di Nijinskij in vignetta 3 era già apparsa nelle pagine precedenti, presentata come riproduzione del manifesto di una tournée a Tokio (un altro esotismo ancora). Il retro del giornale tenuto in mano da Apa mostra bene una scritta e un marchio che sono quelli di Valvoline, a loro volta deformati come caratteri pseudocirillici. L’immagine in vignetta 5 è costruita attraverso il montaggio di forme prese sia dal manifesto che dalla scritta.
Nelle vignette della seconda pagina queste forme vanno incontro a una trasformazione quasi musicale, con un procedimento cinematografico alla Ballet mecanique, dove invece che forme alla Leger si trovano ad agire forme alla Malevich o alla Lisitzky (ecco altri esotismi ancora, da aggiungere alla lista), sino ad arrivare all’immagine concreta, neo-reale (ma non del tutto reale, lo si vede bene) alla fine, che sarebbe magari insopportabilmente estetizzante se non fosse piena di piccoli elementi parodistici (l’automobile quasi da zio Paperino in fondo a destra, le lettere che ancora fluttuano nell’aria confondendosi con le mazze da golf, il cane futurista un po’ da Signor Bonaventura che piscia allegramente sull’elegante mise del padrone…).
Pur preso dalle sue passioni, Igort non è perso in loro. L’ironia permette la distanza dal mito, senza ucciderlo affatto. E nel mito di Igort alta cultura e cultura quotidiana convivono benissimo. Per questo dobbiamo non solo perdonargli l’estetismo, ma anzi ringraziarlo per essere riuscito a fare attraversare pure noi impunemente questa porta pericolosa.
16 Agosto 2016 | Tags: fumetto, Fumettologica, René Goscinny | Category: fumetto |

Caro Goscinny,
mi piacerebbe molto farti gli auguri per i tuoi 90 anni, ma purtroppo sei andato stabilmente in ferie dalla vita quasi 40 anni fa. Sei stato l’uomo del pianeta che mi ha procurato il maggior numero di risate, e della migliore qualità, e non smetterò mai di esserti grato per questo. Sei stato uno dei grandi autori di fumetti del Novecento, e uno dei protagonisti della scena francese degli anni Sessanta, e non smetterò mai di esserti grato anche per questo.
Persino la tua biografia mi ha fatto sognare. Doveva essere magico crescere nella Buenos Aires degli anni Trenta, specie per uno nato a Parigi da una famiglia di ascendenza ebrea polacca. Mica che a Parigi, quando i tuoi se ne andarono perché tuo padre ricevette un’ottima offerta di lavoro laggiù, gli ebrei polacchi ci vivessero male, almeno per qualche anno ancora. È perché in quegli anni l’Argentina doveva essere un luogo incantato, specie per un bambino pieno di immaginazione quale dovevi essere tu. Non c’erano solo i tanghi di Gardel nell’aria, e quella sua misteriosa scomparsa, nel 1935, della quale ancora oggi non si è smesso di parlare; e figuriamoci allora! dai nove anni in poi ci sei cresciuto dentro, a quel mito che aleggiava nell’aria.
E poi leggevi Patoruzù, le storielle di quell’Indio così simpatico e potente, quasi un’anticipazione di Asterix, mi viene da dire. E l’Argentina di quegli anni
Continua qui, su Fumettologica

Un commento di Leila Falà al post di ieri pone alcune domande molto interessanti, che sollecitano altre riflessioni da spiaggia (stavolta all’ombra incerta di una Tamerice rinsecchita, nella spiaggia più deserta che si possa immaginare – ma c’è una casa più su, in questo momento vuota, però nuova, e quindi segno certo che qualcuno viene, almeno ogni tanto).
Provo a sintetizzare il problema, a modo mio. Mi dice Leila che io sento in maniera così acuta il bisogno e l’impossibilità di comunicare la totalità della mia esperienza perché la sto vivendo da solo. Se fossi con qualcun altro, l’altro proverebbe a sua volta già le stesse (forse) sensazioni; e non solo il bisogno di comunicarle sarebbe minore, ma non sarebbe forse già diversa in partenza un’esperienza condivisa in questo modo? “È preferibile forse un’illusoria certezza di condivisione? Illusione che vi sia senso senza dover comunicare, ma che esso sia nella promessa che l’altro fa con la sua presenza?”
Il problema è di grande interesse. In primo luogo, non credo che il problema del dar senso e della comunicazione cambierebbe molto nella situazione in presenza. L’esempio con cui ho aperto il primo post di questa serie era accompagnato dalla considerazione che le mie parole (il mio senso) sarebbe stato tanto più efficace per voi quanto più aveste già vissuto esperienze di questo tipo, che le mie parole vi possano richiamare. Una persona che fosse con me qui e ora starebbe vivendo un’esperienza dello stesso tipo, sicuramente, e quindi le mie parole, il mio senso, potrebbe essere efficace al massimo. Le sue sensazioni saranno davvero le stesse delle mie? La risposta può essere soltanto probabilistica: poiché abbiamo (quasi) lo stesso DNA, siamo cresciuti nella stessa cultura e quindi vissuto esperienze formative simili, tenderemo ad avere sensazioni simili e a dar senso loro allo stesso modo; tuttavia, poiché la differenza individuale esiste, sia a livello di DNA che a livello di formazione, una certa differenza ci sarà. Ed è questo, tra l’altro, che in situazioni di questo genere, ci rende interessante non solo la spiaggia ma anche l’altro, l’altra persona, e questo complica fascinosamente il gioco.
Certo, la presenza di un altro renderebbe diversa l’esperienza sin dall’origine anche per questo, visto che l’altro entra a far parte dell’ambiente che ci produce sensazioni e interazione. Ma c’è dell’altro da prendere in considerazione, che mi sembra ancora più interessante. Ecco dunque la questione della illusoria certezza di condivisione. Nei termini detti sopra, la certezza di condivisione di senso è certamente illusoria, ed è quindi illusorio che ci sia senso senza dover comunicare, a partire dalla promessa procurata dalla presenza.
Ci sono però altri possibili termini, nel gioco, che hanno poco a che fare col senso, e con la comunicazione (almeno come la si intende tecnicamente quale trasmissione di informazione). Mi rifaccio un po’ al discorso sull’intimo che fa François Jullien: che cos’è questa strana connivenza che fa sì che ci si intenda anche solo con uno sguardo, senza bisogno di parole, o anche solo attraverso le parole banali del quotidiano?
Torniamo alla questione dell’azione, anzi dell’interazione. Abbiamo tutti ben presente la sensazione prodotta da un’azione che si sa fare, e che compiamo con disinvoltura senza sentire difficoltà. Camminare su un percorso non accidentato è un’azione estremamente fluida, con cui ci si accorda con grande facilità. Se il percorso diventa leggermente accidentato (come i sentieri per arrivare qui) l’azione resta abbastanza fluida, anche se a ogni passo abbiamo un piccolo problema da risolvere, al fine di non mettere il piede nel posto sbagliato e magari cadere. Questa piccola difficoltà può far parte del piacere, e avere a sua volta una sua fluidità, la fluidità della scoperta, compiuta da una creatura, quella umana, nella cui natura sta anche il saper risolvere problemi nuovi. Quando il percorso diventa ancora più accidentato, la questione cambia: c’è un limite oltre il quale qualsiasi senso di fluidità si perde, e non lo facciamo più per il solo gusto di farlo. Dobbiamo avere un motivo per farlo, una meta. Dobbiamo a ogni passo risolvere problemi impegnativi. Dobbiamo, in un certo senso, a ogni passo dar senso al mondo davanti al nostro piede, e scommettere sull’esito della nostra azione: capire è diventato indispensabile. Ogni passo pone un problema che deve essere analizzato razionalmente e risolto.
Se poi però facciamo il medesimo percorso molte volte, quei problemi non saranno più tali. Saranno già risolti, e l’interazione con il percorso sarà ritornata fluida. Così va l’apprendimento pratico (anche nelle sue applicazioni alla teoria).
Un’interazione fluida produce in noi la sensazione di un accordo con il mondo, quello che in tedesco si dice Stimmung, che è un termine musicale, ma anche psicologico. Se camminiamo fluidamente insieme con un altro, la nostra Stimmung non si produrrà solo nei confronti del mondo, ma anche di questo altro insieme con cui camminiamo. Tutti gli umani sanno camminare più o meno altrettanto bene, per cui non diamo grande valore a una Stimmung tra persone basata su questo. Già però trovarsi ad affrontare fluidamente insieme il percorso accidentato di cui si diceva poco sopra potrebbe produrre una Stimmung più intensa, un sentimento di comunione e di accordo.
Ora pensiamo a quello che succede con le situazioni ritmiche, come la danza. Quando balliamo, siamo necessariamente tutti accordati, sulla base della musica. Magari ciascuno lo fa con gesti propri, diversi da quelli degli altri, ma tutti questi gesti hanno un andamento in comune, e questo è immediatamente riconoscibile.
Io credo che il senso di Stimmung sia uno degli elementi fondamentali della formazione delle comunità umane, a partire dalle loro remote origini rituali: un rito è esattamente un contesto che produce una Stimmung collettiva.
La condizione di intimità tra due persone è una condizione di Stimmung che riguarda interazioni sentite da ambedue come fondamentali. Poco importa che la fluidità che ne risulta nell’interazione reciproca si basi su un’illusione cognitiva (perché in verità le sensazioni di ciascuno e il senso che ciascuno attribuisce loro potrebbero essere diversissimi). La Stimmung non è illusoria, proprio come l’intimità: o c’è oppure non c’è. Che ci sia non garantisce che duri: che invece debba durare può essere davvero un’illusione! (e tanto spesso ne restiamo vittime!)
Se io fossi su questa spiaggia con un’altra persona, la nostra intimità (almeno momentanea) sarebbe certamente più forte di tutto il senso che potrei pensare di trasmettere, e che probabilmente non sentirei nemmeno il bisogno di trasmettere, se non in piccola parte. Nemmeno sentirei l’ansia di non poterlo fare. Di fatto ci sentiremmo accordati nella nostra interazione con le cose intorno, e auspicabilmente anche nella nostra interazione reciproca. In questo senso la mia esperienza sarebbe certamente diversa da quella che è ora.
La Stimmung non si produce solo in presenza (anche se in presenza essa è più facilmente di maggiore intensità). La poesia, l’opera d’arte in generale è qualcosa che produce Stimmung, accordo. Anche quando la fruiamo individualmente, sappiamo che non siamo i soli a fruirne: in qualche altro momento e luogo qualcun altro sta compiendo un’esperienza in accordo con la mia. I Greci conoscevano la magia del teatro, tanto più forte in compresenza, ma che poteva anche legare città diverse o diverse generazioni tra loro nella stessa Stimmung, nello stesso andamento fluido dell’esperienza.
(Mentre scrivevo le ultime righe qui sopra, il mio piccolo paradiso è svanito. Nel giro di pochi minuti sono arrivati prima un motoscafo con una dozzina di persone, e poi due battelli piuttosto grandi e così fitti di gente che parevano immigrati. Musica bumbum a tutto volume, schiamazzi, un sacco di gente a riva: un’improvvisa riminizzazione. Non certo l’altro con cui io potrei sentire alcun senso di intimità, nessuna connivenza, nessuna Stimmung – né peraltro nessun desiderio di trasmettere loro qualsiasi senso io possa essere in grado di dare alle cose. Me ne sono andato. Dopo qualche ricerca, nemmeno troppo sofferta, ho trovato questo rifugio che documento qui sotto, se potete capire, ed entrare in una qualche sintonia con me.)

 Devo aggiungere alcune considerazioni alle riflessioni di ieri sull’impossibilità di dare senso alla totalità dell’esperienza, e quindi alla (dolorosa) impossibilità di comunicarla pienamente. Devo aggiungere alcune considerazioni alle riflessioni di ieri sull’impossibilità di dare senso alla totalità dell’esperienza, e quindi alla (dolorosa) impossibilità di comunicarla pienamente.
Il punto non è tanto (o non è solo né soprattutto) l’impossibilità di cogliere il mondo nella totalità dei suoi aspetti. Che la cosa in sé fosse inattingibile ce lo diceva già Kant, e Peirce, correggendo la mira, parlava di un avvicinamento asintotico progressivo. Ma credo che il punto non fosse affatto quello, perché quello che sentivo era un’incapacità di dar senso, e quindi comunicare, qualcosa che nella mia esperienza comunque c’era – e quindi non si trova a livello della cosa in sé.
Continuando a riflettere (l’eccesso di spiaggia conduce anche a questo) credo che il problema riguardi l’interazione che sto avendo con il mondo attorno – certo, in questo caso, un’interazione estremamente gratificante, e che amerei quindi trasmettere agli altri. Interazione, e quindi azione e percezione dei suoi effetti sul mondo, e conseguente ancora azione con conseguente percezione e così via.
Assumiamo (eccedendo un poco, per semplicità) che nel percepire stiamo già dando un senso, e che quindi ciò che percepiamo sia comunicabile (non è vero per ciascun linguaggio specifico – provatevi a descrivere, con Wittgenstein, il suono di un clarinetto, o il sapore della cipolla! – ma se potessimo registrare tutte le dimensioni sensoriali arriveremmo probabilmente più vicini a questo). Rimane comunque il fatto che la nostra azione non è in sé comunicabile: ovvero, possiamo certamente comunicare la percezione che abbiamo della nostra azione (quello che ne sappiamo insomma, a priori come le sue ragioni, o a posteriori come i suoi effetti), ma non comunichiamo l’azione in sé.
Nonostante siamo noi a compierla, noi conosciamo l’azione più o meno come conosciamo le cose attorno a noi, con l’aggiunta che ne conosciamo (riteniamo di conoscerne) il perché. Non diamo senso all’azione in sé, bensì alla percezione che ne abbiamo, ed è questo che possiamo comunicare.
Ora, il punto è che mentre la cosa in sé appartiene al mondo là fuori, e siamo rassegnati a coglierla solo in parte, l’azione in sé appartiene al mondo qua dentro (l’ho prodotta io, insomma) e ci appare scandaloso, doloroso, non poterle dare senso se non in maniera tanto esteriore come ci accade con le cose. E’ uno smacco profondo al nostro senso dell’io: la drammatica presa di consapevolezza che il nostro fare, il nostro agire, ci è cognitivamente tanto estraneo quanto il mondo attorno. Profondamente dentro di noi c’è insomma un fuori. Il mondo esterno non è solo nella spiaggia attorno a me, bensì anche nella mia interazione con lei, scandalosamente inconoscibile, se non nella stessa maniera parziale con cui diamo senso al mondo.
La filosofia occidentale, da Platone a Cartesio, da Kant a Husserl, è sembrata passare di fianco a questo abisso, senza coglierlo. Questo perché Platone (che, da quel genio che era, non faceva che dare chiarezza e precisione filosofica a dei presupposti contenuti nella sua lingua, come un po’ in tutte le lingue indoeuropee) ha impostato la base del nostro pensiero sull’idea, sul conoscere, giocando sempre al limite tra metafisica e gnoseologia – e così è stato per più o meno tutti quelli che hanno discusso con lui, da Aristotele ai giorni nostri. L’Occidente, così, ha messo il conoscere al centro del proprio mito, pensando la filosofia (conoscere il conoscere) come il proprio punto più alto.
L’abisso viene intuito da Nietzsche, e sostanzialmente rifiutato – proprio nel guardarlo – da Freud, che proprio mentre fornisce i mezzi per concepirlo, continua a parlare di inconscio come di un soggetto nascosto, ma tutto sommato conoscibile. E comunque una sorta di io, non di mondo: un io segreto, sotterraneo, che lo psicoanalista può almeno in parte portare alla luce. Ma quando lo psicoanalista vi spiega che le ragioni per cui avete compiuto una certa azione non sono quelle che credete, bensì altre, cosa ne è del vostro io? Per un attimo scorgete confusamente l’abisso, poi la nuova spiegazione sostituisce la vecchia, e dove c’era l’Es ecco che c’è di nuovo l’Io; certo diverso, dotato di maggiore conoscenza. E alla lunga il processo analitico funziona…
Di fronte al problema di dar compiutamente senso alla mia esperienza su questa spiaggia, l’abisso, invece, si manifesta con forza. La mia interazione con questo amabile intorno non può essere comunicata né più né meno che nei limiti con cui posso comunicare la percezione che ne ho. Peggio anzi: non c’è macchina fotografica, non c’è registratore sonoro, tattile, olfattivo, gustativo, che possa cogliere la mia azione, se non in maniera ancora più esteriore di quanto lo possano le mie parole, già loro evidentemente e ampiamente insufficienti. E la mia azione è l’interazione continua con tutto quello che ho attorno, dal modo di respirare, di muovermi, di toccare le cose: persino la percezione che delle cose sto avendo è intessuta della mia interazione con loro!
Posso produrre un report di tutto ciò, con tutta l’inevitabile esteriorità che tale report avrà, come ho abbozzato ieri, come ho continuato a fare con le foto di oggi.
Oppure posso scrivere una poesia, girare un film, dipingere, comporre un brano musicale. Sarà tanto più evidente, ora, quanto la credenza che un’opera di questi tipi possa comunicare la mia esperienza del qui ed ora, trasmetterne un senso. Non è certo così che funziona la poesia, né l’arte in generale: non descrivendo il mondo, né le emozioni del soggetto, come credevano i Romantici. Travolti dalla nostra adorazione per il Conoscere, abbiamo trattato l’arte come qualcosa che debba trasmettere un messaggio, e questo messaggio vada colto dal fruitore attraverso il processo di interpretazione. Già Susan Sontag, nei primi anni Sessanta, lamentava il dominio dell’interpretazione (il libro è, appunto, Contro l’interpretazione), facendo osservare che questo modo di vedere le cose ha condizionato gli artisti stessi, che hanno prodotto tante opere affinché fossero poi interpretate, riempiendole di verità nascoste, come in un esercizio di enigmistica.
In realtà, quello che capiamo di un’opera d’arte, di una poesia, è importante probabilmente non di più di quello che non capiamo. Un’opera d’arte è tale non per quello che ci dice, ma perché ci propone un’esperienza, intessuta di capire e non capire come le cose del mondo, e a sua volta piena di interazione, perché noi le siamo di fronte, o immersi al suo interno (come nella musica), e quello che percepiamo dipende dalle mosse che facciamo nei suoi confronti. Proprio come con il mondo, non è che percepiamo e basta le opere d’arte, ma il percepire è frutto dell’agire nei loro confronti: dove posiamo lo sguardo, dove e come si fissa l’attenzione, come ci muoviamo nei loro confronti…
Insomma, l’opera d’arte, come il mondo, viene vissuta prima che percepita, e quindi percepita nell’interazione con lei. In questo senso è piena, proprio come il mondo, di quell’inumano che finiamo per ritrovare anche dentro di noi.
La differenza, come concludevamo ieri, è che di mondo si può anche morire, mentre di poesia no; e questo permette un’interazione molto più disinvolta. Ma questa disinvoltura, se siamo sufficientemente attenti, è anche quella che ci permette più facilmente di cogliere l’abisso. Una grande poesia può essere quindi un’esperienza lancinante, ancora più di questa spiaggia, perché mi riguarda ancora più da vicino.

6 Agosto 2016 | Tags: estetica, Grecia, Kalymnos, poesia | Category: estetica, poesia | 
Ecco. Mi trovo qui. Ho camminato per più di un’ora sotto il sole greco, per sentieri mal tracciati e pieni di sassi, un paio di volte scivolando, passando di fianco a un’immensa cavità naturale sul fianco della montagna, un buco che finisce, verso l’alto, con una gigantesca caverna, profondo oltre venti metri dove lo è di meno, pieno di stalattiti e stalagmiti. E adesso sono qui, al bordo dell’acqua del mare appena ondulato, trasparentissimo, all’ombra di una piccola scarpata (e non so quanto quest’ombra durerà), con una lieve brezza. Non fa troppo caldo. Si sta bene.
Sto cercando, se non si era capito, di dare un senso a quello che sto vivendo. Dare un senso significa poter trasmettere a qualcun altro l’esperienza, significa rendere umano il mondo che ci circonda. Lo faccio scrivendo, scattando una foto per poterla mostrare. Se potessi, registrerei i suoni, gli odori, le sensazioni del sole e del vento sulla pelle.
Eppure, per chi mi legge, tutto questo prenderà vita solo nella misura in cui ha già provato, in qualche momento precedente, qualche esperienza che le mie parole, le mie immagini (e suoni, odori registrati, se ci fossero) possano richiamare. Se non avete già vissuto qualcosa di analogo, quello che dico o che mostro rimane informazione astratta, non evocativa. Magari, se per qualche motivo rimane in memoria, potrà diventare evocativa in futuro, una volta che l’esperienza analoga sia stata vissuta: è questa la sorte di tante parole che solo in seguito ci accorgiamo di non aver capito, o non capito del tutto in passato.
Scrivo queste parole, in realtà, perché la cosa che mi ha colpito arrivando in questo luogo e guardando, rapito, la trasparenza dell’acqua sui sassi, è stata l’improvvisa consapevolezza che avrei dovuto rinunciare a darle un senso – o, perlomeno, che qualunque senso le avessi dato, sarebbe stato parziale e fuorviante. Potevo fotografare, descrivere a parole (e l’ho fatto, e continuerò a farlo), e la mia qualità di fotografo e descrittore verbale sarà maggiore o minore, sapendo provocare in misura maggiore o minore reazioni in coloro che guardano le mie immagini o leggono o ascoltano le mie parole. Questo va fatto; è necessario: dare senso al mondo è ciò che ci permette di viverlo.
Ma la consapevolezza che questo processo di dar senso è inevitabilmente, necessariamente incompleto, è qualcosa, in verità, di quasi doloroso. Significa che quello che sto vivendo non può essere veramente acquisito, ridotto a me. Non me lo posso portare con me, per passarlo magari ad altri. È vincolato al qui e ora, all’esser qui, al sentire bruto. Condannato come sono io al capire, il toccare con mano la banalità del non capire quello che comunque sento intensamente, che sento in maniera quasi bruciante, è quasi un dolore, certamente un’ansia, un lutto.
Elaborare questo lutto vuol dire rassegnarsi all’impossibilità di dare un senso a quello che sto vivendo. Qualsiasi senso io possa dare sarebbe comunque la trasformazione di quello che sta attorno a me in una materia nuova (immagini su un supporto, parole, registrazioni di vario tipo), la quale comunque produce le sue percezioni, e trasmette, insieme con il mio, altri sensi suoi – e magari qualcos’altro ancora di non riducibile al senso.
Rassegnarsi all’impossibilità del senso (pur dovendolo produrre) è qualcosa che mi ricorda qualcosa che viene ripetuto in varie discipline orientali, tra cui lo yoga: “non giudicare”. Però è molto più di questo. Giudicare è una forma di senso già molto elaborata: posso aver già prodotto molto senso, senza aver ancora giudicato. Se scatto una foto, la foto sta già dando senso al mondo, ma ancora non lo giudica. Eppure, come abbiamo visto, la foto stessa non basta: qui attorno c’è infinitamente di più di quello che essa può mostrare.
La direzione è comunque quella indicata dal “non giudicare”, ma andando più in là: rassegnati a non poter dar senso. Stai lì e vivi. Quello che possiamo sperare è che tutto questo che ci sta attorno e che indubbiamente ci colpisce senza che siamo capaci di renderne conto dandogli senso, agisca comunque su di noi, e contribuisca magari indirettamente alla formazione di altro senso futuro, magari solo perché di fronte alla descrizione fatta da qualcun altro, saremo in grado di rivivere questo groppo di sensazioni e di emozioni.
C’è, nel fare poetico, sempre la speranza non tanto di rendere la sensazione vissuta in un certo momento (il che sarebbe comunque perdente) quanto di costruire una sensazione che, attraverso il senso, paradossalmente, sappia creare una situazione in cui il lettore si trovi a esperire di più di quello che riesce a trasformare in senso, e viva il piccolo dramma che oggi io ho vissuto qui. Poiché si tratta di poesia, e non di natura, il dramma sarà però catartico, e non tragico: non capire la natura attorno a noi ci può uccidere; non capire la poesia non ci uccide mai, e quando capiamo perché non capiamo, la cosa è persino didattica, e certamente già umana, a sua volta già dotata di senso.


Transmedia storytelling: Trasposizioni
Ripetizione rituale e sviluppo narrativo
Daniele Barbieri
Abstract
La serialità moderna condivide numerosi aspetti con quella che potremmo chiamare serialità primaria, differenziandosi sostanzialmente da essa per la presenza di una periodicità alla sua base. A separarle storicamente sta la nascita e lo sviluppo del romanzo, come forma narrativa unitaria, la cui esistenza stessa permette il porsi del problema teorico della natura della serialità. Ma tra la serialità primaria e quella moderna si trova anche la nascita e lo sviluppo della stampa periodica, la quale finisce per essere il modello della nostra serialità. Nella comprensione del rapporto tra serialità e narrazione, giocano un ruolo particolare le saghe, le più difficili da ricondurre al modello narrativo standard. È possibile osservare che in alcune saghe la dinamica narrativa non è in verità al centro dell’interesse del lettore, e si limita a costruire il quadro di una sorta di accesso al mito. Che cosa succede, infine, quando la serialità moderna si riavvicina a quella primaria, neutralizzando la periodicità (per esempio, attraverso la pubblicazione dei telefilm nel Web)?
Parole chiave
serialità; semiotica; narratività; fumetto; mito
L’articolo intero si trova qui, su Between.
6 Luglio 2016 | Tags: fumetto, Lorenzo Mattotti | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Lorenzo Mattotti, Fuochi, pagina 14 Certo non potrò seguire ancora molto a lungo il criterio di queste prime scelte per questa rubrica, scelte che stanno andando, come vedete, da maestro ad allievo; ma ancora per stavolta posso proseguire, e proseguo. Hugo Pratt (n. 1927) è indubbiamente l’autore di riferimento per la crescita stilistica di José Muñoz (n. 1942), così come Muñoz lo è a sua volta per quella di Lorenzo Mattotti (n. 1954). Fuochi (pubblicato a episodi su Alter dal 1984, e poi da allora numerose volte in volume) è indubbiamente il suo primo capolavoro, il risultato di una acquisita maturità stilistica.
Fuochi è la storia di un uomo (Assenzio, ufficiale di corazzata) che, favorito dagli spiriti di un’isola, si perde nelle proprie emozioni e sensazioni, finendo per provocare il proprio disastro spirituale e la distruzione stessa della nave. Non si tratta di un racconto astratto ed evanescente: al contrario, il racconto è continuamente chiarissimo e pieno di tensione narrativa. Ma l’astrazione e l’evanescenza non mancano, visto che sono esattamente ciò di cui si parla: quel perdersi nelle proprie emozioni che è il filo portante della vicenda, nei loro aspetti positivi e in quelli negativi, ben difficilmente (anzi quasi mai) distinguibili tra loro, se non (un poco) a posteriori, quando la vicenda si è conclusa.
La qualità di Fuochi è quindi legata alla capacità di Mattotti di tenere insieme un filo narrativo nitido e coinvolgente con una serie di travasi emotivi, di improvvise cecità, o di estreme lucidità del tutto straniate. Il filo narrativo è il cavo a cui il lettore si tiene sicuro nella propria avanzata; l’esasperata sensibilità è da un lato l’oggetto del racconto (il perdersi a cui va incontro il tenente Assenzio), e dall’altro la modalità percettiva che viene continuamente proposta al lettore, il quale in questo modo si identifica sempre di più con il protagonista, sino a vivere in prima persona le sue sensazioni.
La chiarezza del filo narrativo è garantita sostanzialmente dalla successione delle immagini e dei dialoghi: si capisce sempre esattamente che cosa stia succedendo, e perché quella cosa sta succedendo sulla base di quanto era accaduto prima (si capisce a posteriori, ovviamente: il racconto è pieno di sorprese). Viceversa, la vividezza dell’emozione è qualcosa che riguarda il singolo istante, ciascun singolo istante, ed è perciò costruita attraverso la forma visiva delle singole immagini, delle vignette. Le didascalie che contengono il flusso di coscienza del protagonista sono una struttura di mediazione, il prodotto di una coscienza che cerca di spiegarsi, razionalizzarsi, raccontarsi quello che le sta succedendo: e infatti, man mano che la storia procede, queste didascalie si fanno sempre più lapidarie, più sgranate, più brevi, sino a scomparire del tutto verso la fine.
Le singole vignette hanno di conseguenza un duplice ruolo: devono contenere un’immagine semplice da decifrare, per permettere al lettore una facile comprensione dell’evoluzione della storia; ma devono al tempo stesso contenere tutta la complessità necessaria per essere fortemente evocative.
Guardiamo dunque la tavola qui a fianco, quattordicesima di sessantadue. Ci troviamo ancora in una fase narrativa iniziale: l’isola sta appena iniziando a manifestare il proprio potere su Assenzio, che si trova in esplorazione con un gruppo di soldati.
Questa tavola è la prima, in tutta la storia, a enfatizzare il proprio sviluppo verticale, con la grande vignetta a sinistra alta due terzi dello spazio, che contiene a sua volta una figura a sviluppo verticale come il faro. Nell’economia complessiva del testo si presenta come una sorpresa, esattamente come il faro alla percezione del protagonista Assenzio: insomma, quello che percepisce il lettore qui è del tutto analogo a quello che percepisce Assenzio in quel momento della sua vicenda. Persino la didascalia che dice “Il faro” non è una semplice descrizione (che sarebbe superflua perché il faro si riconosce benissimo da sé), ma il grido di sorpresa del protagonista.
Guardate ora rapidamente le cinque vignette: l’apparizione del faro, il soldato che lo osserva, di nuovo il faro (in avvicinamento), i soldati che si guardano attorno alla base del faro, Assenzio che sale le scale. La comprensibilità del loro oggetto è immediata, così come immediata è la loro concatenazione narrativa. Ma, subito dopo, ci si accorge che tutto, in queste immagini , è fatto per ridurle a macchie di colore e di luce, a contrasti cromatici. Guardate quella in cui ci sono più figure, cioè la quarta vignetta: dei tre soldati, solo a uno si vede il volto, ed è ridotto a una maschera; al soldato più vicino resta persino tagliato fuori dall’inquadratura. Così, anche qui la variegata struttura giallo-verde dei soldati diventa una base orizzontale su cui si staglia la verticalità della scala sul fondo.
Questo dominio della sensazione si trova vissuto qui insieme dal protagonista e dal lettore, identificati in questo modo sin dall’inizio (e andando avanti sempre di più) in una comune discesa nel Maelstrom.
Se avete sottomano Fuochi, è facile verificare la trasformazione visiva che hanno le rappresentazioni stesse dei fuochi nel corso del testo: all’inizio geometriche e compatte, perché lontane e vissute da fuori, poi informi e sgranate, quando sono un vissuto interiore esaltante e doloroso, e alla fine ancora sgranate ma lineari, quando sono l’esplosione dei cannoni, della corazzata e del sé del protagonista.
Raccontare una storia non è mai un semplice elencare una successione di fatti. Una storia riuscita cerca di farli anche vivere, quei fatti, alla sensazione del lettore. Mattotti, in Fuochi, sfrutta questa possibilità al massimo grado.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|


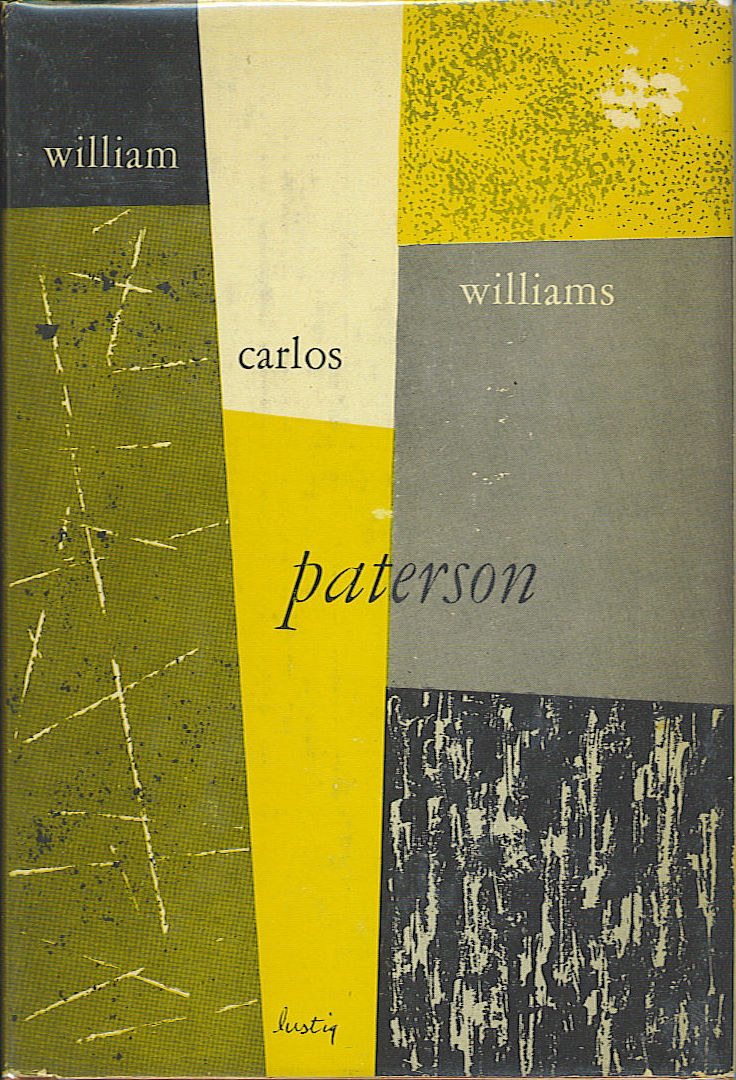







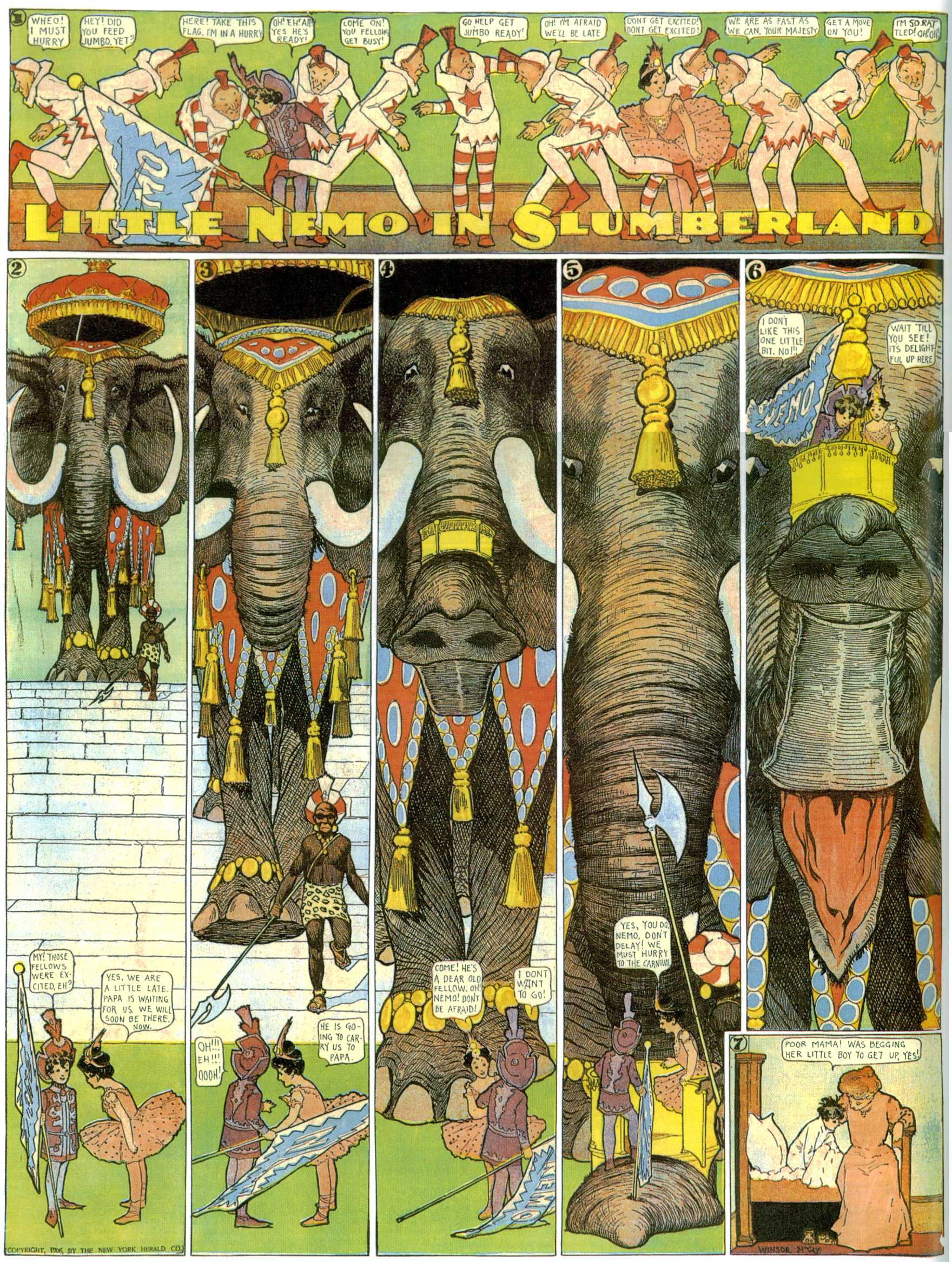

 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



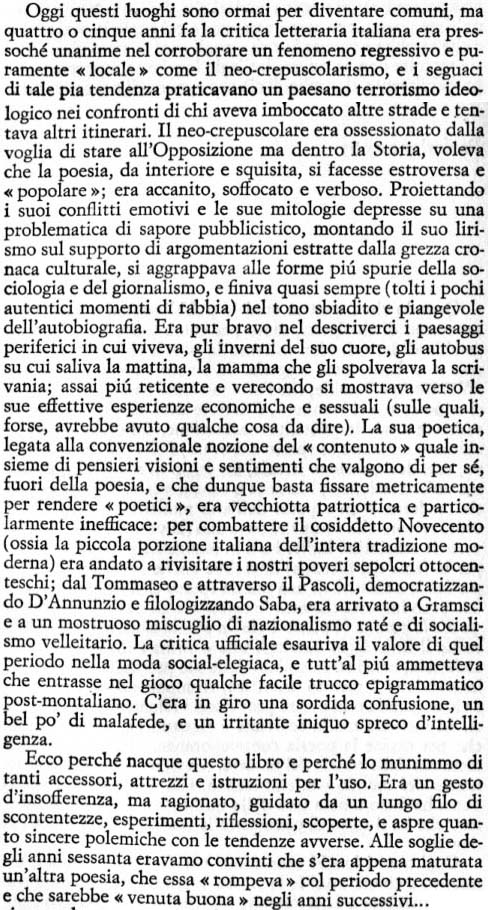
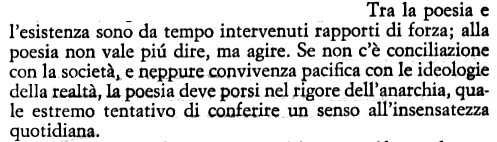
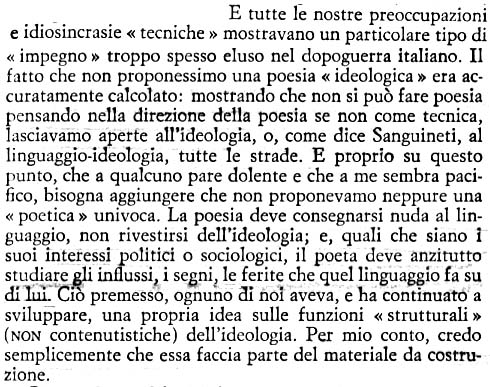
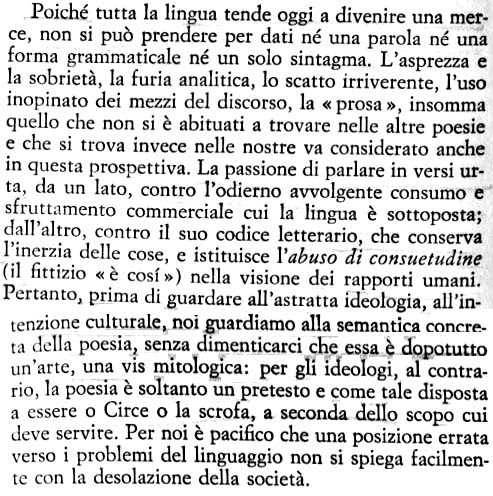
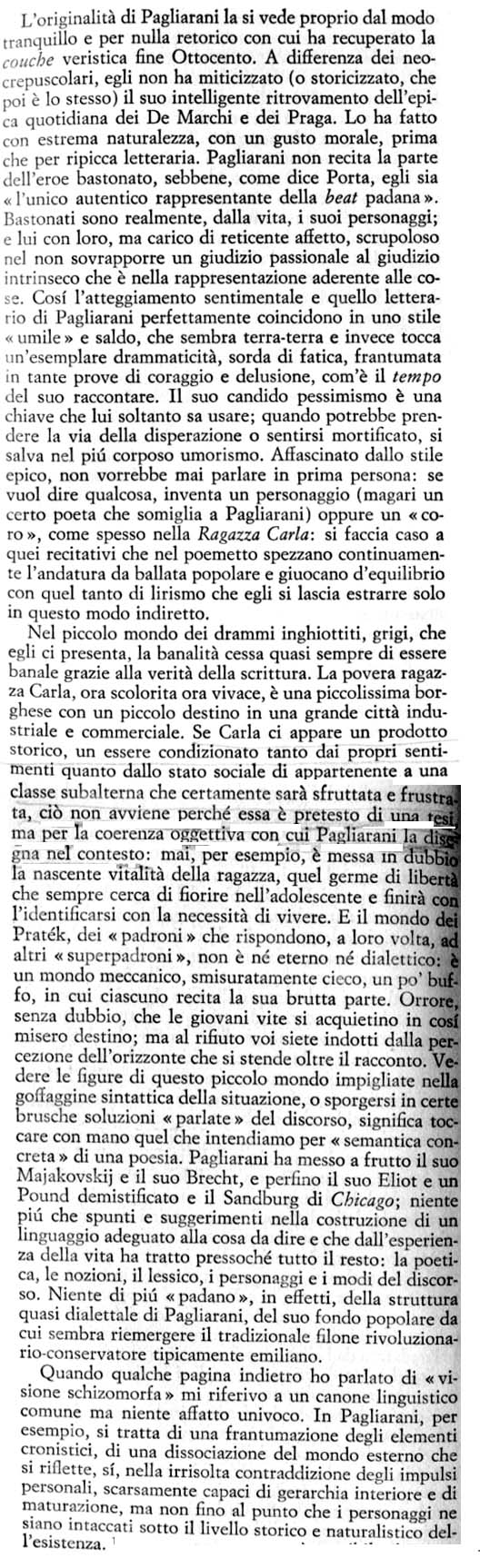
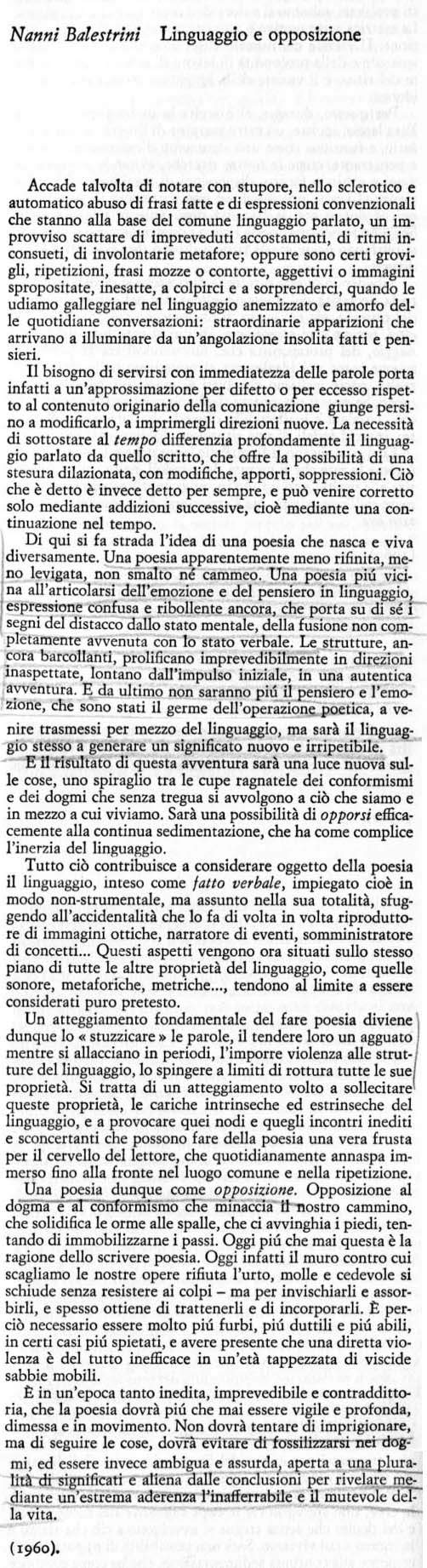






































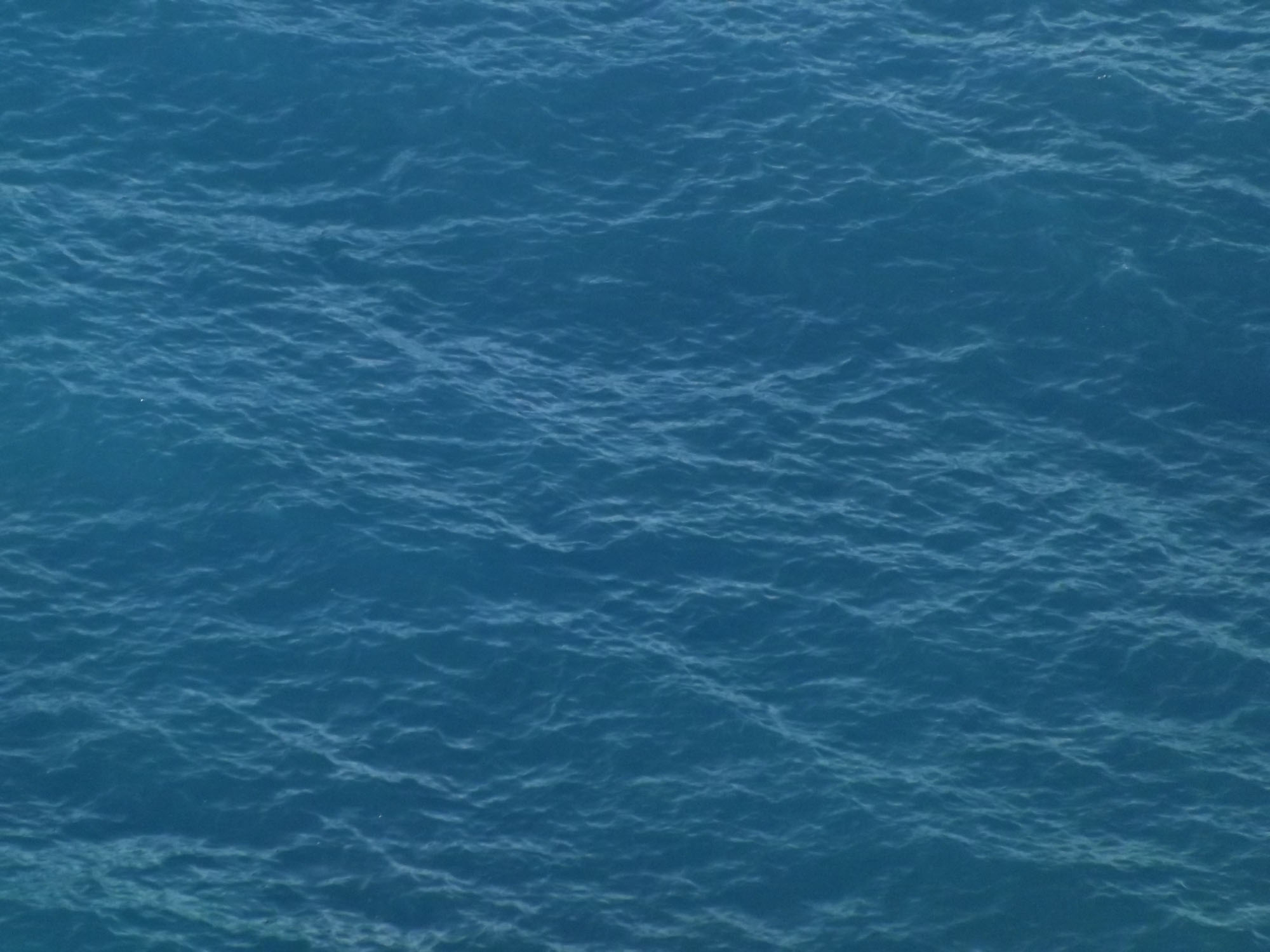

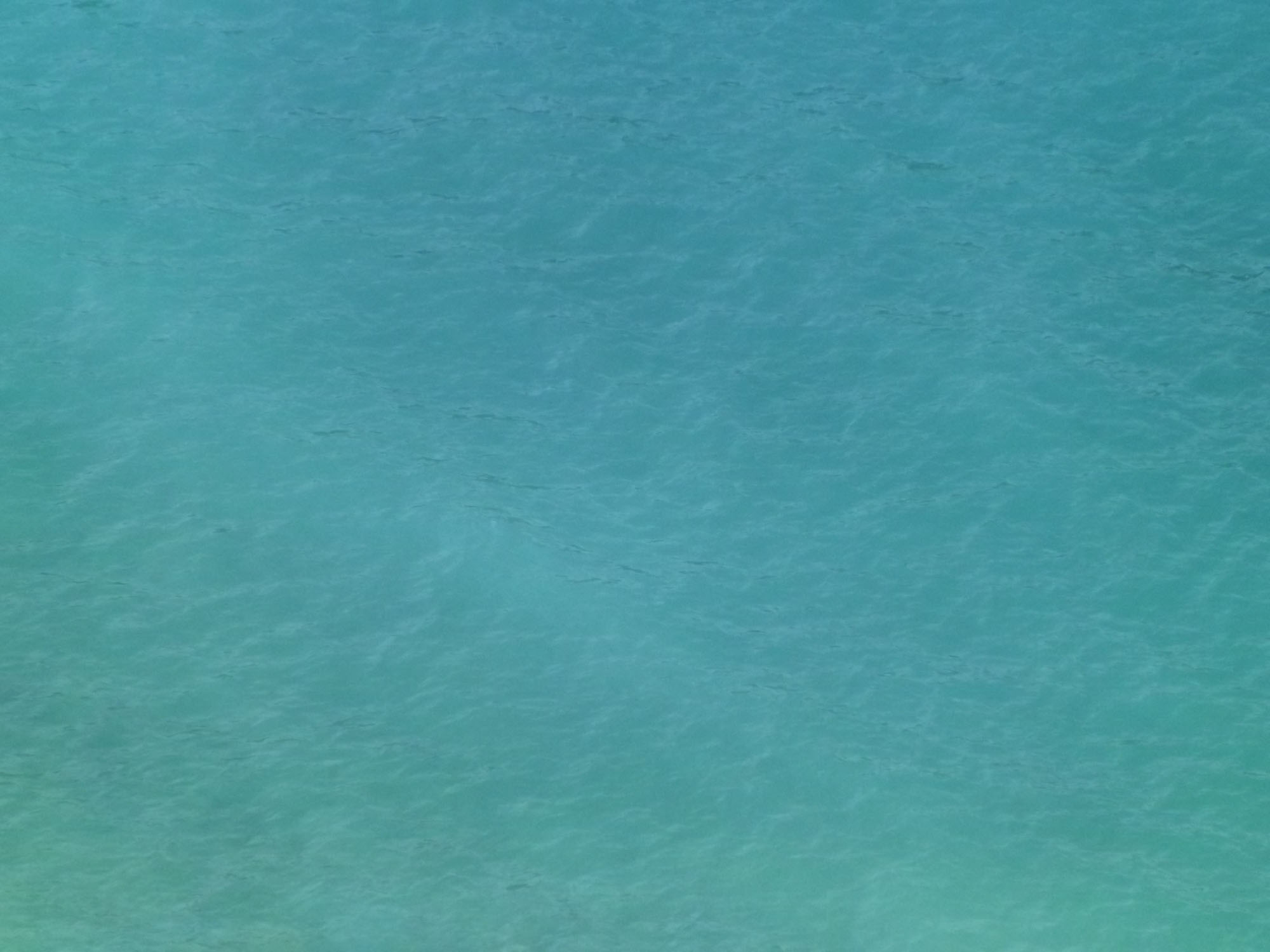





























































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco




Commenti recenti