15 Aprile 2018 | Tags: Dino Battaglia, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Dino Battaglia, “Due amici”, 1976
“Due amici” è il racconto con cui, nel numero di agosto del 1976 di Linus, Dino Battaglia inaugura la serie che poi confluirà nel volume Maupassant. Si tratta di una decina di versioni a fumetti di racconti, per l’appunto, di Guy de Maupassant, scritti e ambientati nella Francia di fine Ottocento. “Due amici” ha inizio nella Parigi dei primi mesi del 1871, durante l’assedio prussiano; non è rimasto quasi nulla da mangiare; due amici si incontrano, e, grazie anche a qualche bicchierino di troppo, decidono di andare a pescare, nonostante la situazione, nel loro posto tradizionale, nella zona occupata dai prussiani. Ottengono il salvacondotto grazie a un’amicizia altolocata, e vanno. Dopo qualche ora di pesca, vengono sorpresi da una pattuglia prussiana. L’ufficiale cerca di estorcere loro la parola d’ordine per rientrare oltre le linee francesi, ma entrambi rifiutano di parlare, nonostante la minaccia di morte. Dopo averli fatti fucilare, l’ufficiale prussiano si fa cucinare il pesce da loro pescato.
Tutto il racconto di Maupassant è giocato sulla contraddizione struggente tra la bellezza della natura e l’orrore della guerra, un orrore sempre presente, anche se dapprima come uno semplice sfondo inquietante, e poi, di colpo, come un destino tragico. Battaglia enfatizza questa opposizione, mettendo in mostra una natura rigogliosa e fiorita, del tutto dimenticandosi di aver iniziato il racconto, seguendo le parole di Maupassant, con un “In una luminosa mattina di gennaio…”. Ma di questo attacco si dimenticano rapidamente anche i lettori, tanto fluida e genuina per lo sviluppo narrativo appare la costruzione del contesto naturale…
Del resto, guardiamo questa penultima pagina del racconto, che mostra la fucilazione dei due amici, e la loro sbrigativa “sepoltura”. Nella seconda e nella quarta vignetta, la tragedia si consuma tra le piante fiorite, in mezzo a una natura meravigliosa e indifferente, ma non per questo meno coinvolgente. Oppure, guardate nella prima vignetta, in cui il corpo del Signor Morisot sembra quasi prendere radici al contatto col suolo, o comunque mescolarsi con l’erba. O guardate la terza, nella sua inconsueta verticalità, in cui tutto lo spazio in basso descrive sì un riflesso (tranquillo e meraviglioso a sua volta) ma anche, insieme, un’insondabile profondità, come quella della morte.
Ho lavorato più volte su un tema che nell’arte grafica di Dino Battaglia riveste una particolare importanza, quello dell’uso del bianco. Come si vede bene anche in questa pagina, il bianco può assumere qui ruoli diversi, e anche combinarli o mescolarli. Può essere un colore, come – in parte – nel corpo del Signor Morisot, o come nei cieli. Ma può essere anche un’assenza, di colore e di altro, come nello stesso corpo di Morisot, o come nel terreno sotto il cadavere di Sauvage nella seconda vignetta. Infine può essere una distanza, un distacco, una separazione, quale è normalmente lo spazio bianco tra le vignette, ma che qui ha una dimensione variabile e un valore sia narrativo che plastico. In aggiunta, può essere anche il semplice fondo-pagina su cui si stagliano le parole nelle didascalie e nei balloon.
E partiamo da queste ultime parole. Di quattro cartigli presenti sulla pagina, tre sono incorniciati e solo uno è liberamente steso sul fondo pagina, Questo uno, benché chiaramente relativo alla seconda vignetta, ne è più largo, e non si lascia iscrivere in un rettangolo ideale. Questo è tanto più significativo perché, come si vede bene in questa pagina, il lettering di Battaglia è attentamente coerente con lo stile del tratto dei disegni: parole e figure, insomma, appaiono formate della stessa materia. La prima e la quarta vignetta sono in parte senza cornice, ed è la posizione della cornice del cartiglio a definirne i limiti spaziali. La terza vignetta, quella lunga, è invece interamente incorniciata, e include il cartiglio, il quale, a sua volta, entra visivamente nell’alternanza delle aree chiare e scure, contribuendo a costruire una sorta di ritmo, all’interno del quale emerge la nota assai più lunga delle altre del riflesso nell’acqua, secondo la sequenza bianco (il cartiglio), nero (il bosco), bianco (il terreno coi soldati e il riflesso di tutto questo), neeeero (il riflesso del bosco), bianco (il riflesso del cielo). È grazie a questo ritmo alterato che il riflesso del bosco appare così profondo, alludendo a quella profondità da cui vengono i pesci (i doni della natura ai due amici) e a cui stanno per approdare i corpi martoriati.
Ma il cartiglio della seconda vignetta appare libero, e del tutto non inquadrato, né in maniera assoluta come quello della terza, né in maniera relativa come gli altri due. Anche qui c’è un’alterazione ritmica: un elemento libero tra elementi vincolati. Questo elemento libero è accostato alla vignetta che si trova tagliata dalla cornice nella maniera più drastica: mentre nelle altre tre i blocchi dei corpi descrivono la scena interamente, e la descriverebbero allo stesso modo anche se la cornice fosse meno definita, la cornice della seconda vignetta è essenziale per focalizzare solo i dettagli dei corpi caduti, dietro gli steli dei fiori in primo piano. E sono gli steli, qui, che potrebbero fare a meno della cornice, come se fossero loro i protagonisti – ed è in realtà questa l’allusione di Battaglia, fedele interprete dello spirito di Maupassant: la bellezza della natura resta, vince, a dispetto della malvagità dell’uomo e dell’orrore della guerra. E forse quella didascalia lì sopra è libera proprio come sono liberi quei fiori, si allarga sulla pagina, non possiede un confine che la debba definire.
Del resto il bianco come distanza è in Battaglia non solo un prezioso elemento di equilibrio grafico della pagina nel suo insieme, ma anche la materia stessa del flusso narrativo. È ciò che scandisce il ritmo, ora allargandosi, ora restringendosi, ora confondendosi del tutto o in parte con i bianchi interni delle vignette. Il bianco, quando non è un colore, rappresenta comunque un’assenza, che sia l’assenza (momentanea) di racconto (quella tra le vignette, quella che qualifica inesorabilmente il loro ritmo), o che sia l’assenza di definizione descrittiva. A differenza del cielo, che è bianco perché è chiaro, il corpo di Morisot nella prima vignetta è bianco perché egli ha già perso la vita, è già entrato nell’assenza di definizione della morte. Sauvage, sopra di lui, è ancora vivo, benché traballante, e il bianco sta invadendo pure lui. La processione, bianca, della terza vignetta si svolge evidentemente nel silenzio, cioè nell’assenza di definizione sonora; mentre il colore scuro ritorna nella quarta, dove lo splash nell’acqua è forte anche se non viene scritto sulla pagina. Del resto è silenzioso il cielo, ogni volta che appare (anche nel riflesso della terza vignetta), ed è silenziosa la terra sotto i fiori nella seconda, e anche nella quarta, nell’angolo a sinistra – e qui lo sarebbe pure il fiume (come nella terza) se non venisse turbato dai segni grafici che descrivono lo spruzzo.
Il nero, in queste pagine di Battaglia, ha un ruolo minore, ma ha comunque rilievo. Nella prima vignetta, quel terreno nero appena screziato di bianco in cui cade il corpo di Morisot rinvia chiaramente alla morte. Così incorniciato appare già quasi un sepolcro, e la scarsa definizione del margine inferiore della figura bianca, se da un lato può essere vista come dovuta alla presenza dell’erba, dall’altro fa sembra che quella figura stia continuando indefinitamente a precipitare, senza fermarsi – mentre, in alto, il corpo già instabile di Sauvage si prepara al medesimo viaggio. Anche nella terza vignetta, il nero del bosco è il nero del mistero, il nero misterioso della grandiosità della natura – di cui anche la morte fa parte.
Resta solo da domandarsi se qui sia il nero o se sia il bianco a inquietare di più. Comunque rispondiamo, Battaglia ha già vinto abbondantemente la sua gara.
29 Marzo 2018 | Tags: Distonia, poesia, poesie mie | Category: poesia, poesie mie | Così scrive del mio libro Francesca Del Moro su Illustrati di marzo (anche on line, qui):

19 Marzo 2018 | Tags: Distonia, poesia, poesie mie | Category: poesia, poesie mie | 
Distonia è uscito, edizioni Kurumuny, collana Rosada. Sono contento ed emozionato.
A Bologna potete trovarlo alla libreria Trame, via Goito 3/c; altrove nelle librerie del circuito Rosada, elencate qui, tra cui le librerie Coop (anche a Bologna). Potete acquistarlo pure sulla pagina dedicata del sito dell’editore Kurumuny. Tra qualche giorno sarà anche su Amazon.
15 Febbraio 2018 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
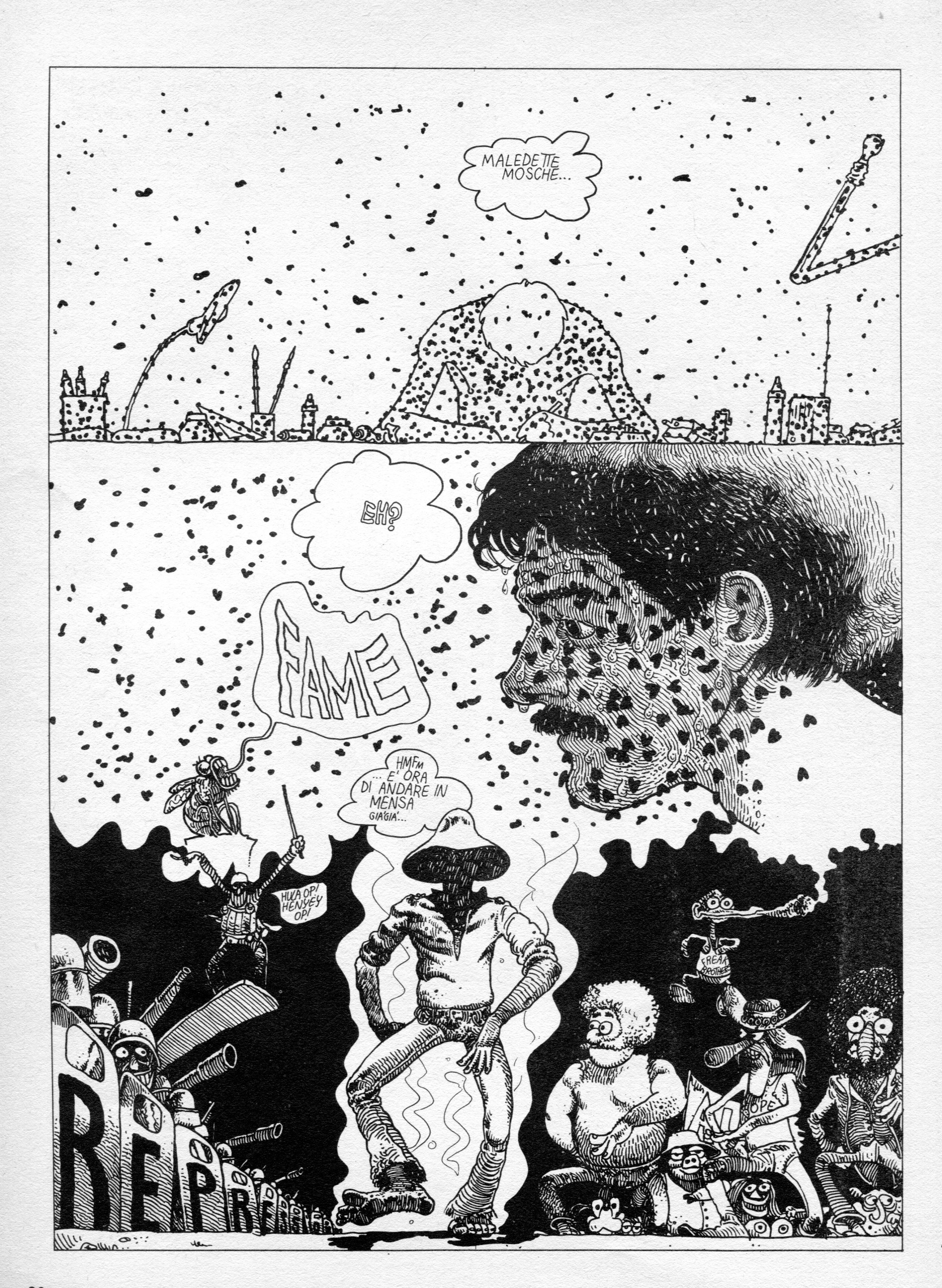 Andrea Pazienza, tavola da “Le straordinarie avventure di Pentothal”, novembre 1977
 Andrea Pazienza, tavola da “Le straordinarie avventure di Pentothal”, novembre 1977 Avrebbe da poco compiuto sessant’anni, Andrea Pazienza, nato il 23 maggio del ’56 e – diciamo così – sperperatosi il 16 giugno 1988. Mi perdonerete la provocazione, ma la capacità grafica e narrativa di APaz era un vero patrimonio dell’umanità, e non solamente sua. Purtroppo non si può rinchiudere in un museo un artista trentaduenne, il quale, tutto sommato, resta comunque un uomo, e ha i suoi diritti, ahinoi! Né probabilmente sarebbe davvero servito. Ma lasciatemi lamentare: in verità non gliel’ho mai perdonata.
Le due tavole da Le straordinarie avventure di Pentothal che guardiamo questo mese sono state pubblicate per la prima volta sul numero di novembre 1977 di Alter Alter, e sono state disegnate quindi – considerando i tempi editoriali – non più tardi di agosto del medesimo anno. Pazienza aveva ventun’anni, aveva già pubblicato su Alter due episodi del medesimo Pentothal, qualche sturiellet su una rivista autoprodotta e autodistribuita (con Scozzari, Tamburini e Mattioli), Cannibale, e distribuito delle vignette sulle barricate del marzo bolognese, che sarebbero in seguito state riunite sotto il titolo Il Kossiga furioso. Certo, c’era alle spalle una carriera artistica liceale brillante a Pescara, ma non conta gran che: di geni scolastici che poi non combinano nulla di rilevante nella vita son piene le fosse, proprio come del senno di poi.
E, viste col senno di poi, magari quelle sturiellet (Perché Pippo sembra uno sballato, per esempio) sono prodotti più maturi e compiuti – magari anche solo perché, non dovendosi esporre di fronte al grande Oreste del Buono, e alla intellighenzia tutta dei lettori di Alter, Pazienza si lasciava già più andare alla propria fantastica spontaneità inventiva. Tuttavia, anche nelle incertezze del disegno che, qua e là, Pentothal ancora lascia intravedere, è evidente che l’autore si sta impegnando a costruire qualcosa di nuovo e sorprendente, straordinario quanto sono straordinarie le avventure del suo personaggio (che è poi, come spesso gli capita, lui stesso).
In queste due tavole Pazienza paga una serie di debiti, in maniera più o meno esplicita: c’è l’underground americano, prima di tutto. I Freak Brothers di Gilbert Shelton accompagnano Pentothal, il quale ne assume il tipico andamento di camminata, ed essi lo seguono idealmente, a conferma di appartenere al medesimo mondo, dove the dope della maglietta del fratello di mezzo è chiaramente un valore cruciale – e il rapporto problematico con le forze dell’ordine ne è un altro. Dietro di loro il cannone fumante che invita a ripensare come visione tutta la scena immediatamente precedente (in un complessivo stato di allucinazione, che caratterizza tutte le pagine di Pentothal, dove quello di realtà è un concetto assai incerto) spunta dalla bocca di un deforme Paperino, mentre la faccia di Pippo (già eroe di APaz, in quegli stessi mesi, su un altro palcoscenico) è facilmente riconoscibile tra le gambe di Fat Freddy: insomma, ecco l’universo Disney. In altre due figurine del gruppo è chiaramente citato Altan, il cui Colombo! stava uscendo su Linus in quegli stessi mesi. Inoltre, se si conosce quello che Linus e Alter avevano pubblicato in quel periodo, non è difficile riconoscere nel rapporto tra i bianchi e il nero di questa stessa tavola l’ascendenza dell’Osso Morto di un altro maestro dell’underground, Vaughn Bodé (uscito su Linus da giugno ad agosto del ’76).
Moebius viene citato in maniera più esplicita in altre tavole, ma anche qui ne possiamo ritrovare elementi del tratteggio, e il deserto della seconda tavola ha molto di suo. No so se Pazienza potesse conoscere il lavoro di Gianni De Luca, la circolazione del cui Shakespeare era limitata in quegli anni al pubblico cattolico del Giornalino – ma forse la vicinanza di Mattioli, che già vi pubblicava Pinky, potrebbe avergli permesso di superare l’ostacolo (non piccolo, in quell’ambiente e in quegli anni). Del resto, anche senza scomodare De Luca, questa composizione globale delle tavole, senza suddivisione in vignette, veniva già sperimentata nei primi Settanta da Sergio Toppi, che pubblicava su Linus, e quindi gli era sicuramente noto.
Detto questo, pagati questi debiti (e chissà quanto altri, in verità, perché Pentothal rigurgita di citazioni, non sempre del tutto coglibili), quello che rimane di squisitamente pazienziano è sicuramente moltissimo. Per esempio, anche se questa composizione grafica, quasi da illustrazione, della tavola, gli arriva da Toppi, o anche da Druillet o da Gal, e in generale dagli Umanoidi francesi, tutti gli altri la usano per creare effetti epici e mitici. Qui l’effetto epico c’è: tuttavia, messo a confronto con il registro decisamente basso dei fatti narrati, serve a produrre un complessivo effetto parodistico, quella caricatura dell’epica di cui Pazienza è stato in tutto il suo percorso un assoluto maestro, sino a Pompeo, e oltre.
Si noti che nonostante ne faccia una caricatura, Pazienza non sta affatto negando che Pentothal sia un’epica: lo è anzi fino in fondo, e il titolo, con le sue Straordinarie avventure, sta a confermarlo. È però l’epica della vita quotidiana dello studente, l’epica dell’allucinazione, del sogno, dello sballo come apertura dell’area della coscienza; qualcosa che per essere riconosciuta come tale da una generazione che non sopporta la retorica dei propri padri deve rivestirsi di divertita autocritica. Una risata vi seppellirà, diceva uno slogan molto usato in quegli anni. Proprio perché Pazienza ha capito che la sua generazione non avrebbe sopportato nessuna celebrazione, ha potuto esserne il cantore, prendendo in giro prima di tutto se stesso e il suo mondo, ma al tempo stesso facendolo grandioso.
Si guardi la camminata verso la mensa della seconda tavola, e la fila di lunghezza incalcolabile che essa mette in scena. La soluzione prospettica trovata per mettere in scena tutto in una sola immagine è davvero straordinaria: quell’occhio di pesce dall’alto che riduce la figura centrale a una sorta di granchio, pur permettendo l’immediata riconoscibilità del percorso, e il successivo perdersi della fila in una lontananza incalcolabile, per poi ritornare verso di noi, a presentarci da vicino la sua massa di disgraziati, ulteriormente abbrutiti dall’attesa e dal caldo (il che fornisce forti indizi sul momento in cui Pazienza la possa aver disegnata, visto quanto la sua creatività è sempre stata legata alle occasioni dell’attualità, pubblica o privata che fosse). Ci importa poco che le ombre siano di fatto invertite (stanno una volta davanti e una dietro alla figura che le proietta) perché sono comunque elementi che concorrono alla riconoscibilità delle figurine e della situazione: la prima è dinamica e segue il personaggio alla sua prima comparsa. Nella seconda comparsa (quella vista esattamente da sopra) non c’è ombra. Rispetto alla terza comparsa, in cui Pentothal si è fermato alla vista della coda, l’ombra funge da anticipazione, trovandosi sul percorso inevitabile dell’occhio (e del racconto), ed è diritta rispetto al verso di lettura, mentre la figurina che la proietta è rovesciata.
Rovesciato è pure il balloon, con la scritta “Immensa questa fila inmensa”. E si noti che nel lettering lo spazio tra la n e la m di “in mensa” non c’è, per cui “inmensa” finisce per diventare un rafforzativo di “immensa”, un trucco favorito dalla difficoltà di lettura del testo a rovescio. Infine la staticità della figurina rovesciata che guarda l’immensa fila in mensa arriva dopo tutto quel camminare ritmato: prima Pentothal insieme con i Freak Brothers e Paperino, poi altre due volte lui da solo, accompagnato dalla citazione del titolo/testo di una nota canzone (Just Like e Woman) che ne evoca efficacemente la scansione ritmica. Un bel contrasto! Una fantastica caricatura della delusione.
 Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere. Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere.
Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male).
Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi).
Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.
I like to hear it. I write because I am personally amused by what I do, and if other people are amused by it, then it’s fine. If they’re not, then that’s also fine. But I do it for my own amusement. (1994, pag. 38)
Well, I don’t really understand people who think of art as an antidote to entertainment, something that should not give you a pleasurable experience. What’s wrong with that? I mean, the idea of punitive art – that sounds like something from the East Village. (1994, pag. 38)
Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):
Nella prospettiva adorniana il pop è intrinsecamente vile, “basso” non tanto perché sia musicalmente incolto, ma in quanto musica connaturata all’intrattenimento, all’evasione, ossia al divertimento e dunque portatrice di un’attitudine menzognera , congenitamente antitetica a una musica d’arte il cui compito è invece di guardare in faccia e svelare la terribile realtà del mondo attuale o, diversamente, sprofondare in se stessa alla ricerca di una verità interiore che non accetta compromessi di sorta.
La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare.
Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra.
Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare.
È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso.
***
Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore.
Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie.
Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo.
Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere.
La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?
13 Novembre 2017 | Tags: fumetto, Manu Larcenet | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Manu Larcenet, Blast 1, pagina 42  Manu Larcenet, Blast 1, pagina 43  Manu Larcenet, Blast 1, pagina 44 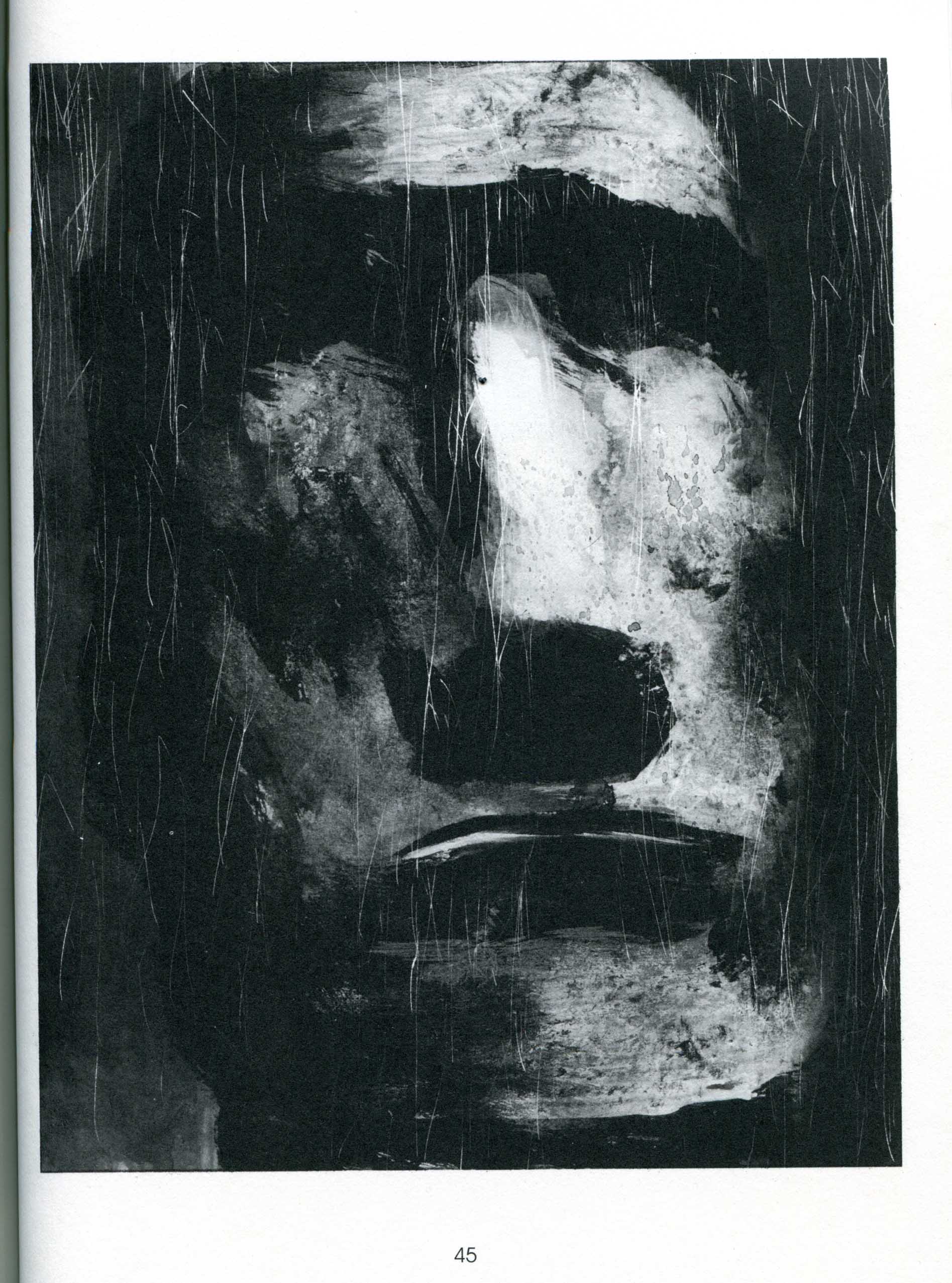 Manu Larcenet, Blast 1, pagina 45 Blast, di Manu Larcenet, è indubbiamente uno dei lavori a fumetti più interessanti degli ultimi anni, e non solo in ambito francese. Tra l’altro, nemmeno particolarmente francese appare questo suo modo di raccontare e disegnare; forse vagamente italiano; forse imparentato con un Gipi che ancora non aveva realizzato unastoria, ma che tanto aveva comunque già fatto in una direzione simile. Simile soprattutto nel tratto, continuamente ambiguo tra una linea schizzata di pennino e aree improvvisamente piene di sfumature di grigio (o di colore); ma con qualche analogia anche nell’amore per le situazioni ambigue e inquietanti. Difficile dire se un influsso vi sia (anche se qualche immagine con paesaggi a piena pagina, grandi cieli con il territorio basso basso, fanno sospettare che ci sia davvero), e in fin dei conti poco importa: Gipi e Larcenet sono comunque entrambi tra i migliori autori sulla scena degli ultimi anni.
Ambiguo, anzi ambivalente, è del tutto il protagonista di Blast, Polza: insieme rivoltante e affascinante, e ancora più affascinante perché anche il suo essere rivoltante finisce per acquistare un senso, e un senso che ci prende. Rivoltante perché di una grassezza esagerata e laida, alimentata da merendine e alcool scadente, con una vita da barbone che non si risparmia varie nefandezze – e tutta la storia, come in un incubo alla Simenon, viene da lui raccontata a due ispettori di polizia, senza che si capisca bene quale sia il delitto che egli ha indubbiamente commesso. Affascinante perché questa sozza palla di lardo rivela continuamente una sensibilità, un’attenzione alla vita e un’intelligenza narrativa che non lasciano indifferenti, e coinvolgono emotivamente il lettore – e anche i poveri poliziotti che vorrebbero arrivare al sodo, mentre Polza sembra giocare con loro come il gatto col topo, costringendoli e seguire e vivere con lui tutto il suo interminabile racconto.
Questa stessa ambivalenza caratterizza le quattro pagine che analizziamo questo mese. Polza ha da poco iniziato a raccontare la propria storia ai poliziotti, arrestato perché – pare – ha massacrato una ragazza. Ha un po’ raccontato, sin qui, la propria infanzia, e il rapporto col padre, rapporto poi progressivamente sfilacciatosi e spentosi. Fino a quando, già grasso, enorme e fallito, viene chiamato all’ospedale dove il padre è malato terminale, ormai in coma farmacologico, e da lì, non sopportando la situazione, fugge ubriacandosi sotto la pioggia. Ed è in questa occasione che ha il primo blast.
Il blast è una sorta di esplosione interiore, di esperienza improvvisa e sconvolgente di spaesamento; una specie di allucinazione, che però, come si vede in queste pagine, ti permette uno stato particolare di lucidità, e l’accesso a percezioni altrimenti impossibili. La comparsa del moai, la testa di pietra dell’isola di Pasqua, finisce per esserne l’elemento cruciale, simbolico di un rapporto naturale ed eterno con le cose.
Il racconto visivo è a sua volta sospeso tra l’oggettività esterna di una sequenza cinematografica, della quale riprende la tecnica di inquadratura e montaggio, e una serie di accentuazioni e alterazioni di carattere molto più soggettivo, espresse attraverso il disegno e la variazione di dimensione della vignetta, ovvero del quadro – cioè attraverso gli aspetti più specificamente fumettistici. L’allargamento della terza vignetta della prima pagina sottolinea lo smarrimento, la solitudine, insieme con lo squallore complessivo del luogo. Ma è soprattutto il conato di vomito subito sotto ad avvicinarsi al sentire soggettivo di Polza, attraverso la scomparsa di tutti i dettagli ambientali, mentre il corpo resta disegnato a sole linee di pennino, e l’unica zona dettagliata e colorata è proprio quella della bocca, dove inevitabilmente si concentra l’attenzione di uno che vomita.
Dopo un attimo, una vignetta, di ripresa dell’oggettività, ritorna ad accadere graficamente lo stesso nel momento in cui il blast inizia: non solo l’inquadratura si fa vicinissima, ma anche nella scelta dei tratti tutto ciò che caratterizza il mondo circostante scompare e il disegno focalizza solo il volto. E la cosa continua allo stesso modo, in crescendo, nelle sei vignette successive, nelle quali sempre di più impazza il colore, accesissimo, e tuttavia scarabocchiato come dalle mani di un bambino. Il colore invade la testa e il corpo di Polza, senza essere colore del mondo. Finché, a metà della terza pagina, di colpo ci ritroviamo nella situazione oggettiva: figura intera, col marciapiede e la pioggia, e niente più colore.
Ancora, nelle ultime due vignette della pagina, il quadro torna vicinissimo, e l’ambiente scompare. Polza apre gli occhi, guardando verso l’alto. La grande immagine della pagina successiva sottolinea, con la propria dimensione relativa, l’impatto emotivo della grande figura del moai sul nostro protagonista: è la prima soggettiva vera e propria della sequenza, ma eravamo già preparati alla resa della soggettività.
A questa resa contribuiscono indubbiamente due elementi generali: il racconto in prima persona, insieme appassionato e ironico; e la tonalità generale del disegno, insieme caricaturale ed emozionale. Notiamo che nel momento in cui descrive l’ingresso nel blast, dopo aver detto “Sentivo di pesare cento volte tanto…”, Polza non può esimersi dall’aggiungere “Vi lascio immaginare”, con evidente riferimento al suo peso già in sé non leggero. Ma poi, subito dopo, ci riporta nella relazione appassionata, così appassionata che, quando le cose si fanno ancora più intense, con la comparsa del moai, la voce tace, e nelle pagine successive (che qui non vediamo) non ci sono più parole, ma quasi la presenza di un’esperienza che si può solo vivere, e non raccontare verbalmente.
Ci pensa però il disegno a portare avanti l’ambivalenza. Non solo Polza; in questa storia tutti i personaggi sono rappresentati con tratti grotteschi, nasi eccessivamente lunghi, o troppo larghi, corpi troppo grassi o troppo magri – il padre addirittura con un lungo becco da uccello. Certo non è un grottesco che miri all’umorismo, anche se, ricorrentemente, permette e favorisce uno sguardo ironico o sarcastico sulle cose, parallelo a quello tenuto dalla voce di Polza. È piuttosto un grottesco espressionista, un’enfatizzazione dei tratti particolarmente significativi del mondo, che li mette in luce a scapito di quelli meno rilevanti. Per questo poi i momenti di comunione con la natura che Polza vivrà nelle pagine successive appaiono così felici, felici non solo per lui, ma anche felicemente riusciti: in questa storia di contrasti estremi, e insieme di razionalistico (ma quasi psicotico) distacco, il grottesco permette di tenere insieme tutti gli elementi. E alla fine non saremo in grado di dire se Polza sta raccontando la verità, o il meraviglioso racconto di uno psicotico che si è costruito da solo la realtà a propria misura.
Della poesia fatta a macchina, e anche di Sergio Rotino
di Daniele Barbieri
A home transformed by the lightning
the balanced alcoves smother
this insatiable earth of a planet, Earth.
They attacked it with mechanical horns
because they love you, love, in fire and wind.
You say, what is the time waiting for in its spring?
I tell you it is waiting for your branch that flows,
because you are a sweet-smelling diamond architecture
that does not know why it grows.
È attraverso una segnalazione di Enzo Campi su Facebook che arrivo a questo articolo di Salvatore Luiso, “La poesia che (non) si doveva scrivere”. L’articolo inizia citando una (discreta, anche apprezzabile) poesia in lingua inglese (qui sopra), rivelando poi che non è stata scritta da nessuno, bensì composta da un algoritmo, un’Intelligenza Artificiale insomma, intorno al 2010. Ora cito io dal medesimo articolo (più veloce, onesto, e comodo che riassumere – per vedere il contesto vale il link sopra) che sviluppa il discorso a situazioni ancora più recenti:
Venendo a qualcosa più vicino a noi, Galileo.net ha pubblicato un articolo molto interessante sul lavoro di Jack Hopkins, fondatore della Spherical Defence Labs LLC di Londra ed ex ricercatore presso il laboratorio di Informatica di Cambridge. Hopkins sta sviluppando alcuni algoritmi per “insegnare” ad una rete neurale artificiale a comporre poesie paragonabili a quelle dei poeti umani. Il suo sistema è molto più “professionale”: sono stati caricati nel programma ben 7,56 milioni di parole ricavate da libri di poesie del ventesimo secolo. Questa IA, inoltre, avrebbe una speciale memoria sia a breve che a lungo termine, “esercitandola” alle emozioni. Il risultato è che il nuovo sistema riesce a scrivere poesie in diverse forme ritmiche, adoperando soluzioni formali e strutture retoriche, persino la rima.
L’IA di Hopkins è in grado di scrivere poesie su molte tematiche: proponendogli una poesia sull’estate, il sistema troverà tutti i termini che richiamano la stagione più calda e ci comporrà una lirica. Nel 70% dei casi in cui l’IA ha composto una poesia “sensata”, gli esseri umani non sono stati in grado di distinguere fra queste poesie e quelle composte da autori umani, trovando spesso le prime addirittura più belle, dunque emozionanti.
Ci sono alcune precisazioni da fare. Quando si dice “in cui l’IA ha composto una poesia sensata” si implica che c’è stato qualcuno, presumibilmente umano, che l’ha giudicata sensata. Quindi è stata compiuta una scelta sui risultati della produzione automatica. Di questa scelta ignoriamo i criteri, ma potrebbe anche trattarsi di criteri minimali di coerenza semantica – non di qualità estetica. Il problema sollevato da questa storia non cambia però di molto: comunque, un algoritmo ha generato poesie (non tutte, non sempre – ma quale umano lo fa?) che alcuni lettori hanno apprezzato (e tra questi, in qualche misura, anch’io).
Ora, il problema non è – come sembra credere Luiso, o anche Hopkins – se i computer davvero comprendano o sentano emozioni (o possano essere “esercitati” alle emozioni). Il computer non ha fatto che seguire regole che derivano dalla combinazione frequente di parole frequenti. Se invece di sottoporgli un corpus di poesie, gli avessimo sottoposto un corpus di ricette culinarie, il computer avrebbe prodotto ricette culinarie. Non lo avrebbe fatto, presumibilmente, con altrettanto successo: una ricetta culinaria deve certamente parte del suo successo al modo in cui viene scritta, ma se poi la ricetta, al momento di metterla in pratica, non funziona, la correttezza linguistica si rivela insufficiente, e il criterio dominante rimane un altro.
Una poesia non è però una comunicazione pratica con diretto effetto sul mondo, e la sua valutazione dipende unicamente da come è scritta. In più, proprio per questo, il lavoro che su di lei compie chi la sta leggendo è assai più importante che in qualsiasi altro tipo di comunicazione verbale. Potremmo dire che una poesia è un oggetto di proiezione, una specie di macchia di Rorschach su cui ogni lettore proietta ciò che può proiettare (senza che questo, evidentemente, si traduca in un giudizio sulla sua psiche); e la qualità di un componimento poetico è la qualità delle proiezioni che permette o suscita. Questo meccanismo può funzionare così bene da produrre un attaccamento anche molto forte da parte del lettore (e io stesso, come lettore di certe poesie, non faccio certo eccezione).
Ma questo meccanismo permette anche che, attraverso identificazioni potenzialmente molto diverse tra loro, lettori diversi si trovino accordati sul medesimo andamento, sul medesimo ritmo poetico (che è anche, ma non solo, quello prosodico-rimico: ci sono un sacco di altri ritmi in gioco in un testo poetico!). In questo modo, la situazione di fruizione collettiva prende la forma di una situazione rituale: benché lo facciamo in momenti diversi del tempo (e dello spazio) tutti noi lettori stiamo seguendo lo stesso andamento ritmico, stiamo vivendo un’esperienza accordata – come quella del ballo, o dell’ascolto musicale. Se la poesia prodotta dal computer, per ragioni qualsiasi, produce nei suoi lettori questa esperienza, allora è una poesia che in qualche modo funziona, ed è comunque una poesia di valore: anche se siamo ingannati, si tratta di un inganno positivo, fruttuoso; abbiamo davanti comunque un oggetto interessante.
La questione che questa storia pone non riguarda tanto, a mio parere, la supposta umanità del computer e la sua capacità di provare emozioni (semmai solleverebbe il problema di cosa sia l’umanesimo, ma sarebbe troppa carne al fuoco per questo post). Io la vedo diversamente: se la poesia composta a macchina può essere preferibile, più interessante, di poesie composte da umani veri, perché non domandarci come lavorano gli umani veri?
Cosa vuol dire essere un poeta? (Non faccio questa domanda da fuori: sono anch’io, comunque, un poeta.) Vuol dire cercare di rientrare, da autori, in un universo di testi di cui siamo stati in precedenza, e ancora siamo, lettori. Non c’è altro modo: se la poesia non ci ha affascinato come lettori, non potremo mai sentire il desiderio di riprodurre direttamente quella fascinazione – nemmeno se il nostro corpus di letture fosse quello banalmente scolastico. Se così fosse scriveremmo poesie altrettanto limitate, ma staremmo comunque riproducendo il meccanismo.
Per riconoscere come poesia quello che scriviamo (e se non lo riconosciamo noi certo non possiamo pretendere che lo riconoscano altri) quello che scriviamo dovrà…
Segue qui, su Nazione Indiana.
C’è qualcosa di nuovo in libreria:
 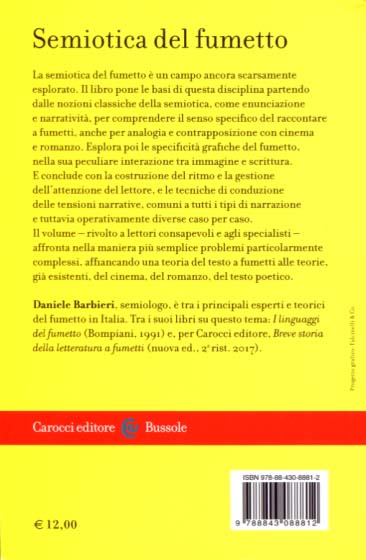 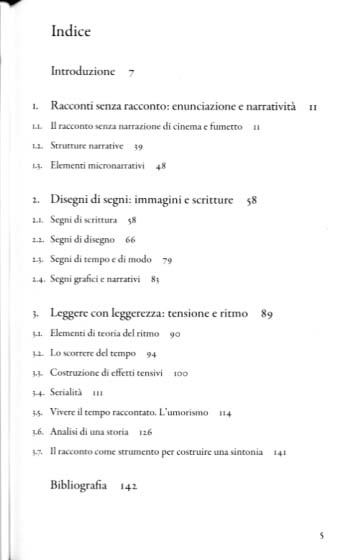
DOCUMENTAR UN DOCUMENTO HISTÓRICO.
MODALIDADES DIFERENTES DE COMUNICACIÓN EN LE PHOTOGRAPHE, DE GUIBERT Y LEFÈVRE
Bilbao, 2015
Le photographe, de Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier, es una novela gráfica publicada originalmente en tres partes entre 2004 y 2006 por Editorial Dupuis. El libro narra el viaje realizado por el fotógrafo Didier Lefèvre a Afganistán en 1986, como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), durante la guerra de liberación de la dominación soviética. Se trata de un trabajo muy particular, también en los relatos dibujados, no solo por la abundancia de la narración verbal (la voz del narrador), sino también por la intercalación de viñetas dibujadas y fotografías tomadas en el campo por Lefèvre. Guibert es el creador de la obra y el dibujante de las viñetas; Lemercier se ha encargado del diseño gráfico, así como del color del conjunto.
Como se trata de una historia real, con relevancia periodística, Le photographe podría atribuirse al género del periodismo gráfico. Sin embargo, más que sobre las condiciones de Afganistán y el trabajo de MSF (que por cierto están muy bien documentados), la obra se centra en la experiencia humana del protagonista, y en su relación con el entorno y con su propio trabajo. Los tres volúmenes originales cuentan, respectivamente: el viaje (a pie en las montañas, con el grupo MSF), la permanencia y el trabajo diario de MSF, así como el regreso solitario y penoso (otra vez caminando en las montañas).
Antes de iniciar el análisis específico hay que decir unas pocas palabras acerca de dos grandes temas: la diferente modalidad comunicativa de las imágenes dibujadas o pintadas y de las fotográficas; y, en el discurso específico de la novela gráfica, el diferente papel que corresponde a la palabra narrativa (en los cartuchos) y a las viñetas (Barbieri, 2004).
La imagen dibujada, como la pintada, es una imagen producida por la mano, cuya adhesión testimonial a determinada realidad se basa enteramente en la confianza en las intenciones y capacidades del diseñador, sin perjuicio de las convenciones gráficas e iconográficas adoptadas. Debido a su naturaleza de imagen producida, la imagen dibujada constituye en sí misma una síntesis extrema, tanto en la representación de la tercera dimensión, con sus volúmenes y sombras, como en la cantidad de detalles. En el contexto adecuado, todavía puede ser considerado afín a cualquier realidad (y por lo tanto, testimonial) también un dibujo muy estilizado, en el que faltan completamente los detalles del fondo; siempre que, en definitiva, estén presentes y reconocibles los elementos figurativos que distinguen la situación de acuerdo a las características que consideramos relevantes. En este sentido, la variabilidad de un dibujo como fuente documental de alguna situación real irá desde el boceto (o desde la máxima estilización) hacia una precisión de nivel fotográfico -presuponiendo siempre la fiabilidad del dibujante-.
La imagen fotográfica es, por el contrario, una imagen semi-automática, el producto objetivo de la grabación de la luz en la emulsión sensible. Lo que vemos en una foto sin duda se presentó ante el ojo del fotógrafo en algún lugar y tiempo. Por supuesto, se puede trucar una foto, pero, sobre todo, en tiempos del pre-Photoshop, socialmente creemos que estos trucos son suficientemente fáciles de detectar; por lo que podemos atribuir a las fotos incluso significación jurídica: su fidelidad testimonial a una realidad es entonces aceptada por el hecho mismo de ser una foto. Sabemos que hay muchas maneras de hacer igualmente “mentir” a una foto: aunque la realidad representada sea innegable, no hay garantía en la foto de que esa sea la misma que está declarada, o que coincida con la ubicación, el tiempo y las circunstancias que tendría que testimoniar. La historia del fotoperiodismo está repleta de falacias: situaciones reconstruidas ad hoc y presentadas como auténticas.
Por otra parte, este milagro de la objetividad tiene una amplia gama de componentes subjetivos, que se deben a la elección del fotógrafo: para limitarnos al solo reportaje fotográfico (en el estudio todavía se incorporan otros elementos), el momento y la duración del disparo, el encuadre, lentes, filtros, etcétera. Con estos instrumentos, a través de su propia elección, el fotógrafo vuelve el fragmento seleccionado y reproducido de realidad en un discurso subjetivo; lo convierte en su propia visión de esa realidad. Dentro de este discurso subjetivo, el componente objetivo, de testigo, no desaparece; sigue existiendo, aunque reducido por los diversos filtros de la simple visualidad, de la inmovilidad temporal y de la subjetividad de las opciones ópticas y espacio-temporales del autor.
No hay fotos, por lo general, en las historietas. En algunos casos las encontramos integradas en un marco dibujado, tal vez explícitamente retocadas, casi para dar un toque de realismo a la situación. Pero su naturaleza documental ya no sigue siendo, por lo general, nada más que esto; ni, por lo general, el hecho es particularmente relevante.
Curiosamente, el paralelo fotográfico de la novela gráfica estándar, es decir, la fotonovela, nunca llegó a picos de especial calidad; y los pocos casos de fotonovelas interesantes suelen ser satíricos, como los que aparecían en Hara-Kiri Mensuel. Creo que lo que limita las posibilidades de la fotonovela es precisamente la naturaleza documental de la fotografía, su inevitable adherencia a la realidad; donde un buen diseñador puede jugar con la deformación y la elipsis para enfocar la atención del lector, mientras que un buen fotógrafo debe en cambio afectar a la realidad que va a reproducir, sin posibilidad de elipsis. Condenado a mantener fondos y detalles, y condicionado por la naturaleza esquemática de las expresiones de los actores en la escena (no ocultas por el movimiento, que en la película las hace más tolerables), el autor de fotonovelas tendría que derrochar demasiado tiempo y dinero…
Sigue aquí – Continua qui, su Signa. Revista de la Asociaciòn Española de Semiòtica, pag. 729
11 Settembre 2017 | Tags: Chris Ware, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
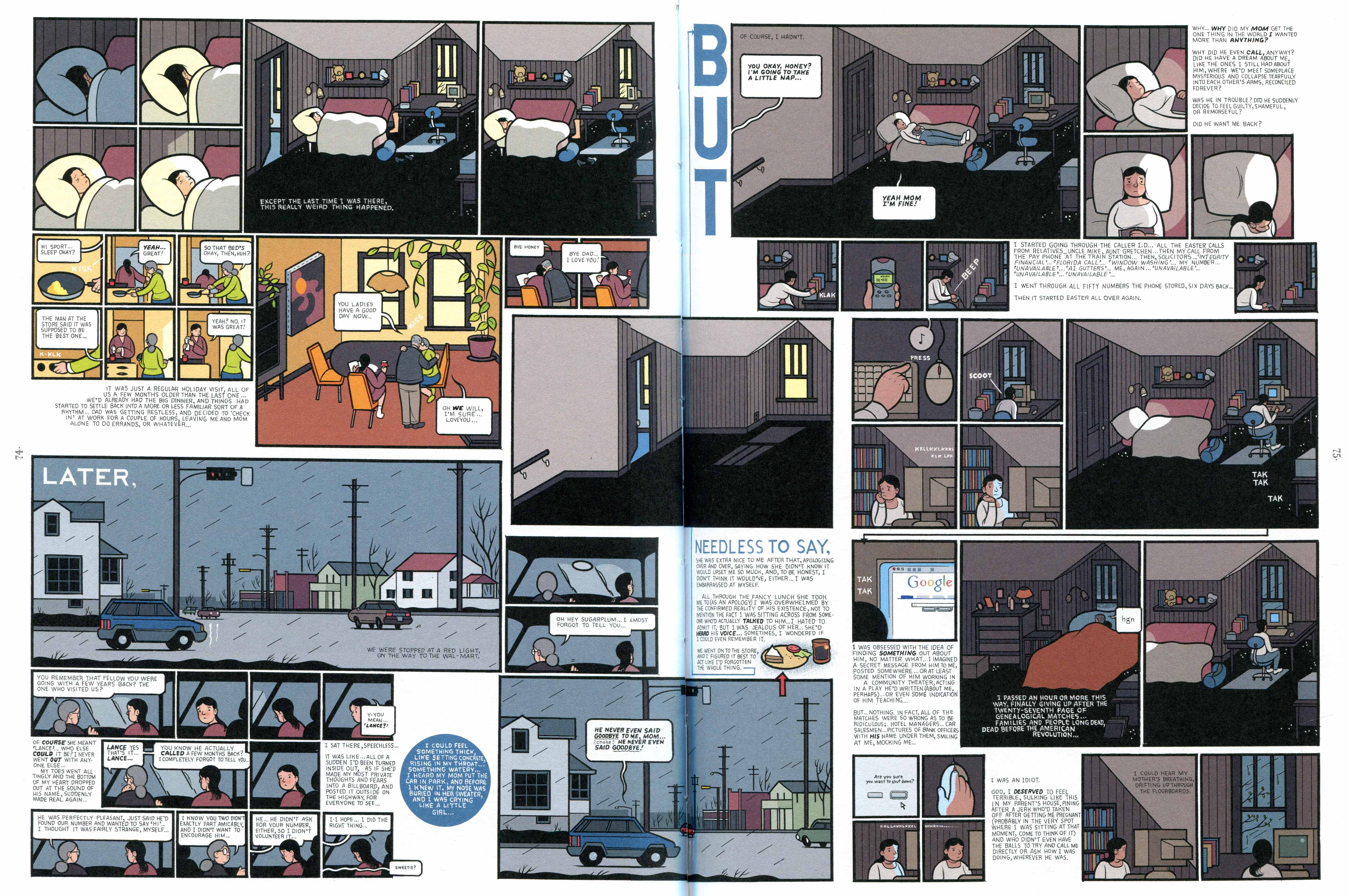 Chris Ware, da Building Stories Dopo averlo così ripetutamente evocato parlando, la volta scorsa, di Paolo Bacilieri, sembra quasi doveroso approdare stavolta a Chris Ware, e lo faccio attraverso questa bella doppia pagina da Building Stories (Pantheon Books 2012, inedito in Italia). Il titolo dell’opera è volutamente ambiguo, volendo infatti dire sia storie di edificio che costruire storie, e tutte e due le interpretazioni sono in questo caso plausibili, visto quanto è importante l’idea di edificio nelle storie che vi sono raccontate, ma visto anche che l’opera si presenta come una raccolta di pezzi, diversi come spessore e formato (dal libro al singolo paginone apribile), che si possono leggere secondo qualsiasi ordine, costruendo una o più storie attorno alla vicenda centrale della ragazza dalla gamba amputata che è sia il soggetto narrante che il principale personaggio.
Questa idea doppiamente architettonica si rispecchia nella struttura delle singole pagine, o doppie pagine, come in questo e in molti altri casi. Qui la protagonista (di cui mai viene detto il nome, perché il punto di vista del racconto verbale è sempre quello suo soggettivo) sta ricordando un episodio accaduto durante una visita a casa dei genitori, che le riporta alla mente una precedente visita, compiuta insieme al fidanzato di allora, il quale pochi mesi dopo la avrebbe lasciata molto sbrigativamente e dolorosamente per lei. La doppia pagina ruota attorno all’immagine centrale della stanza di lei vuota, che si ripete quasi identica dalla doppia pagina precedente (salvo che in quella all’esterno si vede il buio, e qui il sole), ed è organizzata per blocchi narrativi e grafici: le prime sei vignette, dove lei è a letto; le successive nove, insieme con i genitori; la sequenza con la madre in automobile; il raccordo verbale al centro pagina da cui parte una freccia che termina sulla parola BUT (ma); la lunga sequenza che conclude la doppia pagina e l’intero episodio occupando quasi tutta la pagina di destra.
Con una tecnica che in Building Stories Ware usa molto spesso, l’immagine centrale (qui la stanza svuotata) non è direttamente inserita nel racconto, ma è graficamente attraversata da una linea che ne rappresenta il filo. Come dire che da lì in ogni caso si passa, e la metafora dello svuotamento rappresenta direttamente il sentimento dominante della narratrice, mentre mette anche in scena il momento di passaggio tra la camera com’era (nel passato) quando lei ci dormiva da bimba e fino a pochi anni prima, e come è adesso, dopo che la madre dei lei ne ha fatto il proprio studio, sostanzialmente cancellando il passato della figlia.
Questa ambivalenza del valore dell’immagine centrale, che ribadisce più o meno la stessa cosa in diversi modi, si ritrova un po’ in tutta la doppia pagina (e in tutto Building Stories). La sua stessa struttura grafica complessa facilita gli errori del percorso di lettura, e sbagliare qui non è solo permesso bensì quasi favorito, e persino coerente con la modalità generale del racconto, il quale ondeggia continuamente tra momenti storici diversi, presente e passato, permettendoci sì di distinguerli, ma non immediatamente al primo sguardo – e quando arriviamo a cogliere gli indizi che rivelano che il salto temporale c’è stato, abbiamo già percepito gli elementi di continuità che hanno favorito l’errore (e ricordiamo che l’intera opera è fatta di frammenti componibili secondo lo stesso principio).
Insomma, la storia c’è, indubbiamente, ma molto più forte della vicenda che si sviluppa è la costruzione di un mood, di un tono emotivo, che passa dalla protagonista al lettore attraverso lo stratagemma della voce narrante in prima persona. Pure qui, però, la strategia di Ware è tutt’altro che semplice o omogenea: alla voce narrante emotivamente coinvolta in prima persona, che evidentemente ha vissuto (o sta vivendo) i fatti da dentro, corrisponde uno stile grafico geometrico e distaccato, assolutamente gelido e oggettivo, in cui gli angoli retti e a 45 gradi sono assolutamente dominanti, in una schematicità assonometrica che nega persino l’umanesimo della prospettiva in nome di un’apparenza di razionalità totale. Nell’assonometria, infatti, manca il punto di vista individuale che caratterizza la prospettiva propriamente detta (quella centrale rinascimentale, per intenderci): le linee non convergono all’orizzonte, e la visione è quella da occhio di Dio, o da occhio astratto della ragione, spersonalizzato. Questa stessa visione viene però a sua volta messa in discussione: nelle immagini della camera di lei, quella centrale soprattutto, il soffitto obliquo crea altre diagonali, opposte a quelle dell’assonometria, mentre la diagonalità delle scale a sinistra complica ulteriormente il gioco.
Insomma, l’oggettività evocata da questo modo di costruire lo spazio finisce per non essere affatto una rassicurante ricostruzione del mondo, in cui tutti i pezzi trovano razionalisticamente il loro posto, bensì, proprio al contrario, una sorta di labirinto depersonalizzato, in cui le cose hanno un posto soltanto in apparenza, perché quello che manca è un io coerente che le organizzi davvero. L’apparenza di oggettività finisce per presentarsi dunque come la presenza di un vuoto, come il percorrere corridoi che non portano da nessuna parte, a nessuna soluzione.
Questo vuoto esistenziale costruito dall’eccesso di oggettività grafica corrisponde dunque strettamente al vuoto emotivo testimoniato soggettivamente dal racconto verbale. Sembrano fare da tramite tra le due dimensioni quelle poche parole scritte più in grande: LATER, NEEDLESS TO SAY, e soprattutto BUT, nel loro suggerire un sentimento di impotenza, mentre sono composte tipograficamente con il più freddo dei caratteri da stampa. Ecco quindi come Ware costruisce il proprio senso del tragico, combinando due modalità opposte a trasmettere un messaggio simile, ma in questo modo quasi rendendo vana la soggettività mentre si rende universale, quasi oggettiva, la vanità.
La pagina, le storie, appaiono come reticoli di umanità raccontati con grande profondità psicologica, mentre questa medesima vita vissuta e così intensamente resa sembra confrontarsi con un’oggettività che la svuota di senso, la rende inutile. Questo senso di inutilità permette da un lato il distacco del lettore dall’angoscia della protagonista, angoscia che può essere percepita magari come eccessiva, come “quello che a me non potrebbe accadere: io saprei come difendermi”; ma dall’altro pervade il lettore con un’angoscia ancora più tragica, del tipo “che accada o non accada anche a me che cosa cambia?”. Le storie che Ware racconta sono toccanti e profonde e vere, ma è il distacco emotivo che lui riesce a costruirci sopra mentre al tempo stesso ce ne rende partecipi, a evocare una dimensione di suprema inutilità, di vuoto esistenziale, di non affidabilità di tutti i valori in cui ugualmente crediamo – e pure lui sembra crederci, a dispetto di tutto, magari per qualche attimo, perché solo credendoci facciamo emergere un senso nella vita.
1 Settembre 2017 | Tags: Nadia Agustoni, poesia, racconto | Category: poesia |
Nelle spire del racconto, o al di fuori di loro – su Racconto di Nadia Agustoni
di Daniele Barbieri
Avendo lavorato e ragionato, nel corso della mia vita, sostanzialmente da semiologo, di racconto ho sentito parlare, e parlato a mia volta, parecchio. Non ho condiviso la tesi secondo cui qualsiasi testualità possiede, nascosta o palese, una struttura narrativa. Ritengo tuttavia che, anche se ogni tanto se ne può fare a meno, la struttura narrativa sia comunque abbondantemente presente intorno a noi. Di fatto, ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che possa essere descritto come un’azione (cioè un evento intenzionato da qualcuno) siamo anche di fronte a un racconto. Molte poesie sono quindi narrative, anche quando a prima vista non lo sembrerebbero, ma non tutte lo sono – o magari non lo sono nel loro insieme, pur contenendo elementi che, singolarmente, potrebbero essere considerati narrativi.
Il racconto è uno dei (principali) modi in cui diamo senso al mondo. Quando riteniamo di sapere perché e come qualcuno ha fatto qualcosa, e se alla fine ci è riuscito oppure no, il mondo ci appare più chiaro e affrontabile. Leggete Paul Ricoeur (Tempo e racconto) o Algirdas J. Greimas (Del senso e Del senso 2) e avrete un’idea dell’importanza che la forma-racconto ha per il nostro rapporto con il mondo.
È per questo che già Aristotele poteva parlare di catarsi, come esito per lo spettatore di una tragedia. Non importa che la storia abbia un lieto fine: è sufficiente che la fine ci sia, e che la vicenda (il racconto) si presenti come qualcosa che trasmette un senso complessivo, quello di una parabola (sia in senso matematico che biblico) che ci mostra il mondo (o almeno quel suo frammento) come se esso possedesse un disegno, e di quel disegno abbiamo colto le linee.
La differenza tra il mondo reale e il mondo raccontato (magari anche solo raccontato da noi a noi stessi, nel semplice dare senso a quello che vediamo) è dunque una differenza tra qualcosa di immediato ma non (ancora) compreso, e un mondo in qualche modo compreso ma che ha perso l’immediatezza.
Intitolare Racconto una raccolta di testi poetici, come fa Nadia Agustoni, prepara il suo lettore ad aspettarsi che quello che troverà sarà un qualche tipo di percorso, dove, qualsiasi cosa accada, alla fine ci sarà una risoluzione, se pur non necessariamente positiva (le tragedie infatti, Aristotele insegna, non sono meno confortanti delle commedie). E invece, sin dalle prime pagine e poi andando avanti sempre di più, la sensazione che si ricava è quella di una sorta di radiosa immobilità…
Prosegue qui, su Nazione Indiana
5 Luglio 2017 | Tags: fumetto, Paolo Bacilieri | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
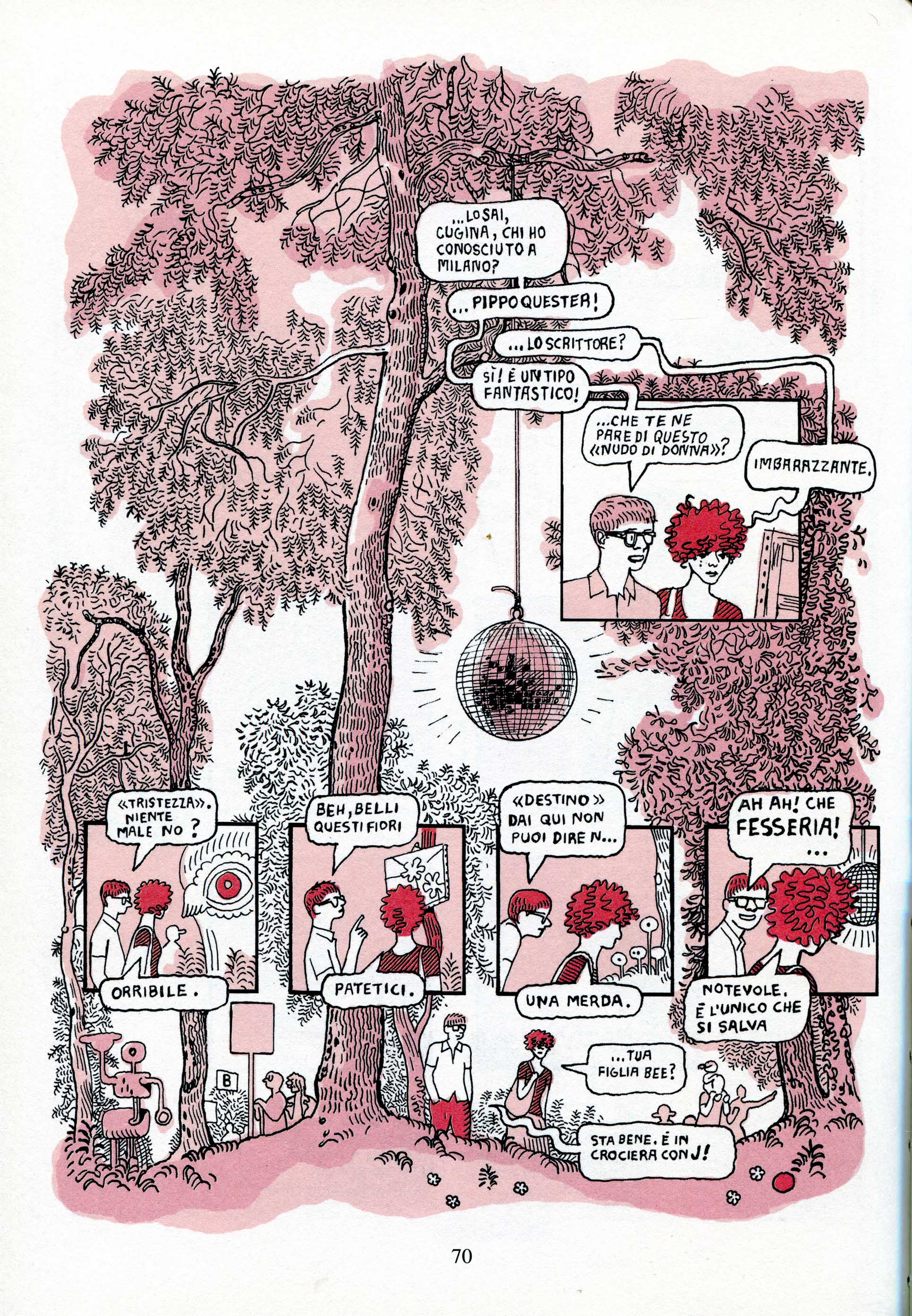 Paolo Bacilieri, Fun, pagina 70  Paolo Bacilieri, Fun, pagina 71 Guardiamo queste due pagine (70 e 71) di Fun, di Paolo Bacilieri (Coconino 2014). Soprattutto nella prima riconosciamo una tecnica molto usata in certi momenti da Frank Miller, quella della splash page che presenta la scena nel suo insieme, inquadrandola nel suo complesso spazialmente e temporalmente, su cui si appoggiano vignette piccole all’interno delle quali si sviluppa nel dettaglio la vicenda. Soprattutto nella seconda pagina riconosciamo invece una tecnica molto usata da Chris Ware, dove le piccole vignette si moltiplicano, con l’aggiunta di frecce e percorsi indicati o aree di fondo bianco lasciate intenzionalmente vuote.
Che cosa hanno in comune due autori così lontani tra loro come poetica, come Miller e Ware? Almeno due cose, direi. La prima è l’attenzione alla costruzione grafica della pagina in senso spettacolare – anche se la spettacolarità di Ware è antitetica come spirito a quella di Miller, essendo una spettacolarità dell’immobile e del raggelato, un esercizio raffinato di proporzioni in cui è sì necessario ricavarsi una dinamica della lettura (si tratta comunque di una storia a fumetti) ma tutto sembra remare contro; mentre in Miller la spettacolarità è momento culminante di un flusso che vuole essere travolgente proprio nel suo scorrere. La seconda è un forte senso della tragedia – di nuovo antiteticamente risolto: tragedia personale, interiore, inesprimibile se non indirettamente per Ware, conflitto di ideologie o di morali per Miller, mostrato come una guerra. Fatte salve le grandissime differenze tra le due impostazioni, sia Ware che Miller sembrano prendere molto sul serio la vita e il modo di raccontarla, premendo, ciascuno a modo suo, il pedale dell’acceleratore dei sentimenti, verso il freddo e il distacco, o verso il caldo e il coinvolgimento.
Ora, che cos’hanno in comune Ware e Miller con Paolo Bacilieri? Come si spiega l’innegabile convergenza grafica che si può notare in queste (e in molte altre) tavole? C’è spettacolarità grafica e c’è tragedia in Bacilieri? Be’, sì, ci sono – anche se non è proprio Fun il luogo della tragedia (Sweet Salgari sarebbe un altro paio di maniche); e tuttavia, se invece di tragedia parliamo di senso del tragico (definito da Thierry Groensteen qualche anno fa parlando di fumetti e in particolare proprio di Chris Ware) inteso come il senso della tragicità e ineluttabilità dei fatti della vita (come lotta inutile nei confronti del destino), ecco che lo troviamo anche nella seconda delle due nostre pagine, e non manca mai, in effetti, nei lavori di Bacilieri, anche quelli in apparenza più scanzonati.
Il fatto è che è pervasivo nel lavoro di Bacilieri, da quello che racconta al modo di raccontarlo sino al tratto del suo disegno, un senso dell’ironia, o forse dell’autosarcasmo, o forse di un distacco un poco sardonico, come un lieve darsi continuamente dello sfigato che, poiché poi né l’autore né il protagonista sono davvero tali, ci qualifica un po’ tutti come tali. Insomma, mentre in Miller c’è l’eroismo del fare, dell’azione, del risolvere, e in Ware c’è l’eroismo del resistere, del perdurare, dell’affrontare la vita di tutti i giorni, quello che viene ribadito qui è proprio un generale antieroismo, dove persino il tragico e la spettacolarità finiscono per essere oggetto di uno sguardo disilluso e un po’ distaccato. Guardate, nella seconda pagina, il modo in cui viene descritta la morte sul lavoro di Zattera: nelle immagini e persino nel lettering dei balloon tutto è quotidiano e ironico, come se si raccontasse un episodio buffo (guardate quei piedi che escono da sotto le lastre di marmo, che sembrano presi da una vignetta di Crumb, per esempio); però al tempo stesso la narrazione è secca e fredda, e dice i fatti nella loro agghiacciante semplicità, preparando il vuoto della seconda parte della terza striscia, e la ripetizione ossessiva del dramma dello zio Italo nelle vignette successive.
Persino le forme preferite da Bacilieri sembrano andare nella medesima direzione. Guardate (qui e altrove) come le forme rotondeggianti o quelle quadrateggianti tendano continuamente alla forma intermedia del rettangolo con gli angoli smussati. È così sempre per i balloon e le didascalie, è così per il lettering (componente importantissima del lavoro di Bacilieri), ed è spesso così anche per le teste, e talvolta persino per le vignette (non qui). Si tratta però di rettangoli irregolari, disegnati a mano con la voluta incertezza della mano libera – nella somiglianza e nell’opposizione con un procedimento non così dissimile seguito da Chris Ware, che però sfrutta geometrie pure e perfette. Magari è proprio in questa contrapposizione tra quelle geometrie, dove il tragico è freddo e distaccato, quasi una condizione esistenziale assoluta, e queste ricercate imprecisioni che si coglie l’antieroismo di Bacilieri, per cui il tragico c’è, certo che c’è, ma non c’è niente di assoluto in ciò, e la banalità della vita quotidiana (che comprende anche la nostra capacità di non prenderci troppo sul serio) è quello che conta davvero.
È questo che dà calore alle sequenze di Bacilieri, contrapponendolo definitivamente al gelo esistenziale di quelle di Ware: è come se Ware disegnasse storie come potrebbero essere viste dall’occhio di Dio, oggettivo e distaccato, mentre Bacilieri le disegna come potrebbero essere viste dal mio occhio, o dal suo, o da quello di uno qualsiasi di tutti gli sfigati di questo mondo (dei quali persino il nome del suo personaggio Zeno Porno è una fantastica, ironica ed efficacissima metafora).
Smontato così il tragico (senza però disfarsene), cosa ne è dello spettacolo? Be’, qui la soluzione è facile: mostrare in maniera spettacolare il quotidiano, nella sua palese antispettacolarità, è un classico della parodia, uno straniamento che ci costringe a guardarlo con occhi diversi, ben attenti a quello che si presenta di ridicolo. Siamo quindi ancora in linea con quello che abbiamo già osservato. Solo che pure in questo caso, proprio come con il senso del tragico, la spettacolarità non si dilegua affatto, rimane (e sappiamo bene come ci siano tavole, anche in questo stesso Fun, fortemente giocate sullo spettacolo grafico – per esempio tutta la sequenza iniziale su New York), anche se in forma un po’ dimessa (il bianco e nero, la bicromia, la normalità dei soggetti che riempiono i quadri…), continuando a suggerirci che è possibile uno sguardo non banale anche sul banale, e che da una vita da sfigato è possibile uscire, pure senza essere l’occhio di Dio, ma con un semplice occhio un poco distaccato, e magari pure un po’ affettuoso.
È il bianco di fondo così dominante, con questi canali bianchi così grossi tra le vignette, a fomentare il confronto con Chris Ware nella seconda pagina. Ma il gioco di irregolarità, pervasivo nei dettagli e diffuso nella struttura, rende la pagina di Bacilieri tanto affettuosa e partecipe quanto quelle di Ware sono fredde e distaccate. Persino questa piccola polifonia di balloon e didascalie diverse, creando quasi un effetto di confusione, alimenta la percezione di un calore affettivo diffuso, come se alla pianificazione grafica indubitalmente presente si sovrapponesse poi una spinta istintuale, un non poter fare a meno di aggiungere dettagli, piccole curve storte, piccole modulazioni dal tondo al grassetto (e ritorno) nel lettering.
Gran parte delle storie contenute in fumetti romanzi film racconta di uno o più protagonisti che cercano di ottenere qualcosa: un tesoro nascosto, la verità su un delitto, la pace interiore, l’amore – o magari semplicemente la sopravvivenza in una situazione pericolosa. Il lettore si identifica con questa ricerca, che diventa il motivo per cui si rimane attaccati alla lettura, o alla visione. Il percorso del lettore è un percorso passionale, che ha qualcosa in comune con quello che viviamo nella nostra vita di tutti i giorni; ma qui è un percorso mediato, condotto, esemplare. Rimaniamo attaccati alla storia perché vogliamo sapere come va a finire: se il protagonista riuscirà o fallirà, e come ci riuscirà o come fallirà. Se qualcuno ci rivelasse in anticipo come va a finire lo odieremmo, lui e il suo spoiler, perché ci toglierebbe il gusto del non sapere, e quindi del patire insieme con i personaggi, ignorando insieme a loro cosa deve ancora accadere.

Ci sono però storie (romanzi, racconti, fumetti, film) che reggono benissimo l’eventuale anticipazione. Potete sapere già come va a finire (vi hanno raccontato tutto, l’avete già letto o visto…) e la storia vi coinvolge lo stesso. Non siete trascinati insieme con i protagonisti nella loro vicenda; voi siete come un dio che sa già tutto, o almeno che sa che cosa deve accadere. Eppure siete ugualmente appassionati.
Evidentemente, il testo che state leggendo o guardando vi dà ugualmente qualcosa, come quando ascoltate una canzone per la centesima volta e vi piace lo stesso: non c’è il problema di “come va a finire” eppure vi sentite coinvolti, appassionati. O anche quando ascoltate un brano di musica più complesso di una semplice canzone: il problema del “come va a finire” non è proprio in gioco, eppure state lì ad ascoltare, magari ugualmente appassionati.
Funzionano un po’ così miti e leggende: magari li conoscete già, o magari no, ma assomigliano a un altro che conoscete e non è difficile capire cosa succederà. Eppure, qualche volta, ripercorrerli è ugualmente magico. Altre volte invece no. In che cosa sta la differenza? Potremmo dire, genericamente: nel modo di raccontare. E il modo di raccontare potrebbe essere definito come un modo per recuperare l’interesse di qualcosa di già noto facendocelo apparire sotto aspetti diversi, aspetti ignoti. Un bravo narratore, insomma, a parole così come per immagini, è in grado di farvi vibrare e penare anche per una vicenda che conoscete già. Sapete come andrà a finire, ma non sapete che cosa vi aspetta al prossimo passo, e, soprattutto, questi prossimi passi arrivano uno dopo l’altro un po’ come gli sviluppi di una melodia musicale, con un ritmo che vi trascina.

Funziona un po’ così anche Ghirlanda, di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky. Mattotti è recidivo: l’aveva già fatto qualche anno fa con Chimera. Tuttavia, a differenza che in Chimera, una storia in verità stavolta c’è, e c’è anche qualche sorpresa verso la fine, ma siccome si tratta evidentemente di una favola, il lieto fine è canonicamente atteso, e infine rispettato. Un po’ di tensione narrativa normale, quella che si potrebbe spoilerare, in fin dei conti è presente. Eppure non è davvero l’incertezza sul futuro di Ippolito e Cocciniglia a mandarci avanti, pagina dopo pagina.
Il bello, direi, è qui di due tipi.
Da un lato c’è…
Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
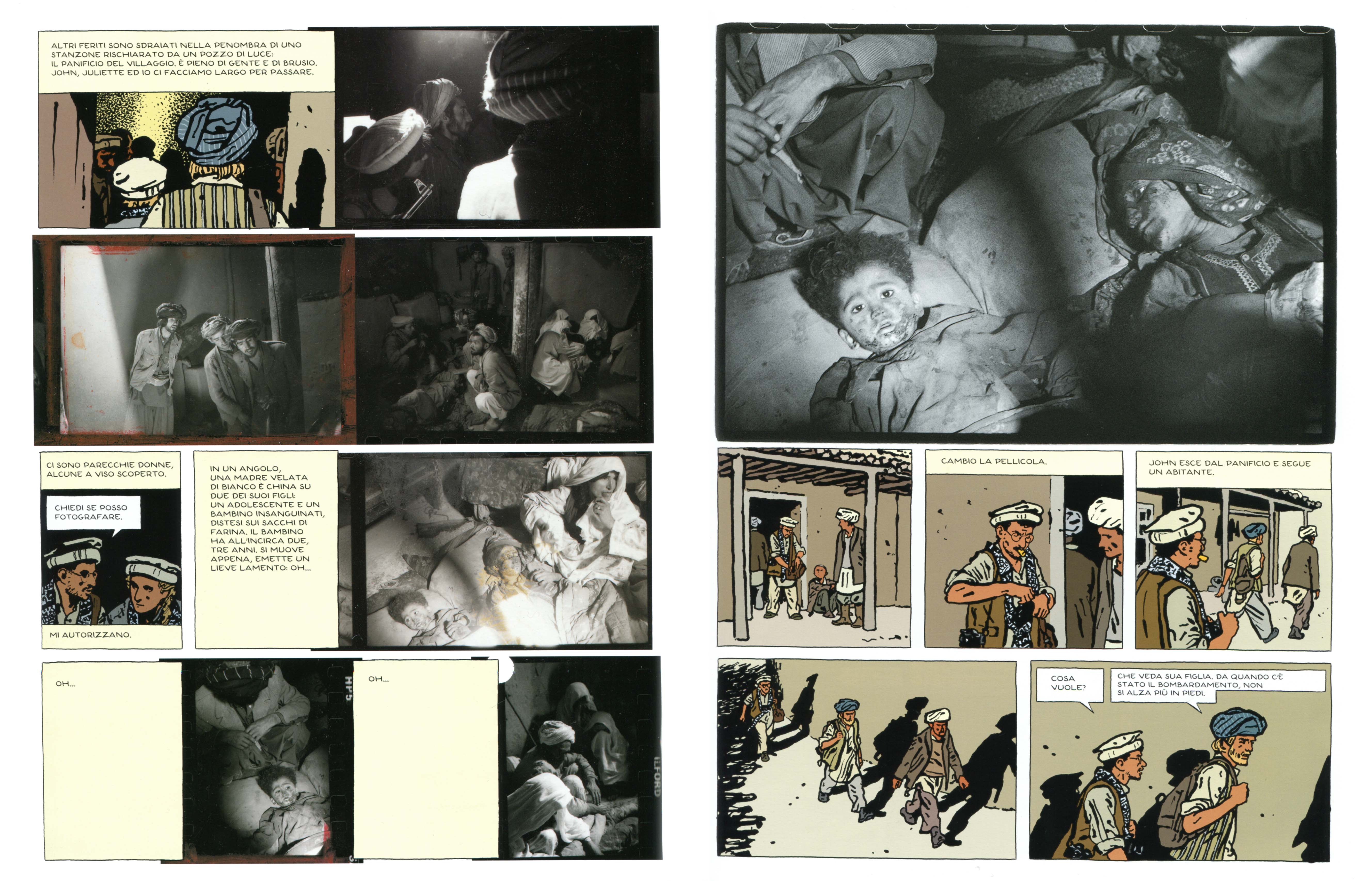 Guibert, Lefèvre e Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Il fotografo, scritto e disegnato da Emmanuel Guibert, con le foto e il racconto di Didier Lefèvre e la realizzazione grafica di Frédérik Lemercier (Coconino, 2010) è stato uno dei libri a fumetti che più ho apprezzato in questi ultimi anni. Guibert ha uno stile grafico estremamente piano, e ugualmente piano è il suo modo di raccontare. In altri suoi libri, questa voluta monotonia, unita alla scelta di trame ugualmente piane, conduce al limite della possibilità di suscitare interesse. Ma il suo è un gioco sottilmente al ribasso.
Non c’è, nel disegno di Guibert, una gran somiglianza apparente con l’aspetto tipico di quella che Joost Swarte ebbe a definire ligne claire, né nella figura del capostipite Hergé, né tantomeno in nessuno dei suoi discepoli diretti degli anni Cinquanta o indiretti degli Ottanta. Eppure, il segno di Guibert, come quello di Hergé, si attaglia perfettamente alla definizione di Swarte: “la linea chiara è un espediente grafico che permette di dare importanza alle persone e alle cose, sia che si trovino in primo piano, sia che facciano capolino sullo sfondo. È un modo di disegnare che alla descrizione premette la narrazione”. Qui come in Tintin, ombre e sfondi appaiono soltanto quando sono narrativamente significativi, e ogni dettaglio che non lo sia viene sistematicamente tralasciato.
Certo, si tratta di una linea chiara sporca, volutamente incerta, fortemente modulata – ma anche i temi e i registri affrontati da Guibert sono ben diversi da quelli affrontati da Hergé e seguaci. Paradossalmente, quella forma di antirealismo che è stata tradizionalmente la linea chiara qui si trova al servizio quasi di un iperrealismo, ma la realtà che emerge così vivacemente non è quella che si vede, bensì quella della storia, quella raccontata. In altre parole, la stilizzazione grafica diventa nelle mani di Guibert uno strumento per mettere in primo piano il racconto, proprio come le parole del narratore verbale, impedendo al lettore di distrarsi su dettagli magari interessanti in sé, ma poco per lo sviluppo narrativo.
Ecco quindi che quando questo modo di raccontare visivamente quasi ascetico dal punto di vista visivo si trova accoppiato all’immagine fotografica, l’effetto è deflagrante. La fotografia, per la sua stessa natura tecnica, si trova al polo opposto della ligne claire: la fotografia non può nascondere quello che inquadra, non può tralasciare dettagli, non può scegliere cosa mettere in scena e cosa no, data una certa inquadratura. La fotografia è proiezione della luce su una pellicola sensibile, e su quella pellicola va a finire tutto quello che viene inquadrato nel momento dello scatto.
Non si sta dicendo che la fotografia non contenga elementi soggettivi e che sia una testimonianza oggettiva della realtà: la soggettività del fotografo si esprime attraverso la scelta dell’inquadratura e del momento dello scatto, della distanza, dell’esposizione, della messa a fuoco e delle lenti, e poi, in postproduzione, con altre scelte sulla carta e sulle luci. Se la foto viene scattata in studio oppure è, in generale, possibile costruire il soggetto, le scelte soggettive sono molte di più, ma non è questo il caso della foto di reportage, il cui valore sta nel testimoniare quello che c’è. Ed è proprio questo il punto e il valore di questo tipo di foto: una volte fatte le scelte di cui si è detto, tutto il resto è testimonianza oggettiva, ovvero in qualche modo la prova che quello che stiamo vedendo nell’immagine si è presentato una volta esattamente così davanti agli occhi del fotografo e del suo obiettivo; insomma, c’è stato, ed era proprio così, almeno per un attimo.
Costruire una storia attraverso la combinazione di immagini disegnate come quelle di Guibert e di fotografie come quelle di Lefèvre, significa mettere fianco a fianco una soggettività che cerca di essere il più oggettiva possibile e un’oggettività che testimonia la soggettività di uno sguardo, e la sua presenza fisica.
Guardiamo ora questa inquietante doppia pagina. Lefèvre si è introdotto in Afghanistan (sono gli anni della guerra con l’Unione Sovietica) insieme con un gruppo di medici volontari, per un reportage sulla loro attività e sulle condizioni di vita della popolazione. Si ritrova all’immediata periferia degli scenari di guerra, a contatto con le loro conseguenze. La vicenda è raccontata per mezzo di lunghe didascalie e dei disegni freddi di Guibert – freddi ma narrativamente efficaci, e sporchi, nel segno, quanto basta per trasmettere l’idea di una realtà altrettanto sporca, incerta, sbrecciata.
Le fotografie sono intercalate, mute, al massimo precedute o seguite da una didascalia narrativa. Il passaggio alla fotografia inevitabilmente rallenta la lettura, perché una foto è naturalmente più ricca di dettagli di un disegno come questi, ed è quindi anche più difficile da decifrare visivamente. Questo rallentamento coincide con la drammatica entrata in scena dell’occhio del narratore: sino a un attimo prima era la sua voce a fornirci, per via di scrittura, i dettagli raccontati della situazione, con tutte le mediazioni e il conseguente distacco che questo comporta. E adesso di colpo stiamo vedendo quello che lui vedeva, la nuca dell’uomo sulla destra, la canna del fucile di quello a sinistra, la luce violenta del sole che cade dall’alto, e poi gli sguardi preoccupati e addolorati, e poi l’agitazione della madre e lo sguardo del bambino che ricambia quello del fotografo: di colpo siamo lì con lui, o almeno con il suo sguardo.
Con tutte le qualità della fotografia di reportage, il suo limite è che anche la foto più straordinaria perde gran parte del suo potere se non è sufficientemente contestualizzata. La foto di reportage forse più famosa del Novecento, quel miliziano caduto ripreso da Robert Capa durante la guerra di Spagna, non sarebbe forse neanche una bella foto (mossa, sfocata, fuori quadro) se non ci fosse noto il contesto in cui è stata fatta; ma in quel contesto, in quelle condizioni, quei medesimi difetti diventano valori aggiunti, perché testimoniano a loro volta che la situazione era concitata, imprevedibile.
Qui, l’operazione di Guibert è proprio quella di creare un contesto narrativo così attentamente dettagliato da magnificare al massimo il potere di testimonianza delle foto di Lefèvre, testimonianza della realtà che si presentava ai suoi occhi, e testimonianza dell’impatto emotivo che quella realtà aveva su di lui. Nello stesso senso vanno le scelte di Lemercier, curatore grafico dell’impresa, che ha lasciato volutamente a molte foto i dettagli della pellicola circostante, o addirittura (non in queste pagine) le cancellazioni di Lefèvre. Molti scatti, nella logica di una pubblicazione fotografica tradizionale, sarebbero stati tralasciati, facendo sopravvivere solo quelli che parlano da sé (qui, per esempio, la foto grande sulla pagina di destra). Invece, introdotti in una logica narrativa come questa, diventano fruibili gran parte degli scatti, e anzi contribuiscono essi stessi a loro volta insieme con le vignette disegnate a definire il contesto che permette loro di avere un senso pieno.
7 Maggio 2017 | Tags: Nadia Agustoni, poesia | Category: poesia | i volti tra le frasi il poco
dei giorni succede chiaro
le parole arrivano viene il mondo
una volta erano le voci
un che di cicoria e limoni
o terra a patire
e il gas falciava i prati
in un altrove dove le spine
dove noi e nulla –
scrivi sulla morte
lì cadono i bambini i fiori
che pensiamo per sempre
e senza le tue parole c’è altro
come se restasse il sangue di tutti
e tutta la vita per niente –
ma il male credimi il male
guarda se siamo soli
se siamo figli padri
qualcun altro –
ricordati chi rideva chi
disse cosa a chi
e non tornava risposta
ma un’eco
l’osso cranico
(io non sono la domanda)
*
perché la pianura sia vento
resta domanda e nel peso delle case
c’è questo cielo i camion che spingono
la polvere le finestre con l’obbligo di vivere
da qui a lì un confine.
*
a esistere c’è il buio
più grande – non pensare
come pensa il mondo.
sembriamo il cortile l’auto
e piango per l’idiota
la ragazza il campo
i vestiti bruciati di
chi è lasciato solo.
così andiamo con le storie
coi cerotti – un vaso
di mele gialle ci pensi i quadri
nei quadri l’albero dei limoni
quando crescevi
senza dire: “anch’io”.
*
nella postura di dopo
noi siamo io vivo
come ognuno vive
accanto
nell’ora che la luce toglie
nebbia torna il campo
i versi e la mia bocca
tornano voce
il tavolo e il campo
sono la voce
potrei sottovoce
fare assenza
*
i giorni chiari il vero
tutto resta sorpreso
le stelle non
credere
dolo di luce è l’inverno
la neve il fiato
l’ala nera dei cipressi
ci pensano
tu dici: “la morte
può solo sembrare”
così è più grande
questo vivere
che capisce
le prigioni
i poveri nemmeno
l’aria li raccoglie
non sanno il banco
d’imparare
prendono giugno o neve
e tutto sempre
gli basta
nel prato solo il prato
non tremano.
sanno il male
portato
col bene.
*
ma scrivo dalla disincarnazione
del dolore tra fabbrica e fine
queste parole mosse da un alito
nel cursore indocile.
sfioriranno nei padiglioni
del cielo contemplando il Tao
delle ingiustizie e faremo
pernacchie ai preti
fermi al sesso degli angeli
*
fabbrica non c’è parole
i secchi mettono il vuoto i secchi
sono l’acqua – c’è mezza luce
scrivi una volta quando i platani
sembrano madre e guardi
sui ginocchi l’entrata del
vento che non cura –
c’è un’intermittenza
che cammina insieme
al buio – le cose durano
dopo i fiori –
sei un mercoledì delle ceneri
il mattatoio dei guanti – i libri
sono il soffitto e la gente che credi:
così pensiamo il corpo nel petto
nelle spalle i petali di una casa
*
il mondo da capo
al minimo animale
fervore di passero
nulla più – il cielo
e universi aperti
dalla cenere.
*
scavare terra
prende la tua visione
ma nulla
nulla
nel petto la casa
clorofilla in bocca
e chiedere se questo
tutto questo
è esistere.
*
la fine è prima della fine
perché ci pensi –
ma dopo è soltanto
ricordarsi
e lo spaventapasseri
l’uccello
il campo
qui alzano gli spari
guardare come dentro un posto
a volte il vuoto
non è l’aprirsi
di un’altra storia
Daniele Barbieri
Nel freddo del male
Poiché il male fa male, va tenuto a distanza. Se si è troppo vicini, il male, anche se riguarda altri, ci è intollerabile. Può essere intollerabile anche quanto riportato, visivamente, sonoramente, letterariamente, ma la letteratura (e ancor più il mezzo audiovisivo) conosce da sempre le strategie per costruire la distanza: si può per esempio sminuire o enfatizzare. Si sminuisce limitando la descrizione, deumanizzando chi subisce il male, allontanando il soggetto che soffre attraverso il ridicolo… Si enfatizza facendo appello al sentimentale, o buttandola sull’horror, sullo splatter – che sono altri modi, in realtà, per sminuire, perché da un lato la retorica dei buoni sentimenti (della cristiana pietà) ci mette dalla parte di chi sta cercando di porre rimedio (anche se in verità nulla facciamo), e, dall’altro, l’accentuazione spettacolare trasporta il male in un’altra dimensione, quella, appunto, dello spettacolo, un universo di finzione, in cui agiscono personaggi e non persone, e di sicuro l’empatia che si può provare per un personaggio è di tipo diverso da quella che si prova per una persona. Dove c’è dramma c’è risoluzione; persino se la storia finisce male, essa comunque finisce, e quello che ce ne resta è soltanto una morale, in ogni caso consolante, per quanto negativa sia.
Lettere dalla fine è un libro sul male, che evita programmaticamente la spettacolarizzazione, e non mostra traccia di sentimentalismo; ma nemmeno deumanizza o ridicolizza. Naturalmente adotta una strategia di distacco, ma diversa da quelle elencate sin qui: quella di Agustoni è la strategia del raffreddamento, dell’occhio separato, della parola che osserva, apparentemente distante.
Manca prima di tutto un soggetto che dica io, che si ponga come il rispecchiamento patemico del dolore nel mondo. Il soggetto è infatti caldo, risponde al male con la propria afflizione, e così facendo funge da schermo nei confronti del lettore, proponendogli una via di pietà.
Dove il soggetto viene lasciato fuori, resta fuori anche la pietà, con il suo calore un po’ stucchevole. Qui, il freddo del male ci arriva direttamente, quasi come un vento da cui non abbiamo riparo.
Ma non arriva da solo, perché – di nuovo – se arrivasse da solo finirebbe ancora, più surrettiziamente, spettacolarizzato. Nei versi di Agustoni quasi non sembra che si parli del male. Si parla di cose di ogni giorno, o di esperienze particolari ma non in sé maligne. È come se il male traspirasse attraverso queste cose. Persino nei versi finali dedicati a Billy Budd (il marinaio ragazzino da un racconto di Melville, impiccato sostanzialmente per un solo gesto irruente) traspira solo una strana calma, una descrizione di quello che si vede attorno – e ci vuole un po’ di attenzione per accorgerci che la voce che parla è quella di un morto, di un impiccato al pennone della nave.
Eppure, pagina dopo pagina, questo discorso tranquillo, fatto di immagini anche solari e di accostamenti a volte sorprendenti, finisce per costruire un sentimento glaciale. Non siamo esposti in verità al vento del male; è piuttosto come se il mondo, nella sua bellezza, nell’insieme dei sentimenti che comunque trasmette, traspirasse il male, traspirasse la morte, traspirasse la fine.
Le lettere dalla fine sono lettere dal mondo in cui la fine è presente sin dall’inizio, sono lettere in cui anche il calore è freddo, perché solo così si può essere degnamente sinceri con i propri lettori, senza strategie di facile commozione – nell’onda di una tradizione che va da Antonio Porta a Giuliano Mesa.
È affascinante comunque vedere, leggendo questi versi, come pagina dopo pagina, il soggetto escluso ritorni in gioco. Non è un soggetto dilaniato come quello di Amelia Rosselli (quasi un paradossale soggetto dell’inconscio) ma forse solo una capacità di mettersi in sintonia, presentando il mondo (con il suo male ma anche con il suo bene) attraverso questa sintonia, un noi più che un io, un trasmettere stupore, un soggetto minimale, ma sufficiente a coinvolgerci, a lasciarci scorgere una struggente vena di calore nel freddo del male.
 Questo testo è stato pubblicato qui, su Bologna in lettere. Questo testo è stato pubblicato qui, su Bologna in lettere.
Lettere dalla fine, di Nadia Agustoni, è primo classificato (ex-aequo) al premio letterario Bologna in lettere 2017
22 Aprile 2017 | Tags: Ida Travi, poesia | Category: poesia | La poesia di Ida Travi mi rende inquieto. Leggendo Dora Pal. La terra, sua raccolta appena uscita, nella quale si continua il discorso iniziato tre libri prima, dando voce ai personaggi di un mondo che non esiste ma nonostante questo esiste, leggendo Dora Pal si ha al tempo stesso la sensazione di capire tutto e di non capire quasi niente, come se un’apparenza di facilità, di semplicità quotidiana, rivelasse in realtà una sorta di abisso di cui non si scorge il fondo. Ho vissuto, nel leggere in sequenza la serie di componimenti che costituisce la raccolta, la singolare esperienza di un etnologo che si trova di fronte a una cultura stranamente familiare e al tempo stesso sconosciuta, come un Ernesto De Martino nella sua terra del rimorso, alla ricerca di configurazioni che fossero in grado di darmi ragione di quei comportamenti così intimamente diversi, però anche stranamente familiari.
Ma il piccolo mondo dei Tolki, il popolo immaginario cui pure la vecchia Dora appartiene, è già all’origine una creazione letteraria, creata apposta per produrre nel suo lettore un’irriducibile sensazione di spaesamento dentro il consueto, dove lo schema esplicativo rassicurante applicabile dall’etnologo in qualsiasi terra del rimorso non può essere davvero applicato. E il lettore è condannato a rimanere lì, appeso a questa identità che è insieme un’alterità, a questa oscillazione tra l’altrove e il qui.
Intanto, dunque, le parole. Le parole di Ida Travi sono semplici, quasi banali…
Continua su Nazione Indiana, qui.
13 Marzo 2017 | Tags: fumetto, The Spirit, Will Eisner | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
 Will Eisner, The Spirit 20.06.1948 frontespizio originale  Will Eisner, The Spirit 20.06.1948 frontespizio della ristampa in bianco e nero degli anni Sessanta Settantacinque anni dalla sua prima apparizione e dieci anni dalla morte del suo autore sono una buona accoppiata di ricorrenze per ridare un’occhiata a The Spirit, e concentrarci, nella fattispecie, sulla tavola di apertura dell’episodio del 20 giugno 1948. Come è noto, The Spirit usciva settimanalmente dal 1940 come una sorta di comic book (il formato era quello) però allegato all’edizione domenicale di un quotidiano, invariabilmente 7 pagine a colori, con una storia autoconclusiva – che in pochi casi aveva un seguito la settimana successiva. È un fatto noto che la crisi del fumetto di supereroi nel dopoguerra aveva progressivamente coinvolto anche The Spirit, seppure con tempi molto più lunghi, così che sul finire dei Quaranta Eisner aveva progressivamente delegato sempre di più il disegno ai collaboratori dello studio, sino a chiuderlo nel 1952. Nell’interregno tra il ’52 e il 1978, anno di rinascita di Eisner come fumettista pubblico, e anno di fondazione ufficiale del formato graphic novel proprio con il suo A Contract with God, Eisner non viene però dimenticato. Ci pensa il suo già collaboratore Jules Feiffer, nel frattempo assurto a sua volta alla fama come satirista, a far ristampare The Spirit, a partire dagli anni Sessanta, ma nella versione in bianco e nero, più economica e più rispettosa dello stile del maestro.
La tavola che analizzeremo viene qui mostrata in due versioni. Quella grande, in bianco e nero, proviene dalla riedizione Kitchen Sink del 1987; quella piccola, a colori, dall’edizione originale. Proprio avendole avute casualmente l’una a fianco dell’altra mi sono reso conto delle differenze, e ho poi verificato che queste differenze non sono occasionali: sono diversi infatti i casi di aggiustamenti tra la versione originale a colori e la riedizione in bianco e nero (non so se già la riedizione Feiffer dei Sessanta, come suppongo, o solo quella Kitchen Sink). Si potrebbe ipotizzare che, ripubblicando, Feiffer o magari Denis Kitchen abbiano colto l’occasione per un recupero filologico di un originale all’epoca menomato per esigenze di pubblicazione. Ma ritengo piuttosto che sia stato lo stesso Eisner, al momento ben vivo e attento curatore dei propri interessi, a proporre delle modifiche, ritenendo l’originale carente (come nei casi di ridisegno completo della pagina) o semplicemente inadatto, così com’era, per la pubblicazione in bianco e nero – essendo stato concepito a suo tempo per il colore.
In questa seconda ipotesi, è davvero interessante il confronto tra le due versioni, perché rende ancora più esplicito l’intento della pagina, e più completa e acuta la spettacolarizzazione narrativa.
Si osservi che nell’originale a colori è presente la testata, la quale conduce naturalmente l’attenzione verso destra, alla fine della lettura del titolo, punto da cui ha inizio la sequenza di ripetizioni dell’insegna SPIRIT, progressivamente poi più grande e vicina, con un andamento da destra verso sinistra, inverso a quello della testata. Sulla quarta ripetizione dell’insegna si inseriscono i due personaggi, una coppia di gemelli identici, dei quali solo uno parla. La stessa coppia ritorna, maggiormente in evidenza, sulla quinta ripetizione, mentre la sesta ripetizione dell’insegna è ortogonale alla quinta, e ripristina il movimento verso destra. C’è adesso una specie di fossa in muratura, con una scala; la direzione della luce è invertita, da destra anziché da sinistra (mentre l’insegna non ha ombra); sul fondo il gemello che parla appare solo e nel suo discorso le parole BLOODLESS MURDER (omicidio senza sangue) hanno un particolare rilievo. Tutto questo su fondo bianco e vuoto.
Nella versione in bianco e nero questo medesimo sfondo si trova striato da una serie di linee in prospettiva, che enfatizzano l’uniformità dello spazio, e la relazione prima/dopo delle varie occorrenze dell’insegna. Poiché non c’è più la testata a condurre l’attenzione al punto di partenza giusto, le occorrenze più lontane dell’insegna non vengono infatti in sé percepite come precedenti a quelle più vicine. Il punto di attacco percettivo, per iniziare, sembra essere piuttosto il primo balloon del gemello di sinistra. Oltre alle linee esplicite di fuga, Eisner introduce perciò un secondo fulcro di interesse in alto a sinistra: una processione di macchie, poi interpretabili come macchie di sangue, che dall’alto si avvicina, ingrandendosi, a noi. La presenza di questa serie affianca la serie delle insegne, e presto si spiega ulteriormente come corrispondente visivo del racconto che viene fatto nei balloon.
In basso, la fossa in muratura ha perso il triangolo d’ombra sulla destra, in modo da permettere la vista della colata del sangue lungo la parete, colata che prosegue sulle scale sino a fermarsi all’altezza di un corpo che ha appena risalito faticosamente quelle medesime scale. Ancora più a destra è comparso un cartiglio, che riprende le parole del personaggio in forma parodisticamente più burocratica, poliziesca, secondo una modalità familiare ai lettori della serie.
Tutte e due le versioni mostrano come si possa trasformare lo spazio (bi- o tridimensionale e senza vettori intrinseci) nel tempo (monodimensionale e intrinsecamente direzionato). Nella prima c’è una sorta di costruzione a Z, basata sulla ripetizione dell’insegna SPIRIT nella testata in alto e nell’immagine, e della figura del box, due volte nella testata e in basso nell’immagine. Nella seconda c’è invece una progressione duplice, dall’alto a destra verso il basso a sinistra, insieme all’allargamento prospettico della situazione focalizzata. La diagonalità è cruciale in ambedue i casi, ma nella seconda versione diventa irrilevante l’inversione di direzione.
Si noti che non sarebbe stato necessario cancellare l’ombra sulla destra, nella fossa, per lasciar vedere la colata di sangue. Se essa viene cancellata è piuttosto per minimizzare o nascondere l’inversione della direzione della luce, che ora non ha più senso (rimane, sì, nella posizione dell’ombra del personaggio, ma senza particolare rilievo, e può restare inosservata). Piuttosto, si è creato adesso un piccolo squilibrio grafico, un vuoto sulla destra, che il cartiglio va a riempire, compensando anche la spinta verso sinistra del cadavere che conclude la progressione delle macchie, e fungendo da raccordo con la vignetta che seguirà nella pagina successiva, idealmente in basso a destra rispetto al cartiglio stesso. Adesso, l’angolo creato dai vettori del cadavere e del cartiglio riprende quello, poco più in alto a sinistra, delle ultime due occorrenze dell’insegna: è la metafora del racconto, che è uscito dalla pagina organizzata in vignette (come quella che vediamo qui in diagonale) per arrivare direttamente a noi, qua fuori. Del resto è proprio a noi, qua fuori, che si rivolge, con lo sguardo e con il you, il personaggio che parla.
                  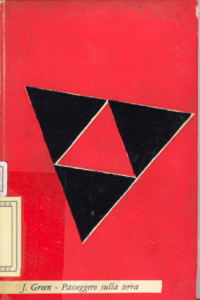         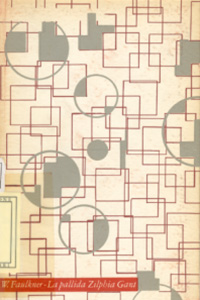
Capita, frequentando le librerie dell’usato, di imbattersi in una piccola pila di libri degli anni Cinquanta, pubblicati da Il Saggiatore. Copertina cartonata, nonostante il piccolo formato e un numero ridotto di pagine; ma quello che succede è che rimango colpito, più che dai titoli dei libri, dalla qualità ricorrente delle copertine. E allora apro uno dopo l’altro questi libri, alla ricerca – non sempre premiata, in campo editoriale – del copertinista. E ricorre questo nome, a me sconosciuto: Balilla Magistri.
Più tardi faccio ricerche sul Web, scoprendo che il nome per intero è Giovanni Balilla Magistri, e trovando questa pagina dedicata, da cui ho tratto le immagini che state vedendo, ovvero la serie delle copertine per Il Saggiatore. Nella stessa pagina si trovano anche i dipinti di questo autore: stupisce che a queste belle copertine astratte corrispondano dei dipinti figurativi. Stupisce anche la varietà di questi astrattismi.
Negli USA i Cinquanta erano gli anni di grandi copertinisti come Alvin Lustig o Paul Rand o Leo Lionni. Mi sembra che le copertine di Magistri non sfigurino di fronte alle loro (mentre non sarei rimasto colpito dai suoi dipinti).
11 Gennaio 2017 | Tags: fumetto, Gipi | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.
(Niente figura stavolta. Bisogna guardare il libro)
Torniamo sul contemporaneo, anzi, proprio sul recente, sull’attuale. D’altra parte, dal mio punto di vista, unastoria di Gipi è già una storia passata alla Storia; è già un classico, nella sua perfezione e ingegnosità. Mi è capitato, in questi mesi, di udire, leggere, e anche discutere di persona con Gipi che racconta come è nato questo racconto a fumetti. Dopo tante storie autobiografiche, e dopo un lungo, lunghissimo silenzio fumettistico (durante il quale Gipi ha fatto altro, cioè soprattutto il regista), questa storia gli si è quasi imposta da dentro, come qualcosa che voleva uscire, con un inizio quasi casuale e una spinta a proseguire, per quanto ancora senza sapere come.
Il metodo con cui Gipi racconta di aver realizzato questa storia è tutt’altro che didatticamente consigliabile, a meno che uno non abbia già numerose storie realizzate alle spalle – e allora magari non ha nemmeno bisogno di consigli didattici… In altre parole, sino a poco prima della fine della realizzazione, l’autore non sapeva come il discorso sarebbe proseguito, né dove sarebbe approdato.
In termini di economia della produzione, si tratta di un rischio enorme, perché proseguendo così, in maniera miope, vedendo soltanto lo sviluppo immediato (e talvolta nemmeno quello) si corre facilmente il rischio di imboccare vicoli ciechi, senza possibilità di sviluppo, trovandosi magari costretto a buttar via una quantità di lavoro già fatto, per poter riprendere il discorso da un punto precedente, quando le possibilità sono ancora aperte. A meno di non essere (quale Gipi è) un grande narratore, con una specie di istinto animale per gli sviluppi più iteressanti e sensati.
A quanto l’autore ha raccontato, di vicoli ciechi quasi non ne sono stati presi: poca roba, insomma, nell’economia complessiva. Ma l’autore l’ha ugualmente pagata in termini di incertezza, di continua angoscia sul come proseguire. È un po’ come con una partita a scacchi, in cui cerchi di prevedere quale sia il ventaglio di possibilità future che la tua prossima mossa ti apre; ma non puoi pianificare l’intera partita. Se sei un giocatore di qualità potrai prevedere quattro, cinque mosse future; ma poi l’insieme dei possibili sviluppi si fa così ampio da non essere più gestibile. E la cosa dipende anche dalla qualità del tuo avversario.
Gipi aveva di fronte un avversario temibile: la banalità, o la prevedibilità, se preferite; il rientrare nel già visto, nel già letto, già noto. Ma ne aveva, al tempo stesso anche un altro, non meno temibile: l’astrattezza, la fumosità, l’incomprensibilità. Sono gli avversari, questi, di qualunque scrittore; ma una cosa è affrontarli sostanzialmente in fase di pianificazione e progettazione iniziale (avendo di fatto già giocato in larga misura la partita sulla stesura del soggetto e della sceneggiatura), e altra cosa è trovarseli di fronte giorno per giorno, mattina dopo mattina, dovendosi domandare se si sta davvero facendo la cosa giusta, e come reagiranno loro. In termini pratici, se chi lavora su una sceneggiatura già preparata può trovare lo spazio per rilassarsi, perché una quantità di problemi globali sono già risolti e ci si può concentrare su quelli locali, di impaginazione e di disegno, Gipi, al contrario, è costretto a stare sul pezzo senza distrazioni, come un sassofonista che stia eseguendo un assolo: non puoi interromperti un minuto per fare altro, e poi riprendere! Se ti azzardi a farlo, perdi il ritmo, perdi il flusso, si dissolve il duende.
Ecco quindi che cosa guadagna Gipi con questa operazione certamente antieconomica, umanamente distruttiva, rischiosissima: guadagna la freschezza dell’improvvisazione, il suo ritmo, la condivisione con il lettore dell’atteggiamento nei confronti della storia che si sta narrando. Perché nelle pagine di unastoria l’autore come il lettore non sa che cosa accadrà dopo, e le sue interrogazioni possono essere le stesse del lettore, il suo feeling il medesimo del lettore, il suo rapporto con i personaggi e con gli eventi proprio quello che sta avendo il lettore. Il guadagno è dunque in freschezza, in immediatezza, nella sensazione che quello che stai leggendo/guardando non arrivi dall’alto, ma prenda vita quasi nel momento in cui lo guardi.
Ho selezionato, da mostrare qui, le prime tre pagine di unastoria. Che cosa vi si sta raccontando? Difficile dirlo. In generale, il rapporto che ciascuno di noi ha con il proprio corpo, con la propria storia personale, con la propria età. Tuttavia, nel fare questo, vengono messe in gioco due figure, quella dell’albero secco, metafora della natura non benigna, e quella della stazione di benzina, metafora di qualcosa che non arriva (per ora) a essere chiaro, perché di colpo entra in campo come una seconda voce, “Cos’è questo posto” al che la voce narrante principale si trova costretta a rispondere “Zitto. Non parlare. Seguimi.”; e poi il discorso riparte da capo, introducendo una variazione nel tema iniziale: non più la vecchia, ma il diciottenne; non più qualcuno che si vede così com’è, ma qualcuno che si vede come sarà tra trent’anni.
Ecco che nel giro di tre pagine, un attacco quasi filosofico, autoriflessivo (“Dammi risposte complesse”) si articola in un dialogo con una seconda voce, e appaiono figure emblematiche. Si tratta di un’introduzione, indubbiamente, e alle introduzioni permettiamo di divagare, di creare l’atmosfera. Narrativamente, qui è ancora tutto aperto; solo, ci si potrà aspettare una storia in cui si rifletta sul rapporto con il proprio io, con l’alterità, con l’esperienza vissuta.
Anche graficamente sta già succedendo molto. Sono stati mostrati diversi personaggi, anche se hanno l’aria delle comparse, funzionali al solo discorso del narratore. Ma soprattutto è stata impostata un’alternanza tra una grafica disegnata, bianconero al pennino graffiato, e una dipinta, tecnica mista con dominanza di acquarello o ecoline.
Non è immediata la comprensione del perché di questo salto d’immagine. Non si tratta di una differenza convenzionale, come spesso si usa nel fumetto, per esempio per contrapporre realtà a sogno o fantasia o ricordo. Al massimo c’è un accenno a un’opposizione di questo tipo, o a un’opposizione narrativa di qualsiasi tipo. Credo che, anche qui, Gipi preferisca giocare di indeterminatezza.
Certo, le immagini al tratto sono fortemente integrate con il lettering che le accompagna, con abbondanza di discorso verbale, come se parole e immagine dovessero essere considerate quasi una cosa sola, quasi un modo fortemente integrato di raccontare, in cui anche la parola è immagine, e l’immagine è a sua volta parola. D’altro canto, le immagini dipinte sono accompagnate da poco testo, e nettamente differenziato da loro, come se l’immagine volesse imporre la propria pregnanza e autosufficienza, facendosi fortemente guardare, perché in quel momento guardare è sufficiente.
In altre parole, con gli strumenti del fumetto, Gipi ci fa passare dal romanzo (dominanza della parola) al film (dominanza dell’immagine), e viceversa, scegliendo per ogni situazione la modalità più adatta per esprimere quello che si vuole esprimere. Un altro ritmo, un altro motivo di fluidità, un altro elemento di complessità che si aggiunge con semplicità al gioco.
Indubbiamente, con questa introduzione alata, intrigante, coinvolgente, ma che non rivela quasi nulla, il lettore ha ragione di aspettarsi un seguito di storia di eguale altezza ed eguale livello di coinvolgimento. Ma le ambasce quotidiane dell’autore Gipi non sono state inutili.
 Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos
Daniele Barbieri
Analizzare un testo letterario, o un testo artistico in generale, non può mirare a mettere in luce una verità del testo, nemmeno in termini di struttura semantica profonda – come invece l’analisi può (e dovrebbe) forse fare nella misura in cui il testo in oggetto ha un qualche tipo di finalità persuasiva. Ovviamente anche un testo letterario può avere una finalità persuasiva, e l’arte non è del tutto estranea alla propaganda ideologica. Tuttavia, nella misura in cui il testo fosse analizzato in termini di verità, o di significato profondo, non lo staremmo trattando davvero come testo artistico, limitandolo alla sua componente persuasiva. Una simile analisi di un testo letterario non sarebbe comunque inutile. Sarebbe piuttosto semplicemente parziale, la messa in luce di uno dei possibili percorsi di lettura, un passo certamente significativo, purché lo si intenda come un passo all’interno di un percorso, e non come una meta.
L’analisi che presenterò in queste pagine parte dall’assunto che un testo artistico non può essere risolto in nessuna delle sue letture, perché lo specifico del testo artistico è quella di stimolare sempre ulteriori letture – ciascuna delle quali andrebbe, eventualmente, sottoposta a nuova analisi. Non per questo l’analisi è priva di utilità: ogni lettura che del testo artistico si dà è una piccola comprensione del mondo, e uno stimolo per ulteriori letture dello stesso testo e anche di altri. Un’analisi semiotica non è, in questi termini, che una lettura particolarmente attenta e metodologicamente supportata, che permette di estrapolare aspetti che facilmente resterebbero altrimenti nell’ombra. Non c’è una pretesa di verità dell’analisi, bensì una di utilità, poiché anche là ove il lettore arrivasse a contestare tutte le osservazioni uscite dall’analisi, questo sarebbe già un successo in termini di fertilità ermeneutica – e quindi un favore fatto al testo artistico.
Ho scelto come oggetto dell’analisi un testo poetico del 2007, la sezione iniziale di un poemetto di Andrea Raos, Le api migratori. Ho scelto volutamente un testo contemporaneo, non canonizzato, il cui valore è riconosciuto (oltre che da me, evidentemente) da una cerchia relativamente ristretta di addetti ai lavori, come succede normalmente ormai per la poesia in Italia. In questo modo, oltre a valorizzare implicitamente e meritatamente il lavoro di Raos, questa analisi mira a presentarsi come esemplare prima di tutto in quanto analisi, e non come proposta di rilettura di un testo classico.
Quello a cui l’analisi mira è la descrizione di un percorso di fruizione da parte del lettore, un percorso esperienziale fatto di sintonizzazioni e prese di distanza, di tensioni e risoluzioni…
Prosegue su Il Sileno, vol.3 n 2 (dicembre 2016), anzi esattamente qui.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|














 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email

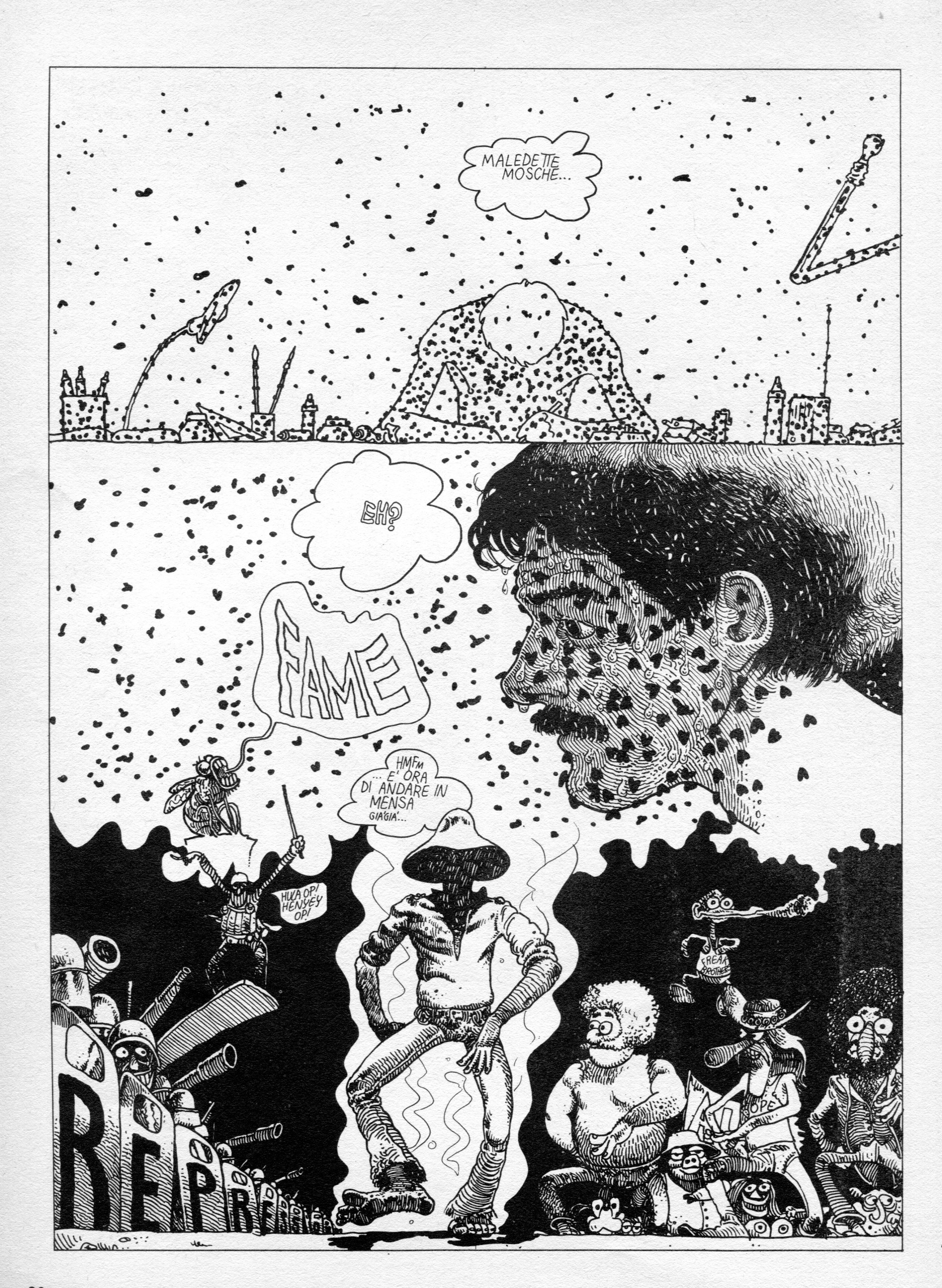





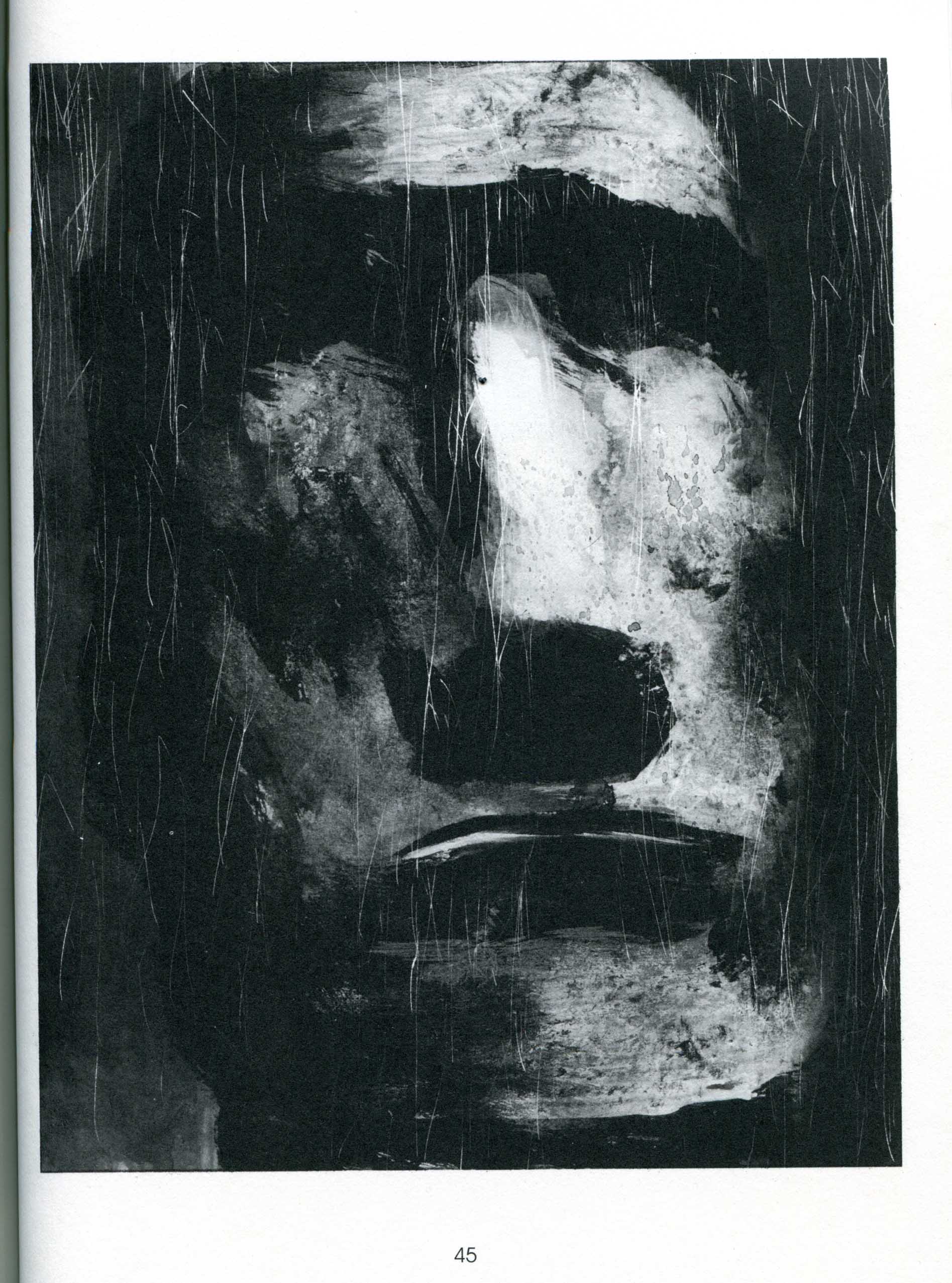

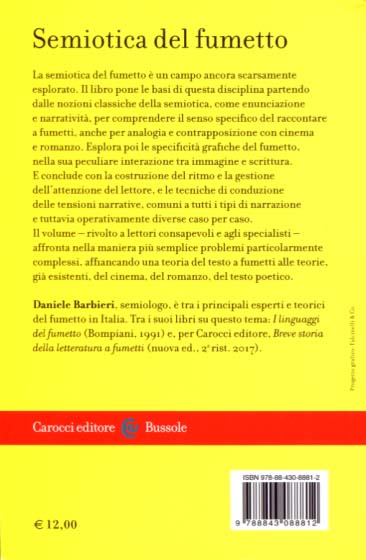
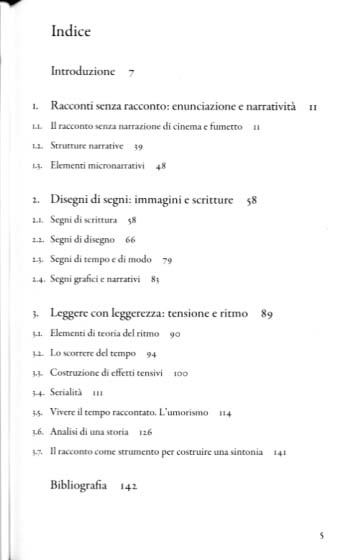
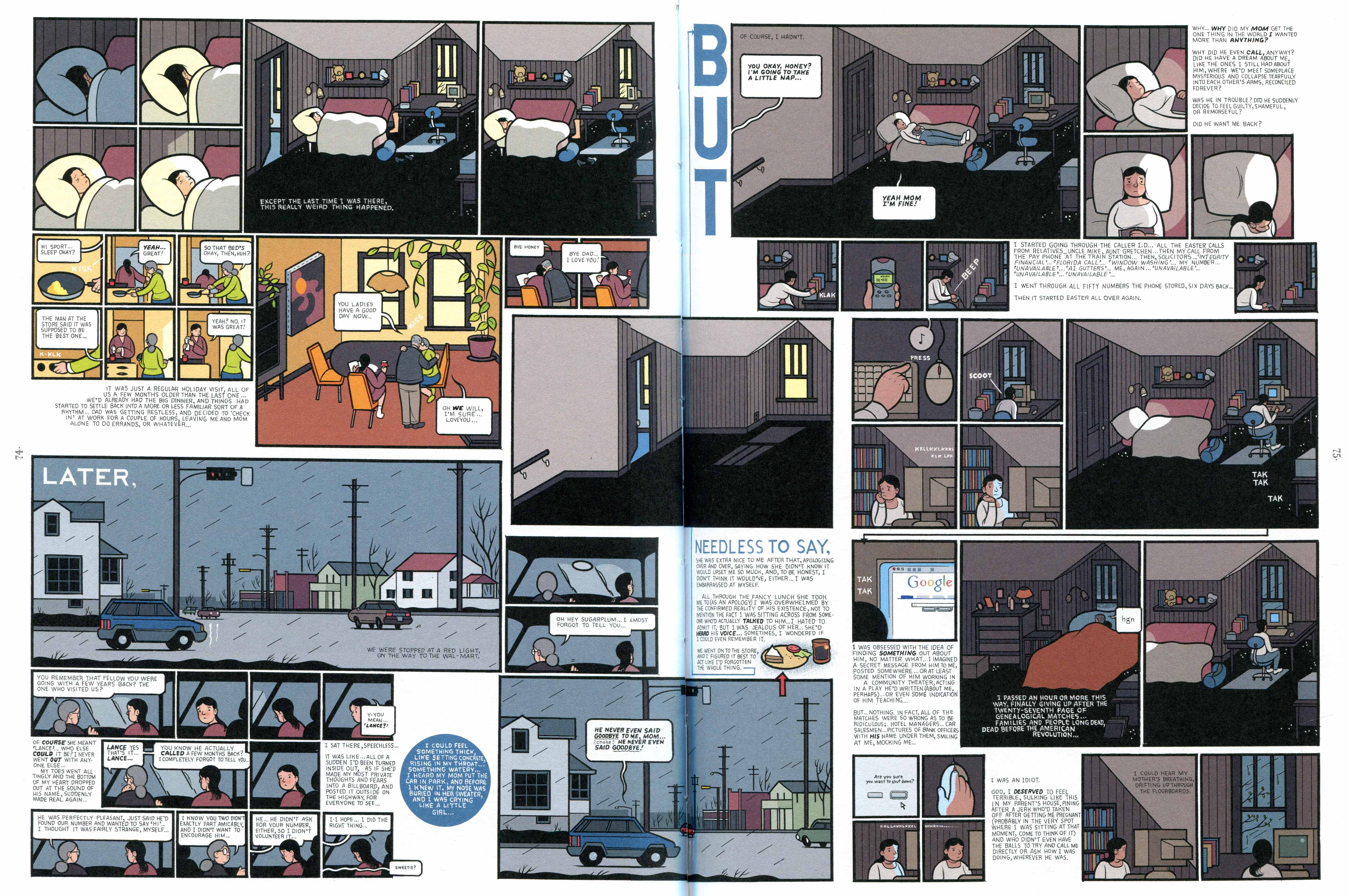
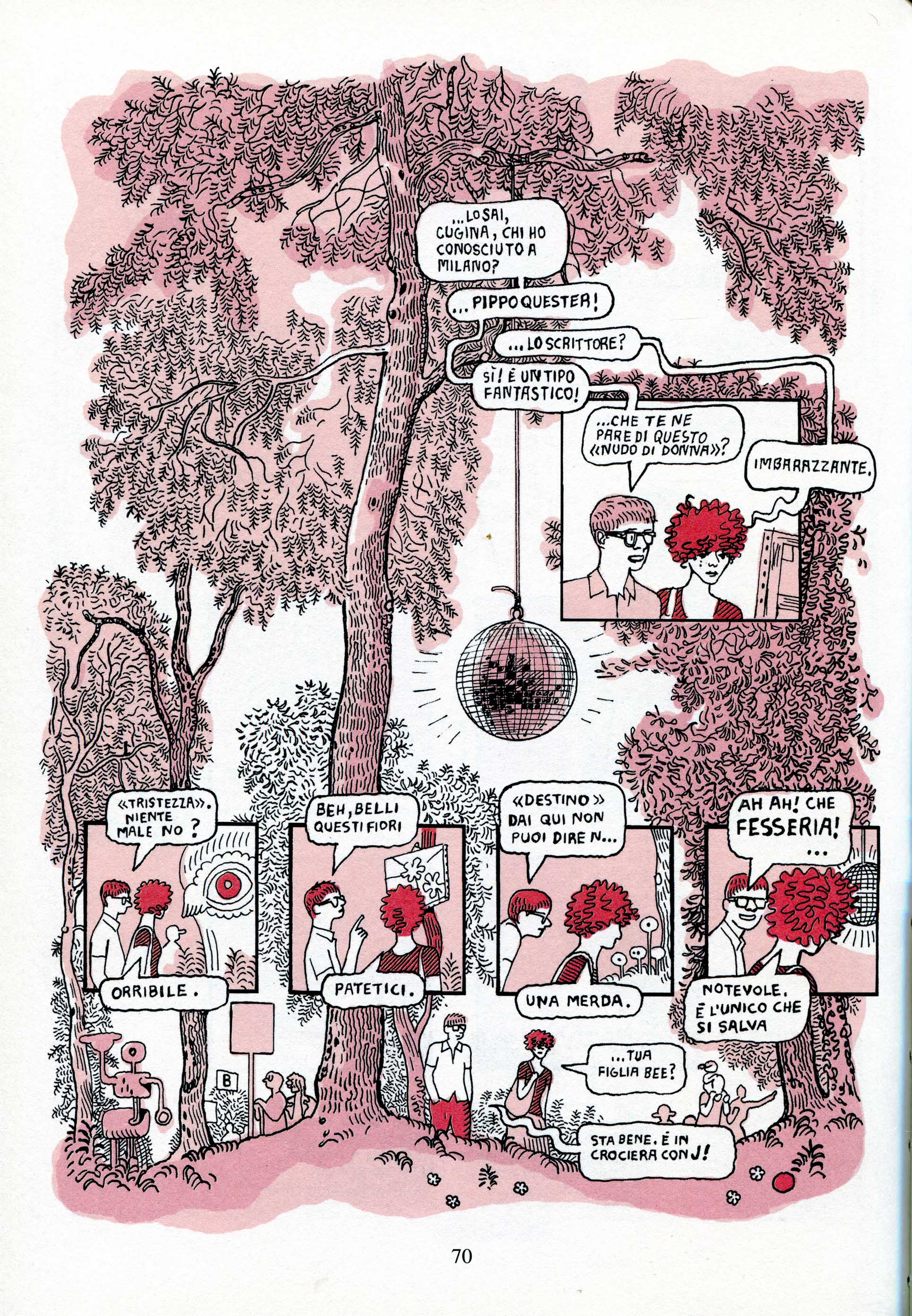



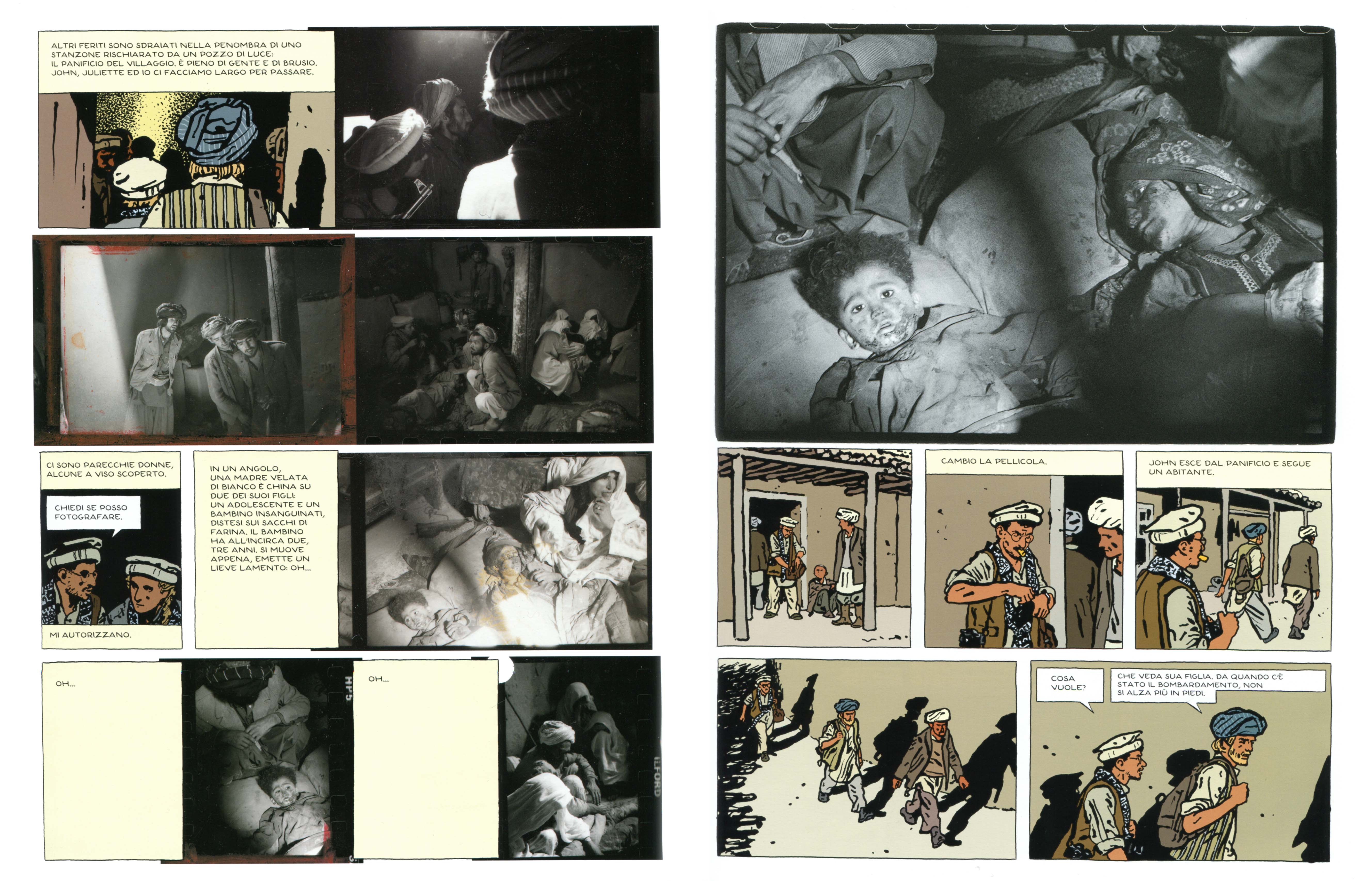
 Questo testo è stato pubblicato
Questo testo è stato pubblicato 



















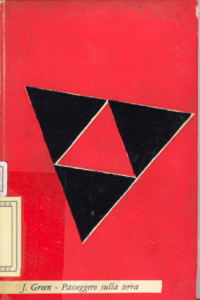








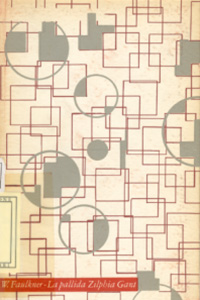


















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco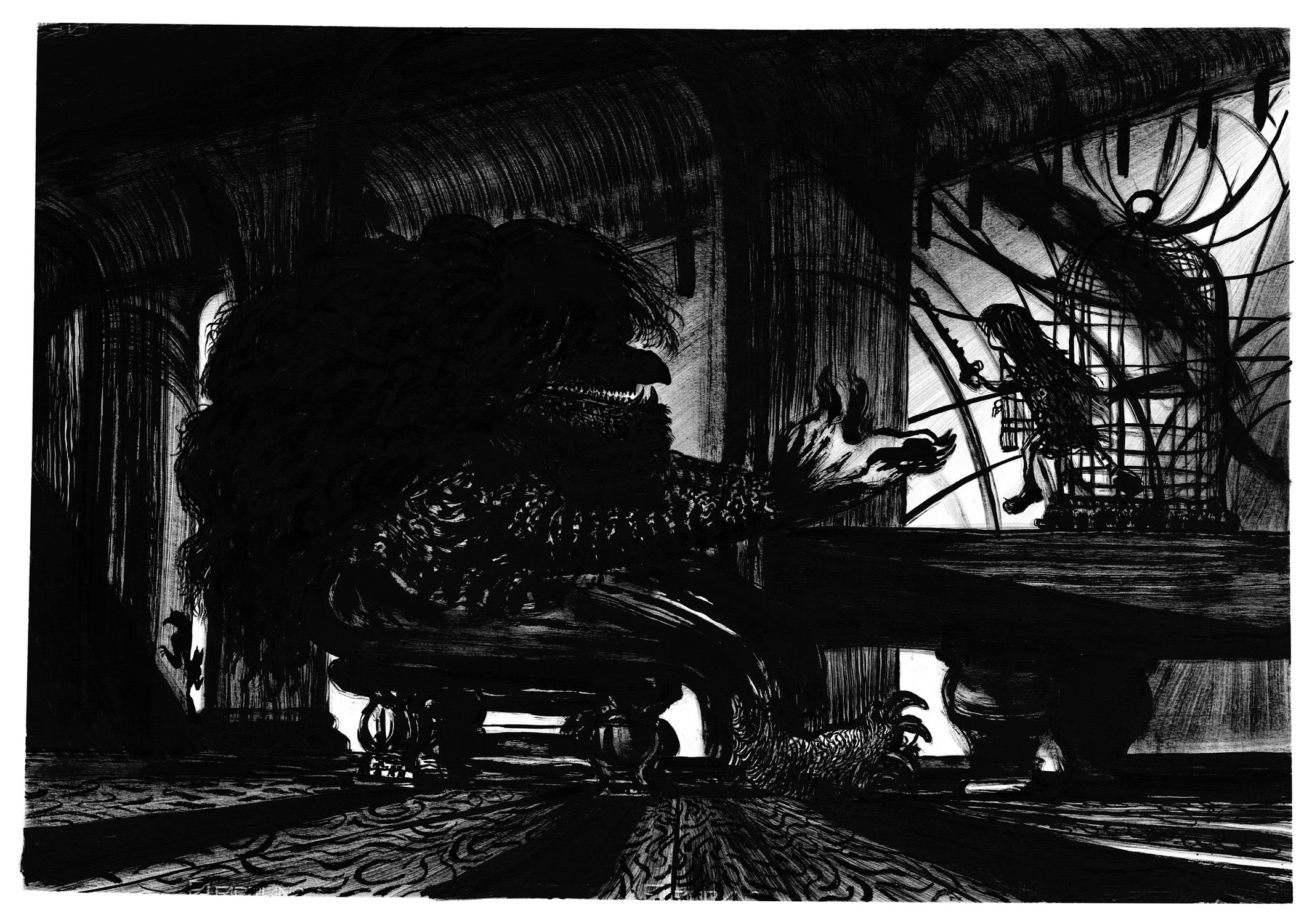



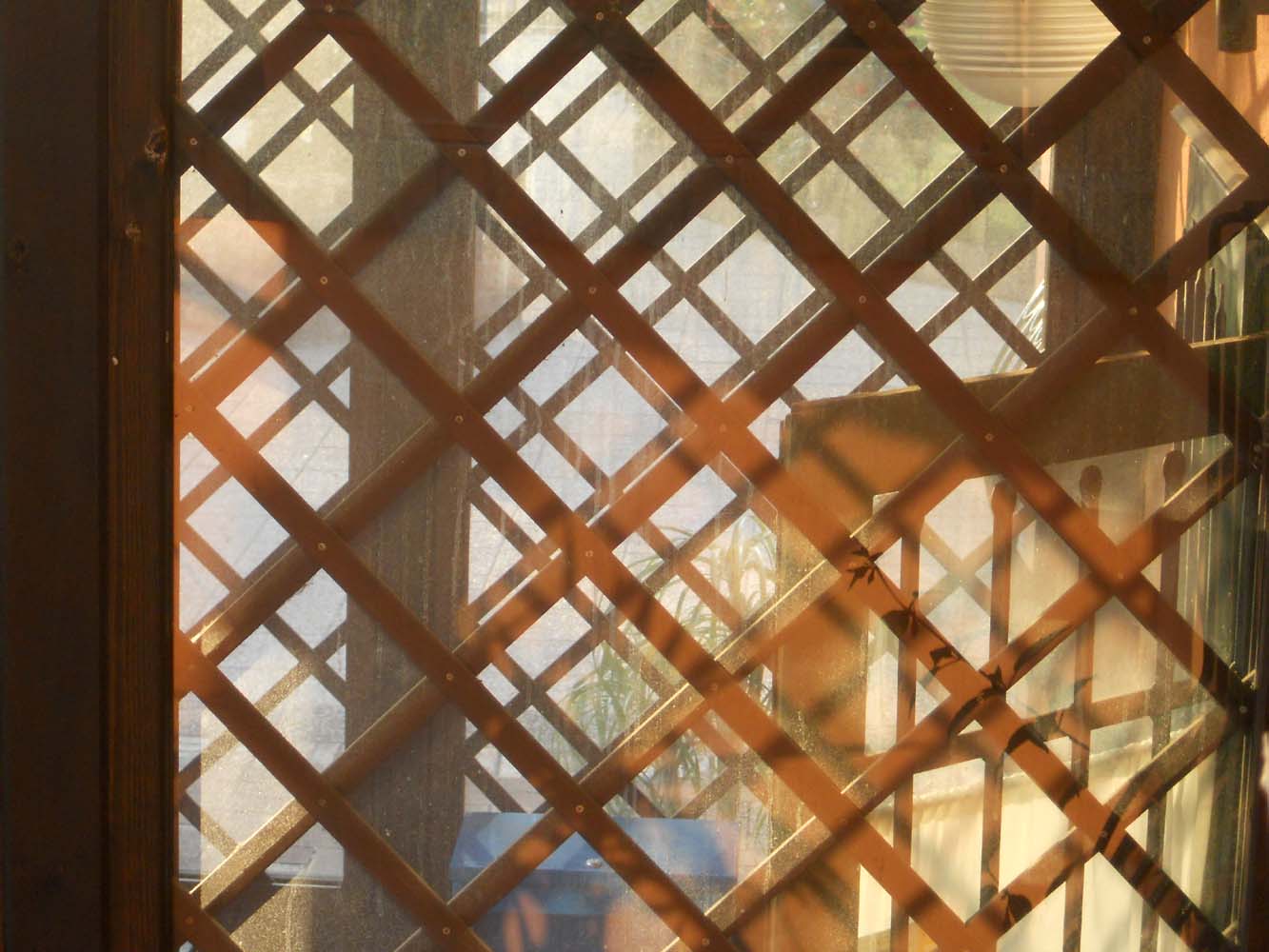




Commenti recenti