La guardiana
Torno alla casa che abbiamo ereditato
è grande e disposta su tre piani,
ma ne occorre un altro. Decido di scavare
in basso piuttosto che elevare al cielo.
Sappiamo tutti che quando possediamo un suolo
– ne abbiamo proprietà –
ci appartiene tutto ciò che è sottostante e ciò
che sta di sopra a dismisura fino alle galassie più
lontane
fino al centro della terra
– così dice l’ordinamento.
Ai piani alti di questa grande casa
vorrei solo aprire le finestre
a far entrare un po’ di luce
che penetri il mio petto svuotato a dovere
che giri un poco d’aria e di correnti
di sangue anche, se si preferisce.
Che il sangue torni a circolare e a distinguersi
tra quello rosso vivo e quello blu
di scorie.
.
Parlando con Raymond Carver
Quando faccio pulizie
mi capita di colloquiare con qualcuno.
Oggi tocca a te Ray e non è la prima volta.
Vorrei seguirti anche in questo
tu che parli con Joyce
tu che parli con Baudelaire
tu che parli di Shelley
sulle loro tombe, sempre.
Io sto solo aspettando che si asciughi il pavimento.
So che sembrerà retorico
assolutamente banale
dire che tra noi c’è un oceano
e io vorrei attraversarlo.
La tua immagine sul cofanetto dei Meridiani
mi fissa, ha un’aria simpatica, non sembra
di un ex alcolista. Comprendo il problema.
Vorrei parlarti di spazio
oltre quello oceanico che ci divide
oltre quello che c’è tra whisky e vino
oltre quello che c’è tra le mani che aggiungono all’argilla
e il marmo da scalpello
oltre quello che c’è tra chi ci lascia parole e chi no
ovviamente, spazio.
Un mio amico che si dice piccolo poeta mi ha insegnato:
lo spazio non è sempre uguale a se stesso
dieci centimetri fra due macchine
non sono dieci centimetri in un letto coniugale.
Penso abbia ragione. La coscienza cade sulle cose
che guardiamo diventare assenti
le scalpelliamo per porgerle, che qualcuno legga.
Ciò che non ha significato profondo
l’esistenza non ha alternative, in fondo non è necessaria
non trova radici se non nella combinatoria interna
divisa.
Patrizia Dughero, da Le stanze del sale, Le voci della luna, 2010
___________________________________________________
.
BROCKWELL PARK
Da quando vivo sola ho imparato
che l’autunno è migliore dell’estate
al suo versarsi sulla terra piega
il chiaro delle voci nell’interno.
Il bambino nella finestra accanto
guarda le gazze prendere il volo
pensa forte una coperta d’alberi
di rami dispiegati sopra i tetti.
Gli scoiattoli in cerca di biscotti.
Ho messo nel lettore Figure Eight
perché spesso mi tornano i suicidi
con amara ed ironica pietà.
Solo i morti conosciamo davvero
il resto è imitazione dell’amato
nel buio non capire o trattenere.
I quaderni, le penne, le monete
nella borsa di Mary Poppins verde –
sono uscita senza aver lavorato
ma ho bisogno presto di un lavoro
della notte restituita al sonno
con il gemere delle tubature
l’urlo dei cani spento sopra i muri.
L’acqua nel parco si ammassa di foglie
un’isola nell’isola incostante –
le anatre cercano pozze scure
di pesci, riemergono nello strato
impietrito, lontano delle frasche.
Mi chiedo dei sopravvissuti, quanti
dai nidi – se sanno, se ricordano.
Un’altra acqua restituisce lenta
pezzi anonimi di senso, quest’osso
mutilato nel fango, non più bianco
l’inchiostro evaporato delle carte
un ordine di buste e di bottiglie.
Siamo l’archeologia di plastica
l’involucro deforme ci resiste.
Non scriverle le poesie, tienile
per camminare svelta nella pioggia
o nella luce quieta di novembre –
L’aria sulle vetrate rannicchiata
una seconda pelle che declina.
Spingendo nelle lame le parole
unirmi il sangue al sangue di altri uguale.
Non scrivere, non sperare, non dire.
C’è una gioia nella mia tristezza
e un’ombra disarmante nell’amore
mi cresce dentro il nudo dei tramonti.
Ho nostalgia del ferire inquieto
mi mancano le vite sconosciute.
Io – non riesco ad appartenere
eppure ogni gesto m’appartiene.
Esistono le cose tutt’attorno
fatti più trasparenti le vediamo –
mentendo la propria solitudine
si riconosce meglio dove amare.
Addomesticare poi significa
creare dei legami. Ogni giorno
un po’ più vicina, tenermi stretta
l’erba ruvida di spago, scorrere
i grani sporgenti, i nodi. La volpe
si può vedere a volte nella sera
sgusciare in una fiamma dai cancelli.
.
L’AIRONE CINERINO
(vita segreta dei giardini)
Hyde Park, fine d’ottobre –
la pioggia circonda le persone
un margine curvo, propagato
dal bagliore dei cigni sulla Serpentina.
Le folaghe e le oche si spingono
su molliche di pane galleggianti.
Un corvo intruglia la carcassa sfatta
di un piccione, il ricamo scarlatto
aggrovigliato al becco. Se ne stacca
distratto al mio passaggio.
Un cestino di ferri, lana, spilli –
le matasse disgiunte all’apertura.
Sotto il ponte iniziano i giardini.
La vegetazione lacustre scava
nell’argine recinti naturali
d’alberi, terriccio, cespugli, giunchi.
Lo scoiattolo percorre i tronchi,
scorteccia frenetico al midollo,
la gazza si affaccia dalla ringhiera.
Sul fondo l’airone grigio osserva –
il salice cascante lo nasconde.
Le pupille laterali, inespressive
come insetti dentro biglie d’ambra,
gli arti lunghi, cauti sopra l’erba
la giuntura flessibile del collo.
Il rostro impercettibile si affila –
un bisturi dell’aria sulle rane.
Dall’entrata la notte procede
oltre il flauto di bronzo del bambino.
“Non è lui – mi ripeto – non può essere”.
Dove il ghigno d’elfo, la tristezza?
L’ombra, gli sterpi di taglio nel corpo?
Sul cerchio dei lampioni, la foschia
viola come un tessuto muscolare.
L’odore d’acqua penetra i vestiti
dalle foglie stampate nelle suole.
(Hyde Park/Kensington Gardens, 28 ottobre 2007)
Francesca Matteoni, da Appunti dal parco, Nizartd 2008
_______________________________________________________________
.
Mi accorgo che, recentemente, mi capita più spesso di apprezzare poesie scritte da donne piuttosto che da uomini. Niente di ideologico in questo, anzi niente di deliberato. Dico “mi accorgo che” proprio perché questo fatto, di carattere statistico/personale, mi colpisce, e mi porta a domandarmi se si tratti di un caso, o se qualche ragione di fondo ci sia, magari persino più stabile di una semplice momentanea maggiore rispondenza o affinità.
Ho un po’ frequentato questa primavera due diversi cicli di presentazioni di volumi di poesie, presso due diverse librerie di Bologna, Feltrinelli e Mel Books. L’occasione di questo post mi è stata fornita proprio da due di questi incontri, uno in cui intervenivano le due poetesse di cui avete appena letto i testi, l’altro in cui si presentava l’Annuario della Poesia 2011, da parte dei suoi due curatori, Paolo Febbraro e Matteo Marchesini.
È stato in questo secondo incontro che si è sollevato il tema della cosiddetta “poesia civile”. Febbraro e Marchesini affrontano la questione ponendo una semplice domanda: come si riconosce la poesia civile? La risposta sarà: be’, la si riconosce per il fatto che tratta temi civili. E dunque il problema è quali siano i temi civili, e come si decida se un tema sia civile o meno. Già: come si decide? La domanda sembra banale perché di solito lo abbiamo già deciso, e sappiamo tutti quali temi siano civili e quali no. Nei dibattiti il “civile” viene contrapposto tipicamente al personale e al “lirico”, un po’ come il pubblico (o il politico) al privato; e lo scrivere poesia civile starebbe allo scrivere poesia su temi personali come il fare attività politica o volontariato sociale starebbe al farsi i cazzi propri, magari pure sentitamente e sinceramente.
Ma la natura della poesia è differente da quella del fare attività politica o volontariato sociale. Pensare che la poesia possa migliorare il mondo secondo strategie analoghe a quelle dell’impegno vuol dire averla già ridotta a elemento funzionale all’interno di un dialogo (quello del “civile” e del personale), e che ha di conseguenza tanto più valore quanto più conta all’interno di quel dialogo. E siccome quel dialogo trova definizione precisa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, lo stesso valore della poesia si troverebbe definito con la massima precisione all’interno di quel dialogo gestito dai media. La stessa definizione di che cosa sia “civile” si trova costruita in quel dialogo.
Questo discorso ascoltato (e qui riportato a memoria, con anche una certa probabile dose di interpretazione mia) mi ha chiarito di colpo le ragioni della mia diffidenza nei confronti dell’enfasi sulla poesia civile: il punto è che questa enfasi trova senso soltanto all’interno di una concezione già finalizzata della poesia e, tanto peggio, già finalizzata all’interno di una concezione del “civile” costruita e valorizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il consenso generale, e in fin dei conti, una certa banalità. Non che si debbano rifiutare i poeti civili, per questo. Pasolini e Fortini sono tra i poeti che ho letto e riletto con maggiore passione; e non posso negare che in parte questa passione sia dovuta a un riconoscermi nei loro valori. Tuttavia, potrei elencare molti altri poeti che ho letto con passione simile, e che farebbero fatica a rientrare nell’ambito di quello che chiamiamo “civile”. Anche leggendo questi poeti, indubbiamente, una parte della passione era dovuta a un riconoscermi nei loro valori, e questi, pur non essendo “civili”, ben difficilmente avrebbero potuto essere definiti “in-civili” o “a-civili”.
Aggiungo un’altra osservazione: sui temi civili si discute, e la discussione fa parte del loro senso e del loro valore. La poesia, in quanto tale, non è fatta per essere discussa, e non ha maggior valore come poesia se apre un maggiore dibattito. Alla critica spetta piuttosto questo ruolo; e solo in un contesto culturale in cui la critica ha più valore dei testi di cui parla, si può pensare che la poesia (o persino il romanzo) abbia più valore se contribuisce al dibattito.
Io credo piuttosto che la poesia agisca a monte dei dibattiti, contribuendo al formarsi di un senso profondo e comune, una sorta di stimmung, cioè di accordatura collettiva, che costituisce la base stessa su cui i dibattiti possono poi crescere. Una poesia mi piace o non mi piace, mi ci ritrovo e mi ci posso mettere in sintonia, oppure non mi piace e non trovo sintonia. Se ne discuto i temi, se non sono “d’accordo”, non la sto più trattando come poesia, ma come un semplice discorso, una proposta nel dibattito; il che naturalmente non è vietato, perché un testo poetico contiene magari anche quello; però se riduco la poesia a quello sto trattando lo specifico poetico come una semplice confezione, una luccicante cartina per trasmettere meglio il cioccolatino della verità contenuto al suo interno. E la poesia non è questo.
La poesia è piuttosto un tramite nei confronti di istanze profonde, quelle che fanno fatica o proprio non possono essere veicolate dal discorso normale, per quanto raffinato e acuto questo possa essere. La poesia ha a che fare con l’inconscio, gli dei, il mito, la natura, il desiderio, il dolore (cose grandi ma anche cose piccolissime), e tutto quello che ci prende come un groppo e le parole non bastano, e ha bisogno di trovare un altro modo per uscire. In questo senso non è in sé né personale né civile, eppure, quando funziona, quando ci colpisce, ci colpisce tanto nel personale quanto nel civile.
Forse è per questo, quindi, che mi trovo a leggere più volentieri poesie scritte da donne, e mi trovo a leggere più volentieri proprio quella scrittura femminile che viene tipicamente accusata di essere troppo lontana dal sociale, troppo poco “civile”. Rileggete i testi che ho allegato: a dispetto della superficie, a dispetto dell’”io” dichiarato nella lettera del testo, non sono poesie dove si parla di sé. Le trovo riuscite perché (in diversa maniera nelle due autrici) non mi danno l’impressione di parlare di loro stesse, delle autrici, bensì di qualcosa che si trova in loro così come si trova in me, e forse in tutti, o almeno in tanti.
In più, questa sentita consapevolezza condivisa si trova qui associata a esperienze quotidiane nelle quali ugualmente mi posso riconoscere, e di conseguenza un domani magari anche personalmente (senza più l’aiuto di questi testi) rivederle, riconoscerle, come vie d’accesso all’indicibile, a quel fondo inevitabilmente oscuro che condividiamo tutti, e che a tutti noi dà forma.
Tutta la buona poesia, io credo, è implicitamente poesia civile, perché ci fa sentire parte di un sentire comune e condiviso. Il suo ruolo si trova a monte dei dibattiti e di qualsiasi propaganda, anche quella di cui condividiamo i temi. La poesia non è pubblicità del bene; può essere grande poesia anche senza propagandare alcun bene, senza condannare alcun male. Il bene, semmai, lo fa; anche senza dirlo.
P.S. Avevo già in parte scritto queste righe quando Francesca Matteoni, su Nazione Indiana, ha pubblicato alcune poesie di Patrizia Dughero, tra le quali una di quelle scelte anche da me. La coincidenza non è casuale. È che gli incontri pubblici servono. Grazie quindi a coloro che li organizzano, nella fattispecie Guido Monti da un lato e Sergio Rotino dall’altro.
8 Giugno 2011 | Tags: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, narratività, poesia, racconto, semiotica | Category: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, poesia, semiotica | Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti.
Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso.
Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa.
Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire.
Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente.
Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo.
Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale.
Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio.
Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti.
Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi.
Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta.
Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi.
In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa.
Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale.
Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso.
Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale).
Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele.
Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock.
Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.
 Umberto Piersanti, L'attesa, da I luoghi persi Non sta davvero il carattere “bucolico” al centro della fascinazione che ha per me questa poesia di Umberto Piersanti, al pari di molte sue altre. Certamente anche i temi della natura, del ricordo, della quotidianità e del sesso hanno il loro peso; tuttavia, nella mia percezione, ritenere Piersanti, sulla base di questi temi, un poeta crepuscolare e intimista, e dunque sostanzialmente tradizionale, è davvero un errore. Piuttosto che a Pascoli e a Pasolini, a me viene da accostare questi versi a quelli di Amelia Rosselli che ho commentato qualche settimana fa.
Naturalmente questa affermazione chiede di essere giustificata, perché tutt’altro che evidente. A prima vista, semmai, i due testi appaiono davvero diversissimi, quanto ai temi, alla costruzione complessiva e all’architettura metrica e ritmica. Non si tratta comunque di individuare una dipendenza, un influsso, che magari ci sono e magari no; ma semmai una convergenza, una vicinanza di fondo tra questi due testi così apparentemente divergenti.
Se si leggono ad alta voce tutti e due i testi, ci si accorge meglio dell’intensità dell’ossessione ritmica su cui sono entrambi giocati. Nel caso della Rosselli c’è un’affabulazione dall’apparenza antimetrica (in cui sono cruciali i tagli arbitrari del verso) su cui si innesta un’insistita ripetizione di suoni, di intere parole, di formule sintattiche e di esplicite citazioni. Nel caso di Piersanti c’è un endecasillabo iperrealistico, tagliato in maniera da enfatizzare la coincidenza tra i versi e le singole clausole sintattico-narrative, a cui la quasi totale assenza di segni di interpunzione delega tutta l’articolazione prosodica del discorso. L’ossessione iterativa lessicale della Rosselli corrisponde all’ossessione iterativa ritmico-prosodica di Piersanti, e in tutti e due i casi quello di cui si parla finisce in secondo piano rispetto alla dominanza di un ritmo della parola che rimanda al ritmo con cui i singoli momenti del discorso arrivano a consapevolezza.
È questo ritmo, nella Rosselli come in Piersanti, che ci prende, che ci trascina, che ci affascina. Solo in quanto siamo trascinati in questo meccanismo regolato e omogeneo di emergenze al livello del senso, solo in quanto ci ritroviamo, leggendo, a vivere direttamente questo andamento dell’azione (un’azione ricostruttiva ed evocatrice); solo in quanto, in questo modo, ci sentiamo vivere insieme con il soggetto lirico la sua stessa esperienza, solo allora l’esperienza specifica si trova qualificata, ed emergono le differenze, e il delirio drammatico e sentimentale della Rosselli, e il sospiro bucolico di Piersanti. Tuttavia, a questo punto, il gioco è già fatto; ci siamo già dentro, e tanto la Rosselli come Piersanti potrebbero raccontarci (quasi) qualsiasi cosa.
L’esperienza ritmica, che coinvolge la dimensione del suono quanto quella del senso, è un’esperienza che viene vissuta dal lettore; mentre ciò di cui il testo parla (discorso o racconto che sia) è comunque un resoconto, qualcosa che ci arriva tramite il linguaggio, attraverso la sua mediazione. L’esperienza ritmica non è mediata dal linguaggio; piuttosto, essa è direttamente prodotta dalla lettura della sequenza verbale. Per questo si trova enfatizzata e più facilmente riconoscibile attraverso una lettura ad alta voce; ma il lettore esperto riesce a ricostruirla anche solo interiormente.
Se lo leggiamo in questi termini, il testo di Piersanti perde grandissima parte del tono crepuscolare e bucolico che gli attribuisce chi ne privilegia il senso letterale delle parole e delle frasi che lo compongono. La campagna, la quotidianità, il sesso ci sono, certamente; sono ciò di cui si parla, sono l’occasione del discorso – e sono comunque diretti, non oggetto di parodia, né di recupero post- o neo-qualcosa. Ma quello che rende Piersanti un mio contemporaneo, cioè un poeta che leggo e in cui posso riconoscermi, è l’inevitabile distanza mediata dal principio ossessivo, che scardina il discorso tradizionale, quello tipicamente atteso di fronte a questi temi.
Potremmo dire, esagerando un po’, che l’endecasillabo agisce in questo testo di Piersanti come le parole (citate e più volte ripetute) di Campana agiscono nel testo della Rosselli. È il quadro, il contesto attraverso cui ci appare ancora possibile accedere all’esperienza, specie quella emotivamente profonda, nel momento stesso in cui quell’esperienza si trova inevitabilmente e dolorosamente al di fuori di noi, in verità inattingibile. La possiamo, in letteratura, soltanto evocare, nominare, mentre le nostre parole producono, attraverso i propri ritmi, nuove e differenti esperienze in chi ci legge.
La poesia, e la letteratura in generale, finge sempre di portarci nel luogo di cui parla; mentre in realtà ci sta violentemente trascinando altrove – almeno quando ci riesce, quando funziona.
 Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).
I versi di Campana sono quelli che iniziano così:
Non so se tra rocce il tuo pallido
Viso m’apparve, o sorriso
Di lontananze ignote
Fosti, la china eburnea
Fronte fulgente o giovine
Suora de la Gioconda:
O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O Regina o Regina adolescente…
Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.
Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.
Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.
L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.
Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.
La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.
Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.
Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.
A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.
Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.
La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?
Ho concluso un post precedente (19 gennaio: Della poesia, della prosa, della critica e del Web) dicendo che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Non ero arrivato a questa conclusione spinto dall’entusiasmo per le potenzialità del Web rispetto alla poesia, ma da alcune considerazioni piuttosto amare (e condivise con altri) sulla marginalità editoriale della poesia, e sulla sua irrilevanza di fatto rispetto al mercato. Come dire sì “evviva il Web per la poesia”, ma non perché le favorisca una nuova giovinezza, bensì perché le permette di sopravvivere, di tirare avanti, di far sì che l’esiguità dei confini sociali del suo orto non la uccida del tutto.
Quasi nessun editore di poesia oggi fa davvero l’editore. Tolto Einaudi e poco altro, e tolte le stampe o ristampe di autori ritenuti affermati e quindi sicuri, il ruolo di investimento economico (ovvero pagare le spese) tocca di solito all’autore – mentre quello che si autodefinisce editore non fa che organizzare la stampa e la distribuzione, senza rischio economico. Di conseguenza i poeti che non vogliono o non possono pagare non pubblicano – oppure si rifugiano sul Web, nelle varie forme, più spontanee o più organizzate, che il Web permette; tutte comunque a costo vicino allo zero.
Se il costo economico è vicino allo zero, lo stesso non si può dire del costo culturale, che non è enorme, ma è comunque consistente, e rischia di trasformare ulteriormente la poesia e il sentire che le sta attorno.
Credo che alla base del meccanismo di approvazione poetica stia un bisogno di distanza personale: in altre parole, per il campo della poesia vale moltissimo l’antico adagio nemo profeta in patria. Solo quando qualcuno è già stato riconosciuto profeta (poeta) altrove può tornare in patria con qualche speranza di essere apprezzato anche lì (ma voi potrete mai credere davvero che il figlio del falegname dietro l’angolo, che conoscete sin da quando rompeva le scatole calciando il pallone contro la vostra porta, e che avete visto fare le normali cazzate che tutti fanno, potrete mai credere davvero che sia quello che si dice in giro che sia? Ma andiamo!).
I meccanismi del Web e dei social network tendono a ridurre il mondo a paese. Quando non so chi sia qualcuno, faccio una piccola ricerca su google. Spesso trovo con facilità anche l’indirizzo email. Se poi le poesie appaiono su un blog, posso persino commentarle affinché prima di tutto lui (lei) legga il commento. Se poi pubblico anch’io poesie su un blog, mi aspetterò che lui (lei) ricambi la gentilezza: ho apprezzato le tue poesie; mi aspetto quindi che tu apprezzi le mie.
Non è un meccanismo nuovo. Gli ambienti culturali funzionano così da sempre, attraverso commenti e recensioni sui giornali. Ma nel Web il meccanismo assume una dimensione capillare e microscopica, e il successo di un poeta può ben dipendere dalla quantità dei rapporti personali che ha, e dalla quantità di apprezzamenti che è capace di distribuire.
Non che la qualità di quello che scrive non conti. Ma, assodato che il poeta abbia un minimo di sensibilità poetica, sulla base di questo meccanismo sarà ben difficile discriminare tra chi ne ha davvero soltanto un minimo e chi ne ha ben di più. La poesia funziona bene quando può davvero giocare sul proprio alone mitico; e uno dei compiti dell’editoria tradizionale consisterebbe anche nel costruirlo. Se un editore (vero) pubblica il libro di un autore, è perché ha evidentemente deciso che vale. La poesia pubblicata va perciò incontro al mondo già armata di questo riconoscimento – che, naturalmente, sarà tanto maggiore quanto maggiore prestigio avrà l’editore. Poi, il meccanismo delle recensioni e delle varie modalità della critica serve anche a rafforzarne l’aura.
Il problema del Web non è tanto che leggere una poesia su un monitor è meno coinvolgente che leggerla su una pagina (è un po’ vero, ma è anche – credo – questione di abitudine); è semmai che la stessa natura democratica del Web rende difficile la costruzione dell’aura. Se il poeta si autopropone, la sua aura indotta è prossima allo zero, e potrà contare solo sulla propria capacità di pubbliche relazioni; se il poeta viene proposto da qualcun altro, l’aura dipenderà dal prestigio di chi lo propone; ma l’universo della poesia è conservatore, e tipicamente questo prestigio sarà stato costruito attraverso i media tradizionali, e non sul Web. In ogni caso, il Web ha una storia troppo breve perché il prestigio di un editore di poesia (qui editore in senso lato, evidentemente) possa essere grande.
Non sono certo di quello che dico, e mi piacerebbe sentire altre opinioni in proposito. Mi baso anche sulla mia stessa esperienza di lettore di poesia. Posso dire che non mi piace giudicare le poesie che leggo; o che non leggo poesie allo scopo di giudicarle. Leggo piuttosto per vivere un’esperienza coinvolgente. Ma la poesia è un medium difficile, che non sempre rivela la propria qualità a prima vista, e che può talvolta richiedere numerose (e magari faticose) letture per permettermi di accedere a esperienze anche di valore. Tuttavia, io a priori non lo so se quello che sto leggendo vale la pena dello sforzo che mi richiede.
Se ho davanti a me un campo sterminato di auto-proposte, sono costretto a giudicare, e sono costretto a scartare rapidamente tutte quelle che non mi appaiono subito degne di interesse – a costo, inevitabile, di errori madornali. Non è umanamente possibile approfondire tutto. L’aura (comunque acquisita) serve anche a questo: se una poesia ce l’ha, sarò disposto a dedicarle più attenzione, a non fermarmi alla prima difficoltà, alla prima incomprensione. Questo non vuol dire che apprezzerò comunque quello che leggo. Io sono comunque condannato a giudicare. Tuttavia, avrò almeno giudicato dopo aver fatto un certo lavoro interpretativo, dopo aver dato al testo che ho sotto gli occhi svariate chances interpretative.
La parità di diritti, paradossalmente, è nemica della poesia. Il mio sogno di lettore è quella di incontrare sempre testi di grande interesse; di non dover mai distogliere gli occhi (o le orecchie) annoiato. Sul Web questo sogno è diventato ancora più lontano di quanto non fosse con la carta.
Poi, io leggo e giudico un sacco di roba, è inevitabile. E se non facessi così non scoprirei mai niente di nuovo. Ma sono grato all’editoria e alla critica che mi risparmiano una parte del lavoro e mi indirizzano: se tutto fosse davvero uguale, e tutte le proposte avessero lo stesso peso, anche la mia volontà esplorativa sarebbe frustrata dall’enormità del compito. E magari non leggerei nemmeno più.
A questo punto, non posso che ripetere con maggior forza che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Il valore di luoghi di riflessione e presentazione come Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, °punto critico, Poesia 2.0, AbsoluteVille, con tutti i loro difetti, è enorme; è l’unica cosa che può salvare la poesia sul Web. Dovrebbero forse occuparsi di più di quello che sul Web già c’è – ma certo non è facile, e le logiche del favore reciproco non sempre lo rendono possibile.
Talvolta, purtroppo e inevitabilmente, questi siti finiscono invece per costituire l’arena di spettacoli abbastanza deprimenti, dove il dibattito culturale degenera in ridicolo litigio. Per esempio, qui è possibile trovare la traccia di una discussione altamente edificante. Magari discussioni del genere ci sono sempre state, tra poeti; ma quando il privato era separato dal pubblico, la voce pubblica del poeta era sostanzialmente quella dei suoi testi. Che cosa resta dell’aura, qui?
Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.
Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:
Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.
Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).
Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.
Radio-lied. Il racconto trasmutato
.
.
Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004).
Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone.
La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”.
[1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo.
Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica.
Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia:
Compagnia
| 1 |
Verso l’ora di cena, |
| 2 |
mentre tutti si davano da fare |
| 3 |
in soggiorno, in cucina, |
| 4 |
invece di dare una mano |
| 5 |
sono uscito sul terrazzino, |
| 6 |
all’aria fresca, |
| 7 |
con tutta la vista intorno. |
|
. |
| 8 |
Là dietro li sentivo ancora bene |
| 9 |
chiamarsi, ridere; |
| 10 |
di colpo, però, mi mancavano. |
| 11 |
Erano più lontani dei palazzi |
| 12 |
dall’altra parte del campo |
| 13 |
– sei, sette in fila – |
| 14 |
con tutte le luci accese. |
|
. |
| 15 |
Eppure proprio ora |
| 16 |
che non li avevo più di fronte |
| 17 |
mi venivano incontro. Nei segnali |
| 18 |
lungo la ferrovia, nell’erba gialla, |
| 19 |
nel muro cieco, li riconoscevo. |
|
. |
| 20 |
Sentivo, ora, che loro – alle mie spalle – |
| 21 |
erano fatti della pasta del mondo, |
| 22 |
solida, chiara. E io, di niente. |
|
. |
| 23 |
Niente: la slogatura |
| 24 |
tra una stanza affollata e l’orizzonte. |
.
.
1. La poesia di Umberto Fiori
.
Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3.
Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale.
Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi.
Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo…..
L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura.
Subconciencia
Has hablado, has hablado y me he dormido,
Pero duermo y no duermo, porque siento
Que estoy bajo el supremo pensamiento:
Vivo, viviré siempre y he vivido.
Has hablado, has hablado y he caído
En un marasmo… cede hasta el aliento.
Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:
Estoy ciega. No tengo sentimiento.
Como el espacio soy, como el vacío,
Es una sombra todo el cuerpo mío
Y puedo como el humo levantarme:
Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…
Sujétame a la tierra con tus manos,
Que si el viento te mueve ha de llevarme.
.
Subconscio
Parli, parli, e mi sono addormentata
ma se dormo non dormo, subisco
l’influsso di un pensiero supremo:
vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.
Parli, parli, e sono caduta
nel marasma in cui cede anche il respiro.
Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.
Sono cieca. Non provo sentimento.
Sono come lo spazio, come il vuoto,
è solo un’ombra tutto il corpo mio
e posso sollevarmi come fumo.
Ascolto soffi eterei, sovrumani.
Con le tue mani legami alla terra
perché il vento non mi porti via.
.
Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.
La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.
E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.
Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!
Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.
E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.
La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!
L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.
Ho concluso il post precedente sulla poesia con un interrogativo, domandandomi come si concili un’affermazione come quella del Faust di Goethe (“In principio era l’atto”) con il dominio della lirica nel mondo della poesia, che negli anni del Faust era già un fatto, e in seguito lo sarebbe stato ancora di più. In altre parole, come si concilia un’istanza anti-soggettiva come quella espressa dalle parole di Faust (a cui farà seguito Nietzsche e l’invenzione freudiana dell’inconscio, e le prospettive a-soggettive delle scienze sociali) con l’istanza profondamente soggettiva che sta alla base della lirica?
Naturalmente non c’è bisogno che si concilino, perché in ogni epoca non esiste un solo spirito del tempo, ma ben più di uno – per cui istanze profondamente soggettive e istanze profondamente anti-soggettive possono condividere la stessa epoca e gli stessi luoghi. Però credo che la questione possa essere affrontata in maniera meno banale di questa, e che il rapporto tra l’anti-soggettività e l’iper-soggettività moderne sia più stretto di una semplice coabitazione.
Di lirica ho già parlato in questo blog in più occasioni. Ma mi ha risensibilizzato particolarmente al problema la lettura di due testi interessanti di Guido Mazzoni. Il primo l’ho trovato in rete, nel blog di Punto Critico, ed è un’intervista di Italo Testa al medesimo Mazzoni. Il secondo, letto in seguito all’incontro più o meno fortuito con quell’intervista, è il libro di Mazzoni che ha per titolo Sulla poesia moderna (ed. Il Mulino, 2005).
Riassumerò le tesi di Mazzoni (che trovo di grande interesse) con due citazioni. La prima, tratta dall’intervista su Punto Critico, è questa:
Ora: non tutta la poesia moderna coincide con la lirica, ma è indubitabile che la lirica sia il centro della poesia moderna. Allo stesso modo, è indubitabile che la perdita di mandato sociale dello scrittore, che segna la storia della scrittura in versi da un secolo e mezzo almeno, valga a maggior ragione per il sottogenere lirico, perché quest’ultimo esprime in forma pura quell’individualismo, quell’egocentrismo, quell’«inesplicato bisogno di individualità», come dice Mallarmé, che è il fondo etico della forma di vita emersa negli ultimi secoli. In particolare, la lirica esprime bene la variante del soggettivismo che Charles Taylor chiama «espressivismo», cioè l’ideale etico per cui il senso della vita starebbe nella capacità – in qualche modo nell’obbligo – di essere all’altezza della propria originalità, di esprimere la propria differenza soggettiva. A partire dall’epoca romantica, l’espressivismo diventa un ethos sempre più condiviso dagli intellettuali; a partire dagli anni Sessanta, si diffonde fra le masse in Occidente. La poesia moderna è l’arte d’élite che più direttamente si lega a un simile bisogno, e la lirica è il centro del sistema.
La seconda invece proviene dal volume, a pag. 212:
L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.
C’è molto più di questo sia nell’intervista che nel volume (davvero molto interessante) di Mazzoni; ma credo che queste due citazioni bastino per spiegare la posizione di Mazzoni sul rapporto tra dominio della lirica e affermazione del soggettivismo (anzi, dell’espressivismo). Mi sono ritrovato interamente nelle posizioni di Mazzoni (e ne consiglio caldamente la lettura), ma voglio aggiungere alcune altre considerazioni a queste, anche come risposta al problema da cui siamo partiti.
Una delle cose su cui Mazzoni insiste nel suo libro è il fatto che, benché l’istanza espressivista sia già chiara nelle teorizzazioni dei primi romantici, e anche in Leopardi, la poesia ha continuato per molto tempo a muoversi all’interno delle maglie della tradizione. La rottura delle regole metriche, che sancisce definitivamente il dominio del soggetto, avviene solo a fine Ottocento, e comunque in maniera progressiva e bisognosa di continui appoggi nella tradizione stessa: il verso libero di Dino Campana proviene da quello di Walt Whitman, e quello di Whitman a sua volta dalla Bibbia…
Se pure il dominio del soggettivismo (e di conseguenza della lirica) è chiaro nella teoria da molto tempo, come mai i medesimi poeti che lo dichiarano non riescono, se non nel giro di parecchi decenni, a realizzarlo appieno? La risposta facile è che, per un poeta romantico, già il suo livello di violazione della regola è sentito come sufficiente per esprimere la propria soggettività; e che solo quando quella sua violazione diventa, col passare del tempo, a sua volta regola, si sente il bisogno di fare un passo più in là. Questa risposta facile è vera, ma è insufficiente, perché postula che lo sviluppo del soggettivismo stia in una continua violazione della regola al momento data – e che di conseguenza la poesia (come qualsiasi altra arte) non possieda un nucleo storicamente più duro, dandosi solo rispetto alle aspettative del momento.
Io ritengo piuttosto che la poesia possa essere riconosciuta come tale solo quando chi la legge ne riconosce un qualche tipo di valore universale. La natura di questo valore si modifica col tempo; mentre il fatto che ci debba essere è sentito come costante. Il poeta romantico, se vuole sperare che il suo lavoro possa essere riconosciuto come poesia deve necessariamente adeguarlo alle aspettative del suo pubblico, rispetto a quello che il suo pubblico ritiene “valori universali”. Le sue innovazioni sono accettate nella misura in cui sono riconosciute come qualcosa che esprime meglio di prima quegli stessi valori universali. Per questo, si potrà arrivare anche alla distruzione della metrica tradizionale, quando quella metrica inizierà a essere sentita come un vincolo astratto, un ostacolo all’espressione dei valori universali anziché un indispensabile strumento.
È parte cruciale di questa dimensione di universalità percepita anche la natura rituale della testualità poetica, una natura che tradizionalmente è passata in larga misura attraverso le regole del metro, e il conseguente irrigidimento dei ritmi prosodici che ne deriva. Il poeta espressivista ha potuto a un certo punto lavorare contro il metro, ma lo ha potuto fare solo recuperando qualche altro tipo di ritualità (come il versetto biblico per Whitman). Universalità attribuibile e ritualità sono i due scogli con cui si è dovuto variamente misurare l’espressivismo: coloro, tra chi scrive poesia, che non hanno capito che questo è comunque un passaggio obbligato, vanno a riempire la grandissima schiera dei poeti della domenica. Sono le vittime della poetica dell’epressivismo, quelli che hanno creduto davvero che la poesia non sia altro che “esprimere se stessi”.
Ecco però che, a difesa di queste vittime, entra in gioco la preminenza faustiana del fare, o l’inconscio freudiano, o le strutture sociali studiate dall’antropologia. Se infatti proprio nel cuore del soggetto, nel suo fondo più profondo (e “più profondo che non pensi il giorno”, per dirla con lo Zarathustra di Nietzsche), sta un’istanza non soggettiva, naturale o culturale che sia, cioè l’inconscio, le strutture sociali, il DNA, l’azione, allora paradossalmente è proprio esprimendo se stesso che il soggetto può costruire una nuova universalità. Non è più l’universalità delle regole date dalla tradizione, ma quella “spontanea” del buon selvaggio nascosto dentro ciascuno di noi.
Se vediamo le cose in questo modo, abbiamo ancora più ragioni di quanto non ne abbia Mazzoni per riconoscere come lirica anche quello che cerca di spacciarsi oggi come suo superamento o negazione. Se al cuore del soggetto che si esprime liricamente sta un buco di soggettività (alla Nietzsche), allora la sua espressione non sarà né più né meno lirica di quella di chi cerca di “ridurre” quel soggetto (per usare le parole di Alfredo Giuliani nella prefazione ai Novissimi) o di abolirlo attraverso pratiche varie di scrittura automatica o semi-automatica (come il googlism). Non c’è in verità nessun cambio di paradigma in queste pratiche di scrittura, e Mazzoni ha del tutto ragione a denunciarne la soggettiva ricerca di una modalità di espressione diversa, e quindi comunque personale.
Resta il fatto che qualsiasi pratica di scrittura poetica deve confrontarsi con i requisiti di universalità percepita e ritualità. L’esistenza di una non-soggettività (culturale o naturale) nel cuore stesso del soggetto va incontro alla prima. Ma la seconda rimane comunque un banco di prova per la qualità poetica del testo. Si tratta di un banco di prova scivoloso e variabile, perché i riti variano con la collettività stessa. Però, se in principio era l’atto, e questa natura originaria dell’atto deve essere trasmessa dalla poesia, la poesia sarà riconosciuta come tale solo se agisce su di me, e lo fa facendomi sentire parte di un agire condiviso, collettivo. La lirica è la forma (molteplice) che questo agire ha preso negli ultimi secoli.
Egli sta scritto: “Nel principio era la parola.” (“Im Anfang war das Wort!”) Ecco io sono già impacciato! E chi m’ajuterà ad uscirne? No, io non posso stimare sì alto la parola, e se lo spirito degna illuminarmi mi bisogna tradurre diversamente. Sta scritto: “Nel principio era la mente (der Sinn).” Bada bene al primo verso ve’, che la tua penna non precipiti! può egli la mente tutto produrre e informare? Forse starà meglio così: “Nel principio era la possanza (die Kraft).” Ed ecco pur nell’atto ch’io scrivo questo, io mi sento da non so che avvertire che non devo contentarmene. Or sì il cielo mi aiuta da vero! Io prendo per una volta consiglio, e animosamente scrivo: “Nel principio era l’atto (die Tat).” (Johann Wolfgang von Goethe, Faust, traduzione di Giovita Scalvini, 1835 – da LiberLiber)
Mi sono sempre domandato se Goethe si rendesse conto dell’importanza della sua proposta filosofica, oppure se volesse soltanto mettere in scena un delirio interpretativo da parte di Faust, quando già Mefistofele si trova presso di lui sotto forma di un can barbone, e di lì a poco si manifesterà, e il patto sciagurato tra loro verrà sancito. Seguendo questa seconda ipotesi potremmo prendere le parole di Faust come semplice testimonianza dello stato confuso della sua mente, già votata all’eresia e poco dopo al patto col diavolo. Ma poiché Goethe questa cosa l’ha poi scritta davvero, e sta lì – e pure il suo Faust alla fine si salva (a differenza dei suoi predecessori nella tradizione) – possiamo legittimamente prenderla per buona, e guardarla più da vicino.
Certo, non possiamo prendere davvero le proposte di Faust come traduzioni alternative delle parole di S.Giovanni. Il logos può essere inteso certamente come la parola (il verbo della vulgata), e anche, di conseguenza, come il pensiero. La seconda proposta di Faust è ancora plausibile dunque: qui Sinn viene tradotto come mente, che è corretto, però ancora prima che mente Sinn significa senso, o significato. Pensare che all’inizio di tutto ci stia il senso, o la mente, è ancora coerente con il platonismo di fondo su cui si basa il pensiero cristiano, e la filosofia occidentale sino a Goethe (e ancora dopo di lui).
Ma la terza proposta di traduzione di Faust è già rischiosa: la possanza, o meglio (diremmo oggi) la forza (die Kraft), postula un materialismo agnostico, e pone all’inizio delle cose un puro principio naturale, in maniera del tutto slegata dalla trascendenza. È come dire che al principio di tutto sta l’energia, il Big Bang, il cieco scontrarsi delle forze. È la metafisica dello scientismo, decisamente alternativa a quella, idealistica, che mette al principio il logos (parola o pensiero che sia). In questa terza concezione, il principio non è solo un principio logico, ma anche un principio temporale, l’alba di tutte le forze.
Faust non è però contento, e vuole andare più in là. In principio, dunque, era l’atto, die Tat, cioè l’azione, il fare (tat è anche il passato di tun, cioè fare, e quindi feci, o facevo). Tutto sommato, mettere al principio di tutto la forza significa sovvertire la gerarchia tradizionale, dichiarando una priorità della natura e delle sue leggi sul pensiero; tuttavia i protagonisti tradizionali della riflessione filosofica occidentale (la natura e la nostra conoscenza) rimangono al loro posto, e muta solo il valore dato all’uno piuttosto che all’altro. Un’ontologia materialista, proprio come una spiritualista, vede il mondo in termini di natura e di pensiero che la conosce; solo che anche il pensiero viene pensato come riducibile alla natura – anziché viceversa, come era prima, quando si metteva al primo posto il pensiero assoluto di Dio.
Ma mettere a fondamento di tutto il fare, l’azione, l’atto, è una mossa assolutamente più radicale. Se l’azione si trova al principio, allora non la possiamo considerare come una conseguenza del pensiero, e la dialettica fondante mondo vs conoscenza (con le sue varie soluzioni – materialiste e spiritualiste) va semplicemente a farsi fottere. Se nel principio c’è l’azione, da essa dipendono sia la conoscenza che la natura – con il corollario che ogni tentativo di spiegarla compiutamente è destinato a fallire. Spiegare l’azione vorrebbe infatti dire ricondurla al pensiero o al mondo, ovvero a un sistema cognitivo o naturale. Ma se l’azione si trova al principio, è semmai essa a spiegare il pensiero e il mondo. L’azione in sé però non spiega: fa, e basta.
A meno che non sia, appunto, azione esplicativa. Tuttavia l’azione esplicativa rimane fondante solo finché è in atto, cioè finché resta azione; mentre il suo risultato, cioè la spiegazione (ovvero il pensiero) non è più azione. Mettere l’azione al primo posto, in altre parole, significa postulare un fondo inspiegato e inspiegabile dell’essere: il fallimento stesso, dunque, del pensiero occidentale – una buona ragione, in fin dei conti, per vendere l’anima al diavolo.
Magari Goethe voleva dire altro, o magari stava solo facendo delirare Faust. Sta di fatto però che, via Schopenhauer e Nietzsche, queste riflessioni arrivano trasversalmente sino al medico positivista Sigmund Freud, il quale, quasi senza rendersene conto – e continuando a pensare di agire nei termini di una metafisica della forza (die Kraft) – mette al centro del soggetto un’entità, l’inconscio, che alla fine dei conti non è riconducibile a nulla. Poiché Freud è ancora un materialista, ritiene di poterla spiegare in termini causali (in termini di forze, appunto).
Poiché non possiamo fare a meno di spiegare, presumibilmente la posizione di Freud resta quella corretta, in linea di principio. Postulare l’inconscio vuol dire far fuori infatti con un colpo solo le due prime traduzioni di Faust: in principio non può essere né la parola (Wort) né il senso (o la mente – Sinn), perché entrambe frutto della coscienza; e se esiste l’inconscio, la coscienza non può essere che un concetto emergente.
Eppure la posizione di Freud contiene in sé i germi della propria negazione. Se postuliamo infatti l’inconscio, stiamo dicendo che alla base del nostro agire non sta nessuna spiegazione, perché l’inconscio non spiega, e non contiene spiegazioni. La spiegazione materialista, dunque, potrà magari essere valida, ma non è sufficiente a fondare il nostro agire. L’azione viene dunque necessariamente prima della spiegazione, perché ci può essere sempre qualche sua componente che non può essere riportata a una qualche spiegazione. Postulare l’inconscio vuol dire pensare che in molti casi vengono prima le azioni dell’uomo, e solo poi le loro spiegazioni o motivazioni.
Questo ribalta il tradizionale meccanismo di causa-effetto, senza però sostituirgli nulla (non la causa finale, non il caso…). Che a ogni azione corrisponda una serie di cause si può certo postulare, ma solo in astratto – perché persino il soggetto che ha agito sarà a conoscenza di solo una parte di loro; e la soluzione riduzionista neurologica è in verità troppo complessa per essere veramente percorribile.
Ma, d’altro canto, se davvero assumiamo il primato dell’azione, la spiegazione acquisisce senso solo in prospettiva di un’azione futura. È tutto un gran casino, insomma. Da un lato, infatti, la visione del mondo in termini di natura e conoscenza ci è necessaria (e la filosofia occidentale ha tentato di costruirla al meglio per venticinque secoli); dall’altro, la priorità dell’azione ce la rende falsa, vacua, utile solo localmente.
Ma non è tutto merito di Freud. La scoperta dell’inconscio ci ha permesso di mettere in dubbio l’esistenza del soggetto medesimo (quello che S.Agostino e Cartesio prendevano come base certa, attraverso l’atto stesso del dubitare), ma Freud fatica ad abbandonare l’io, e continua a cercarne delle tracce in profondità. Più radicali in questo senso sono certamente Jung e Lacan.
Antropologia e sociologia hanno spesso assunto di fatto la presenza di una dimensione non di pensiero al cuore dei processi stessi del pensiero – una posizione che, per quanto riguarda il nostro discorso, è diversa da quella della psicoanalisi solo metodologicamente. Senza parlare di io e di Es, anche qui il soggetto si trova dissolto, e con lui il concetto stesso di parola, di senso, di spiegazione.
Ma la conclusione di Faust non può davvero dare origine a una disciplina cognitiva, scienza o filosofia che sia. Una disciplina del sapere non può accettare veramente una preminenza diversa da quella del sapere stesso. Per bene che vada, una disciplina cognitiva potrà giusto ammettere di ritrovarsi localmente confusa.
Goethe non era un filosofo, infatti, bensì un poeta. Se manteniamo centrale questa considerazione, potremo pensare che dichiarare la preminenza del fare sul conoscere significa lanciare un monito, un monito nei confronti di chi legge la poesia come se fosse filosofia, cioè (tentativo di) spiegazione, riflessione, pensiero, parola che definisce. Se la poesia manifesta la priorità, le preminenza del fare, essa riproduce in qualche modo la fattività del mondo, senza necessariamente descriverla.
In altre parole, non è che la poesia non possa descrivere o spiegare, ma, in tal caso, quello che conta è il fatto che essa sta descrivendo o spiegando, e non ciò che vi si trova descritto o spiegato. Se nel principio c’era l’azione, quello che conta è quello che la poesia fa, non quello che dice, o comunica: lo farà magari anche dicendo o comunicando qualcosa, ma quelli sono semplicemente modi del suo fare, non la sua essenza.
Goethe, attraverso Faust, potrebbe dunque stare allertandoci proprio sulla natura non cognitiva della poesia (e delle arti in genere). La poesia è essenzialmente un’azione (poiein), molto prima e molto di più di quanto non sia comunicazione. Per questo, per capirne la natura non abbiamo davvero bisogno di mettere in gioco le problematiche del soggetto (che è un’entità cruciale per la parola e per il senso – ma non per l’azione). Naturalmente, cercare di capire la natura della poesia è già un ricondurla al cognitivo – e quindi un inevitabile sviamento. Dovremmo limitarci a leggerla, e quindi a viverla! Ma noi abbiamo bisogno di spiegazioni, a costo di ingarbugliarci tra le contraddizioni.
La poesia, dunque, sarebbe tale proprio perché mette fuori gioco la trasmissione del sapere tra soggetto e soggetto. In questo senso non è solo performativa, o perlocutiva, perché nelle definizioni di performatività e perlocutività i soggetti vengono comunque messi in gioco. E tuttavia la si potrebbe davvero prendere come modello di un certo modo di usare il linguaggio, un modo che veda il linguaggio come prassi sociale, come modo non tanto di comunicare quanto di produrre un qualche tipo di consonanza, di accordo, di Stimmung.
È singolare comunque che l’epoca in cui Goethe fa dire queste cose al suo Faust sia anche quella che inaugura, in poesia, il dominio della lirica, ovvero di una forma di poesia che ha al suo centro proprio il soggetto, e la comunicazione del suo sentire nei confronti di altri soggetti. Da questo punto di vista, la lirica sembrerebbe piuttosto presupporre una metafisica centrata sul senso (Sinn), o sulla parola (Wort) in quanto strumento per comunicare. Ma questo potrebbe essere il tema di un prossimo post.
La poesia ha diritto a essere, se non incomprensibile, almeno molto poco comprensibile. È un diritto che la prosa non ha, perché la sua natura è diversa.
Sto parlando di diritti: non di stati di fatto e nemmeno di opportunità. Nello stato di fatto molta poesia (fortunatamente) non sfrutta questo diritto; e quanto all’opportunità sono dell’opinione che si tratta di un diritto che la poesia dovrebbe sfruttare il meno possibile. Ma un diritto è un diritto, che si rivela importante solo quando ce n’è bisogno. Dei diritti si può anche abusare, ma questo rientra nel campo dell’opportunità, non del diritto stesso.
La poesia ha diritto a essere (quasi) incomprensibile in un senso più forte di quello per cui diciamo che ciascuno di noi ha diritto di scrivere quello che gli pare ma poi se quello che scrive è incomprensibile non si può lamentare se nessuno lo legge. La poesia (quasi) incomprensibile ha il diritto di essere letta, ed eventualmente apprezzata se se lo merita – un diritto che la prosa non condivide, a meno che non sia (magari) poesia camuffata.
Al centro della prosa sta un discorso, che a volte è un’argomentazione (come questa) e a volte è un racconto; sta cioè un tentativo di trasmettere contenuti sufficientemente precisi da un soggetto della comunicazione a un altro. Al centro della poesia sta un ritmo, ovvero un’azione di carattere rituale, che ha come fine di indurre uno stato emotivo-partecipativo.
La presenza di un discorso, ovviamente, non è esclusa dalla poesia, però è accessoria, non cruciale. Leggiamo di solito le poesie come discorsi perché siamo abituati a pensare la parola come qualcosa che serve per veicolare discorsi. Indubbiamente la parola serve a questo, però non solo a questo, come sa ogni buon credente che partecipi a un rito religioso: nella consacrazione dell’ostia, per esempio, non c’è nessun discorso; le parole servono piuttosto per produrre la transustanziazione. Lo fanno in virtù del loro potere rituale, ovvero del fatto che intorno a esse si verifica una Stimmung, una accordatura della comunità concelebrante. Se io non ne faccio parte – perché sono magari un antropologo che sta studiando i riti locali – non sarò nemmeno capace di entrare nel rito; e magari allora davvero per me quelle parole saranno intese come parole che intendono trasmettere un discorso, e finirò forse per pensare che si tratta di un discorso privo di senso. Non avrò magari nemmeno tutti i torti: quelle parole hanno davvero poco senso, ma non perché chi le produce e chi partecipa al rito siano scemi o primitivi, bensì perché quelle parole non intendono averlo, il senso, non sono fatte per averlo, non intendono trasmettere nessun discorso.
La poesia funziona allo stesso modo. Il senso complessivo ci può essere, naturalmente, ma può anche permettersi di essere scemo o primitivo, perché non è quello il fulcro dell’operazione poetica. E l’azione ritmica che la poesia mette in gioco riguarda il senso delle parole non meno di quanto riguardi il suono. La poesia non è la musica, e i suoni di cui fa uso, essendo parole, sono già all’origine dotati di senso. Più che un discorso coerente, la poesia è tenuta a produrre un ritmo coerente (nel senso tanto quanto nel suono, o nella loro interazione), ovvero a permetterci di entrare, almeno virtualmente, in una situazione rituale, cioè condivisa, di carattere immersivo.
Per questo la poesia ha diritto di essere (quasi) incomprensibile, dove quel quasi dipende dalla natura delle parole e dall’esistenza di un loro senso di base, un senso che non può andare perduto: se il ritmo dev’essere ritmo anche del senso, un qualche senso (non necessariamente così coerente da trasmettere complessivamente un discorso) ci dev’essere per forza. Dal mio specifico punto di vista, di singola persona, una poesia scritta in una lingua che non conosco non è nemmeno una poesia, nemmeno se la sento recitata ad alta voce: per bene che vada sarà magari musica – ma di solito nemmeno quello.
La poesia ha dunque diritto alla (quasi) incomprensibilità perché il discorso non è al suo centro, perché l’eventuale significato complessivo è un effetto collaterale della sua efficacia rituale, e perché la poesia è ambigua per natura (proprio per questi motivi) e non si risolve mai in nessuna delle sue spiegazioni.
Quanto all’opportunità di essere poco comprensibili, piuttosto, la questione è diversa. Il celebrante che consacra l’ostia non emette parole incomprensibili; esse sono semmai irrilevanti quanto al loro senso, perfettamente noto a chi le ascolta nel rito. Sono state però incomprensibili per secoli, almeno alla maggioranza dei partecipanti al rito, sinché venivano dette in latino; tuttavia il rito funzionava lo stesso, forse addirittura meglio, sostiene qualcuno. La traduzione in italiano produce comunque la sensazione di una partecipazione più attiva, più consapevole.
In poesia succede qualcosa di simile. Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.
La consapevolezza della natura rituale della poesia è quasi scomparsa dal nostro presente. In un mondo in cui tutto è spiegazione o spiegato, rimane poco spazio per la presentazione dell’inspiegato o inspiegabile. Jacques Lacan parlava da qualche parte degli dei come proiezione del reale, e il reale non era per lui la realtà, bensì quegli aspetti del mondo e della nostra vita che nessuna spiegazione razionale è in grado di farci accettare: come la morte, per esempio.
La poesia, nel suo piccolo, adempie alla medesima funzione di contatto col reale, con l’inspiegabile, con ciò che non può essere ricondotto alla ragione. Darle una patina di senso, ricoprirla di un discorso, travestirla parzialmente da prosa (cioè da discorso razionale) può certamente aiutare ad avvicinarci alla dimensione (terribile) del reale. Ma è solo uno (spesso indispensabile) stratagemma seduttivo. Le poesie che ci prendono, che ci restano in mente, che ci emozionano, non sono alla fine quelle che fanno dei bei discorsi, o dei discorsi con cui siamo d’accordo. Quella è retorica, magari positiva, magari condivisibile; ma la poesia è altro.
Leggo fumetti, leggo poesie, vado al cinema perché mi diverto. Non c’è dubbio in proposito. Ma forse è un modo un po’ superficiale di spiegare le cose. Non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi piace mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi diverte mi piace.
Non sempre le parole divertire e divertimento hanno avuto il senso odierno (più o meno) di dilettare e diletto, o di sollazzare e sollazzo. Del significato antico restano tracce in alcuni linguaggi tecnici, come quello musicale: in certe forme musicali, il divertimento non è una parte più allegra, bensì una sezione in cui ci si allontana particolarmente dal soggetto o dal tema principale, salvo in seguito ritornarvi. Oggi dovremmo forse usare, per capirci meglio, la parola diversione; e divergere per quello che era divertire.
Si sa come nascono le parole nuove. C’è un uso inizialmente metaforico, che si diffonde e progressivamente diventa standard: nel divertimento di oggi il senso di diversione non lo percepisce più nessuno.
Un poco più onesto è forse il termine intrattenimento, dove con poco sforzo si riesce a cogliere il senso originario di tenere (o trattenere) dentro, ovvero quello che si fa per evitare che qualcuno se ne vada. E ancora più onesto (e di conseguenza molto meno usato) è il termine evasione, che ancora mantiene forte il significato di fuga da un luogo chiuso, per cui ci accorgiamo che quando lo usiamo in espressioni come letteratura d’evasione si tratta di una metafora, attraverso la quale si dipinge la vita quotidiana come un luogo oppressivo da cui è però possibile fuggire.
Se percepissimo ancora il senso originale di divertimento come diversione, probabilmente ci renderemmo conto che le sue implicazioni non sono molto diverse da quelle di evasione. Divertirsi è divergere dalla noia o dal dolore della quotidianità; è fare una diversione rispetto a una vita quotidiana che non ci soddisfa – anche se, lo sappiamo, siano condannati a ritornarvi presto. In fin dei conti, le diversioni non sono vere evasioni, e nemmeno le evasioni letterarie (o televisive) sono vere evasioni.
Ecco quindi che mi preoccupo nello scoprire che leggo fumetti, poesie ecc. perché mi diverto. Sarebbe come dire che il piacere che queste fruizioni producono in me deriva dal fatto che sto momentaneamente evadendo dalla mia gabbia quotidiana. In altre parole, l’ideologia del divertimento ha bisogno di sostenere che la vita è una cacca, e che l’unico modo per provare piacere è fare una diversione, spostarsi momentaneamente nell’altrove.
Ma è davvero così?
Proviamo a guardare le cose più da vicino. Tra le cose che ci divertono ci sono senz’altro quelle che ci fanno ridere. Ma non si ride senza che ci sia una complicità e un accordo di fondo. Questo è talmente vero che far ridere qualcuno è anche un modo per crearli, questa complicità e questo accordo di fondo – come sa benissimo il grande barzellettiere che regge le sorti di questo paese. Ma se c’è complicità e accordo di fondo, su che cosa si basa la diversione, cioè il divertimento? Credo che le cose stiano così: l’accordo di fondo ci tranquillizza (non c’è nulla di pericoloso in gioco), per cui si può parlare e dire davvero qualsiasi cosa, anche quelle che altrimenti non diremmo mai. Ecco il senso della diversione, cioè del divertimento: nella cornice rassicurante dell’accordo, può venir fuori l’assurdità e paradossalità di tante cose.
La diversione c’è, senza dubbio, ma neutralizzata dalla complicità e dall’accordo di fondo: c’è perché non è pericolosa. La risata del divertimento non ha niente a che fare con l’utopia anarchica di “una risata vi seppellirà”. Il divertimento non seppellisce niente, perché quello che vi appare oggetto di critica è già stato rafforzato all’origine.
Quando poi si costruisce un impero mediatico sul divertimento, si stanno saldamente impiantando dei valori: non quelli presi in giro in superficie, ma quelli condivisi nel fondo. Ho seguito recentemente un po’ di striscio una polemica su Drive In, trasmissione paleoberlusconiana che molti difendono oggi perché era una presa in giro, anzi una intelligente presa in giro, della comunicazione televisiva. Sarà. Non voglio prendere una posizione netta, perché ne ricordo ben poco: Drive In mi annoiava già allora (molto meglio la surreale insipienza di Colpo Grosso, che non si ammantava di nulla, e sviliva la donna italiana con candida sincerità) e non lo guardavo praticamente mai. Voglio solo avanzare il sospetto che quella intelligente presa in giro si basasse sulla conferma profonda di una serie di valori (che sono poi stati quelli su cui si è fondata la fortuna del grande barzellettiere) mentre in superficie (e in maniera evidentemente più effimera) se ne condannavano altri.
Dove il divertimento diventa il valore principale della vita, ci si dovrebbe domandare da cosa ancora si stia divergendo. Ha buon gioco, il grande barzellettiere, a suggerire continuamente da che cosa si debba evadere (tasse a parte): i comunisti, le toghe rosse, i moralisti, i perbenisti… Dio mio! Eccomi ridotto, nel mondo costruito da lui, a fare proprio la parte del vecchio moralista! E pur di dargli addosso, devo arrivare persino a parlar male del divertimento! (il che confermerà oltre ogni dubbio, con sicurezza, che sono un vecchio moralista!) Certo, all’interno del suo mondo o si è puttane (letterali o metaforiche) o si è moralisti. Le puttane (soprattutto quelle metaforiche) si divertono; e chi non si diverte non ha capito che si trattava di una battuta.
Vorrei divertirmi anch’io. Lo faccio, quando riesco, anche evitando di pensare al grande barzellettiere. Ma che triste divertimento! Mi viene in mente Palazzeschi. Lo riporto qui sotto. Provate a rileggerlo pensando al divertimento come diversione, al poeta come qualsiasi persona intelligente con qualche velleità creativa sincera, e magari facendo finta che questi versi siano stati scritti oggi. Una poesia tragica, direi! (sembra quasi la sinistra italiana)
__________________________________________
E lasciatemi divertire
(canzonetta di Aldo Palazzeschi, 1910)
Tri tri tri,
fru fru fru,
ihu ihu ihu,
uhi uhi uhi!
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente!
Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto.
Cucù rurù,
rurù cucù,
cuccuccurucù!
Cosa sono queste indecenze?
Queste strofe bisbetiche?
Licenze, licenze,
licenze poetiche!
Sono la mia passione.
Farafarafarafa,
tarataratarata,
paraparaparapa,
laralaralarala!
Sapete cosa sono?
Sono robe avanzate,
non sono grullerie,
sono la spazzatura
delle altre poesie
Bubububu,
fufufufu.
Friu!
Friu!
Ma se d’un qualunque nesso
son prive,
perché le scrive
quel fesso?
bilobilobilobilobilo
blum!
Filofilofilofilofilo
flum!
Bilolù. Filolù.
U.
Non è vero che non voglion dire,
voglion dire qualcosa.
Voglion dire…
come quando uno
si mette a cantare
senza saper le parole.
Una cosa molto volgare.
Ebbene, così mi piace di fare.
Aaaaa!
Eeeee!
Iiiii!
Ooooo!
Uuuuu!
A! E! I! O! U!
Ma giovanotto,
ditemi un poco una cosa,
non è la vostra una posa,
di voler con così poco
tenere alimentato
un sì gran foco?
Huisc…Huiusc…
Sciu sciu sciu,
koku koku koku.
Ma come si deve fare a capire?
Avete delle belle pretese,
sembra ormai che scriviate in giapponese.
Abì, alì, alarì.
Riririri!
Ri.
Lasciate pure che si sbizzarrisca,
anzi è bene che non la finisca.
Il divertimento gli costerà caro,
gli daranno del somaro.
Labala
falala
falala
eppoi lala.
Lalala lalala.
Certo è un azzardo un po’ forte,
scrivere delle cose così,
che ci son professori oggidì
a tutte le porte.
Ahahahahahahah!
Ahahahahahahah!
Ahahahahahahah!
Infine io ò pienamente ragione,
i tempi sono molto cambiati,
gli uomini non dimandano
più nulla dai poeti,
e lasciatemi divertire!
28 Febbraio 2011 | Tags: poesia, pornografia, Rustico Filippi | Category: poesia | A voi, Chierma, so dire una novella:
se voi porrete il culo al colombaio,
cad io vi porgerò tal manovella,
se non vi piace, io no ne vo’ danaio.
Ma tornerete volontier per ella,
ch’ella par drittamente d’un somaio:
con tutto che non siate sì zitella
che troppo colmo paiavi lo staio.
Adunque, Chierma, non ci date indugio,
che pedir vi farabbo come vacca
se porrete le natiche al pertugio.
Tutte l’altre torrete poi per acca:
sì vi rinzafferò col mio segugio
ch’e’ parrà ch’Arno v’esca de la tacca.
Definiremmo pornografico questo sonetto? Lo scrisse il fiorentino Rustico Filippi, in qualche momento degli ultimi decenni del Duecento, quando già Dante iniziava a essere attivo. Non lo chioserò. Vale la pena spendere un po’ di tempo in tentativi esegetici personali o in qualche ricerca, perché quando si arriva a capire quello che non è immediatamente evidente, c’è ancora più gusto, e il gioco vale decisamente la candela.
D’altra parte, se ci potrà essere qualche dubbio, per il lettore moderno, sul significato specifico di qualche espressione, credo che nessun dubbio si possa avere sul tema e sul significato complessivo del sonetto, che è una specie di spot autopromozionale nei confronti di una presumibilmente bella signora, non privo di una paradossale presa in giro di se stesso e delle proprie esagerazioni.
Io lo trovo bellissimo, e lo conosco a memoria, insieme ad alcuni altri di Rustico, quasi altrettanto riusciti. Va da sé che, nonostante la sua qualità, sulle nostre antologie scolastiche non compare – ed è già molto che ci sia l’Angiolieri, con le sue sparate ben difficili da giustificare moralmente.
Pornografia? Forse l’argomento lo è, con questa descrizione dettagliata e pittoresca di un sesso palesemente fine a se stesso. Ma come si fa a definire pornografico un testo da cui sprizza intelligenza e malizia a ogni parola; e di cui si può legittimamente sospettare che il vero bersaglio fosse lo stile angelicato che iniziava ad andare di moda in quegli anni?
Voi la penserete come volete, perché la regola è dubbia, e l’uso multiforme. Per quanto mi riguarda, un testo intelligente non sarà mai pornografico, quand’anche parlasse della cosa più laida del mondo. E se non è pornografia, questo non vuol dire che sia allora erotismo: col sonetto di Rustico l’erotismo non c’entra proprio niente. Semmai, in questo caso, provocazione…
Pornografico è dunque un appellativo negativo, con cui si cerca di infamare anche opere che con la pornografia hanno in comune solo il sesso, come a suo tempo quelle di Diderot e De Sade, citate recentemente da Boris Battaglia.
Pornografico è ciò che ha argomenti laidi, e in più è stupido e noioso, e non è mai eversivo. Come le vicende del nostro principe telecratico, da quello che ha fatto lui ai mille racconti che i media ci hanno di conseguenza propinato. Anche con questo è riuscito a renderci tutti pornofili! Era meglio Cicciolina, in parlamento o sul set, tutto sommato. Quella situazione, almeno, era sincera.
25 Febbraio 2011 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, illustrazione, manifesto, musica, pittura, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, tipografia, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia |  Guardare e leggere. La copertina Be’, sì, è in libreria. L’altro giorno, quando ho detto a un mio amico che stava per uscire, lui mi ha chiesto: “E il blog l’hai fatto?”. Ho avuto un momento di perplessità. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai quando si pubblica un libro si crea anche il blog per riparlare ed espandere i suoi temi. Ma io il blog ce l’ho già. Anzi è venuto al mondo un anno prima del libro. Un blog ha però una gestazione breve, mentre un libro ce l’ha decisamente più lunga. Il libro in verità esisteva già prima del blog, e il nome che a suo tempo ho dato al blog era anche augurale per il libro. Quindi, in fin dei conti, al mio amico ho risposto “Sì”.
Il libro è più specifico del blog, come è giusto. Se volete sbirciare indice e introduzione potete andare qui.
Mi sento un po’ come quelli che dal romanzo è uscito il film, o dal film il fumetto, o dal fumetto il romanzo. Il blog non cambierà, ma se qualcuno mi propone qualche tema di cui nel libro si parla, può essere una buona occasione per tornarci sopra.
Per adesso, ne parlo pubblicamente in un incontro nell’ambito del festival del fumetto Bilbolbul, sabato mattina 5 marzo alle 11.30 alla libreria Irnerio (via Irnerio 27) a Bologna, con Luca Raffaelli. Spero di vedervi tutti.
10 Febbraio 2011 | Tags: Dylan Thomas, Fernanda Romagnoli, poesia | Category: poesia | Sola
Bastò che nel tuo plasma
s’ammutinasse un atomo: alzò gorghi
tutta la foce. E crollò la fortezza
di settantasei anni. Fu feroce
il dettato di resa. In un minuto
la tua carne divenne un ectoplasma
dai gesti incomprensibili,
il tuo sguardo un messaggio indecifrabile
come da muto a muto.
Nulla avevamo appreso dalla vita,
nulla, che s’adombrasse in quel linguaggio.
Poi cedettero i gorghi. E tu già stavi
disciolta da noi vivi. Verso incerte
balugini dischiusa. Maturavi
sola – nella placenta della morte.
Fernanda Romagnoli, da Il tredicesimo invitato, Garzanti 1980
Quel poco che so di Fernanda Romagnoli lo devo a un’antologia di qualche anno fa: Maledetti italiani, a cura di Davide Brullo, Il saggiatore 2007. So che era nata nel 1916 ed è scomparsa nel 1986, e che ha avuto un attimo di notorietà con la pubblicazione de Il tredicesimo invitato, per poi riscomparire nel nulla. Wikipedia mi informa che Il tredicesimo invitato è stato ristampato da Scheiwiller nel 2003, ma io non sono riuscito a trovarlo. Qualche altra poesia e informazione si può trovare anche qui, ma a me basterebbe questa sola poesia a farmela ricordare, riportata nella antologia di Brullo.
Visionaria, invidio la nettezza con cui vengono enumerate queste metafore eccessive, fantasmagoriche, in cui tuttavia si ritrova una logica, la ferocia di una guerra. Questa idea della morte, la cui componente davvero terribile sarebbe la solitudine a cui ci condanna, è bella e originale. Il nostro corpo, con la sua materia e le sue regole di carne, appare come l’unica via verso il contatto umano.
Io non riesco a non associare questa poesia della Romagnoli con un’altra, che mi è ugualmente molto cara, del delirante gallese Dylan Thomas. Anche qui una morte, anche qui un corpo che si disgrega, anche qui un delirio di fantastiche visioni.
Among those Killed in the Dawn Raid was a Man Aged a Hundred
When the morning was waking over the war
He put on his clothes and stepped out and he died,
The locks yawned loose and a blast blew them wide,
He dropped where he loved on the burst pavement stone
And the funeral grains of the slaughtered floor.
Tell his street on its back he stopped a sun
And the craters of his eyes grew springshots and fire
When all the keys shot from the locks, and rang.
Dig no more for the chains of his grey-haired heart.
The heavenly ambulance drawn by a wound
Assembling waits for the spade’s ring on the cage.
O keep his bones away from the common cart,
The morning is flying on the wings of his age
And a hundred storks perch on the sun’s right hand.
——————–
Fra le vittime dell’incursione all’alba c’era un uomo di cent’anni
Mentre il mattino si svegliava sopra la guerra,
Indossò i suoi vestiti, varcò la soglia, e morì;
Le serrature allentate saltarono a uno scoppio:
Cadde lì dove amò, sul marciapiede esploso,
Nella funebre polvere del suolo massacrato.
Dite alla strada capovolta che egli arrestò un sole
E eruttò fiamme e virgulti dai crateri degli occhi
Quando tutte le chiavi caddero dalle toppe e tintinnarono.
Non scavate più per le catene del suo cuore canuto.
L’ambulanza del cielo tratta da una ferita
Aspetta, radunando, il suono della vanga sulla gabbia.
Oh, tenete lontane le sue ossa da quel carro comune;
Il mattino s’invola sulle ali dei suoi anni
E cento cicogne si posano alla destra del sole.
Da Dylan Thomas, Poesie, Einaudi 1965. Trad. di Ariodante Marianni
19 Gennaio 2011 | Tags: critica, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Mi guardo intorno, anzi sarebbe meglio dire mi leggo intorno. Leggo su questo schermo blog di diversi tipi, di diversi argomenti. Nei blog dove si ragiona di poesia mi colpiscono in questi giorni tre post differenti, ma che girano attorno a un tema solo, o forse (meglio) a temi diversi con una radice unificante; uno è quello di Paolo Zublena su punto critico, Esiste (ancora) la poesia in prosa?, un altro è quello di Massimiliano Manganelli su Absoluteville, La poesia contro il romanzo, e il terzo, ancora su Absoluteville, solo in apparenza di tema differente, è quello di Rosaria Lo Russo, Scrivere sotto dittatura; tutti con i relativi commenti.
Il tema unificante a cui girano attorno è che cosa sia questa roba che chiamiamo poesia, e in particolare che cosa sia rispetto a quell’altra roba che, per contrasto, si chiama prosa, ed è soprattutto, nel mondo di oggi, romanzo. Non è, io credo, una questione di vincoli maggiori o minori; semmai di quali vincoli. Un commentatore del post di Zublena (Gianluca Garrapa) suggerisce di assumere una regola arbitraria, tipo i 140 caratteri di Twitter “come fosse una regola (quasi oulipo) di versificazione e stare quindi nella ‘poesia’ in una più ampia, però, struttura narrativa_di_prosa. come se insomma ‘macroscopicamente’ fosse prosa e ‘microscopicamente’ poesia”. Mi pare una proposta che può essere magari interessante per fare degli esperimenti (tipo Oulipo, appunto), ma che con la poesia non ha niente a che spartire, in sé (anche se ci si può porre come sfida di scrivere poesia sottostando pure a un vincolo come quello).
Mi sento semmai più in sintonia con Rosaria Lo Russo, che parla di dettatura (o dittatura) del corpo ispirato. Forse la Lo Russo pone troppo l’accento sul corpo (ma lo scrive in un post, non in un trattato, e non si può sottilizzare troppo in poche righe), perché la poesia, da diversi secoli a questa parte, non è solo vocalità. Però io trovo che sostanzialmente abbia ragione, e che nella poesia sia presente una dinamica fisica, o fisiologica, di carattere principalmente vocale-sonoro, ma anche secondariamente (a mio parere) grafico-visivo, che non si può eliminare, se non uscendo dai suoi confini.
Lo dice bene Paul Valery, citato da un altro commentatore del post di Zublena (Luigi Bosco): “L’essenza della prosa è di perire, – cioè di essere «compresa», – cioè di essere dissolta, distrutta in modo irreparabile, del tutto sostituita dall’immagine o dall’impulso che essa significa secondo la convenzione del linguaggio. Infatti la prosa sottintende sempre l’universo dell’esperienza e degli atti, – universo nel quale, – o grazie al quale, – le nostre percezioni e le nostre azioni o emozioni devono alla fine corrispondersi o rispondersi in un solo modo, – uniformemente. L’universo pratico si riduce a un insieme di scopi. Ottenuto tale scopo, la parola muore”. Come dire che, nella prosa, la parola si esaurisce nella trasmissione del proprio significato, e si legge unicamente per capire: tutto il resto, compreso tutto il sentire emotivo che eventualmente ne deriva, passa completamente da lì, dalla comprensione della sequenza di parole. Viceversa, nella poesia la parola resiste alla comprensione del suo significato, e il suo suono traccia altre relazioni, che si accompagnano a quelle del significato, e non si esauriscono in quelle.
La comprensione (anche profonda) del significato di una poesia è ben lontana dall’esaurirla. Con forme differenti, la poesia condivide con la musica l’irriducibilità al senso – pur essendogli più vicina di quanto non gli sia la musica, per la sua natura ovviamente verbale. Qualche giorno fa scrivevo (qui) che “la poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni”. Potrei aggiungere, esagerando e semplificando, che il sentire personale è legato al senso, al significato, mentre quello collettivo è legato agli aspetti ritmici e sonori. Starei esagerando e semplificando perché le relazioni sono molto più complesse di così, ma non starei mancando del tutto il bersaglio.
In altri termini, potrei anche dire che la poesia è un meccanismo che mette in relazione il significato verbale con altre reti di relazioni, non necessariamente riducibili, nemmeno in ultima istanza, al significato verbale stesso. Se tale riduzione fosse possibile, una buona interpretazione di un testo poetico lo esaurirebbe (come sembra aver ipotizzato qualcuno in epoca neoavanguardista, secondo il racconto, ancora su punto critico, di Antonio Loreto).
In verità, anche Valery sta esagerando e semplificando. Persino la prosa non si esaurisce del tutto nel suo significato, anche se certo il valore sonoro (o visivo) delle parole è estremamente minore di quello della poesia. Proprio per questo è virtualmente possibile costruire della prosa che conservi i valori della poesia di non riducibilità al significato. Ma non ha tutti i torti Zublena a ritenere la poesia in prosa un’operazione che ha avuto valore storico, un valore oggi del tutto superato (i grassetti della citazione sono miei):
Questo non vuol dire ovviamente che i generi letterari dagli anni ’60 in poi si siano dissolti. Anzi. Sarebbe però ingenuo allo stato attuale considerarli qualcosa di più di dispositivi pragmatici che inquadrano un patto di lettura tra autore e lettore, o ancor meglio tra autore e lettore implicito nell’orizzonte di attesa contemporaneo. Ma questi dispositivi pragmatici sono in primo luogo sopravvivenze di istituti teorici (e normativi) del passato la cui portata si è spostata dal campo letterario (e quindi, se proprio volessimo seguire Bourdieu, da ragioni di conflitto circa il capitale culturale) a quello economico dell’industria culturale: oggi i generi si definiscono in funzione degli interessi del mercato editoriale.
In questo senso, se la nozione di poesia in prosa poteva avere un tempo – e certamente ha avuto – una funzione liberante di ibridismo rispetto a generi ancora fortemente canonizzati, oggi che i generi sono soprattutto etichette in libreria, e la poesia in primo luogo un concetto la cui ipostatizzazione ideologica inverte – appunto ideologicamente – la marginalizzazione che la letteratura che non si vende subisce dal mercato editoriale elevandola nel migliore dei casi a luogo anodino di resistenza etico-politica, nel peggiore a squisito rifugio irresponsabile da anime belle: se insomma la poesia non ha più bisogno di libertà perché il mercato le lascia tutta l’indifferente libertà che vuole, allora questa nozione (la poesia in prosa) è oggi probabilmente inutile.
In questo predominio dell’industria editoriale, la prosa – cioè il romanzo – è diventato davvero pienamente quello che descriveva Valery, cioè qualcosa il cui linguaggio si risolve nel proprio significato: in altre parole, la trama, il plot, la struttura del raccontato. Per Massimiliano Manganelli, su Absoluteville, proprio grazie alla sua marginalità, la poesia “è diventata il terreno più fertile della scrittura letteraria, quello dove si consumano gli esperimenti, dove l’invenzione conta ancora qualcosa, contro l’infinita ripetizione del romanzo”. Alla luce delle sconsolate parole di Zublena, questa fertilità sembrerebbe tuttavia dovuta proprio a quella “indifferente libertà” lasciatale dal mercato.
Nell’un caso come nell’altro, non è però chiaro perché il mercato abbia scelto il romanzo. Non dobbiamo dimenticare che il mercato non ha affatto demonizzato, per esempio, la musica, che è l’altro polo che influisce sulla poesia. In altri termini, il mercato ha puntato da un lato su una parola narrativa che si esaurisce nel racconto, e dall’altro su una struttura ritmico-sonora che si tiene ben lontana dal senso (basti pensare alla banalità media o irrilevanza dei testi delle canzoni, quando ci sono). La poesia, dal canto suo, ha percorso i sentieri aspri delle avanguardie, e si è adornianamente tirata fuori da quella dialettica, enfatizzando l’inevitabile complessità che deriva dal mettere assieme i due campi, quando si cerca di giocare insieme all’interno e all’esterno del senso. La separazione tra mercato e poesia è stata dunque per molti versi consensuale.
Il problema, a questo punto, è concretizzare davvero la non coincidenza tra la cultura e il mercato culturale. Non possiamo lamentarci che la poesia non venda. Dovremmo lamentarci piuttosto che il vendere sia l’unico criterio di valore riconosciuto pubblicamente, e agire di conseguenza. Dovremmo perciò renderci conto che la pubblicazione a stampa non può più essere il discrimine tra poeti da considerare criticamente e poeti da ignorare. La pubblicazione è comunque qualcosa che si paga, vuoi che la paghi il mercato, l’editore o l’autore stesso. Se non crediamo nel valore del mercato dobbiamo coerentemente squalificare anche il valore della pubblicazione a stampa.
In altre parole, sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani. Naturalmente è molto più scomodo analizzare un campo così vasto, non previamente scremato dalle scelte degli editori. Ma non ci sono alternative, oggi, io credo. Se il criterio seguito da Cucchi e Giovanardi per la loro nota antologia mondadoriana (di prendere in considerazione soltanto autori pubblicati, e da editori veri) era discutibile nel 1996, e pericoloso nel 2004 (le date delle due edizioni dell’opera), credo che sarebbe semplicemente sbagliato, o falso, oggi.
P.S. Sto partecipando al Premio Turoldo.
Se volete leggere i testi (anzi il lungo testo) che ho inviato, e magari lasciare qualche commento, mi potete trovare qui: http://www.poiein.it/premi_letterari/Turoldo2010/aaa_elenco.htm.
(dopo)
questo sopra quello sotto,
e poi il geranio e il filo di ferro,
gli esterni gli interni e sfondamenti,
e poi il sale sul gambo,
il tonfo dietro, il battito dentro,
la notte nel giardino tenue,
e poi le labbra e la nebbia… e poi…
e poi altro… a perdersi, in ritorni e fughe,
finché ci saranno coordinazioni (e poi…)
per allineare nella paratassi (e poi… )
altro ancora, malvisto, poi visto fin troppo,
andremo e verremo, e poi ancora, e poi piano
più forte, più intensamente, poi meno
e ancora, in successione, trovando
un posto, anche noi, tra i fatti :
il posto dell’ostacolo,
rallentando di traverso
quasi a tenere, a prendere,
in un abbraccio,
le ombre onde, lo scatto dei denti
sugli echi (e poi ?)
Le poesie riportate in questo post sono di Andrea Inglese, tratte da L’indomestico (2005, scaricabile per intero da qui). Le riporto non solo perché mi piacciono, ma perché mi hanno suggerito una riflessione sul senso della lettura e, soprattutto, sul senso della critica – una riflessione che prende come spunto la poesia, ma che vuole avere valore più generale, per qualsiasi oggetto di carattere estetico/artistico di cui si voglia parlare.
Mi riferisco non tanto alla critica storica, non tanto a quella che tira le somme, ma piuttosto a quella che legge e propone, cercando di indurre i propri lettori a un apprezzamento (o non apprezzamento) dei testi in oggetto. Quella che deve dire (nel caso) se un testo è bello e perché. Lo può fare perché sta scrivendo una recensione, oppure perché sta cercando di spiegare (in una prospettiva più storica) le ragioni della qualità o del successo di un testo.
Ora: teniamo presente che quando riteniamo che il ruolo della critica sia quello di spiegare il testo, rendendone evidenti i contenuti nascosti, stiamo già presupponendo che il testo possa essere spiegato, e che valga la pena di farlo. Se vale la pena di farlo è perché siamo convinti che il testo abbia valore, e che questo valore stia nel suo significato (e dove altrimenti?): aiutare il lettore a cogliere meglio questo significato sarebbe dunque un compito principe della critica.
Non metto in dubbio, né qui né in generale, l’utilità di una spiegazione del significato dei testi. Certo non si tratterà mai di una spiegazione definitiva (un buon testo estetico non dà mai fondo alle sue possibili interpretazioni), tuttavia già fornire al lettore qualche chiave di lettura in più (magari per discuterla o addirittura – criticamente – rifiutarla) è certamente qualcosa di positivo.
Il punto della mia riflessione è piuttosto se la funzione della critica debba limitarsi a questo basilare “fornire una chiave in più” alla lettura, oppure se essa possa ambire anche a qualcos’altro. Cosa potrebbe essere questo “qualcos’altro”? E pure limitandosi magari alla semplice funzione di base, in che modo essa dovrebbe essere espletata?
Potrei, tanto per cominciare da una procedura molto basilare, prendere questi testi e sottoporli a parafrasi, proprio come si fa a scuola, ma temo che nel loro caso non otterrei molto. La parafrasi è utile quando la sintassi è complicata – cosa che non succede nelle poesie di Inglese. Il risultato non sarebbe molto diverso dall’originale: solo più brutto, presumibilmente.
Potrei allora prendere questi testi ed esplorarli andando a fondo nella rete interna dei significati. Se io sono davvero un critico di poesia, non trascurerò, nel farlo, le dimensioni metriche e in generale ritmiche, cercando di individuare il loro specifico contributo al senso complessivo. Analizzarò i campi semantici e le ricorrenze isotopiche, magari identificando relazioni sottili e imprevedibili tra le parti. Alla fine otterrò magari anche un’interpretazione coerente, un senso complessivo sufficientemente unitario. Se lo volessi fare su questi testi, sarei perfettamente in grado di farlo. Serve lavoro, anche parecchio, ma alla fine si ottiene un oggetto critico molto soddisfacente: una specie di sostituto del testo iniziale, certo parziale, ma molto più coerente e conchiuso. È un lavoro che, da bravo semiologo, ho compiuto tantissime volte, sia su testi poetici che su tanti altri tipi di testi (in primis i testi a fumetti, ovviamente).
Il problema che mi trovo di fronte in questo momento è che anche se un lavoro di questo genere mi insegna di solito moltissime cose sul testo che ho di fronte, nulla mi dice invece sul perché questo testo mi piace, e sul perché debba eventualmente piacere anche ad altri (cioè ai miei lettori, cui lo sto proponendo). Semmai questo lavoro è esso stesso una conseguenza e manifestazione del fatto che il testo mi piace, e può al contempo fornire una serie di stimoli tali per cui il testo potrà più facilmente piacere a qualcun altro (cioè ai miei lettori). Insomma, il mio lavoro non dice del testo “è bello” in maniera critica, spiegando il perché lo sia; ma si limita a suggerire che, se io, critico, vi ho individuato tanti aspetti interessanti è perché l’ho trovato, nel suo complesso, bello, e che lo stesso potrebbe dunque accadere a te, lettore.
Non che questo sia poco, ovviamente; ma continuiamo a trovarci al livello della descrizione del testo, e non del perché esso sia interessante.
Facendo un passo più in là, un altro strumento di cui si può fare uso sono le considerazioni di carattere storico-critico. Non la storia vera e propria – che è un altro genere, parente ma diverso dalla critica – bensì il tentativo di trovare il senso nel testo attraverso il rapporto che esso intrattiene con testi antecendenti. Per esempio, potrei argomentare che io trovo un rapporto piuttosto stretto tra le poesie di Inglese e quella di Antonio Porta, specie le sue prime e le ultime (ovvero lasciando in subordine quelle della fase più strettamente legata al gruppo ’63). Affinché un’affermazione del genere abbia davvero valore storico andrebbe sostenuta da qualche riscontro maggiormente oggettivo. Così come la pongo io, invece, non si tratta che di un’ipotesi, avente valore più dal lato del consumo (mio) che dal lato della produzione (dell’autore). Andrea Inglese, infatti, per quanto ne so, è un francesista – per cui magari, più che Porta, andrebbe chiamato in gioco qualche autore francese, che io però non conosco o non conosco abbastanza. Nonostante questo, il riferimento a Porta non è privo di senso. Esso significa, per me, che il piacere che provo leggendo i testi di Inglese è in qualche modo simile a quello che provo leggendo i testi di Porta. Certo non si tratta che di uno spostamento: mi piace Inglese perché mi piace Porta; e Porta, a sua volta, perché mi piace? Tuttavia, per coloro tra i miei lettori che già conoscono e apprezzano Porta, lo spostamento risulta utile, e rappresenta un’indicazione piuttosto chiara: essi possono apprezzare questi testi perché già apprezzano quelli di Porta. Si tratta però, inevitabilmente, di un’indicazione parziale: Inglese non è Porta e (per fortuna) nemmeno lo copia. È un autore differente che porta una qualche somiglianza di famiglia.
Ma le considerazioni storico-critiche possono costituire la base anche di un diverso tipo di apprezzamento. Per esempio, se esiste una nostra scelta di campo ideologica che riteniamo debba essere sostenuta, la collocazione del nostro testo all’interno di quel campo potrà costituire una ragione sufficiente per apprezzarlo. Nel nostro caso, per esempio, se fossimo sostenitori di una certa posizione avanguardista o delle sue conseguenze, avvicinare Inglese a Porta potrebbe essere una mossa per valorizzarlo come prosecutore di una determinata tradizione che riteniamo apprezzabile in sé. Agire in questo modo, insomma, sarebbe un po’ come dire che Inglese è dei nostri, e va apprezzato e sostenuto anche solo per questo. Più che critica, questa mi pare comunque attivismo politico. Più che apprezzamento estetico, la definirei militanza. Non è necessariamente un atteggiamento negativo, ma ha in sé poco a che fare con la critica, persino con il suo compito di base di aiutare la comprensione.
Nonostante qualche piccolo passo in avanti, sostanzialmente non stiamo uscendo dal dare un senso al testo, e restiamo lontani dallo spiegare perché il testo sia di valore, perché mi piaccia e dovrebbe piacere anche ai miei lettori.
Un’altra e differente soluzione mi appare più ingenua e controproducente delle precedenti: è quella che potremmo definire critica impressionista, ovvero il tentativo di rendere l’impressione che il testo produce su di me. Ma come si rende un’impressione? Be’, per esempio in versi, o attraverso una prosa letteraria… Dovrei dunque costruire un secondo testo estetico, che abbia come tema l’esperienza percettiva del primo. Il lettore che apprezzasse il mio testo dovrebbe sentirsi invitato ad apprezzare anche quello di Inglese. Naturalmente, se io fossi un grande scrittore, potrebbe anche capitarmi di produrre un testo critico assai più interessante del testo oggetto. Più frequentemente, invece, accade proprio il contrario, e la critica impressionista non invoglia affatto alla lettura. Gran parte dei commenti ai post dei blog di poesia sono di questo tipo, e lo sono perché l’autore del commento sta cercando un modo per esprimere gli elementi del proprio apprezzamento.
Perché dunque (quando non vi siano presupposti ideologici di scelta di campo a sostenerlo) è così difficile spiegare le ragioni del proprio apprezzamento estetico? Dire “mi piace” è facile. Anche dire “non mi piace” è facile, però è più semplice giustificarlo. Per esempio, non mi piacciono le cose banali, che sono quelle in cui ritrovo troppo facilmente delle strutture che già conosco: per dichiarare banale un testo, dunque, non ho che da trovargli degli antecedenti sufficientemente simili. Di conseguenza, trovandomi ora nella situazione opposta, dovrei spiegare nei termini della loro non banalità il perché questi testi mi piacciono. Tuttavia, mentre dire a che cosa qualcosa somiglia può essere facile, è molto più difficile metterne in luce la diversità – tantopiù che c’è sempre qualcosa a cui un qualsiasi testo somiglia, e questo non lo rende ipso facto banale. I testi di Inglese mi ricordano quelli di Porta, ma ne sono comunque sufficientemente lontani da non apparirmi affatto banali.
Se si resta fuori dalle scelte di campo ideologiche, l’apprezzamento estetico è qualcosa di sottile e personale. Questo non vuol dire che non sia condivisibile o trasmissibile, poiché – nella diversità individuale – siamo tutti comunque sufficientemente simili da poter avere a volte gli stessi gusti. Ma è comunque questione di sintonia. In altre parole, non riconosciamo che un testo è bello allo stesso modo in cui riconosciamo il suo significato; piuttosto, entriamo in sintonia con esso, e riconosciamo la nostra condizione di sintonia. Per questo, possiamo dare spiegazioni sul significato, ma non possiamo spiegare il bello. Al massimo possiamo aiutare gli altri ad entrare nella nostra medesima condizione di sintonia.
Mi resta dunque ancora una possibilità, proprio assumendo questa soggettività dell’esperienza del bello. Quello che posso fare è provare a descrivere l’esperienza, ovvero semplicemente testimoniare il mio vissuto, nell’ipotesi che questo vissuto possa essere, per lo meno, contagioso, e confidando nel fatto che il mio gusto non sia troppo esclusivo. Non è un’operazione facile, perché nel corso della lettura di un testo la nostra attenzione è ovviamente concentrata sul testo stesso, e non sulla nostra esperienza.
« Entra nell’ascensore, poi scendi. »
« Mi servirà davvero ? Avranno custodito
il groviglio, il segreto, la mano porgerà
la chiave, saprò dove nasce
il movente?» « Sei nella colonna
vuota, in caduta, passi i piani della memoria
finché ricorderai non ciò che vedevi
con imprecisi contorni e richiami,
ma lo spessore di tavoli e sedie,
l’impugnatura dei recipienti,
le piastrelle scalfite, i mattoni
a nudo, i sacchi di plastica in aria,
ed altre tattili inezie che sotto
le dita non hai percepito
nell’urgenza di tanto sognare. »
Che cosa posso dire, dunque, in concreto, di queste poesie di Andrea Inglese? Mi colpisce, per esempio, il ritmo con cui vengono elencati i concetti, un ritmo piuttosto stringente, ossessivo, con cui mi arrivano una serie di oggetti ed eventi che sono insieme elementi di quotidianità e correlativi di inquietudine. Non ci sono metafore in questi versi, ma solo questo stillicidio di cose, di eventi, di riflessioni, il cui ricorrere cadenzato mi costringe a comparare, ad accostare, come se io stessi percorrendo gli elementi di un racconto, il quale insieme però c’è e non c’è: non succede nulla in verità, eppure le cose appaiono cariche di storia, quasi di presagi.
Esco dalla lettura di ciascuno di questi testi con una sensazione inquieta, come se il mondo che mi circonda quotidianamente si fosse riempito di indizi, come se ciascuno degli oggetti mi stesse dicendo “attento, io ho un segreto”, ma poi il segreto non viene disvelato. Lo snocciolarsi degli oggetti del mondo nello snocciolarsi delle proposizioni e dei versi costruisce in me un ritmo di piccoli brividi.
Fra poco torneranno. Tutte quante. Le cose.
Come ai bei vecchi tempi. Nella dimora
del cuore. Ad una ad una. Col raffio,
il bastone curvo, la rete, pian piano.
Con il loro blues, il mormorio roco
di fondo, in umida mota, dal fondo
sorgeranno. E meditano, nel sommo,
una calma definitiva adunata.
Persino quando, a volte, un accenno di racconto si trova davvero, non è che poi cambi molto le cose. Mi appare quasi come un ordinamento apparente, un modo per organizzare in superficie una dinamica espositiva che rimane comunque quella dell’elenco ossessivo, quella dell’emergenza progressiva di figure inquietanti. Il racconto stesso, in fin dei conti, non è che una di queste figure, e non più importante delle altre.
Mi picerebbe scoprire, ora, come fa Inglese a produrre questa sequenza di piccoli brividi. A partire dalle mie sensazioni dovrei dunque analizzare il linguaggio, il metro, le figure, e il modo in cui tutto questo viene messo in successione. Ne otterrei, auspicabilmente, non un’interpretazione critica del testo, non cioè la mia versione della sua verità, ma semplicemente un’ipotesi sul suo funzionamento retorico, cioè sul modo in cui riesce a essere così efficace – efficace su di me, ovviamente, ma forse anche su altri lettori.
Desiderio
Le reti erano quelle alte del tennis
dietro a cui colava un’acqua
dubbia, tra argini d’erba.
Tu imparavi a ipnotizzare
le rane, io sganciavo cauto
il tuo reggiseno, e le menti buie
schiarivano, in sogno nessuno
ha fretta, potevo passarti
ogni tanto la lingua sulla schiena,
tra le scapole, mentre la festa
in giardino continuava.
Portavo bicchieri sempre doppi,
pieni di sangue, che rovesciavo
a terra, al riparo da bocche
assetate, indiscrete,
ancora non ti decidevi
a sfilarlo il vestito scollato,
ci spostavamo sui fondali
senza mai doverlo consumare
il desiderio, ed esso si eternava
davanti a noi, nitido nell’aria,
come un fiore crudo, una galassia.
La chiamiamo ancora “critica” un’operazione di questo tipo? Io sono convinto di sì. Ma bisogna capire che c’è differenza tra pensare i testi come portatori di una qualche verità, e pensarli piuttosto come meccanismi estetici, o retorici, dove anche la loro eventuale verità non è che un elemento tra gli altri per costruirne l’efficacia.
Due consideraioni conclusive:
1. il discorso è ben lontano dal potersi concludere qui, e vorrei tornarci sopra presto, magari anche parlando di oggetti diversi dalla poesia; e
2. analizzare davvero le poesie di Andrea Inglese nei termini di cui si è detto potrebbe essere davvero interessante, ma è un’operazione che richiederebbe troppo spazio per il post di un blog, persino per un blog logorroico come questo. Ci vorrebbe un articolo dedicato, e un po’ di tempo a disposizione per scriverlo. Per ora spero che il poco che sono riuscito a dire almeno aiuti ad apprezzare meglio queste belle poesie.
Volevo scrivere un post sulla poesia; volevo scrive un post su una poesia. Credevo di averla, la poesia su cui scrivere. Poi l’ho riletta, e non era adatta. Ci sono poesie che, quando le togli dal contesto in cui sono state pubblicate, si disfano, non reggono l’isolamento, perdono senso e valore. Questo non significa che siano cattive poesie, ma solo che, come tutta la poesia, sono delicate; sono come un cibo dal sapore così delicato che, se lo combini o lo accosti male non lo senti più, e diventa insignificante, e ti domandi perché te l’abbiano proposto.
Così sono andato alla ricerca di poesie un poco più robuste, che almeno potessero reggere l’isolamento dell’autonoma citazione, l’essere messi lì, come testi davvero autonomi, davvero autoconclusivi, così come siamo abituati dai tempi della scuola a considerare le poesie – le quali, certo, testi autoconclusivi lo sono, ma insieme anche no, perché a scuola ogni poesia ci viene propinata insieme con un sacco di informazione e di critica, che la rendono niente affatto autonoma, niente affatto autoconclusiva. Non è certo come leggere una raccolta, un vero libro di poesie (la poesia a scuola è sempre travisata, tradita) ma è comunque qualcosa, una preparazione, un riferimento, un riassunto del contesto che ci fa da sfondo.
Che cos’è che rende una poesia sufficientemente robusta (almeno in questo senso) da essere riportata da sola, da essere citata come testo autonomo? Naturalmente non il fatto di essere migliore e certamente non quello di essere peggiore. Forse una certa capacità di crearsi da sola il contesto, e quindi, di conseguenza, una certa forza, un qualche impeto – anche magari a costo di un poco di retorica: per avere forza, un testo deve presentare degli elementi che siano riconoscibili con qualche facilità, e gli elementi riconoscibili sono ovviamente elementi noti. Se non lo fossero, richiederebbero molto più tempo ed energia (e contestualizzazione) per essere compresi; il che non andrebbe necessariamente a scapito della qualità, ma certamente della forza, e dell’autonomia di presentazione.
Ho trovato quello che cercavo, dopo qualche tentativo, in un volume di Giovanna Sicari: Epoca Immobile (Jaca Book 2004). Ce n’erano parecchie, lì dentro, di poesie che facevano al caso mio, e ne ho scelte due. Ecco la prima:
Di lutto indescrivibile amore
È senza il tempo di una storia
ogni giorno una prostituta mi guarda
ha come me una fascetta sul braccio
anch’io della sua razza randagia irosa in cammino
mi mescolo al suo sonno alle sue albe
di cagna che vede giorno dopo giorno l’aprile nel petto
e solchi di strappi, pressioni, e tutto
il nuovo muta e si è miti per forza come lei,
bella bella di giorno mentre il suo lutto preme in un gorgo
e quando piove, il corpo aperto sbatte alla porta
del tempo – mostra quella fascetta sul polso infermo –
lei non lo sa da dove viene il pianto
dalla profondità di miserie e rancori
dalla classifica dell’odio, da un pomeriggio infame di luce
La componente retorica è piuttosto evidente: è il tema dell’identificazione dell’io poetico con un escluso, un calpestato, qualcuno che ha ragioni evidenti per star male, un correlativo oggettivo del proprio dolore. A questo va aggiunto un elemento formale meno immediatamente riconoscibile, ma non meno efficace. La prima parte della poesia è costituita da un unico lungo crescendo, in cui, verso dopo verso, aumenta la concitazione e la frequenza degli enjambement – secondo un modello classico stranoto, quello del sonetto di Foscolo A Zacinto. E sarà un caso, ma anche qui, proprio come là, il crescendo dura esattamente undici versi. Non è invece certamente un caso (non perché la Sicari abbia voluto rifarglisi esplicitamente, ma di sicuro ce l’aveva nelle orecchie) che la poesia prosegua con quella chiusa, dove il tono diventa esplicativo e rassegnato; e non è un caso che il primo verso della chiusa sia un endecasillabo, che riprende per un attimo proprio il tono del foscoliano “Tu non altro che il canto avrai del figlio”. Quando si usa il verso libero, l’improvvisa irruzione di uno schema metrico tradizionale (come l’endecasillabo) segna sempre un momento di rilievo, attraverso l’emersione inaspettata di un’eco della tradizione.
Potrei continuare, ora, a elencare gli elementi retorici, le riprese da una qualche tradizione. C’è il modo in cui l’immagine della fascetta sul braccio si propone all’inizio del crescendo, e poi si ripropone alla fine, con ben altra densità di significato, ora – anche qui secondo un modello di cui si potrebbero trovare tanti antecendenti. C’è la struttura tripartita della chiusa, sancita da tre “da”, con una classica progressione (in senso musicale), a cui corrisponde, dal punto di vista del senso, un nuovo breve crescendo – che culmina in un tragico ossimoro, quel pomeriggio di luce che potrebbe essere splendido se non fosse infame, perché infame è la vita che lo rende tale.
Spiegare una poesia è, inevitabilmente, riportarla al già noto; è quello che il lettore consapevole fa, nell’atto stesso di leggerla. Non si legge poesia né nulla, senza compiere questa operazione. Ma la ragione per cui un componimento poetico ci colpisce non è l’aderenza a una qualche tradizione. Dovremmo dire, semmai, che il componimento ci colpisce e, insieme, aderisce a una qualche tradizione; e attraverso questa coincidenza quella stessa tradizione improvvisamente ritorna viva, e improvvisamente ritorna a rappresentarci, a essere parte attiva di noi. Spiegare le poesie può essere utile, ma se il lettore non ne coglie autonomamente il lampo, la vita, il grido di esistenza, se non sente di colpo la corrispondenza con il proprio stesso sentire, qualsiasi spiegazione è del tutto inutile. La poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni: solo se riusciamo a sentire entrambe le cose, la poesia funziona (e che oggi, nonostante tutto, la forma dominante di poesia sia ancora la lirica è probabilmente legato al fatto che il nostro sentire personale, privato, intimo, resta legato all’idea di un io ugualmente privato e intimo – ma non è sempre stato così, né è detto che lo debba essere in futuro). Le spiegazioni ci aiutano a imboccare la strada buona, ma se poi non arriviamo a questo sentire unificante, le spiegazioni sono state inutili.
La seconda poesia della Sicari è quella che riporto qui sotto, meno drammatica, meno immediatamente riconducibile a strutture note (che però, a saperle ascoltare, ci sono ugualmente). La metto qui, senza commenti. Ho già parlato abbastanza.
I piedi sono candidi
I piedi sono candidi ma non ho scarpe buone
non ho cavalli per attraversare
scarpe rasoterra che attanaglino intorno
non ho slanci, privilegi, rare parole
le scarpe svaniscono in un serraglio
per me che non trovo una scorciatoia
per voi che mi custodite intatta.
Dove siete ora – uomini più bravi
di me – vi aspetto in una sala d’albergo
buia contrada in ordine sparso
spari nella notte, foresta, ghiaia,
festa da non udire.
I temi che ho affrontato due settimane fa in un post intitolato Delle questioni delle poetiche, della lirica, del soggetto e della leggibilità continuano a girarmi per la testa e a crearmi più perplessità che certezze. Il post era stato ispirato da un intervento di Andrea Inglese su Nazione indiana; e a farmi rimuginare questi temi hanno contribuito altri post, tenendo aperto un dibattito in cui questi stessi temi si inseriscono (anche se esso ne investe pure altri, che non affronterò qui): sono il post di Marco Giovenale ancora su Nazione Indiana, quello di Lorenzo Carlucci su Poesia 2.0, la prima e la seconda più articolata risposta del medesimo Giovenale su Slowforward, con tutte le relative abbondantissime discussioni, ora molto interessanti ora pura polemica personale.
Il punto (o almeno quello che mi ronza per la testa ora) è la questione della cosiddetta “riduzione dell’io”. Alfredo Giuliani scrive nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. Mi sembra del tutto ragionevole che Giorgio Manacorda (introducendo nel 2004 il suo La poesia italiana oggi. Un’antologia critica) faccia notare che c’è qualcosa di paradossale nel fatto che l’espressione, e per giunta l’espressione soggettiva, si debba realizzare mediante riduzione del soggetto medesimo, per cui “o il punto non è l’espressione, bensì il referto (appunto la riduzione dell’io a “cosa”) e allora va bene cancellare o anche solo ridurre l’io, o il problema è l’espressione, e allora perché ridurre l’io, magari fino a cancellarlo? Questa scelta ha avuto conseguenze per le generazioni successive.”
Non si può certo qui ripercorrere quello che è successo nella poesia italiana dagli anni Settanta in poi. Trovo però interessante che tutti e due i corni della scelta – che Giuliani cercava ancora, eliotianamente (montalianamente?) e pericolosamente di tenere insieme – abbiano trovato espressione, e prodotto, talvolta, anche opere di qualità.
Non riesco, proprio per questo dunque, a far a meno di vedere nelle dichiarazioni di Giuliani qualcosa di molto meno assertorio, universale e definitivo di quanto il suo tono di voce voglia far credere. Le frasi chiave del discorso di Giuliani mi paiono in verità queste, appena dopo l’apertura del saggio introduttivo: “Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo.” Se leggiamo tutto il resto alla luce di questo, ci appare evidente che Giuliani non sta dicendo come si debba fare poesia in generale, ma semplicemente proponendo un percorso di uscita da una situazione culturale di stallo; e che Pasolini ne fosse in quegli anni l’emblema lo dimostra abbastanza chiaramente la sua successiva parabola poetica involutiva.
In altre parole, Giuliani sta proponendo di rinnovare la poesia italiana guardando più a Eliot e Pound che a Pascoli e Corazzini. Ma cosa ne sarà del valore di un’affermazione di questo genere qualche anno dopo, una volta che la poesia sia stata davvero rinnovata? Se la scelta starà tra “riduzione dell’io” e “espressione soggettiva”, una volta che la “riduzione dell’io” abbia vinto, dovremo ritornare all'”espressione soggettiva” per rinnovare di nuovo? E poi ancora viceversa? Certo che oggi, cinquant’anni dopo, potremmo magari leggere proprio in questi termini quello che è accaduto in seguito, e valutare in termini di progressisti e conservatori ora gli uni ora gli altri, ora i riduttivisti ora gli espressivisti.
Le polemiche che si possono leggere in calce ai post che ho citato sopra appaiono spesso (non sempre) impostate davvero in questi termini. Assunta come opinione condivisa che sia positivo essere progressista e negativo essere conservatore, ci si scanna per decidere chi sia il vero progressista. Naturalmente scannarsi serve anche per proporsi pubblicamente, e quindi in questo dibattito c’è senz’altro una forte (e positiva) componente di promozione personale (insomma, di autopubblicità). E questo va benissimo, soprattutto con il poco interesse che gira nell’aria in Italia per la poesia: magari qualche dibattito acceso può richiamare l’attenzione di qualcuno, e far venir voglia persino di leggere le opere.
Ho tuttavia la sensazione che il dibattito manchi il punto, e che ci siano troppi elementi sia a favore che contro (tanto per i riduttivisti quanto per gli espressivisti) per poter prendere partito per una delle due posizioni. A me pare semplicemente che quando un lavoro poetico è davvero riuscito, se ne percepisca sia una componente di espressività che una di superamento della soggettività: se sentiamo che l’io straborda, non è poesia, ma diario, autobiografia; se dell’io non troviamo traccia non è poesia, ma tabella, elenco, calcolo. D’altro canto, ci sono poesie riuscite in cui apparentemente l’io straborda, ma sono riuscite perché è facile rendersi conto che questo strabordare è pura apparenza, presentazione di un caso umano – e la poesia è riuscita perché quel caso umano è sentito come universalmente rappresentativo. E ci sono anche poesie riuscite in forma apparente di elenco o calcolo, dove ci si accorge che da quelle relazioni apparentemente astratte emerge in verità un universo di significati, e di nuovo qualcosa di universalmente rappresentativo. Nell’uno e nell’altro caso questa universale rappresentatività non è necessariamente una verità: può essere una domanda, un dubbio, una ricerca; comunque sia è qualcosa in cui ci possiamo riconoscere – e possiamo riconoscerci, con questo, parte dell’umanità.
Poiché nella poesia che funziona, quella che è bella, profonda, riuscita, non trovano spazio vero né la riduzione dell’io né l’espressione soggettiva, e tuttavia entrambe possono farne parte come mattoni da costruzione, i simpatizzanti di ambedue i partiti possono con una certa plausibilità accusare gli avversari di cercare di mettere nella poesia qualcosa che non ci dovrebbe essere. Dovrebbe essere evidente, a questo punto, la natura pretestuale di entrambe le posizioni: sono due ricette, ciascuna delle quali pretende di produrre la vera poesia; due apparenti scorciatoie, o, se siamo più generosi, due proposte di percorso. Alla poesia buona, di qualità, si può di fatto arrivare sia per l’uno che per l’altro percorso, o anche (credo) per nessuno dei due. E la poesia buona soddisferà tutti e due i partiti, perché gli uni vi ritroveranno l’assenza della riduzione dell’io, e gli altri quella dell’espressione soggettiva.
Bisognerebbe relativizzare, a questo punto, anche il concetto di “poesia buona”. A che cosa si aspira quando si fa poesia? A influenzare il presente? Ma allora basterebbe una buona comunicazione funzionale. A poter essere storicizzati? E allora basta trovare il pubblico giusto, che siano i tanti (ma anche di scarsa competenza poetica) della Merini, o che siano i molto meno (ma di molto superiore competenza poetica) di De Angelis. Chi vale di più, dei due? Integrati e apocalittici hanno pane per i reciproci denti. E la storia si scrive anche attraverso queste discussioni.
Personalmente, preferisco di gran lunga De Angelis, ma ci sono anche per me, qua e là, alcune poesie illuminate della Merini. La critica è utile, spesso indispensabile, ma l’emozione della lettura alla fine riguarda me e solo me; e sono solo io a poter dire che cosa è buona poesia e cosa non lo è. Per questo, se non c’è un numero sufficiente di io ad apprezzare la poesia, buona o cattiva che sia è come se non esistesse.
Se il proprium delle avanguardie è la centralità della poetica e la sua prevalenza sull’opera (un commento nei dibattiti di cui sopra mi ha ricordato che lo ha pure sostenuto Eco nella sua prolusione ai quarant’anni del Gruppo 63 – ma ne ero convinto comunque), allora è proprio l’idea di progetto a essere al centro del lavoro dei loro autori. Ma pensare la poesia come operazione sul linguaggio, alla Giuliani, o operazione politica, alla Brecht, significa pensarla come comunicazione funzionale.
Ora, una buona comunicazione funzionale è certamente un valore positivo, ma la nostra concezione della poesia di fatto non si risolve in quello. Se si risolvesse in quello, i dibattiti tra poeti e tra poetiche non farebbero che esplicitare quale sia il proprio scopo comunicativo, e si discuterebbe, a parità di scopi, quale sia il modo migliore per raggiungerli. E invece l’ambiguità medesima in cui cade Giuliani cercando di tener salda sia la riduzione dell’io che l’espressione del soggetto deriva proprio dall’impossibilità di intendere funzionalmente la poesia – nonostante lui stesso in vari momenti cerchi di presentarla così.
Se riduciamo la poesia a comunicazione funzionale non c’è poi modo di tenerla fuori dalla logica alienante del mercato, dallo “sfruttamento commerciale cui la lingua è sottoposta” (sempre Giuliani, ibidem). Vista in questi termini, ci sarà sempre, prima o poi, una situazione in cui la logica del mercato la re-ingloba, anche, al limite, se si è Balestrini, o e.e.cummings.
D’altra parte, se riconosciamo alla poesia una dimensione differente dalla comunicazione funzionale, questa dimensione potrà manifestarsi a volte persino nelle poesie della Merini, o magari nei versi di un cantautore, persino di uno di successo. Ci troveremo costretti a constatare che la qualità di un’opera non ha a direttamente che fare con il suo successo commerciale, non in positivo (coincidenza o dipendenza) ma nemmeno in negativo (esclusione).
Adorno è morto, per fortuna. La sua grandezza di critico e filosofo ci ha impedito di vedere per molto tempo i danni che la sua estetica ha prodotto.
19 Ottobre 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, avanguardie, estetica, fumetto, lirica, poesia, poetiche, progetto, riduzione dell'io, sacro | Category: estetica, fumetto, poesia | Nel post di Andrea Inglese “Che genere di discorso” pubblicato su Nazione Indiana del 12 ottobre, e soprattutto nel dibattito da esso generato, si incontrano una serie di temi che mi impongono una riflessione: c’è la questione delle poetiche, ovvero delle dichiarazioni di intenti degli autori; c’è la questione del soggetto e c’è quella della lirica; e c’è la questione della leggibilità. Sono temi interessanti anche perché non riguardano solo il mondo della poesia e della prosa, che è quello di cui specificamente si discute in quella sede; investono piuttosto qualsiasi produzione o comunicazione di carattere estetico, da quelle che definiamo tradizionalmente “artistiche” sino a quelle di carattere esplicitamente funzionale, come la pubblicità.
Sulle poetiche, mi fa sorridere che Inglese, dopo un’evidente dichiarazione di poetica, ammetta nei commenti, in risposta a una mia obiezione, di non credere davvero sino in fondo alle dichiarazioni di poetica: “sono scettico rispetto alla nozione di poetica. O meglio, ho raggiunto una certa idea di cosa sia la poetica: un campo di proiezioni immaginarie sul proprio fare.” Mi fa sorridere perché l’ambiguità in cui, con questo, Inglese cade è probabilmente inevitabile oggi, per chiunque si cimenti con una produzione artistica, poetica, prosastica, filmica, pittorica o fumettistica che sia (o quant’altro). E credo che lo sia perché rispecchia un’analoga ambiguità presente oggi nella nozione di Arte.
Quando frequentavo l’università, ho fatto in tempo a seguire le lezioni di Luciano Anceschi, che ci parlava dell’estetica e delle poetiche, sottolineando il valore e l’importanza di queste ultime assai più della prima – che nella sua visione finiva per essere quella che lui chiamava, se ben ricordo, una “sistematica”, contrapposta al “sistema”, per esempio, di Adorno (che era, nell’anno in cui lo seguii, l’argomento del corso). Fu così che per il suo esame preparai una tesina (ma lo spessore non giustificherebbe il diminutivo) sulle poetiche dei Novissimi.
Con questo accento forte sull’importanza delle poetiche, ho dato per scontato per molto tempo, io come tanti, che si trattasse di un problema costitutivo della produzione artistica. E non c’è dubbio che per il Novecento lo sia: ma prima? Ci sono delle dichiarazioni di poetica precedenti al Manifesto del Futurismo che siano davvero tali? Qualcosa del genere indubbiamente c’è, perché spesso gli artisti hanno riflettuto sul proprio lavoro; tuttavia la mia sensazione è che manchi a quelle dichiarazioni quella dimensione programmatica che invece da Marinetti in poi diventa cruciale, e che rende le poetiche del Novecento assolutamente peculiari.
La mia sensazione è che la nascita delle poetiche (in senso novecentesco, di qui in poi) sia una conseguenza dell’affermarsi dell’idea di progetto, in campo comunicativo e in campo politico. Il progetto è ciò che permette di finalizzare una comunicazione, di decidere a priori quali scopi si vogliano raggiungere, e con quali mezzi ci si proponga di agire: è il mito che attraversa l’universo del design (che significa non solo disegno, ma anche progetto) dal Bauhaus a Ulm e oltre, ma è anche quello che chiaramente si ritrova nel programma di Marinetti. In questo senso le avanguardie sono chiaramente le figlie di una mentalità razionalistica e progettuale, che si distingue da quella del design industriale solo per la diversità degli scopi e degli strumenti specifici.
Se dovessimo valutare le opere delle avanguardie sulla base delle poetiche espresse, ovvero dei progetti dichiarati dai loro autori, la nostra valutazione sarebbe non molto diversa da quella che uno studio di valutazioni qualitative compie su una campagna pubblicitaria: è riuscita se (e solo se) ha raggiunto lo scopo che si proponeva. E con tutto questo non intendo affatto sminuire l’ideologia del progetto, che è la vera sostanziale novità del Novecento, trasversale dal marxismo sino ad Heidegger e all’esistenzialismo, dalla giocosità dadaista alle teorie sulla progettazione del software.
Tuttavia, di fatto, non è in questi termini che ci poniamo di fronte a quegli oggetti che definiamo opere d’arte, o, almeno, non è solo in questi termini. Esiste un modo tradizionale, antico, di sentire il bello come espressione di valori positivi condivisi dalla comunità, che precede la nozione stessa di Arte, la quale è una nozione moderna (ne ho parlato più a fondo in un post su Coomaraswamy). Secondo questo modo, l’Arte ha a che fare non con l’estetico, bensì con il sacro. Il Romanticismo, in epoca di positivismo imperante, cerca di recuperarne l’essenza attraverso l’intromissione del sentimento e del soggetto, perché la soggettività e l’interiorità gli appaiono come le uniche risposte possibili alla desacralizzazione che sta compiendo la scienza. Così si costruisce un’idea dell’Arte che poi il novecento insieme combatte e perpetua: che ha ragione di combattere perché si tratta di una perversione contingente, e che ha ragione di perpetuare perché spesso appare come l’unico legame rimasto con quella sacralità così essenziale – una sacralità che non è necessariamente religiosa, ma è semplicemente un senso mistico della comunità.
Esporre la propria poetica e insieme dichiarare che non ci si può credere davvero è dunque l’espressione di questa oscillazione tra un’Arte come progetto, che ci permette di liberarci dalle pastoie romantiche dell’esaltazione dell’io, e della lirica intesa in questo senso; e un’arte come sacralità, in cui la dimensione irrisolvibile del simbolo si lega a un senso collettivo che trascende a priori il soggetto, senza negarlo ma senza nemmeno porlo come mediazione irrinunciabile (come fanno i Romantici). Rinunciare alla poetica significherebbe rinunciare al dialogo con le espressioni artistiche del novecento; ma rinunciare al sacro significherebbe rinunciare a quello che sentiamo come Arte – e fare, del tutto legittimamente, e magari anche ottimamente, della comunicazione funzionale. Tuttavia, in questo modo si rinuncerebbe al dialogo con tutto quel mondo che noi sentiamo come Arte e che precede il novecento – a meno di considerarlo, del tutto legittimamente ma un po’ riduttivamente, anch’esso come comunicazione funzionale.
Tuttavia, perché la riduzione (anche parziale) dell’io deve coincidere con un aumento della complessità dell’opera e delle difficoltà di fruizione da parte del lettore/spettatore? Certo che l’opera difficile, oscura, attinge più facilmente alla dimensione del simbolico, ed è più facilmente distinguibile da quella della comunicazione funzionale tout court, specie se si intende svalutare quest’ultima come troppo compromessa con i mali del presente. Così, la scarsa leggibilità è certamente una scorciatoia per dichiararsi dalla parte del sacro, nonostante si continui a progettare la propria comunicazione. Un testo facilmente leggibile è più facilmente sussumibile – non c’è dubbio – alle logiche del consumo, che sono antitetiche a quelle del sacro. E senza progettazione non c’è avanguardia, sia nel senso storico, che nel senso più banale di gruppo organizzato attorno a uno scopo politico (magari anche solo politico-culturale).
Mi sembra che siamo di fronte a un bel nodo di contraddizioni, ben difficili – forse impossibili – da sciogliere. Eppure l’io, la lirica, la leggibilità, mi sembrano tutti temi-ponte, parole d’ordine su cui aggregare il dibattito, su cui organizzare la comunicazione che permette poi all’opera di essere conosciuta, avendo incuriosito qualcuno, e di essere letta, fruita. Un’opera che non viene fruita è come se non esistesse.
Voglio concludere facendo osservare che le cose non procedono allo stesso modo su tutti i fronti. Se nel campo della poesia e dintorni la ricerca verte sul come mettere un po’ da parte questo io troppo strabordante e imbarazzante, nel mondo del fumetto sembra invece essere proprio la ricerca dell’io e del suo intimismo a definire un percorso di rinnovamento, e di differenziazione dal passato. Il punto è che le forme non sono universalmente distribuite allo stesso modo, e quello che vale come novità in un campo può non valere affatto in un altro.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|


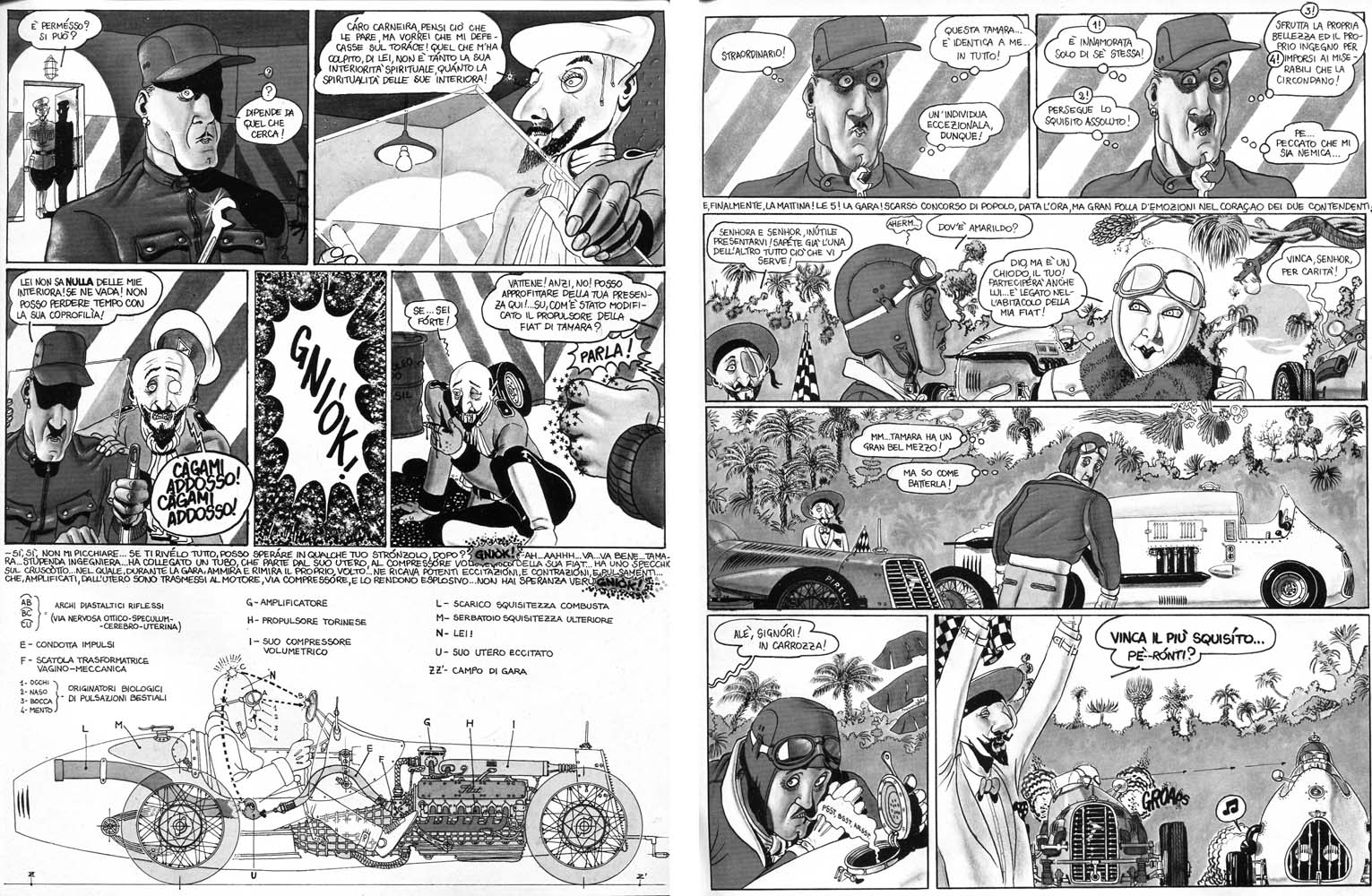











 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email






















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco

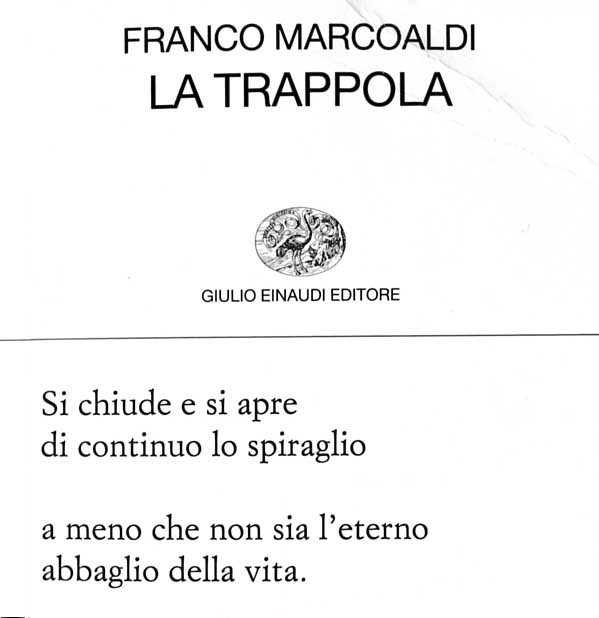
Commenti recenti