19 Marzo 2018 | Tags: Distonia, poesia, poesie mie | Category: poesia, poesie mie | 
Distonia è uscito, edizioni Kurumuny, collana Rosada. Sono contento ed emozionato.
A Bologna potete trovarlo alla libreria Trame, via Goito 3/c; altrove nelle librerie del circuito Rosada, elencate qui, tra cui le librerie Coop (anche a Bologna). Potete acquistarlo pure sulla pagina dedicata del sito dell’editore Kurumuny. Tra qualche giorno sarà anche su Amazon.
 Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere. Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere.
Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male).
Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi).
Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.
I like to hear it. I write because I am personally amused by what I do, and if other people are amused by it, then it’s fine. If they’re not, then that’s also fine. But I do it for my own amusement. (1994, pag. 38)
Well, I don’t really understand people who think of art as an antidote to entertainment, something that should not give you a pleasurable experience. What’s wrong with that? I mean, the idea of punitive art – that sounds like something from the East Village. (1994, pag. 38)
Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):
Nella prospettiva adorniana il pop è intrinsecamente vile, “basso” non tanto perché sia musicalmente incolto, ma in quanto musica connaturata all’intrattenimento, all’evasione, ossia al divertimento e dunque portatrice di un’attitudine menzognera , congenitamente antitetica a una musica d’arte il cui compito è invece di guardare in faccia e svelare la terribile realtà del mondo attuale o, diversamente, sprofondare in se stessa alla ricerca di una verità interiore che non accetta compromessi di sorta.
La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare.
Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra.
Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare.
È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso.
***
Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore.
Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie.
Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo.
Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere.
La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?
Della poesia fatta a macchina, e anche di Sergio Rotino
di Daniele Barbieri
A home transformed by the lightning
the balanced alcoves smother
this insatiable earth of a planet, Earth.
They attacked it with mechanical horns
because they love you, love, in fire and wind.
You say, what is the time waiting for in its spring?
I tell you it is waiting for your branch that flows,
because you are a sweet-smelling diamond architecture
that does not know why it grows.
È attraverso una segnalazione di Enzo Campi su Facebook che arrivo a questo articolo di Salvatore Luiso, “La poesia che (non) si doveva scrivere”. L’articolo inizia citando una (discreta, anche apprezzabile) poesia in lingua inglese (qui sopra), rivelando poi che non è stata scritta da nessuno, bensì composta da un algoritmo, un’Intelligenza Artificiale insomma, intorno al 2010. Ora cito io dal medesimo articolo (più veloce, onesto, e comodo che riassumere – per vedere il contesto vale il link sopra) che sviluppa il discorso a situazioni ancora più recenti:
Venendo a qualcosa più vicino a noi, Galileo.net ha pubblicato un articolo molto interessante sul lavoro di Jack Hopkins, fondatore della Spherical Defence Labs LLC di Londra ed ex ricercatore presso il laboratorio di Informatica di Cambridge. Hopkins sta sviluppando alcuni algoritmi per “insegnare” ad una rete neurale artificiale a comporre poesie paragonabili a quelle dei poeti umani. Il suo sistema è molto più “professionale”: sono stati caricati nel programma ben 7,56 milioni di parole ricavate da libri di poesie del ventesimo secolo. Questa IA, inoltre, avrebbe una speciale memoria sia a breve che a lungo termine, “esercitandola” alle emozioni. Il risultato è che il nuovo sistema riesce a scrivere poesie in diverse forme ritmiche, adoperando soluzioni formali e strutture retoriche, persino la rima.
L’IA di Hopkins è in grado di scrivere poesie su molte tematiche: proponendogli una poesia sull’estate, il sistema troverà tutti i termini che richiamano la stagione più calda e ci comporrà una lirica. Nel 70% dei casi in cui l’IA ha composto una poesia “sensata”, gli esseri umani non sono stati in grado di distinguere fra queste poesie e quelle composte da autori umani, trovando spesso le prime addirittura più belle, dunque emozionanti.
Ci sono alcune precisazioni da fare. Quando si dice “in cui l’IA ha composto una poesia sensata” si implica che c’è stato qualcuno, presumibilmente umano, che l’ha giudicata sensata. Quindi è stata compiuta una scelta sui risultati della produzione automatica. Di questa scelta ignoriamo i criteri, ma potrebbe anche trattarsi di criteri minimali di coerenza semantica – non di qualità estetica. Il problema sollevato da questa storia non cambia però di molto: comunque, un algoritmo ha generato poesie (non tutte, non sempre – ma quale umano lo fa?) che alcuni lettori hanno apprezzato (e tra questi, in qualche misura, anch’io).
Ora, il problema non è – come sembra credere Luiso, o anche Hopkins – se i computer davvero comprendano o sentano emozioni (o possano essere “esercitati” alle emozioni). Il computer non ha fatto che seguire regole che derivano dalla combinazione frequente di parole frequenti. Se invece di sottoporgli un corpus di poesie, gli avessimo sottoposto un corpus di ricette culinarie, il computer avrebbe prodotto ricette culinarie. Non lo avrebbe fatto, presumibilmente, con altrettanto successo: una ricetta culinaria deve certamente parte del suo successo al modo in cui viene scritta, ma se poi la ricetta, al momento di metterla in pratica, non funziona, la correttezza linguistica si rivela insufficiente, e il criterio dominante rimane un altro.
Una poesia non è però una comunicazione pratica con diretto effetto sul mondo, e la sua valutazione dipende unicamente da come è scritta. In più, proprio per questo, il lavoro che su di lei compie chi la sta leggendo è assai più importante che in qualsiasi altro tipo di comunicazione verbale. Potremmo dire che una poesia è un oggetto di proiezione, una specie di macchia di Rorschach su cui ogni lettore proietta ciò che può proiettare (senza che questo, evidentemente, si traduca in un giudizio sulla sua psiche); e la qualità di un componimento poetico è la qualità delle proiezioni che permette o suscita. Questo meccanismo può funzionare così bene da produrre un attaccamento anche molto forte da parte del lettore (e io stesso, come lettore di certe poesie, non faccio certo eccezione).
Ma questo meccanismo permette anche che, attraverso identificazioni potenzialmente molto diverse tra loro, lettori diversi si trovino accordati sul medesimo andamento, sul medesimo ritmo poetico (che è anche, ma non solo, quello prosodico-rimico: ci sono un sacco di altri ritmi in gioco in un testo poetico!). In questo modo, la situazione di fruizione collettiva prende la forma di una situazione rituale: benché lo facciamo in momenti diversi del tempo (e dello spazio) tutti noi lettori stiamo seguendo lo stesso andamento ritmico, stiamo vivendo un’esperienza accordata – come quella del ballo, o dell’ascolto musicale. Se la poesia prodotta dal computer, per ragioni qualsiasi, produce nei suoi lettori questa esperienza, allora è una poesia che in qualche modo funziona, ed è comunque una poesia di valore: anche se siamo ingannati, si tratta di un inganno positivo, fruttuoso; abbiamo davanti comunque un oggetto interessante.
La questione che questa storia pone non riguarda tanto, a mio parere, la supposta umanità del computer e la sua capacità di provare emozioni (semmai solleverebbe il problema di cosa sia l’umanesimo, ma sarebbe troppa carne al fuoco per questo post). Io la vedo diversamente: se la poesia composta a macchina può essere preferibile, più interessante, di poesie composte da umani veri, perché non domandarci come lavorano gli umani veri?
Cosa vuol dire essere un poeta? (Non faccio questa domanda da fuori: sono anch’io, comunque, un poeta.) Vuol dire cercare di rientrare, da autori, in un universo di testi di cui siamo stati in precedenza, e ancora siamo, lettori. Non c’è altro modo: se la poesia non ci ha affascinato come lettori, non potremo mai sentire il desiderio di riprodurre direttamente quella fascinazione – nemmeno se il nostro corpus di letture fosse quello banalmente scolastico. Se così fosse scriveremmo poesie altrettanto limitate, ma staremmo comunque riproducendo il meccanismo.
Per riconoscere come poesia quello che scriviamo (e se non lo riconosciamo noi certo non possiamo pretendere che lo riconoscano altri) quello che scriviamo dovrà…
Segue qui, su Nazione Indiana.
1 Settembre 2017 | Tags: Nadia Agustoni, poesia, racconto | Category: poesia |
Nelle spire del racconto, o al di fuori di loro – su Racconto di Nadia Agustoni
di Daniele Barbieri
Avendo lavorato e ragionato, nel corso della mia vita, sostanzialmente da semiologo, di racconto ho sentito parlare, e parlato a mia volta, parecchio. Non ho condiviso la tesi secondo cui qualsiasi testualità possiede, nascosta o palese, una struttura narrativa. Ritengo tuttavia che, anche se ogni tanto se ne può fare a meno, la struttura narrativa sia comunque abbondantemente presente intorno a noi. Di fatto, ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che possa essere descritto come un’azione (cioè un evento intenzionato da qualcuno) siamo anche di fronte a un racconto. Molte poesie sono quindi narrative, anche quando a prima vista non lo sembrerebbero, ma non tutte lo sono – o magari non lo sono nel loro insieme, pur contenendo elementi che, singolarmente, potrebbero essere considerati narrativi.
Il racconto è uno dei (principali) modi in cui diamo senso al mondo. Quando riteniamo di sapere perché e come qualcuno ha fatto qualcosa, e se alla fine ci è riuscito oppure no, il mondo ci appare più chiaro e affrontabile. Leggete Paul Ricoeur (Tempo e racconto) o Algirdas J. Greimas (Del senso e Del senso 2) e avrete un’idea dell’importanza che la forma-racconto ha per il nostro rapporto con il mondo.
È per questo che già Aristotele poteva parlare di catarsi, come esito per lo spettatore di una tragedia. Non importa che la storia abbia un lieto fine: è sufficiente che la fine ci sia, e che la vicenda (il racconto) si presenti come qualcosa che trasmette un senso complessivo, quello di una parabola (sia in senso matematico che biblico) che ci mostra il mondo (o almeno quel suo frammento) come se esso possedesse un disegno, e di quel disegno abbiamo colto le linee.
La differenza tra il mondo reale e il mondo raccontato (magari anche solo raccontato da noi a noi stessi, nel semplice dare senso a quello che vediamo) è dunque una differenza tra qualcosa di immediato ma non (ancora) compreso, e un mondo in qualche modo compreso ma che ha perso l’immediatezza.
Intitolare Racconto una raccolta di testi poetici, come fa Nadia Agustoni, prepara il suo lettore ad aspettarsi che quello che troverà sarà un qualche tipo di percorso, dove, qualsiasi cosa accada, alla fine ci sarà una risoluzione, se pur non necessariamente positiva (le tragedie infatti, Aristotele insegna, non sono meno confortanti delle commedie). E invece, sin dalle prime pagine e poi andando avanti sempre di più, la sensazione che si ricava è quella di una sorta di radiosa immobilità…
Prosegue qui, su Nazione Indiana
7 Maggio 2017 | Tags: Nadia Agustoni, poesia | Category: poesia | i volti tra le frasi il poco
dei giorni succede chiaro
le parole arrivano viene il mondo
una volta erano le voci
un che di cicoria e limoni
o terra a patire
e il gas falciava i prati
in un altrove dove le spine
dove noi e nulla –
scrivi sulla morte
lì cadono i bambini i fiori
che pensiamo per sempre
e senza le tue parole c’è altro
come se restasse il sangue di tutti
e tutta la vita per niente –
ma il male credimi il male
guarda se siamo soli
se siamo figli padri
qualcun altro –
ricordati chi rideva chi
disse cosa a chi
e non tornava risposta
ma un’eco
l’osso cranico
(io non sono la domanda)
*
perché la pianura sia vento
resta domanda e nel peso delle case
c’è questo cielo i camion che spingono
la polvere le finestre con l’obbligo di vivere
da qui a lì un confine.
*
a esistere c’è il buio
più grande – non pensare
come pensa il mondo.
sembriamo il cortile l’auto
e piango per l’idiota
la ragazza il campo
i vestiti bruciati di
chi è lasciato solo.
così andiamo con le storie
coi cerotti – un vaso
di mele gialle ci pensi i quadri
nei quadri l’albero dei limoni
quando crescevi
senza dire: “anch’io”.
*
nella postura di dopo
noi siamo io vivo
come ognuno vive
accanto
nell’ora che la luce toglie
nebbia torna il campo
i versi e la mia bocca
tornano voce
il tavolo e il campo
sono la voce
potrei sottovoce
fare assenza
*
i giorni chiari il vero
tutto resta sorpreso
le stelle non
credere
dolo di luce è l’inverno
la neve il fiato
l’ala nera dei cipressi
ci pensano
tu dici: “la morte
può solo sembrare”
così è più grande
questo vivere
che capisce
le prigioni
i poveri nemmeno
l’aria li raccoglie
non sanno il banco
d’imparare
prendono giugno o neve
e tutto sempre
gli basta
nel prato solo il prato
non tremano.
sanno il male
portato
col bene.
*
ma scrivo dalla disincarnazione
del dolore tra fabbrica e fine
queste parole mosse da un alito
nel cursore indocile.
sfioriranno nei padiglioni
del cielo contemplando il Tao
delle ingiustizie e faremo
pernacchie ai preti
fermi al sesso degli angeli
*
fabbrica non c’è parole
i secchi mettono il vuoto i secchi
sono l’acqua – c’è mezza luce
scrivi una volta quando i platani
sembrano madre e guardi
sui ginocchi l’entrata del
vento che non cura –
c’è un’intermittenza
che cammina insieme
al buio – le cose durano
dopo i fiori –
sei un mercoledì delle ceneri
il mattatoio dei guanti – i libri
sono il soffitto e la gente che credi:
così pensiamo il corpo nel petto
nelle spalle i petali di una casa
*
il mondo da capo
al minimo animale
fervore di passero
nulla più – il cielo
e universi aperti
dalla cenere.
*
scavare terra
prende la tua visione
ma nulla
nulla
nel petto la casa
clorofilla in bocca
e chiedere se questo
tutto questo
è esistere.
*
la fine è prima della fine
perché ci pensi –
ma dopo è soltanto
ricordarsi
e lo spaventapasseri
l’uccello
il campo
qui alzano gli spari
guardare come dentro un posto
a volte il vuoto
non è l’aprirsi
di un’altra storia
Daniele Barbieri
Nel freddo del male
Poiché il male fa male, va tenuto a distanza. Se si è troppo vicini, il male, anche se riguarda altri, ci è intollerabile. Può essere intollerabile anche quanto riportato, visivamente, sonoramente, letterariamente, ma la letteratura (e ancor più il mezzo audiovisivo) conosce da sempre le strategie per costruire la distanza: si può per esempio sminuire o enfatizzare. Si sminuisce limitando la descrizione, deumanizzando chi subisce il male, allontanando il soggetto che soffre attraverso il ridicolo… Si enfatizza facendo appello al sentimentale, o buttandola sull’horror, sullo splatter – che sono altri modi, in realtà, per sminuire, perché da un lato la retorica dei buoni sentimenti (della cristiana pietà) ci mette dalla parte di chi sta cercando di porre rimedio (anche se in verità nulla facciamo), e, dall’altro, l’accentuazione spettacolare trasporta il male in un’altra dimensione, quella, appunto, dello spettacolo, un universo di finzione, in cui agiscono personaggi e non persone, e di sicuro l’empatia che si può provare per un personaggio è di tipo diverso da quella che si prova per una persona. Dove c’è dramma c’è risoluzione; persino se la storia finisce male, essa comunque finisce, e quello che ce ne resta è soltanto una morale, in ogni caso consolante, per quanto negativa sia.
Lettere dalla fine è un libro sul male, che evita programmaticamente la spettacolarizzazione, e non mostra traccia di sentimentalismo; ma nemmeno deumanizza o ridicolizza. Naturalmente adotta una strategia di distacco, ma diversa da quelle elencate sin qui: quella di Agustoni è la strategia del raffreddamento, dell’occhio separato, della parola che osserva, apparentemente distante.
Manca prima di tutto un soggetto che dica io, che si ponga come il rispecchiamento patemico del dolore nel mondo. Il soggetto è infatti caldo, risponde al male con la propria afflizione, e così facendo funge da schermo nei confronti del lettore, proponendogli una via di pietà.
Dove il soggetto viene lasciato fuori, resta fuori anche la pietà, con il suo calore un po’ stucchevole. Qui, il freddo del male ci arriva direttamente, quasi come un vento da cui non abbiamo riparo.
Ma non arriva da solo, perché – di nuovo – se arrivasse da solo finirebbe ancora, più surrettiziamente, spettacolarizzato. Nei versi di Agustoni quasi non sembra che si parli del male. Si parla di cose di ogni giorno, o di esperienze particolari ma non in sé maligne. È come se il male traspirasse attraverso queste cose. Persino nei versi finali dedicati a Billy Budd (il marinaio ragazzino da un racconto di Melville, impiccato sostanzialmente per un solo gesto irruente) traspira solo una strana calma, una descrizione di quello che si vede attorno – e ci vuole un po’ di attenzione per accorgerci che la voce che parla è quella di un morto, di un impiccato al pennone della nave.
Eppure, pagina dopo pagina, questo discorso tranquillo, fatto di immagini anche solari e di accostamenti a volte sorprendenti, finisce per costruire un sentimento glaciale. Non siamo esposti in verità al vento del male; è piuttosto come se il mondo, nella sua bellezza, nell’insieme dei sentimenti che comunque trasmette, traspirasse il male, traspirasse la morte, traspirasse la fine.
Le lettere dalla fine sono lettere dal mondo in cui la fine è presente sin dall’inizio, sono lettere in cui anche il calore è freddo, perché solo così si può essere degnamente sinceri con i propri lettori, senza strategie di facile commozione – nell’onda di una tradizione che va da Antonio Porta a Giuliano Mesa.
È affascinante comunque vedere, leggendo questi versi, come pagina dopo pagina, il soggetto escluso ritorni in gioco. Non è un soggetto dilaniato come quello di Amelia Rosselli (quasi un paradossale soggetto dell’inconscio) ma forse solo una capacità di mettersi in sintonia, presentando il mondo (con il suo male ma anche con il suo bene) attraverso questa sintonia, un noi più che un io, un trasmettere stupore, un soggetto minimale, ma sufficiente a coinvolgerci, a lasciarci scorgere una struggente vena di calore nel freddo del male.
 Questo testo è stato pubblicato qui, su Bologna in lettere. Questo testo è stato pubblicato qui, su Bologna in lettere.
Lettere dalla fine, di Nadia Agustoni, è primo classificato (ex-aequo) al premio letterario Bologna in lettere 2017
22 Aprile 2017 | Tags: Ida Travi, poesia | Category: poesia | La poesia di Ida Travi mi rende inquieto. Leggendo Dora Pal. La terra, sua raccolta appena uscita, nella quale si continua il discorso iniziato tre libri prima, dando voce ai personaggi di un mondo che non esiste ma nonostante questo esiste, leggendo Dora Pal si ha al tempo stesso la sensazione di capire tutto e di non capire quasi niente, come se un’apparenza di facilità, di semplicità quotidiana, rivelasse in realtà una sorta di abisso di cui non si scorge il fondo. Ho vissuto, nel leggere in sequenza la serie di componimenti che costituisce la raccolta, la singolare esperienza di un etnologo che si trova di fronte a una cultura stranamente familiare e al tempo stesso sconosciuta, come un Ernesto De Martino nella sua terra del rimorso, alla ricerca di configurazioni che fossero in grado di darmi ragione di quei comportamenti così intimamente diversi, però anche stranamente familiari.
Ma il piccolo mondo dei Tolki, il popolo immaginario cui pure la vecchia Dora appartiene, è già all’origine una creazione letteraria, creata apposta per produrre nel suo lettore un’irriducibile sensazione di spaesamento dentro il consueto, dove lo schema esplicativo rassicurante applicabile dall’etnologo in qualsiasi terra del rimorso non può essere davvero applicato. E il lettore è condannato a rimanere lì, appeso a questa identità che è insieme un’alterità, a questa oscillazione tra l’altrove e il qui.
Intanto, dunque, le parole. Le parole di Ida Travi sono semplici, quasi banali…
Continua su Nazione Indiana, qui.
 Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos
Daniele Barbieri
Analizzare un testo letterario, o un testo artistico in generale, non può mirare a mettere in luce una verità del testo, nemmeno in termini di struttura semantica profonda – come invece l’analisi può (e dovrebbe) forse fare nella misura in cui il testo in oggetto ha un qualche tipo di finalità persuasiva. Ovviamente anche un testo letterario può avere una finalità persuasiva, e l’arte non è del tutto estranea alla propaganda ideologica. Tuttavia, nella misura in cui il testo fosse analizzato in termini di verità, o di significato profondo, non lo staremmo trattando davvero come testo artistico, limitandolo alla sua componente persuasiva. Una simile analisi di un testo letterario non sarebbe comunque inutile. Sarebbe piuttosto semplicemente parziale, la messa in luce di uno dei possibili percorsi di lettura, un passo certamente significativo, purché lo si intenda come un passo all’interno di un percorso, e non come una meta.
L’analisi che presenterò in queste pagine parte dall’assunto che un testo artistico non può essere risolto in nessuna delle sue letture, perché lo specifico del testo artistico è quella di stimolare sempre ulteriori letture – ciascuna delle quali andrebbe, eventualmente, sottoposta a nuova analisi. Non per questo l’analisi è priva di utilità: ogni lettura che del testo artistico si dà è una piccola comprensione del mondo, e uno stimolo per ulteriori letture dello stesso testo e anche di altri. Un’analisi semiotica non è, in questi termini, che una lettura particolarmente attenta e metodologicamente supportata, che permette di estrapolare aspetti che facilmente resterebbero altrimenti nell’ombra. Non c’è una pretesa di verità dell’analisi, bensì una di utilità, poiché anche là ove il lettore arrivasse a contestare tutte le osservazioni uscite dall’analisi, questo sarebbe già un successo in termini di fertilità ermeneutica – e quindi un favore fatto al testo artistico.
Ho scelto come oggetto dell’analisi un testo poetico del 2007, la sezione iniziale di un poemetto di Andrea Raos, Le api migratori. Ho scelto volutamente un testo contemporaneo, non canonizzato, il cui valore è riconosciuto (oltre che da me, evidentemente) da una cerchia relativamente ristretta di addetti ai lavori, come succede normalmente ormai per la poesia in Italia. In questo modo, oltre a valorizzare implicitamente e meritatamente il lavoro di Raos, questa analisi mira a presentarsi come esemplare prima di tutto in quanto analisi, e non come proposta di rilettura di un testo classico.
Quello a cui l’analisi mira è la descrizione di un percorso di fruizione da parte del lettore, un percorso esperienziale fatto di sintonizzazioni e prese di distanza, di tensioni e risoluzioni…
Prosegue su Il Sileno, vol.3 n 2 (dicembre 2016), anzi esattamente qui.
7 Novembre 2016 | Tags: estetica, poesia, poesia civile | Category: estetica, poesia |  La mia testa continua a ronzare sulla questione della poesia civile, e continua a fare qualche passo più in là. Sto cercando di capire perché la nozione di poesia civile (mi) appaia tanto più problematica della nozione (per esempio) di romanzo civile. La mia testa continua a ronzare sulla questione della poesia civile, e continua a fare qualche passo più in là. Sto cercando di capire perché la nozione di poesia civile (mi) appaia tanto più problematica della nozione (per esempio) di romanzo civile.
Proviamo a seguire questa linea di pensiero: in principio c’era l’epica, Omero, insomma. Era poesia civile, quella? Non mi sembra un’espressione adeguata per parlare dei poemi omerici. Questi però, indubbiamente, esprimevano una serie di valori in cui i suoi fruitori si riconoscevano, e sappiamo bene quanto fosse importante la funzione anche didattica dell’epica omerica. Proviamo allora a definire quella della poesia omerica come una funzione sociale della poesia, nel senso che proprio perché i valori espressi da quella poesia erano valori condivisi e fondanti per la società greca, la definizione di sociale può essere accettabile. Sottolineo che non sono particolarmente legato a questa parola, sociale; potrebbe andar bene anche un altro termine, purché diverso da civile. Potremmo dire che era umana, nel senso di portatrice di valori umani, ma questo potrebbe implicare che si tratta di valori universali; mentre erano semplicemente greci. Potremmo dire che era culturale, nel senso che contribuiva a costruire la cultura greca, ovvero il modo che i Greci avevano di pensare il mondo; ma questo potrebbe apparire riduttivamente cognitivo. Per ora, sociale mi sembra il termine più adatto; ma sono pronto ad abbandonarlo di fronte a proposte migliori.
Quello che è interessante è che, in questi termini, la lirica di Saffo non era meno sociale dell’epica di Omero. Se godeva di successo, era proprio perché a sua volta esprimeva dei valori socialmente condivisi. Si noti che l’espressione socialmente condivisi non vuol dire universalmente condivisi, nemmeno nell’universo ristretto della cultura greca. In altre parole, affinché la poesia di Saffo come quella di Omero sia sociale non occorre che i valori che esprime siano condivisi da tutti: è sufficiente che ci sia un gruppo che li condivide, e tanto meglio se si tratta di un gruppo influente, perché vasto o perché forte, o perché sufficientemente compatto e duraturo.
Dovremo insomma ammettere che la poesia di qualità, ovvero la poesia che viene apprezzata da un gruppo in qualche modo influente, è comunque poesia sociale, anche se parla d’amore, perché l’amore stesso è un fatto sociale, ed è estremamente sociale il modo in cui se ne parla e lo si affronta.
Il fatto che tutta la poesia, nella misura in cui viene apprezzata, sia comunque poesia sociale, non è esente da problemi. Appena (cioè sempre) la società non è compatta, appena gruppi sociali diversi hanno valori diversi, si diversificherà anche la possibilità di apprezzare la poesia sulla base dei valori che esprime. Certo, ci saranno presumibilmente dei valori molto profondi e indiscussi che vengono riconosciuti più o meno da tutti, e che permetteranno un consenso molto più vasto di altri.
Questo non vuol dire che questi valori siano universali. L’epoca della Controriforma dà per esempio vita, specie in terra spagnola, a una straordinaria vena di poesia mistica. I suoi valori erano certamente all’epoca ampiamente condivisi. Tuttavia, per me, oggi, apprezzare la poesia, poniamo, di Juan de la Cruz, mi costringe a un esercizio di selezione dei valori, arrivando a vedere quelli più specificamente cattolici come prodotto della sua epoca, con una componente ineliminabile di persuasività pro-fede (propaganda cattolica controriformistica, insomma), e salvando invece gli altri, che comunque ci sono, e contribuiscono a mantenere grande e viva la sua poesia ancora oggi. Se la poesia è sociale, è anche terreno di scontro sociale, inevitabilmente.
Nel frammento 84 della Gaia Scienza (non finirò mai di citarlo), Nietzsche sottolinea la straordinaria capacità persuasiva della poesia, dovuta al ritmo, e alla conseguente capacità di costruire un accordo condiviso, una Stimmung. Non è un caso che la riflessione di Nietzsche arrivi proprio sul finire di un secolo, l’Ottocento, che ha visto il trionfo della retorica (nel peggior senso del termine), ovvero della poesia utilizzata come motore persuasivo per cause politiche, dove la nobiltà della causa doveva essere associata alla nobiltà (ovvero classicità) del linguaggio.
A questo modo (pessimamente) civile di intendere la poesia, il Novecento contrappone un’incapacità di certezze, un’indecisione sistematica, un’epica (se vogliamo chiamarla così) dell’impossibilità dell’epica. Questa nuova poesia non è meno sociale della precedente: è che tra i valori che esprime adesso ce n’è uno fondamentale, che prima restava molto più in ombra, ovvero la problematicità del rapporto tra l’individuale e il collettivo. Per quanto paradossale possa apparire, l’accordo collettivo che si viene a creare su questa nuova poesia si fonda proprio sul riconoscimento della difficoltà dell’accordo, sull’impossibilità di risolvere la coscienza individuale nei valori civili, qualunque essi siano.
Quello che diventa cruciale, nella poesia del Novecento, è qualcosa che prima stava molto più nell’ombra (pur essendo presente) ovvero la sua capacità di mettere in movimento ciò che è assestato, di mettere in dubbio le certezze, di attivare dei modi differenti di guardare alle cose (di attivarli, non di proporli!), perché solo in questo modo essa esprime il valore (ormai fondamentale per noi) della problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. La poesia non è ora né più né meno sociale di prima, ma lo è certamente in modo diverso, perché si trova a cavalcare una contraddizione che è assurta a valore fondamentale.
La proposta di Balestrini con cui concludevamo il post precedente va esattamente in questa direzione. Balestrini vede nello scardinamento del linguaggio lo strumento per attivare dei modi differenti di guardare alle cose, con spirito profondamente nietzschiano (ma ora è il Nietzsche del Crepuscolo).
Che cosa succede quando la poesia non si limita ad attivare, ma cerca piuttosto di proporre dei modi differenti di guardare le cose. La mia sensazione è che, così facendo, la poesia stia invadendo il campo di altre forme espressive, più legittimamente persuasive, e che indebolisca implicitamente, in questo modo, la sua capacità di esprimere il valore del rapporto complesso tra individuo e collettività. Lo fa perché, proponendo dei modi specifici di guardare, sta già proponendo direttamente dei valori, e in questo modo sta anche proponendo l’appartenenza a una comunità ben definita, per quanto magari alternativa a quella dominante.
In altre parole, la poesia che fa una scelta politica sta dichiarando un’appartenenza, e in questo senso può essere sentita come falsa (o addirittura propagandistica) da chi si riconosce nei valori della problematicità, dell’incertezza di appartenenza. Ecco quindi il problema della poesia civile: che per essere civile rischia di smettere di essere sociale. Che per sostenere un valore in cui io potrei pure riconoscermi, rischia di mettere in discussione un valore molto più profondo, in cui certamente io mi riconosco, perché è la base dell’idea stessa di libertà, che sta sotto a qualsiasi mozione civile.
Proprio perché la poesia è intimamente sociale, essa vive a monte di qualsiasi scelta politica. I valori di libertà, responsabilità individuale, capacità personale di arrivare a comprendere sono quelli che la nostra poesia implicitamente esprime, e lo fa attraverso il modo in cui essa è costruita ancora prima che attraverso ciò di cui parla. La poesia ci deve turbare, deve permetterci di vedere le cose come altrimenti non le vedremmo. Se cerca di darci soluzioni, non ci esprime più, nemmeno quando quelle soluzioni sono condivisibili da noi. Avrebbe scelto, in questo modo, la strada facile del consenso: ma il consenso per noi è la morte, la negazione della libertà.
Qualche volta riusciamo a chiamare civile una poesia che rispetta la problematicità del rapporto tra l’individuo e la collettività. Si tratta probabilmente di una poesia che attiva dei dubbi di carattere civile, piuttosto che asserire delle certezze, piuttosto che fare delle proposte. Le proposte ideologiche e politiche sono certamente una cosa importante, ma non spettano alla poesia. Per entrare in poesia esse devono distruggere valori ben più importanti, e trascinarla verso la triste retorica della poesia dell’Ottocento.
Certo, tutto questo non varrebbe più se i valori della libertà fossero tramontati. Credo che, per fortuna, non sia ancora così. Se lo fosse, quella che a me appare pessima retorica civile potrebbe legittimamente apparire ad altri come espressione di valori condivisi e profondi.
31 Ottobre 2016 | Category: estetica, poesia | Rispondo ai commenti di Renata, Francesca e Leila al post precedente con un nuovo post, perché ho scoperto di avere ancora troppe cose da dire per stare nello spazio ristretto di un commento.
Con Renata direi che siamo sulla stessa linea. E trovo anch’io azzeccata, come Francesca, l’idea che “la poesia è civile quando è pensiero critico di un presente condiviso” – anche se mi sembra che le conseguenze di questa posizione allarghino molto il campo, il che non è detto che sia sbagliato. Ma sarà ciò di cui parlerò tra poco.
Inoltre, sì, ci sono state epoche (e ci sono anche oggi luoghi nel mondo) in cui la poesia civile poteva avere davvero un’azione (comunicativa) civile. Non, di sicuro, qui e ora. Anzi, temo che in termini di azione civile, il cattivo romanzo che Francesca non scriverà sarebbe comunque più efficace delle buone poesie che invece scrive. Del resto, basta non illudersi, non pensare di essersi lavati la coscienza per aver fatto “pensiero critico di un presente condiviso” (e mi scuso con Francesca per averle attribuito l’espressione desiderio di successo – ma penso che, nel giusto contesto, anche sei lettori lo possano essere, un successo; e comunque non vedo perché il poeta dovrebbe sentirsi in colpa di averne sei, o anche sei milioni). Le poesie di Francesca hanno certamente un peso e un’efficacia in quanto poesie, ma mi permetto di dubitare che ce l’abbiano in quanto azione civile. Da questo punto di vista serviranno a far discutere persone che sono già sensibili al tema, cui magari basterebbe una qualsiasi altra occasione per farlo.
Con Leila (dopo un’iniziale perplessità, perché il suo discorso è articolato, e inizialmente sembra sostenere il contrario) mi trovo d’accordo. Quando parlo di sincerità intendo più o meno le stesse cose che dice lei quando dice che le cose bisogna averle vissute per parlarne, oppure avere una capacità straordinaria di immedesimazione. Torno in leggera dissintonia sul finale: “poiché io so solo scrivere poesia, allora questo è il mio modo per fare azione civile”. Sì, certo. Peccato che, inteso in questo senso, non sia di nessuna utilità civile.
Il che non vuol dire di nessuna utilità. Tendo a pensare, anzi, che questa problematica relazione con il civile dipenda dal fatto che la poesia è, diciamo così, meta-civile. Ovvero, che tutta la poesia, quella buona, che in un modo o nell’altro ci tocca, ci riguarda tutti come collettività, in una maniera che sta alla base, ancora alle spalle, degli atteggiamenti che generalmente definiamo civili, anche se parla di cuore-amore-dolore (e magari pure fiore) – purché parlando di cuore-fiore sia in grado di mostrarci un aspetto di quella relazione che ci era sconosciuto, o nascosto. Così facendo, persino la poesia d’amore potrebbe avere un valore civile, perché abitua a guardare le cose del mondo in maniera diversa da quella che il nostro modo di vivere (e il sistema culturale) ci impone. Scrivere e leggere (buona) poesia è quindi comunque un (civilissimo) esercizio di libertà, più importante e precedente di qualsiasi retorica dell’uguaglianza.
In ogni caso, le orecchie mi ronzavano. Sono andato a rileggermi i testi critici che accompagnano l’antologia I Novissimi (1961), e ci ho ritrovato più o meno tutti i termini del dibattito dell’altra sera e di ora. Riconoscendomi nano sulle spalle di giganti, mi sono messo al lavoro di scansiona, taglia e incolla, e ho prodotto le citazioni che seguono, tutte, a mio parere, molto pertinenti.
La prima è presa dall’Introduzione di Alfredo Giuliani all’edizione Einaudi del 1965 (sono le pagg. 3 e 4 della ristampa del 72), e il tema del discorso è “perché è nato questo libro, visto da quattro anni dopo”. Il bersaglio polemico è presumibilmente Pasolini:
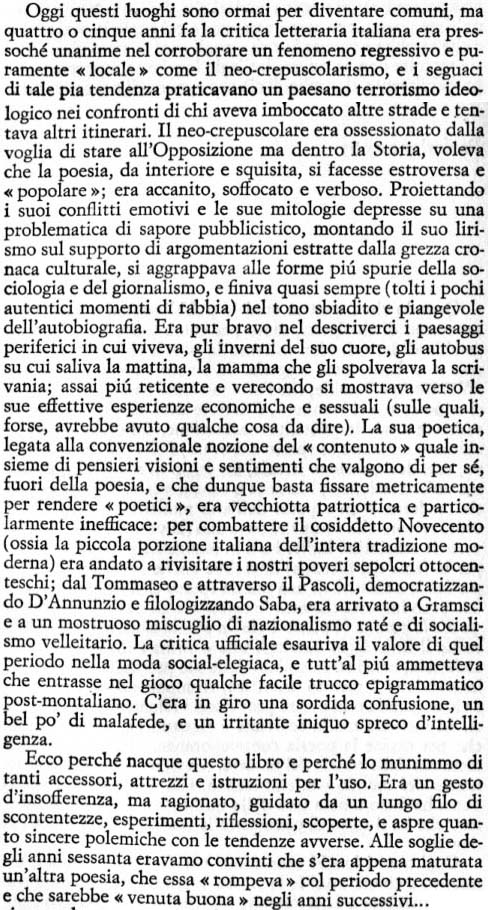
Si noti che quello che viene messo in discussione non è la vocazione civile dei”neo-crepuscolari”, bensì il loro rifarsi a una tradizione a cui non ci si può rifare, perché è il linguaggio stesso di quella tradizione a essere compromesso col potere. Detto in parole povere, parlare contro il potere utilizzando il suo stesso linguaggio, significa rafforzare le basi linguistiche su cui quel potere si fonda, e quindi in ultima analisi sostenerlo. Insomma: i neo-crepuscolari credono di fare poesia civile, mentre rafforzano ciò che credono di criticare.
Ancora va aggiunto che l’ermetismo non è tra i bersagli polemici di Giuliani, e non certo per connivenza. E’ semmai che in quel momento storico, e in quel dibattito, si dava per scontato che la poesia dovesse essere in qualche modo civile. Essere poesia in qualche modo civile è uno dei valori in gioco nel dibattito; mentre gli ermetisti ne sono già, solo per questo, evidentemente esclusi.
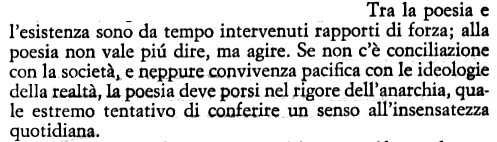
Qui siamo a pag. 5. Questa sembra essere una sorta di concessione a Balestrini, su cui arriveremo più sotto. E’ la posizione più estrema in merito che viene espressa da Giuliani: dove l’incidenza politica è di fatto impossibile, la poesia può (deve, per loro) scegliere la strada estrema dell’anarchia. Non so quanto Giuliani potesse essere consapevole dell’ulteriore isolamento che questa presa di posizione avrebbe portato alla poesia – ma si tratta comunque di una posizione civile. (Sull’eccesso di posizioni di questo genere ho parlato in un post di pochi giorni fa)
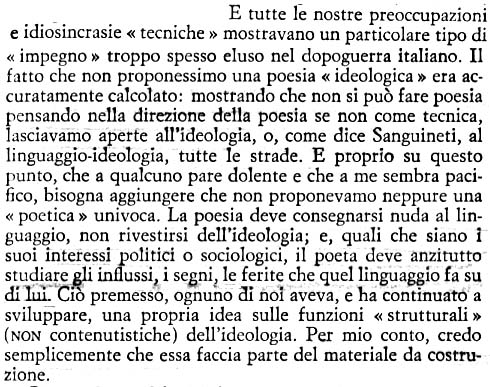
A pagina 11 (siamo sempre nell’introduzione del ’65) Giuliani esprime molto nettamente la sua posizione: non sono i contenuti che rendono ideologica (ovvero civile) una poesia, ma l’utilizzo che dell’ideologia si fa a livello di struttura (o, altrimenti detto, di linguaggio). Detto questo tra i cinque autori che partecipano alla raccolta, ciascuno si regola a modo proprio.
Le ragioni di questa posizione erano già state spiegate piuttosto chiaramente nell’Introduzione originale all’edizione del ’61. Eccole (pag. 18):
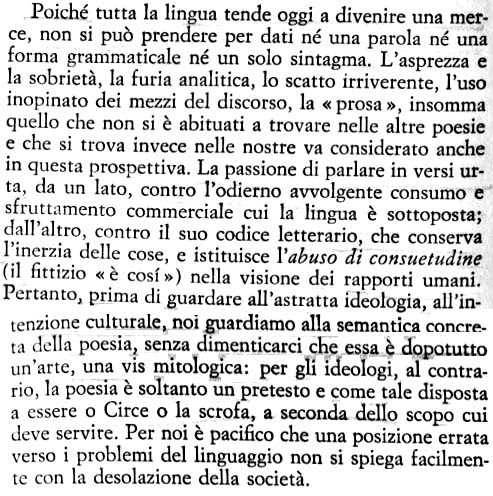
Guardare alla semantica concreta prima che all’astratta ideologia, e all’intenzione culturale, vuol dire proprio pensare che l’atteggiamento civile in poesia non riguarda i contenuti, ma un atteggiamento precedente, di natura strutturale. Insomma, lo specifico critico sociale della poesia sembra essere la critica del linguaggio, in una prospettiva fortemente nietzschiana. Nel frammento 84 della Gaia Scienza, Nietzsche parla proprio della truffa messa in atto dal linguaggio poetico, e poi, nel Crepuscolo degli idoli, della necessità di uccidere la grammatica per saltarne fuori.
All’atteggiamento neo-crepuscolare, Giuliani contrappone quello del suo compagno di viaggio Elio Pagliarani (pagg. 23-24):
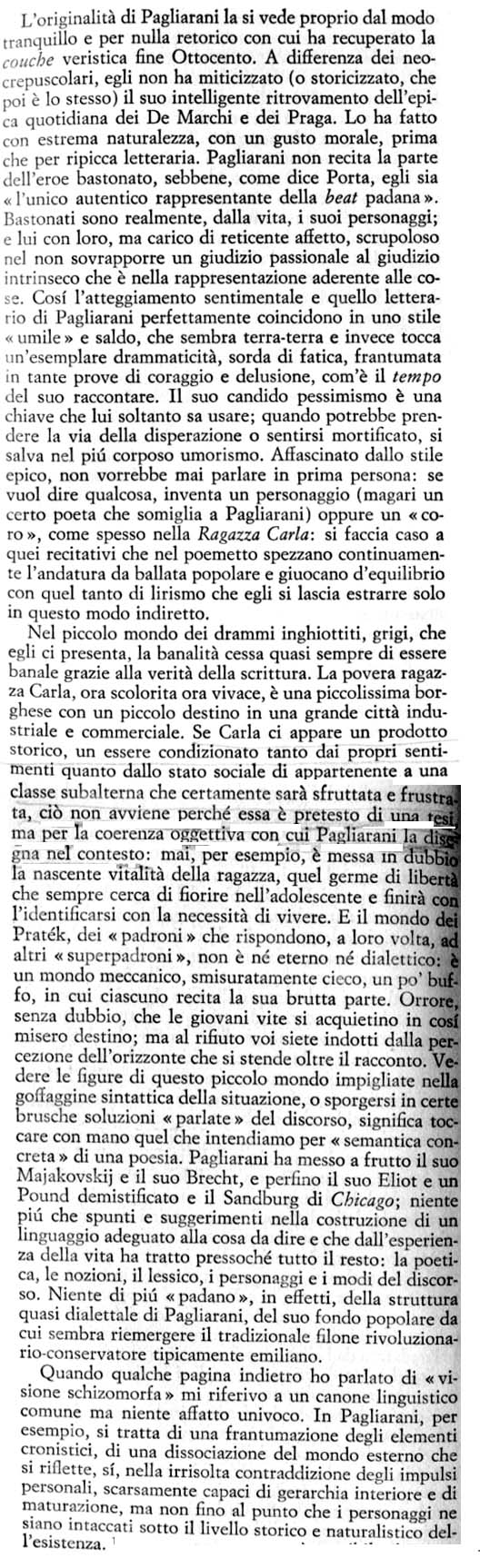
In Pagliarani, gli elementi ideologici si manifestano in questa scomparsa dell’io narrante/giudicante, oltre che nelle modalità di costruzione del suo poemetto. In verità, anche a livello di contenuti l’ideologia sembrerebbe non apparire (non c’è mai giudizio sui fatti, solo la loro presentazione); anche se, evidentemente, questo genere di contenuti appare più pacificamente civile.
Eppure, il poeta del gruppo che prende la posizione più schieratamente civile, non è Pagliarani, bensì l’apparentemente formalista Balestrini. Riporto qui l’intero intervento suo, in calce all’antologia (pagg. 196-198):
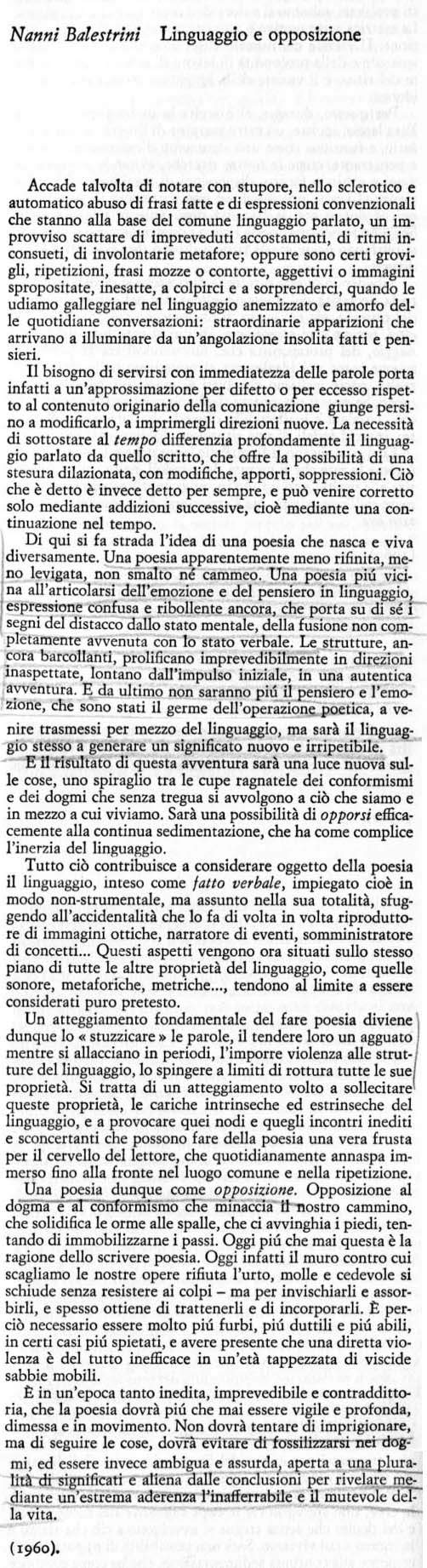
Fin dal titolo, la posizione di Balestrini è chiara: l’opposizione si fa con il linguaggio, e questo è lo specifico della poesia. Opposizione al dogma e al conformismo. Opposizione attraverso la distruzione della grammatica, prima base solida del potere.
Ora, siamo davvero lontani qui dall’idea di poesia civile come “pensiero critico di un presente condiviso”? Se assumiamo che il pensiero sia tale quando viene esplicitato, sicuramente lo siamo. Ma se riteniamo che il pensiero si possa manifestare anche attraverso le scelte strutturali, linguistiche, allora anche la poesia di Balestrini è certamente “pensiero critico di un presente condiviso”, e lo è in forma assai più radicale che in quei neo-crepuscolari in cui sembra così facile vedere la vocazione civile.
Spero di avere scompigliato a sufficienza le carte in tavola
28 Ottobre 2016 | Tags: estetica, poesia, poesia civile | Category: estetica, poesia | Ho partecipato ieri sera a uno degli incontri quasi settimanali che si tengono il giovedì presso l’osteria Vamolà, a Bologna, “I giovedì di/versi” (info qui). Ieri sera il tema dell’incontro era la poesia civile, con presentazione di alcune esperienze e dibattito aperto in seguito. Si tratta di una situazione semiinformale, con i pro e i contro del caso. Più strutturata la parte di presentazioni, più selvaggio il dibattito, attorno a un lungo tavolo di osteria (una trentina i partecipanti), con una gestione un po’ anarchica di molte voci desiderose di dire la propria – e, purtroppo, molto rumore di fondo. Ma anche così, il dibattito è stato acceso e fecondo.
Ho finito per non prendervi parte, un po’ subissato dal rumore di fondo che non favoriva la concentrazione, un po’ perché altri hanno detto una parte delle cose che avevo in mente, e un po’ perché non mi era del tutto chiaro quello che mi si è venuto poi chiarendo in seguito, e che voglio provare a esprimere qui. Della conversazione mi sono rimaste due voci (altre dicevano con meno chiarezza cose simili, ad altre ancora non ho avuto accesso acustico, per via del rumore di fondo). Mi perdonino le autrici degli interventi se sarò parziale; e mi perdonino maggiormente se farò loro dire qualcosa che non hanno detto: questo è quello che ho capito e che mi ricordo. Quindi me ne prendo tutta la responsabilità.
Marinella Polidori ha esposto, con molta verve, due tesi che faccio fatica a far stare insieme. In primo luogo quella, che almeno in parte condivido, secondo cui tutta la poesia è civile, purché si sottragga alla logica neoliberista del successo, del farsi vedere, del vendere – che ha ormai assoggettato quasi interamente la narrativa. Poi però, pressata dall’obiezione che così si perderebbe un po’ il senso dell’espressione poesia civile Polidori ha insistito sull’idea di cercare di salvare la parola “civile”, che per lei resta una parola nobile; e la poesia sarebbe civile, dunque, se collegata a un impegno di carattere sociale. A questa seconda versione, non del tutto compatibile con la prima, mi opporrò tra poco, e in parte anche alla prima.
Francesca Del Moro ha obiettato alla prima posizione che esiste anche un legittimo desiderio di riconoscimento e di successo da parte del poeta, e non lo si può ridurre a un asservimento al sistema. Ma soprattutto (su sollecitazione di qualcun altro) ha parlato del proprio recente volume Gli obbedienti, il cui tema è la vita in ufficio con le sue vessazioni. Riflessione sulla vita o denuncia civile?
Ora, io capisco e mi piacerebbe approvare l’idea che tutta la poesia che non si sporchi le mani con il sistema delle vendite è di fatto civile, ma capisco bene che così facendo si vanifica il senso di “civile”, perché non esisterebbe poesia che non sia civile. La poesia, in quanto tale, ha già scelto la strada della marginalizzazione rispetto alla grande editoria. Se voglio recuperarle un senso, legando la poesia civile all’impegno sociale, finisco per dire che non è così, perché anche tra i poeti non compromessi con l’industria ci sarà chi non si distingue per impegno sociale.
D’altra parte, anche la tesi secondo cui la poesia è civile se non si sporca le mani con il neoliberismo è difficile da sostenere. Supponiamo che un poeta che, come tutti, vive la sua situazione di marginalità culturale ed editoriale, diventi improvvisamente famoso, e i suoi libri inizino a vendere moltissime copie, creando un caso letterario. La stessa poesia sarebbe dunque civile prima e non civile dopo?
Proviamo a guardare le cose in un altro modo. Che cosa è azione civile nel campo della comunicazione? Io direi che è cercare di informare e convincere il maggior numero di persone rispetto a fatti e opinioni che consideriamo politicamente/civilmente rilevanti. In questo senso una graphic novel come Kobane Calling di Zerocalcare è certamente una riuscita operazione di letteratura civile. E’ fatta molto bene, fornisce informazioni e un modo intelligente e originale di vedere le cose sulla cultura dei Curdi e sul loro ruolo di combattenti nella guerra in Medio Oriente. E raggiungerà molta gente, compresi tanti che non si erano mai posti il problema, e che ora saranno magari più sensibili a questi temi.
Se vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto a una causa come quella del popolo curdo, la graphic novel può essere un ottimo canale, e lo è proprio in quanto inserito in quel sistema dell’editoria di successo cui la poesia è estranea. Tant’è vero che un buon servizio televisivo trasmesso nell’orario giusto potrebbe fare ancora di più (ed è infatti significativo che non lo si faccia). A quanto pare, per la massima efficacia di un’azione (comunicativa) civile la visibilità è essenziale, e quindi l’inserimento nel sistema (neoliberista) dei media.
Se vediamo le cose in questi termini, fare azione (comunicativa) civile attraverso la poesia appare davvero come tempo sprecato, in termini di sfruttamento delle risorse: tempo buttato. La poesia, come di solito accade, sarà letta solo dagli addetti ai lavori, di solito già sensibili ai temi in oggetto – e comunque davvero pochi. Insomma, se quello che ci interessa è fare azione civile, la poesia civile appare come una sorta di fallimento se non di truffa: se l’azione civile ci interessasse davvero utilizzeremmo altri mezzi. L’obiezione che farlo attraverso la poesia nobilita comunque il tema, cosa a cui forse qualcuno crederà ancora, non sposta le carte in tavole: si tratta di una nobiltà che interessa solo ai poeti. E io la trovo anche un po’ demodé, per non dire falsificatoria a sua volta.
E Pasolini, allora, non faceva poesia civile? Pasolini è un buon esempio: a mano a mano che si è reso conto che la poesia non era lo strumento davvero efficace per fare azione civile, la sua poesia si è disfatta in una sorta di prosa argomentativa in versi, che sceglieva contesti di pubblicazione, come i quotidiani, molto adatti all’azione civile e molto poco alla poesia. Alla fine sembra che della poesia gli importasse ben poco. Del resto, il cinema si prestava molto meglio a raggiungere un grande pubblico con temi civili.
Il libro di Francesca Del Moro che abbiamo citato sopra non sarebbe poesia civile, dunque. Io, per chiarezza, abolirei la nozione, che fa pensare che esista un genere specifico, nobilitato particolarmente dalla sua missione civile. Volendola conservare a tutti i costi, la nozione, ne propongo qui di seguito una versione minimale, ma dotata – almeno per me – di qualche senso (e che permette di conservare a Gli obbedienti la qualifica di poesia civile).
Proporsi di fare poesia civile, intesa come modo di usare la poesia per fare azione civile, è una falsificazione; un modo per lavarsi la coscienza, potendo dire di aver agito – mentre si è evitato di agire. Tuttavia fare poesia ha comunque un senso civile, che non è quello dell’azione civile, perché – come diceva inizialmente Polidori – è l’azione stessa di fare poesia anziché qualcos’altro di più compromesso con il potere a essere in sé civile. Proprio questo, secondo me, dovrebbe avere in mente il poeta: essere sincero con se stesso, non darsi fini di persuasione o propaganda (anche in senso positivo, come quella pro-Curdi di Zerocalcare). Potrà poi capitare, a posteriori, che una poesia scritta sinceramente possa essere riconosciuta da qualcuno come un intervento civile. E questo va bene; e questo potrà essere chiamato poesia civile.
Ma si tratta di una valutazione a posteriori, che non aggiunge (né certamente toglie) valore alla poesia. Insomma, la poesia civile potrebbe essere quella poesia che per qualcuno fa anche azione (comunicativa) civile, e che è buona o cattiva poesia in maniera del tutto indipendente da questo. Troppo spesso, l’entusiasmo per una causa condivisa ci porta a introdurre (se siamo autori) o a perdonare (se siamo lettori) eccessi di retorica che altrimenti eviteremmo. In questo senso, il civile fa frequentemente molto male alla poesia.
Ma ci sono stati grandi poeti nei cui versi echeggiano temi civili: poeti civili, dunque. Credo che la loro influenza sull’opinione pubblica sia stata comunque irrilevante. La poesia è di solito un discorso in cui ci si riconosce, e in cui si trova conferma. Per convincere chi ha opinioni diverse, la prosa argomentativa è già enormemente più efficace; ma anche la narrativa, verbale, filmica, fumettistica, teatrale che sia, funziona molto meglio. Diciamo che è bello incontrare buona poesia in cui scorrono idee civili in cui ci riconosciamo: questo è il massimo che all’idea di poesia civile posso concedere.
Le parole che seguono sono state scritte poco fa come commento a un articolo di Andrea Inglese pubblicato su Nazione Indiana, “Paesaggio e convenzioni figurative nella poesia italiana contemporanea”. Dopo aver inviato il commento, mi sono reso conto che la questione che affronta è in realtà più vasta dell’occasione per cui è – di getto – stato scritto, e ho deciso di pubblicarlo, come post autonomo, anche qui.
Il saggio, come sempre quando Inglese scrive, è acuto e pieno di spunti. Non posso che condividere l’idea del testo come paesaggio, visto che io stesso l’avevo buttata lì in un post del 2010. Tuttavia, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi, continuo a sentire una sorta di perplessità, di cui provo a spiegarmi il motivo in questo modo.
Sembra che questi testi testimonino l’impossibilità, in un mondo tardo-capitalistico, in cui la stessa parola è divenuta merce, di dire qualcosa che non sia l’impossibilità stessa di un rapporto sentimentale con il paesaggio. Quello che sarebbe rimasto possibile in questo contesto non sarebbe dunque il rapporto con il paesaggio, bensì quello con il film pubblicitario sul paesaggio. Di conseguenza, quello che la poesia può fare non sarebbe che “essere un prezioso strumento di rilevazione della realtà, ma in “negativo”, mostrando l’inadeguatezza dei nostri discorsi e delle nostre narrazioni e tenendo vivi la nostalgia e il desiderio di reale”. Insomma, l’unica possibilità sincera della poesia starebbe nel negativo, nel tener viva la nostalgia del reale. Il che mi ricorda molto le parole di Adorno a chiusura del saggio su Schoenberg nella “Filosofia della musica moderna”, e in generale il lamento di Adorno per l’impossibilità, oggi, di un’arte innocente, ovvero inconsapevole della corruzione (capitalistica) dell’immagine stessa del mondo (e del paesaggio).
Il mio disagio, di fronte ai testi di Giovenale e Broggi qui citati, è dovuto probabilmente alla sensazione che essi mi mettano di fronte all’ineluttabilità e generalità di questa sola possibile negatività dell’approccio poetico, come se l’approccio diretto al paesaggio fosse davvero ormai reso impossibile dal dominio del film pubblicitario (e di tutto ciò che esso sta a simboleggiare). Come se l’emozione e il sentimento di fronte al paesaggio fossero ormai possibili solo come “nostalgia”, perché l’emozione autentica è negata, comunque, dalla mediazione ideologica dell’apparato mediatico e delle sue capillari conseguenze.
Ora, io non credo che sia così. Né ho mai ben tollerato la heideggeriana nozione di “autenticità”, fatta propria e utilizzata da Adorno. Ci sta, nella mia intolleranza, la consapevolezza del fatto che, per parlare di autenticità perduta, è necessario avere un’idea dell’autenticità posseduta; ovvero ipotizzare un’età dell’oro in cui l’arte poteva essere innocente, mentre ora non lo è più. L’idea che l’accesso diretto al paesaggio che si poteva avere ieri, oggi è reso impossibile dal fatto che esso è inevitabilmente negato dal film pubblicitario, mi fa credere che ieri esso non fosse negato, e che un’arte innocente fosse davvero possibile. E’ l’idea di una possibilità perduta (ma esistita) che giustifica la legittimità di un’arte come nostalgia del reale, in cui non sia possibile esprimere l’emozione del rapporto con il paesaggio se non nei termini della sua negazione.
A questa logica io mi sottraggo, non certo per difendere la mistificazione capitalistica, che c’è; ma perché essa non è che la forma moderna di una serie di mistificazioni che hanno sempre condizionato il rapporto con il paesaggio, plasmandolo epoca per epoca. Ritenere che la mistificazione specifica della nostra epoca sia l’unica o la più grande è a sua volta una mistificazione, perché ci induce a ritenerci alfieri di una verità altrimenti perduta.
La mia opinione è che la poesia non può ridursi alla nostalgia e al negativo che la può generare, perché una visione in qualche modo positiva del rapporto col paesaggio resta possibile oggi come in ogni tempo – purché consapevole della propria dimensione relativa e condizionata. Purché non ingenua insomma. L’arte di qualità non è mai stata innocente, e ha sempre posseduto una componente negativa, in grado di “tener viva la nostalgia e il desiderio di reale”; ma non si è nemmeno ridotta a soltanto questo.
14 Ottobre 2016 | Tags: Bob Dylan, Dario Fo, Nobel, poesia, teatro | Category: poesia |  Baluginano lampi d’ira tra i letterati per il Nobel assegnato a Bob Dylan. La canzone non è letteratura! E’ vero, infatti, così come è vero del teatro. Nella canzone il testo verbale fa parte di un discorso cui la musica concorre in maniera fondamentale, e i semplici testi verbali di Dylan sono solo mezzi testi, e dunque non testi letterari in senso stretto. Ma lo stesso si potrebbe dire del teatro, che non esiste senza la messa in scena (la quale, non di rado, conta assai di più delle parole scritte). Vogliamo dunque contestare anche il Nobel a Dario Fo? Baluginano lampi d’ira tra i letterati per il Nobel assegnato a Bob Dylan. La canzone non è letteratura! E’ vero, infatti, così come è vero del teatro. Nella canzone il testo verbale fa parte di un discorso cui la musica concorre in maniera fondamentale, e i semplici testi verbali di Dylan sono solo mezzi testi, e dunque non testi letterari in senso stretto. Ma lo stesso si potrebbe dire del teatro, che non esiste senza la messa in scena (la quale, non di rado, conta assai di più delle parole scritte). Vogliamo dunque contestare anche il Nobel a Dario Fo?
In realtà, avremmo ragione forse più di contestare il Nobel a un uomo di teatro che non a un cantautore. C’è stata un’epoca, sino a non molti secoli fa, in cui tutta la poesia nasceva per la musica. Parte di questa poesia era epica: quando questa recitazione cantata si è incrociata con la cerimonia, è nato quello che chiamiamo teatro. Duro sarebbe dimostrare che la cerimonia è una forma di letteratura, e un certo aspetto cerimoniale il teatro l’ha giustamente conservato.
Quindi, cari amici letterati, tenete presente che contestare il Nobel a Dylan in quanto la sua non è letteratura significa implicitamente avanzare un’istanza ben più forte nei confronti di Dario Fo. Chi si azzarda?

Un commento di Leila Falà al post di ieri pone alcune domande molto interessanti, che sollecitano altre riflessioni da spiaggia (stavolta all’ombra incerta di una Tamerice rinsecchita, nella spiaggia più deserta che si possa immaginare – ma c’è una casa più su, in questo momento vuota, però nuova, e quindi segno certo che qualcuno viene, almeno ogni tanto).
Provo a sintetizzare il problema, a modo mio. Mi dice Leila che io sento in maniera così acuta il bisogno e l’impossibilità di comunicare la totalità della mia esperienza perché la sto vivendo da solo. Se fossi con qualcun altro, l’altro proverebbe a sua volta già le stesse (forse) sensazioni; e non solo il bisogno di comunicarle sarebbe minore, ma non sarebbe forse già diversa in partenza un’esperienza condivisa in questo modo? “È preferibile forse un’illusoria certezza di condivisione? Illusione che vi sia senso senza dover comunicare, ma che esso sia nella promessa che l’altro fa con la sua presenza?”
Il problema è di grande interesse. In primo luogo, non credo che il problema del dar senso e della comunicazione cambierebbe molto nella situazione in presenza. L’esempio con cui ho aperto il primo post di questa serie era accompagnato dalla considerazione che le mie parole (il mio senso) sarebbe stato tanto più efficace per voi quanto più aveste già vissuto esperienze di questo tipo, che le mie parole vi possano richiamare. Una persona che fosse con me qui e ora starebbe vivendo un’esperienza dello stesso tipo, sicuramente, e quindi le mie parole, il mio senso, potrebbe essere efficace al massimo. Le sue sensazioni saranno davvero le stesse delle mie? La risposta può essere soltanto probabilistica: poiché abbiamo (quasi) lo stesso DNA, siamo cresciuti nella stessa cultura e quindi vissuto esperienze formative simili, tenderemo ad avere sensazioni simili e a dar senso loro allo stesso modo; tuttavia, poiché la differenza individuale esiste, sia a livello di DNA che a livello di formazione, una certa differenza ci sarà. Ed è questo, tra l’altro, che in situazioni di questo genere, ci rende interessante non solo la spiaggia ma anche l’altro, l’altra persona, e questo complica fascinosamente il gioco.
Certo, la presenza di un altro renderebbe diversa l’esperienza sin dall’origine anche per questo, visto che l’altro entra a far parte dell’ambiente che ci produce sensazioni e interazione. Ma c’è dell’altro da prendere in considerazione, che mi sembra ancora più interessante. Ecco dunque la questione della illusoria certezza di condivisione. Nei termini detti sopra, la certezza di condivisione di senso è certamente illusoria, ed è quindi illusorio che ci sia senso senza dover comunicare, a partire dalla promessa procurata dalla presenza.
Ci sono però altri possibili termini, nel gioco, che hanno poco a che fare col senso, e con la comunicazione (almeno come la si intende tecnicamente quale trasmissione di informazione). Mi rifaccio un po’ al discorso sull’intimo che fa François Jullien: che cos’è questa strana connivenza che fa sì che ci si intenda anche solo con uno sguardo, senza bisogno di parole, o anche solo attraverso le parole banali del quotidiano?
Torniamo alla questione dell’azione, anzi dell’interazione. Abbiamo tutti ben presente la sensazione prodotta da un’azione che si sa fare, e che compiamo con disinvoltura senza sentire difficoltà. Camminare su un percorso non accidentato è un’azione estremamente fluida, con cui ci si accorda con grande facilità. Se il percorso diventa leggermente accidentato (come i sentieri per arrivare qui) l’azione resta abbastanza fluida, anche se a ogni passo abbiamo un piccolo problema da risolvere, al fine di non mettere il piede nel posto sbagliato e magari cadere. Questa piccola difficoltà può far parte del piacere, e avere a sua volta una sua fluidità, la fluidità della scoperta, compiuta da una creatura, quella umana, nella cui natura sta anche il saper risolvere problemi nuovi. Quando il percorso diventa ancora più accidentato, la questione cambia: c’è un limite oltre il quale qualsiasi senso di fluidità si perde, e non lo facciamo più per il solo gusto di farlo. Dobbiamo avere un motivo per farlo, una meta. Dobbiamo a ogni passo risolvere problemi impegnativi. Dobbiamo, in un certo senso, a ogni passo dar senso al mondo davanti al nostro piede, e scommettere sull’esito della nostra azione: capire è diventato indispensabile. Ogni passo pone un problema che deve essere analizzato razionalmente e risolto.
Se poi però facciamo il medesimo percorso molte volte, quei problemi non saranno più tali. Saranno già risolti, e l’interazione con il percorso sarà ritornata fluida. Così va l’apprendimento pratico (anche nelle sue applicazioni alla teoria).
Un’interazione fluida produce in noi la sensazione di un accordo con il mondo, quello che in tedesco si dice Stimmung, che è un termine musicale, ma anche psicologico. Se camminiamo fluidamente insieme con un altro, la nostra Stimmung non si produrrà solo nei confronti del mondo, ma anche di questo altro insieme con cui camminiamo. Tutti gli umani sanno camminare più o meno altrettanto bene, per cui non diamo grande valore a una Stimmung tra persone basata su questo. Già però trovarsi ad affrontare fluidamente insieme il percorso accidentato di cui si diceva poco sopra potrebbe produrre una Stimmung più intensa, un sentimento di comunione e di accordo.
Ora pensiamo a quello che succede con le situazioni ritmiche, come la danza. Quando balliamo, siamo necessariamente tutti accordati, sulla base della musica. Magari ciascuno lo fa con gesti propri, diversi da quelli degli altri, ma tutti questi gesti hanno un andamento in comune, e questo è immediatamente riconoscibile.
Io credo che il senso di Stimmung sia uno degli elementi fondamentali della formazione delle comunità umane, a partire dalle loro remote origini rituali: un rito è esattamente un contesto che produce una Stimmung collettiva.
La condizione di intimità tra due persone è una condizione di Stimmung che riguarda interazioni sentite da ambedue come fondamentali. Poco importa che la fluidità che ne risulta nell’interazione reciproca si basi su un’illusione cognitiva (perché in verità le sensazioni di ciascuno e il senso che ciascuno attribuisce loro potrebbero essere diversissimi). La Stimmung non è illusoria, proprio come l’intimità: o c’è oppure non c’è. Che ci sia non garantisce che duri: che invece debba durare può essere davvero un’illusione! (e tanto spesso ne restiamo vittime!)
Se io fossi su questa spiaggia con un’altra persona, la nostra intimità (almeno momentanea) sarebbe certamente più forte di tutto il senso che potrei pensare di trasmettere, e che probabilmente non sentirei nemmeno il bisogno di trasmettere, se non in piccola parte. Nemmeno sentirei l’ansia di non poterlo fare. Di fatto ci sentiremmo accordati nella nostra interazione con le cose intorno, e auspicabilmente anche nella nostra interazione reciproca. In questo senso la mia esperienza sarebbe certamente diversa da quella che è ora.
La Stimmung non si produce solo in presenza (anche se in presenza essa è più facilmente di maggiore intensità). La poesia, l’opera d’arte in generale è qualcosa che produce Stimmung, accordo. Anche quando la fruiamo individualmente, sappiamo che non siamo i soli a fruirne: in qualche altro momento e luogo qualcun altro sta compiendo un’esperienza in accordo con la mia. I Greci conoscevano la magia del teatro, tanto più forte in compresenza, ma che poteva anche legare città diverse o diverse generazioni tra loro nella stessa Stimmung, nello stesso andamento fluido dell’esperienza.
(Mentre scrivevo le ultime righe qui sopra, il mio piccolo paradiso è svanito. Nel giro di pochi minuti sono arrivati prima un motoscafo con una dozzina di persone, e poi due battelli piuttosto grandi e così fitti di gente che parevano immigrati. Musica bumbum a tutto volume, schiamazzi, un sacco di gente a riva: un’improvvisa riminizzazione. Non certo l’altro con cui io potrei sentire alcun senso di intimità, nessuna connivenza, nessuna Stimmung – né peraltro nessun desiderio di trasmettere loro qualsiasi senso io possa essere in grado di dare alle cose. Me ne sono andato. Dopo qualche ricerca, nemmeno troppo sofferta, ho trovato questo rifugio che documento qui sotto, se potete capire, ed entrare in una qualche sintonia con me.)

 Devo aggiungere alcune considerazioni alle riflessioni di ieri sull’impossibilità di dare senso alla totalità dell’esperienza, e quindi alla (dolorosa) impossibilità di comunicarla pienamente. Devo aggiungere alcune considerazioni alle riflessioni di ieri sull’impossibilità di dare senso alla totalità dell’esperienza, e quindi alla (dolorosa) impossibilità di comunicarla pienamente.
Il punto non è tanto (o non è solo né soprattutto) l’impossibilità di cogliere il mondo nella totalità dei suoi aspetti. Che la cosa in sé fosse inattingibile ce lo diceva già Kant, e Peirce, correggendo la mira, parlava di un avvicinamento asintotico progressivo. Ma credo che il punto non fosse affatto quello, perché quello che sentivo era un’incapacità di dar senso, e quindi comunicare, qualcosa che nella mia esperienza comunque c’era – e quindi non si trova a livello della cosa in sé.
Continuando a riflettere (l’eccesso di spiaggia conduce anche a questo) credo che il problema riguardi l’interazione che sto avendo con il mondo attorno – certo, in questo caso, un’interazione estremamente gratificante, e che amerei quindi trasmettere agli altri. Interazione, e quindi azione e percezione dei suoi effetti sul mondo, e conseguente ancora azione con conseguente percezione e così via.
Assumiamo (eccedendo un poco, per semplicità) che nel percepire stiamo già dando un senso, e che quindi ciò che percepiamo sia comunicabile (non è vero per ciascun linguaggio specifico – provatevi a descrivere, con Wittgenstein, il suono di un clarinetto, o il sapore della cipolla! – ma se potessimo registrare tutte le dimensioni sensoriali arriveremmo probabilmente più vicini a questo). Rimane comunque il fatto che la nostra azione non è in sé comunicabile: ovvero, possiamo certamente comunicare la percezione che abbiamo della nostra azione (quello che ne sappiamo insomma, a priori come le sue ragioni, o a posteriori come i suoi effetti), ma non comunichiamo l’azione in sé.
Nonostante siamo noi a compierla, noi conosciamo l’azione più o meno come conosciamo le cose attorno a noi, con l’aggiunta che ne conosciamo (riteniamo di conoscerne) il perché. Non diamo senso all’azione in sé, bensì alla percezione che ne abbiamo, ed è questo che possiamo comunicare.
Ora, il punto è che mentre la cosa in sé appartiene al mondo là fuori, e siamo rassegnati a coglierla solo in parte, l’azione in sé appartiene al mondo qua dentro (l’ho prodotta io, insomma) e ci appare scandaloso, doloroso, non poterle dare senso se non in maniera tanto esteriore come ci accade con le cose. E’ uno smacco profondo al nostro senso dell’io: la drammatica presa di consapevolezza che il nostro fare, il nostro agire, ci è cognitivamente tanto estraneo quanto il mondo attorno. Profondamente dentro di noi c’è insomma un fuori. Il mondo esterno non è solo nella spiaggia attorno a me, bensì anche nella mia interazione con lei, scandalosamente inconoscibile, se non nella stessa maniera parziale con cui diamo senso al mondo.
La filosofia occidentale, da Platone a Cartesio, da Kant a Husserl, è sembrata passare di fianco a questo abisso, senza coglierlo. Questo perché Platone (che, da quel genio che era, non faceva che dare chiarezza e precisione filosofica a dei presupposti contenuti nella sua lingua, come un po’ in tutte le lingue indoeuropee) ha impostato la base del nostro pensiero sull’idea, sul conoscere, giocando sempre al limite tra metafisica e gnoseologia – e così è stato per più o meno tutti quelli che hanno discusso con lui, da Aristotele ai giorni nostri. L’Occidente, così, ha messo il conoscere al centro del proprio mito, pensando la filosofia (conoscere il conoscere) come il proprio punto più alto.
L’abisso viene intuito da Nietzsche, e sostanzialmente rifiutato – proprio nel guardarlo – da Freud, che proprio mentre fornisce i mezzi per concepirlo, continua a parlare di inconscio come di un soggetto nascosto, ma tutto sommato conoscibile. E comunque una sorta di io, non di mondo: un io segreto, sotterraneo, che lo psicoanalista può almeno in parte portare alla luce. Ma quando lo psicoanalista vi spiega che le ragioni per cui avete compiuto una certa azione non sono quelle che credete, bensì altre, cosa ne è del vostro io? Per un attimo scorgete confusamente l’abisso, poi la nuova spiegazione sostituisce la vecchia, e dove c’era l’Es ecco che c’è di nuovo l’Io; certo diverso, dotato di maggiore conoscenza. E alla lunga il processo analitico funziona…
Di fronte al problema di dar compiutamente senso alla mia esperienza su questa spiaggia, l’abisso, invece, si manifesta con forza. La mia interazione con questo amabile intorno non può essere comunicata né più né meno che nei limiti con cui posso comunicare la percezione che ne ho. Peggio anzi: non c’è macchina fotografica, non c’è registratore sonoro, tattile, olfattivo, gustativo, che possa cogliere la mia azione, se non in maniera ancora più esteriore di quanto lo possano le mie parole, già loro evidentemente e ampiamente insufficienti. E la mia azione è l’interazione continua con tutto quello che ho attorno, dal modo di respirare, di muovermi, di toccare le cose: persino la percezione che delle cose sto avendo è intessuta della mia interazione con loro!
Posso produrre un report di tutto ciò, con tutta l’inevitabile esteriorità che tale report avrà, come ho abbozzato ieri, come ho continuato a fare con le foto di oggi.
Oppure posso scrivere una poesia, girare un film, dipingere, comporre un brano musicale. Sarà tanto più evidente, ora, quanto la credenza che un’opera di questi tipi possa comunicare la mia esperienza del qui ed ora, trasmetterne un senso. Non è certo così che funziona la poesia, né l’arte in generale: non descrivendo il mondo, né le emozioni del soggetto, come credevano i Romantici. Travolti dalla nostra adorazione per il Conoscere, abbiamo trattato l’arte come qualcosa che debba trasmettere un messaggio, e questo messaggio vada colto dal fruitore attraverso il processo di interpretazione. Già Susan Sontag, nei primi anni Sessanta, lamentava il dominio dell’interpretazione (il libro è, appunto, Contro l’interpretazione), facendo osservare che questo modo di vedere le cose ha condizionato gli artisti stessi, che hanno prodotto tante opere affinché fossero poi interpretate, riempiendole di verità nascoste, come in un esercizio di enigmistica.
In realtà, quello che capiamo di un’opera d’arte, di una poesia, è importante probabilmente non di più di quello che non capiamo. Un’opera d’arte è tale non per quello che ci dice, ma perché ci propone un’esperienza, intessuta di capire e non capire come le cose del mondo, e a sua volta piena di interazione, perché noi le siamo di fronte, o immersi al suo interno (come nella musica), e quello che percepiamo dipende dalle mosse che facciamo nei suoi confronti. Proprio come con il mondo, non è che percepiamo e basta le opere d’arte, ma il percepire è frutto dell’agire nei loro confronti: dove posiamo lo sguardo, dove e come si fissa l’attenzione, come ci muoviamo nei loro confronti…
Insomma, l’opera d’arte, come il mondo, viene vissuta prima che percepita, e quindi percepita nell’interazione con lei. In questo senso è piena, proprio come il mondo, di quell’inumano che finiamo per ritrovare anche dentro di noi.
La differenza, come concludevamo ieri, è che di mondo si può anche morire, mentre di poesia no; e questo permette un’interazione molto più disinvolta. Ma questa disinvoltura, se siamo sufficientemente attenti, è anche quella che ci permette più facilmente di cogliere l’abisso. Una grande poesia può essere quindi un’esperienza lancinante, ancora più di questa spiaggia, perché mi riguarda ancora più da vicino.

6 Agosto 2016 | Tags: estetica, Grecia, Kalymnos, poesia | Category: estetica, poesia | 
Ecco. Mi trovo qui. Ho camminato per più di un’ora sotto il sole greco, per sentieri mal tracciati e pieni di sassi, un paio di volte scivolando, passando di fianco a un’immensa cavità naturale sul fianco della montagna, un buco che finisce, verso l’alto, con una gigantesca caverna, profondo oltre venti metri dove lo è di meno, pieno di stalattiti e stalagmiti. E adesso sono qui, al bordo dell’acqua del mare appena ondulato, trasparentissimo, all’ombra di una piccola scarpata (e non so quanto quest’ombra durerà), con una lieve brezza. Non fa troppo caldo. Si sta bene.
Sto cercando, se non si era capito, di dare un senso a quello che sto vivendo. Dare un senso significa poter trasmettere a qualcun altro l’esperienza, significa rendere umano il mondo che ci circonda. Lo faccio scrivendo, scattando una foto per poterla mostrare. Se potessi, registrerei i suoni, gli odori, le sensazioni del sole e del vento sulla pelle.
Eppure, per chi mi legge, tutto questo prenderà vita solo nella misura in cui ha già provato, in qualche momento precedente, qualche esperienza che le mie parole, le mie immagini (e suoni, odori registrati, se ci fossero) possano richiamare. Se non avete già vissuto qualcosa di analogo, quello che dico o che mostro rimane informazione astratta, non evocativa. Magari, se per qualche motivo rimane in memoria, potrà diventare evocativa in futuro, una volta che l’esperienza analoga sia stata vissuta: è questa la sorte di tante parole che solo in seguito ci accorgiamo di non aver capito, o non capito del tutto in passato.
Scrivo queste parole, in realtà, perché la cosa che mi ha colpito arrivando in questo luogo e guardando, rapito, la trasparenza dell’acqua sui sassi, è stata l’improvvisa consapevolezza che avrei dovuto rinunciare a darle un senso – o, perlomeno, che qualunque senso le avessi dato, sarebbe stato parziale e fuorviante. Potevo fotografare, descrivere a parole (e l’ho fatto, e continuerò a farlo), e la mia qualità di fotografo e descrittore verbale sarà maggiore o minore, sapendo provocare in misura maggiore o minore reazioni in coloro che guardano le mie immagini o leggono o ascoltano le mie parole. Questo va fatto; è necessario: dare senso al mondo è ciò che ci permette di viverlo.
Ma la consapevolezza che questo processo di dar senso è inevitabilmente, necessariamente incompleto, è qualcosa, in verità, di quasi doloroso. Significa che quello che sto vivendo non può essere veramente acquisito, ridotto a me. Non me lo posso portare con me, per passarlo magari ad altri. È vincolato al qui e ora, all’esser qui, al sentire bruto. Condannato come sono io al capire, il toccare con mano la banalità del non capire quello che comunque sento intensamente, che sento in maniera quasi bruciante, è quasi un dolore, certamente un’ansia, un lutto.
Elaborare questo lutto vuol dire rassegnarsi all’impossibilità di dare un senso a quello che sto vivendo. Qualsiasi senso io possa dare sarebbe comunque la trasformazione di quello che sta attorno a me in una materia nuova (immagini su un supporto, parole, registrazioni di vario tipo), la quale comunque produce le sue percezioni, e trasmette, insieme con il mio, altri sensi suoi – e magari qualcos’altro ancora di non riducibile al senso.
Rassegnarsi all’impossibilità del senso (pur dovendolo produrre) è qualcosa che mi ricorda qualcosa che viene ripetuto in varie discipline orientali, tra cui lo yoga: “non giudicare”. Però è molto più di questo. Giudicare è una forma di senso già molto elaborata: posso aver già prodotto molto senso, senza aver ancora giudicato. Se scatto una foto, la foto sta già dando senso al mondo, ma ancora non lo giudica. Eppure, come abbiamo visto, la foto stessa non basta: qui attorno c’è infinitamente di più di quello che essa può mostrare.
La direzione è comunque quella indicata dal “non giudicare”, ma andando più in là: rassegnati a non poter dar senso. Stai lì e vivi. Quello che possiamo sperare è che tutto questo che ci sta attorno e che indubbiamente ci colpisce senza che siamo capaci di renderne conto dandogli senso, agisca comunque su di noi, e contribuisca magari indirettamente alla formazione di altro senso futuro, magari solo perché di fronte alla descrizione fatta da qualcun altro, saremo in grado di rivivere questo groppo di sensazioni e di emozioni.
C’è, nel fare poetico, sempre la speranza non tanto di rendere la sensazione vissuta in un certo momento (il che sarebbe comunque perdente) quanto di costruire una sensazione che, attraverso il senso, paradossalmente, sappia creare una situazione in cui il lettore si trovi a esperire di più di quello che riesce a trasformare in senso, e viva il piccolo dramma che oggi io ho vissuto qui. Poiché si tratta di poesia, e non di natura, il dramma sarà però catartico, e non tragico: non capire la natura attorno a noi ci può uccidere; non capire la poesia non ci uccide mai, e quando capiamo perché non capiamo, la cosa è persino didattica, e certamente già umana, a sua volta già dotata di senso.


Sul linguaggio della poesia, editoriale di Daniele Barbieri.
La poesia è fatta di parole, e poco altro comunque alle parole strettamente collegato: intonazioni se il linguaggio è orale, sonoro, disposizioni grafiche se scritto. Eppure la poesia costituisce la prova vivente che il modo in cui tipicamente concepiamo il linguaggio è ampiamente inadeguato.
Nella vulgata, la parola è uno strumento per trasmettere concetti, e in quanto tale il suo ruolo si esaurisce in questo, la sua funzione è tutta qui. Non esistono parole in natura, cioè senza che qualcuno le abbia prodotte, come strumenti per trasmettere un’idea. Esistono invece immagini, e quando il pittore produce artificialmente le proprie, anche se non abbiamo difficoltà a considerarle come discorso (e quindi a loro volta strumenti per trasmettere idee) accettiamo pure senza grandi difficoltà che esse non si risolvano in quel discorso, mantenendo anche quel valore visivo che possederebbero comunque al di fuori del loro uso strumentale. Che la bellezza di una Madonna di Raffaello debba essere intesa come un omaggio alla santità è in generale probabile, storicamente e criticamente accettabile, ma questo non impedisce allo spettatore di vedere una bella donna nell’immagine, che continuerebbe a essere vista anche se non riconoscessimo il soggetto dell’opera, e fossimo quindi nell’impossibilità di dar senso al discorso dell’autore.
Facciamo molta più fatica a considerare le cose in questo modo quando l’universo di riferimento è sonoro anziché visivo. Siamo abituati a organizzare l’universo visivo per cose, e le cose sono quanto di più facile concettualizzazione esiste, per noi; è molto più difficile riconoscere cose nel mondo del sonoro, e cogliere ritmi, andamenti, regolarità di processi è certamente per noi qualcosa di molto meno concettuale: quando va bene diciamo che li sentiamo, li percepiamo. Non a caso tuttavia i ritmi, gli andamenti, le regolarità di processi raramente possiedono un nome, qualcosa che li identifichi così nettamente come un gatto soriano, un prato, una gamba, Socrate. Quando lo possiedono, o siamo comunque nell’ambito di un lessico elevato, specialistico (come nel caso di endecasillabo), oppure c’è di mezzo un passaggio attraverso la dimensione visiva (come di nuovo nel caso di endecasillabo).
La stessa natura cosale delle parole (intese dunque come quelle cose che udiamo o leggiamo, o pronunciamo o scriviamo) è probabilmente legata alla loro distintività visiva quando sono scritte. Il discorso orale fluisce, senza definire confini…
Prosegue qui, su Versante ripido
Amelia Rosselli, l’io, l’avanguardia
di Daniele Barbieri
Ho trovato in un aforisma di Nietzsche la chiave per capire il metodo compositivo di Amelia Rosselli, e la relazione tra quel metodo e il problema dell’io, anzi della sua riduzione. Ecco le parole di Nietzsche (da Il crepuscolo degli idoli, La “ragione” nella filosofia, 5, trad. Mirella Ulivieri) :
Il linguaggio appartiene, secondo la sua origine nel tempo, alla forma più rudimentale di psicologia: se prendiamo coscienza dei presupposti fondamentali della metafisica del linguaggio — in parole più chiare, della ragione — penetriamo in un rozzo feticismo. Esso vede ovunque autore e atto: crede nella volontà come causa in generale; crede nell’«io», nell’io come essere, nell’io come sostanza, e proietta la fede nell’io-sostanza su ogni cosa — solo così crea il concetto di «cosa»… L’essere viene penetrato col pensiero, interpolato ovunque come causa; solo dalla concezione dell’«io» segue, come derivato, il concetto di «essere»… […] La «ragione» nel linguaggio: oh, che vecchia donnaccia ingannatrice! Temo che non ci libereremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica…
L’inganno del linguaggio, secondo Nietzsche, starebbe proprio nella separazione tra soggetto e oggetto, intesi come sostanze diverse, l’una dotata di volontà e ragione, l’altra inerte, ma non per questo non dotata di essere, e interpretabile causalmente. Il (nostro) linguaggio sarebbe il principale perpetuatore di questa prospettiva: dall’idea di io nasce quella di essere, che è a sua volta alla base dell’idea di Dio. Dio, essere e io non sono che conseguenze della (nostra) grammatica, ovvero della (nostra) ragione.
Prendiamo ora un frammento molto citato della prefazione di Alfredo Giuliani all’antologia I Novissimi (1961):
Ovviamente, l’inclinazione a far parlare i pensieri e gli oggetti dell’esperienza è un atto individuale, di me che scrivo e che non voglio affatto nascondere la mia soggettività. La “riduzione dell’io” è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente […]. Ora, però, dalla parte dell’oggetto, che è ancora penetrabile e pronunciabile senza falsità, si svolge una poesia che, secondo la “qualità dei tempi”, cerca l’unità di visione e quindi il recupero di quel medesimo io prima ridotto metodicamente. Dialettica, se vogliamo, dell’alienazione. (pp. 22-23 dell’edizione Einaudi 1965)
Se rileggiamo Giuliani alla luce dell’aforisma di Nietzsche, ci accorgiamo che la (comunque problematica – anzi, dialettica) riduzione dell’io continua a svolgersi in una prospettiva di rapporto tra soggetto e oggetto, solo che – a differenza che nella lirica tradizionale – è l’oggetto a trovarsi in primo piano. Del resto, poche righe prima, Giuliani aveva scritto anche che:
Troppo frequentemente, nelle poesie che vorrebbero essere le più aliene dall’intimismo, l’io si nasconde con orgoglio e pervicacia dietro una presunzione di oggettività. Le apparenze, come di solito, ingannano. In realtà – e ciò spiega perché diamo importanza a un certo orientamento metrico – il tono non solo fa la musica del discorso, ma ne determina l’operatività, il significato. Così la riduzione dell’io dipende più dalla fantasia linguistica che dalla scelta ideologica. (p 21)
È quindi l’oggettività ciò che andrebbe cercato in vista di una riduzione dell’io. Ma se seguiamo Nietzsche, l’oggettività non è che una conseguenza di un’organizzazione del linguaggio basata sull’io-ragione-grammatica: nella negazione apparente della soggettività, dunque, l’oggettività non farebbe che riproporla surrettiziamente, rimettendo in campo – proprio con il cercare di escluderlo – il soggetto attraverso l’oggetto che esso crea, e che insieme lo crea, perché soggetto e oggetto (e dunque soggettività e oggettività) escono dalla stessa matrice linguistica.
Di più, la teorizzazione stessa di Giuliani, che coinvolge nella stesura di riflessioni critiche anche gli altri autori dell’antologia, e che poi, come bisogno di teoria, caratterizzerà fortemente l’operare della futura neo-avanguardia, è un’operazione progettuale, e, in quanto tale, un’operazione che si basa su quella volontà che Nietzsche vede alla base del processo di organizzazione dell’essere in soggetti (che possono volere) e oggetti (che non hanno volontà). In altre parole, la preoccupazione critica medesima di Giuliani lo porta di per sé in direzione contraria a ogni possibile riduzione dell’io, come lo porterà (lui e i suoi compagni di viaggio dal ’63 in poi) ogni concezione progettuale dell’agire poetico.
Si noti che il problema di Giuliani (la riduzione dell’io) è importante, ed è importante anche l’apparato critico-esplicativo con cui la nuova avanguardia nasce. Il problema è che si tratta di due strade incompatibili, quasi opposte se seguiamo la prospettiva nietzscheana…
Prosegue qui, su Nazione Indiana.
1 Maggio 2016 | Tags: oralità, poesia, Web | Category: poesia, Web e multimedia |  È stata la nascita della scrittura la prima digitalizzazione. Non che ci fossero cifre (digit) in gioco, ma l’idea stessa di registrare la parola in un medium che non è il suo pone già alcuni dei problemi di qualsiasi digitalizzazione vera e propria. In quel caso (così come – mutatis mutandis – in ciascuno dei successivi) era necessario suddividere il continuo del discorso verbale in una serie di tratti distinti, e selezionarne alcuni da riportare sul supporto visivo. Si optò, da un lato, per i tratti fonetici, maggiormente distintivi rispetto ad altri, come quelli intonativi, che vennero trascurati; e, dall’altro, per i tratti semantici più immediatamente utili all’azione pratica (mentre quelli più sottili e lontani vennero lasciati all’intuizione del lettore). La più antica scrittura (come ancora un po’, oggi, quella cinese) fu quindi una scrittura del fonema (o meglio, del gruppo di fonemi) e del senso immediato. Poi, progressivamente, in tutta quella parte del mondo che non era estremo oriente (nel quale agivano motivazioni diverse), la scrittura del senso (ideografica) si andò perdendo, e apparve sufficiente fare uso dei soli singoli fonemi: e così la scrittura alfabetica fu per molti secoli e in molti luoghi il tramite attraverso il quale si poteva ricostruire la parola orale, e da questa, a sua volta, il discorso vero e proprio. È stata la nascita della scrittura la prima digitalizzazione. Non che ci fossero cifre (digit) in gioco, ma l’idea stessa di registrare la parola in un medium che non è il suo pone già alcuni dei problemi di qualsiasi digitalizzazione vera e propria. In quel caso (così come – mutatis mutandis – in ciascuno dei successivi) era necessario suddividere il continuo del discorso verbale in una serie di tratti distinti, e selezionarne alcuni da riportare sul supporto visivo. Si optò, da un lato, per i tratti fonetici, maggiormente distintivi rispetto ad altri, come quelli intonativi, che vennero trascurati; e, dall’altro, per i tratti semantici più immediatamente utili all’azione pratica (mentre quelli più sottili e lontani vennero lasciati all’intuizione del lettore). La più antica scrittura (come ancora un po’, oggi, quella cinese) fu quindi una scrittura del fonema (o meglio, del gruppo di fonemi) e del senso immediato. Poi, progressivamente, in tutta quella parte del mondo che non era estremo oriente (nel quale agivano motivazioni diverse), la scrittura del senso (ideografica) si andò perdendo, e apparve sufficiente fare uso dei soli singoli fonemi: e così la scrittura alfabetica fu per molti secoli e in molti luoghi il tramite attraverso il quale si poteva ricostruire la parola orale, e da questa, a sua volta, il discorso vero e proprio.
Per i nostri Antichi, Greci o Romani che fossero, il discorso non stava nella parola scritta, che era un puro espediente mnemonico per ricostruire quella orale – e si leggeva solamente ad alta voce, ricostruendo nell’interpretazione vocale tutti quei tratti, intonativi, semantici e altro, che nella scrittura non erano presenti. Per loro, insomma, la scrittura funzionava un po’ come funziona per noi la notazione musicale: le note scritte non sono la musica, ma soltanto il supporto mnemonico interpretando il quale il bravo esecutore produce musica. Per fare questo, deve metterci del suo, riempiendo gli inevitabili vuoti – perché non si può trascrivere tutto. Quando, intorno al XII secolo, gli scoliasti iniziano a leggere senza vocalizzare e persino senza muovere le labbra, il processo arriva a compimento anche in Europa (in altre culture era presumibilmente già avvenuto): la scrittura inizia a essere autonomamente discorso, in parallelo all’oralità e non più in sua funzione. Ma se la scrittura è anche autonomamente discorso, allora è discorso pure quello veicolato dalla sola scrittura, senza la mediazione dell’oralità: il discorso, dunque, non ha più bisogno del suono, né nelle sue componenti intonative, escluse da sempre, né in quelle fonetiche. Queste ultime possono essere sempre ricostruite, se è necessario; tuttavia di solito non lo è, e leggiamo tranquillamente con gli occhi, e il senso si trova direttamente associato alla forma grafica delle parole, anzi alla combinazione di quelle 52 cifre (cui si aggiungono lo spazio e qualche segno di punteggiatura) che sono i caratteri maiuscoli e minuscoli dell’alfabeto latino.
La grande conquista della digitalizzazione alfabetica (ora sì compiutamente digitalizzazione, pur eseguita con cifre non numeriche) si paga con la riduzione del discorso a chiarezza comunicativa; e nel momento in cui la scrittura (specie in secoli di stampa e di alfabetizzazione diffusa) diventa il modello del discorso non banale, lo stesso discorso non banale si riduce ai suoi elementi di chiarezza comunicativa, al punto che facciamo persino fatica, oggi, a processo avanzato, a immaginare quali possano essere gli elementi esclusi, e che cosa vi possa essere nella parola che non rientra nei criteri della chiarezza comunicativa….
Segue qui, su L’Ulisse, n.19.
François Jullien, la poesia, la critica
di Daniele Barbieri
Quando leggo François Jullien mi trovo frequentemente in convergenza col suo pensiero, riconoscendo comunque in lui l’invidiabile vantaggio di poter basare le proprie riflessioni su duemilacinquecento anni di pensiero cinese, nella sua fondamentale diversità dal nostro. L’assunto (wittgensteiniano) di base delle osservazioni di Jullien è che ciò che ci è troppo vicino, ciò che è alle basi stesse del nostro pensiero, ci sia per questo stesso motivo invisibile; ma che la sostanziale diversità del pensiero cinese (al di là del suo maggiore o minore valore rispetto al nostro, che non è in questione) ci può servire proprio come punto di vista esterno, dal quale vedere il nostro modo di pensare con maggiore chiarezza (e anche viceversa, ovviamente – però questo ci interessa di meno). Si tratta di un’operazione non così dissimile da quella che compiva a suo tempo Michel Foucault, cercando il proprio punto di appoggio in quell’altrove che sono le altre epoche storiche, ciascuna con il proprio episteme. Ma, proprio in questi termini, il punto di appoggio di Jullien si rivela più efficace di quello di Foucault, perché ci permette di cogliere la relatività culturale di nozioni che condividiamo con Platone e/o con Aristotele, al di là della (comunque presente) variazione storica che esse hanno subito.
Si tratta di un numero non piccolo di nozioni cruciali, e altrimenti difficilmente pensabili, perlomeno in termini filosofici, poiché rappresentano spesso proprio ciò che in Occidente è rimasto impensato da parte della ragione, a vantaggio delle nozioni che sono state poi effettivamente sviluppate. Queste nozioni di origine o ispirazione cinese si trovano argomentate nei numerosi libri che Jullien ha pubblicato negli ultimi vent’anni, ma anche molto utilmente raccolte nel suo ultimo: De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinoise de la pensée (Gallimard 2015). Proprio perché si tratta di una sorta di lessico (filosofico), il libro è organizzato per coppie oppositive, dove a un termine sviluppato dal pensiero cinese si oppone quello che ha avuto successo in Occidente: propensione (vs causalità), potenziale di situazione (vs iniziativa del soggetto), disponibilità (vs libertà), affidabilità (vs sincerità) ecc.
Non è mia intenzione qui fare un rendiconto dei contenuti del volume, cosa che sarebbe davvero difficile, visto che si tratta a sua volta di una sorta di compendio di vent’anni di riflessioni in trenta altri volumi. Mi limiterò a concentrarmi su tre coppie oppositive, e sulle conseguenze che la loro presa in carico da parte del pensiero occidentale può avere sulla riflessione sul testo poetico e sulla critica che lo riguarda:influenza (vs persuasione), coerenza (vs senso), connivenza (vs conoscenza).
La struttura della lingua cinese non permette l’oggettivazione dell’essere. Il pensiero tradizionale cinese è quindi estraneo ai concetti di ente e di essenza che sono stati, da Aristotele in poi, alla base del pensiero filosofico e teologico occidentale…
Prosegue qui, su Nazione Indiana
30 Gennaio 2015 | Tags: poesia, Versante ripido | Category: poesia |
La poesia, l’immaginario e l’evoluzione sociale, editoriale di Daniele Barbieri.
C’era una volta la poesia. Va bene: non è proprio così; la poesia c’è ancora. Ma una volta c’era un ruolo sociale della poesia che da molto tempo non esiste più; del quale per lungo tempo è rimasto solo lo spettro, sinché è scomparso pure quello, e quello che resta oggi ne è forse lo spettro dello spettro.
Le parole di Omero e degli aedi che come lui recitavano a memoria dei versi epici lungo le strade della Grecia antica, spesso semi-inventandoli ogni volta, non servivano solo a divertire gli animi, anzi spesso non divertivano affatto. Quando Ulisse, alla corte di Antinoo, sente il racconto dell’aedo, si mette a piangere, coprendosi il volto col mantello. Certo in questo caso lo fa perché si accorge che si sta raccontando di lui stesso; ma evidentemente tra i greci non doveva essere un fatto così singolare che il racconto in versi di un aedo suscitasse commozione.
L’importanza sociale che i Greci attribuivano ai versi omerici era tale che essi adottarono i segni dei fenici per non correre il rischio di perderli. Il punto è che quello che quei versi cantavano non erano solo le imprese degli eroi, ma il senso stesso della civiltà greca, la quale – comunque – delle imprese degli eroi del mito era impregnata. I versi dei poeti costruivano l’immaginario della popolazione greca, e l’immaginario è ciò su cui si fonda il desiderio che dirige le nostre azioni. Il che non vuol dire che i Greci desiderassero comunque ripetere le gesta di Ulisse, ma che c’era in quel modo di agire e di vivere qualcosa che non poteva essere perduto, e che comunque influenzava l’azione dei singoli, e l’evoluzione della società. Per questo l’adozione della scrittura venne sentita come un evento cruciale, che permetteva ai Greci di mettere maggiormente al sicuro la propria identità futura, la propria specifica differenza rispetto ai barbari.
Proprio perché Augusto era consapevole di questo potere mitopoietico della poesia, chiese al massimo poeta della sua epoca, Virgilio, di scrivere un poema che glorificasse le ascendenze di Roma dando in questo modo un supporto mitologico al proprio impero. Nell’immagine di Roma costruita dall’immaginario dell’Eneide, un duce saggio e illuminato come Augusto diventa certamente più desiderabile delle litigiosità del Senato, che avevano condotto a quasi un secolo di lotte intestine e guerre civili.
Il potere mitopoietico della poesia, potere quindi di influenzare l’evoluzione della società, continua a lungo, e diminuisce progressivamente a mano a mano che aumenta il rilievo di altri strumenti di costruzione dell’immaginario…

Continua qui, su Versante ripido.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|












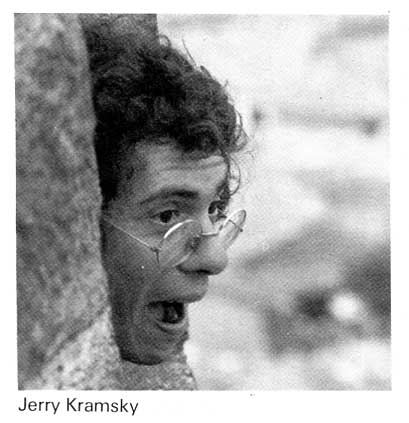


 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email
 Questo testo è stato pubblicato
Questo testo è stato pubblicato 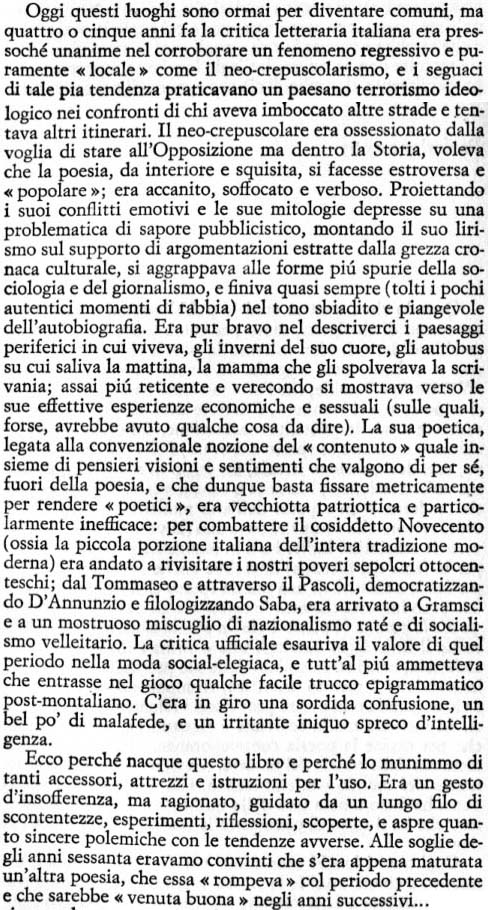
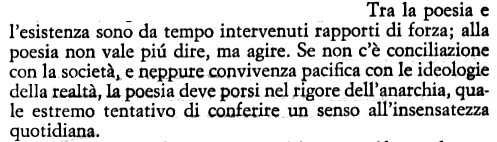
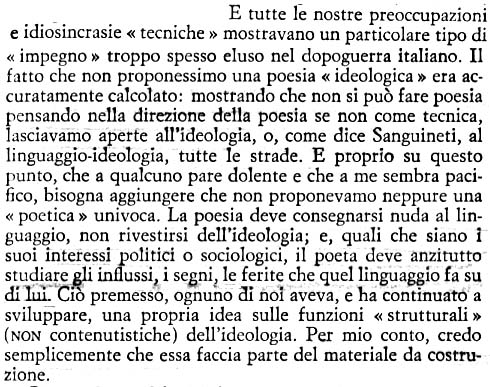
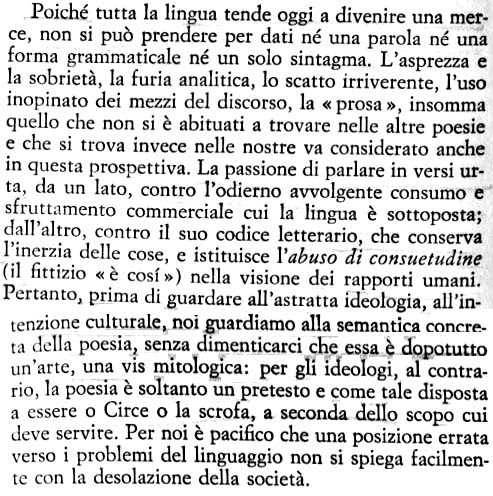
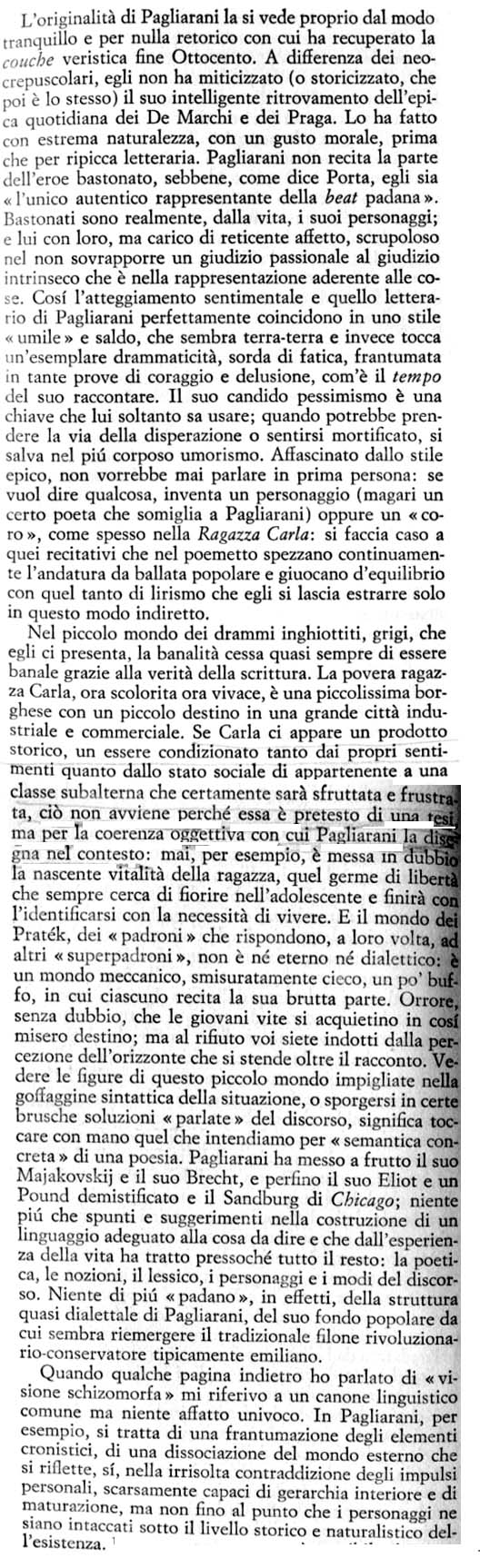
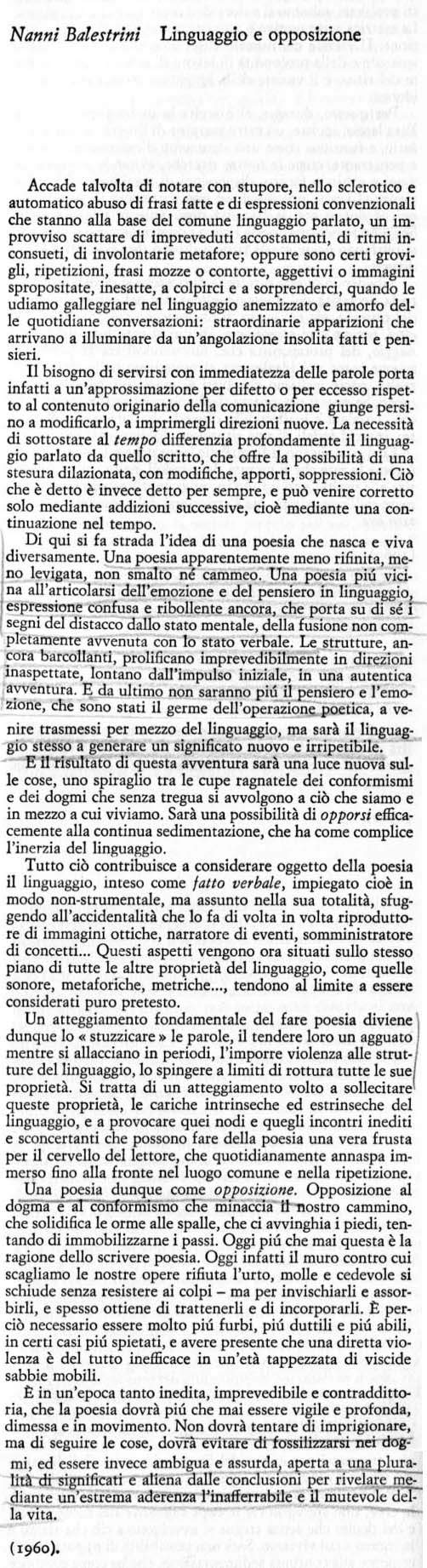


























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco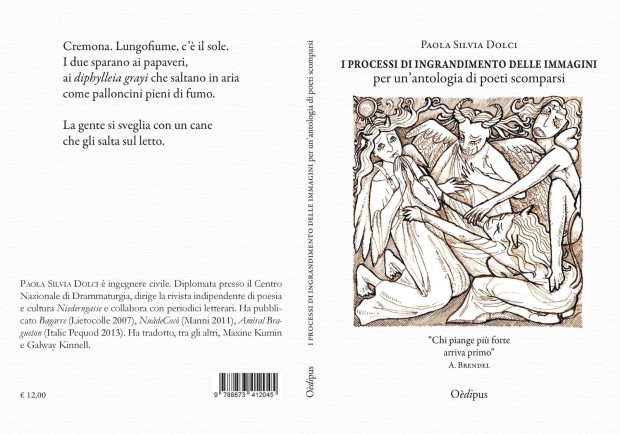



Commenti recenti