Continuo le riflessioni sulla ritualità del testo poetico esposte in questo post.
Si diceva che la poesia deriva la sua dimensione sacrale dal porsi come una situazione rituale, in cui il lettore dà vita al testo scritto leggendolo (almeno interiormente) ad alta voce, e così vivendolo, in sintonia ritmica con tutti gli altri lettori del medesimo testo, passati e futuri. Per funzionare, la poesia richiede dunque al suo fruitore un fare, una posizione cioè più attiva del semplice scorrimento con gli occhi cui siamo abituati nel leggere normale prosa.
Ma, che cosa succede quando la poesia viene letta ad alta voce da altri, e recepita solo attraverso l’udito? Ci sono diversi ordini di problemi.
In primo luogo c’è una potenziale riduzione di comprensibilità. Da secoli, i testi poetici sono fatti per essere fruiti prima di tutto attraverso lo sguardo, un senso globale, che permette in qualsiasi istante di rallentare o interrompere la sequenzialità, per magari tornare indietro, rileggere quanto non era chiaro, confrontare visivamente parti diverse del testo… L’ascolto non permette nulla di tutto questo: siamo vincolati al flusso. Se il recitante è bravo, ovviamente, saprà aggiungere, attraverso l’intonazione, strumenti di interpretazione, almeno in parte riducendo i problemi. Ma non potrà mai arrivare a restituirmi quello che il testo scritto mi avrebbe potuto dare.
Permettere all’ascoltatore di leggere autonomamente il testo scritto mentre il recitante lo esegue risolve questo problema. In questo modo non si perde quello che lo sguardo può cogliere dalla versione scritta, e si acquista quello che una buona voce sa dare.
In alternativa, bisogna che la poesia sia stata scritta appositamente per l’oralità, pensandola davvero come un meccanismo sonoro. Tali sono, per esempio, i componimenti di Lello Voce, la cui versione scritta non è in realtà che un palinsesto, un canovaccio, un supporto per la memoria, uno spartito. Una poesia pensata per la voce finisce per essere diversa da una pensata per l’occhio, e, inevitabilmente, si allontana da una tradizione basata sulla scrittura.
Il secondo ordine di problemi riguarda la dimensione rituale. Se il lettore autonomo entra nella dimensione rituale attraverso il proprio fare, la propria attività pratica come lettore, cosa ne sarà di tutto questo se questa stessa attività gli viene sottratta da un recitante diverso da lui stesso? La ritualità del semplice ascolto è molto più debole di quella della recitazione diretta. A meno che il fare dell’ascoltatore/spettatore non possa riproporsi in diverso modo.
Ascoltando musica, per esempio, possiamo ballare, o andare a tempo, o canticchiare tra noi la melodia che sta venendo eseguita. Sono tutti modi attraverso i quali l’ascoltatore si fa attivo, partecipe, e vive la musica avendo almeno una piccola parte nel suo farsi. Ma può la poesia recitata produrre effetti di questo tipo?
Di nuovo, la simultanea visione del testo scritto permetterebbe di indebolire il problema, rimettendo in gioco le componenti visive altrimenti escluse. Ma che succede con una poesia radicalmente orale, come negli esempi fatti sopra?
La mia sensazione è che le componenti di prevedibilità di un testo poetico siano troppo inferiori a quelle di un brano musicale, per poter permettere una partecipazione attiva sin dal primo ascolto. Probabilmente ascolti ripetuti permetteranno l’istanziarsi della situazione di tipo rituale, perché l’ascoltatore/spettatore ha intanto memorizzato almeno in parte i testi, e può ripeterli (liturgicamente) con il recitante.
Quando la poesia era sostanzialmente orale, la situazione era un po’ di questo tipo. Un po’ i testi erano noti, e un po’ la poesia era musicata, cioè era canto, musica. Ma ora che la poesia è sostanzialmente scritta, se la poesia orale non recupera in qualche modo una dimensione musicale, è destinata a perdere la componente rituale, rimanendo puro spettacolo, performance altrui, in cui, come nel teatro o nel cinema, si è attori oppure spettatori, di qua o di là dalla barricata, e comunque non compartecipanti.
Certo, la poesia resta conosciuta come tale, e il carattere sacrale che le viene dalla dimensione rituale può restarle attaccato addosso anche là dove la situazione rituale è stata annullata. Ma questo vale perché la situazione rituale della lettura personale è la norma, oggi, mentre la recitazione altrui ad alta voce rimane un’eccezione. Se le parti si invertissero, la poesia subirebbe un cambiamento di status che la porterebbe a essere molto più vicina al teatro – il quale deve, faticosamente, ricostruire la propria dimensione rituale in altri modi, ritualizzando anche la partecipazione come spettatore. Oppure, per sopravvivere, la poesia dovrebbe trasformarsi in musica, e diventare, per esempio, canzone d’autore. Ma qui insorgono altri guai…



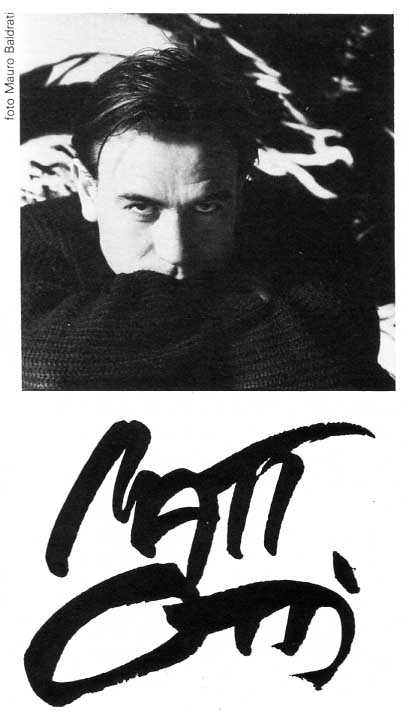








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email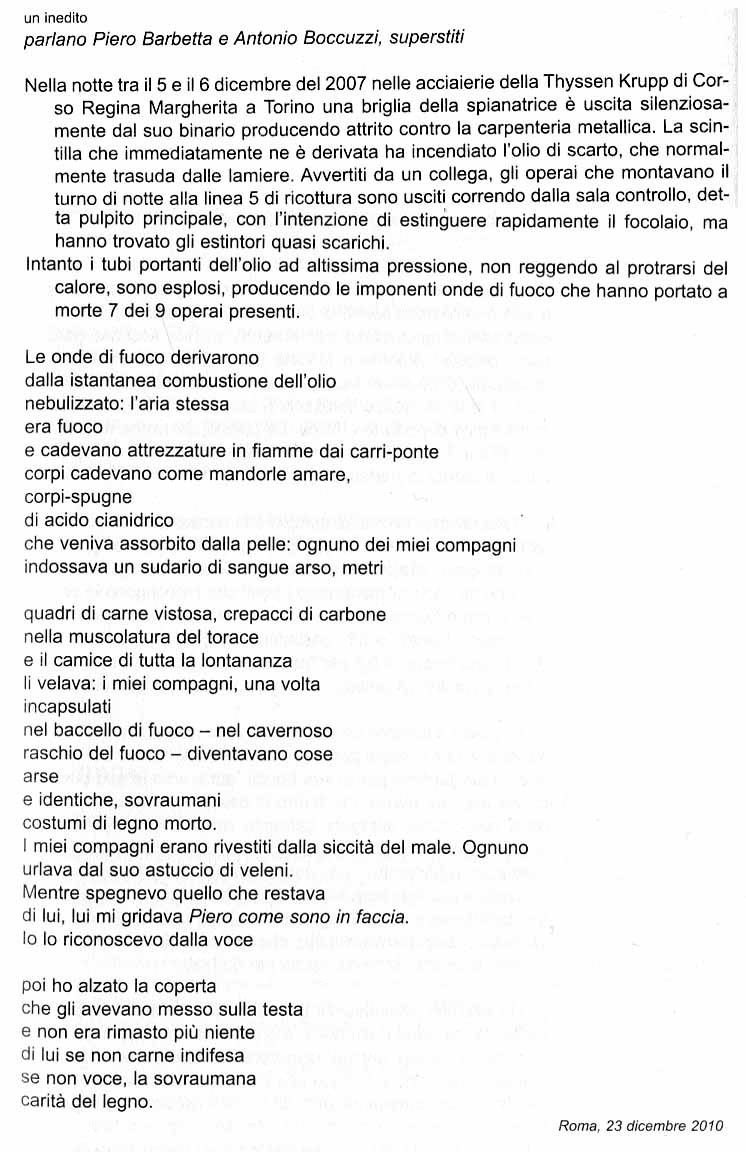



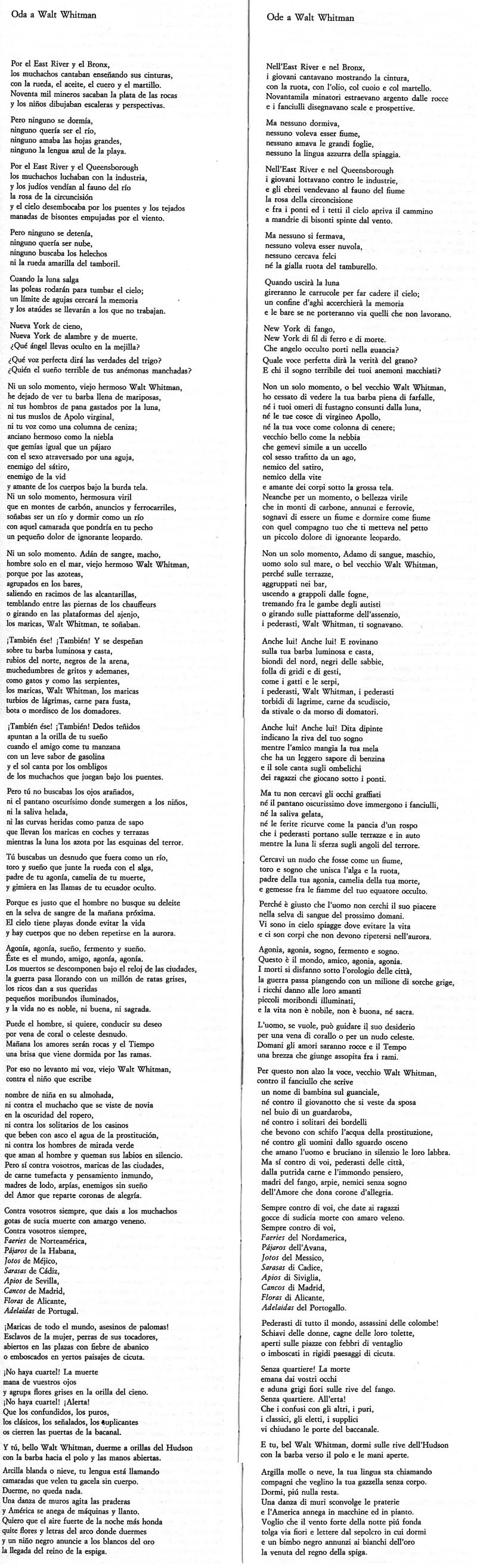

La sensazione è che nella poesia non solo ci sia una componente di prevedibilità inferiore rispetto a un brano musicale, come dici tu, ma credo anche che il livello musicale della poesia, da quando il verso si è liberato da metriche stringenti, consista in un’armonia di suoni che ci viene fornita senza tempi né indicazioni di andamento. E’ come se ci trovassimo davanti ad una sequenza di note di cui non ci viene indicata la scala, la chiave musicale… Detta così, pare anche una bella esperienza: la ricerca del codice misterioso che ci permetta di entrare nel mondo poetico e di coglierne la sacralità a patto di scoprirne i tempi e i ritmi. In realtà, forse, abbiamo perso ogni esperienza possibile di poeticità e musicalità della parola… e infine: buongiorno Daniele!
Sì, penso anch’io che il verso libero comporti un’esperienza di ricerca del codice ritmico (e la presenza dei versi costituisce la garanzia – o la promessa – che tale codice ci sia; in prosa non lo cercheremmo). Però non credo che abbiamo perso ogni esperienza possibile di musicalità e poeticità della parola; nella modernità certo le priorità sono altre, e la parola è prima di tutto uno strumento funzionale a trasmettere un messaggio, ma il fatto che ci siano ancora autori e lettori di poesia dimostra che l’esperienza di una parola che non si risolva nel suo senso è ancora possibile – rara e difficile, ma possibile.
E infine, ciao Paola. E’ un piacere sentirti!
Ti lascio un pensiero e ti chiedo un pensiero. E’ una cosa che mi rigira per la testa da molto ed è collegata al tuo discorso. Il mio pensiero nasce dall’ascolto del dixit dominus di Handel (HWV 232), contrappunto su un testo che è il salmo di Davide 109 (o 110). Tutte le volte che lo ascolto penso che è come se Handel cercasse qualcosa che è proprio vicino a quello che tu dici. Le parole del salmo sono poche, di complessa comprensione, altamente metaforiche diremmo. Handel le fa dire a più voci, e ripetere e sovrapporre in vari punti (contrappunto infatti) come se cercasse di ritornare al suono delle parole, come se proprio lì, se pronunciate bene, potessero produrre qualcosa di magico o divino. Ti lascio uno stimolo di pensiero, spero; attendo un tuo stimolo al mio pensiero. C’è qualcosa di magico in quelle parole divine…
Haendel fa musica, qui in particolare musica religiosa. Io credo che la musica sia comunque un fenomeno rituale, perché, persino quando la ascolti da solo, la segui e ti muovi col corpo in sintonia con tutti gli altri ascoltatori di quella stessa musica, in altri tempi e luoghi. Basterebbe questo a mostrare la presenza di elementi di sacralità (o di sublime, che per me è all’incirca lo stesso) in qualsiasi musica che ci prenda almeno un poco. Nel caso del brano di Haendel, poi, anche il tema è sacro. Il suono delle parole, se pronunciate bene, può davvero produrre qualcosa di magico o divino: persino da non credente, quando sento certe parole della Messa, a me vengono i brividi, e questo mi succede anche con certi mantra indiani, di cui nemmeno capisco il senso. Mi succede poi con la poesia: certo lì sono passato anche attraverso il senso, ma è il suono che produce il brivido.
Haendel è un musicista, non un poeta; ha a che fare sostanzialmente col suono, e lavora su quello, mentre il senso gli è già dato perché il testo verbale preesiste. Naturalmente anche il suono ha un senso (che il senso non conosce), e quindi il risultato alla fine è anche semanticamente differente. Diciamo che qui il musicista parte da una liturgia (quella implicita nel Salmo) per elaborarla e ottenere un’altra liturgia, ancora più coinvolgente, o, se vogliamo, ancora più travolgente.
La musica può travolgere/coinvolgere in maniera straordinaria. La poesia mi sembra più lenta, in questo, probabilmente per la sua minore previsionalità (quindi ci entri dentro un po’ meno), e poi perché la componente semantica rimane comunque più presente, e quella richiede un’elaborazione maggiore: tempi più lunghi, maggiore attenzione volontaria e dunque tendenzialmente minore coinvolgimento immediato. Sottolineo sia il “tendenzialmente” sia l'”immediato”, perché anche la poesia produce gli stessi effetti, ma ha bisogno di più impegno e di più tempo.
La cosa buffa è che oggi ascoltavo proprio Haendel, dopo un sacco di tempo…
Ah ah! Ecce Handel!
Grazie del tuo pensiero… concordo e dico: da quando i numeri (metrica o contrappunto) si sono allontanati dalle parole, quante disgrazie amico mio!!! Il salmo come parole del salmo, infatti, in Handel non si ritrova quasi più… cerca il suono delle parole lui, prima di tutto. E’ questo che mi incanta! e poi: è sempre bello leggerti!
🙂