A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?
Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).
Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.
Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…
 Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).











 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email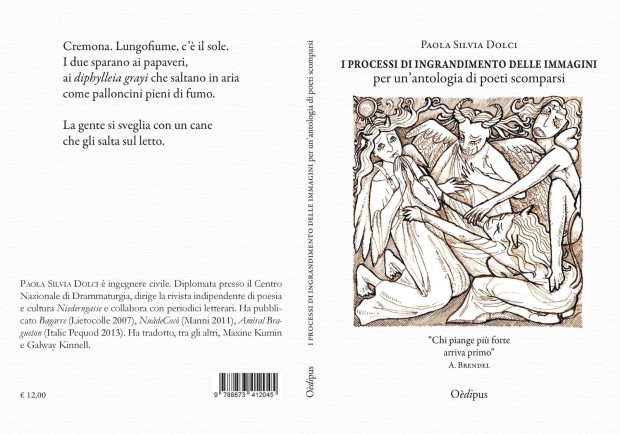

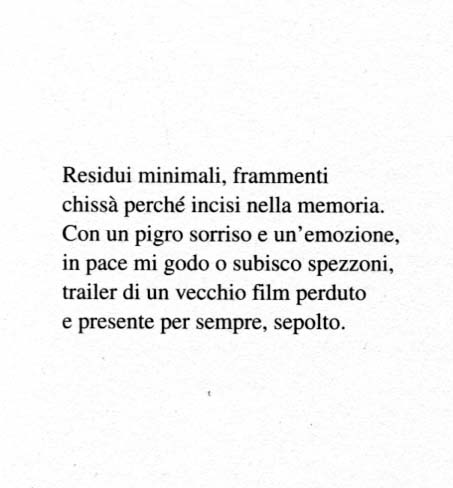
Leave a Reply