 Il primo abbaglio lo si prende dalla copertina. Il ritmo, la perentorietà di quei quattro versi, la rima interna, fuori posto ma proprio per questo elegantissima, fanno pensare a Montale. Tuttavia, si trattasse anche del grande Eugenio di persona, il clima di settanta, ottant’anni dopo farebbe già sì, di per sé, che le medesime parole possano apparire qualcosa di ben diverso (rileggetevi il sardonico Borges di “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, per capire che cosa voglio dire). Dopo di che, quando si vanno a leggere le pagine interne, qualcosa di montaliano c’è davvero, però si tratta di un Montale bonificato o buonista, privato di ogni fremito d’orrore, risolto in elegante e classicistica maniera.
Il primo abbaglio lo si prende dalla copertina. Il ritmo, la perentorietà di quei quattro versi, la rima interna, fuori posto ma proprio per questo elegantissima, fanno pensare a Montale. Tuttavia, si trattasse anche del grande Eugenio di persona, il clima di settanta, ottant’anni dopo farebbe già sì, di per sé, che le medesime parole possano apparire qualcosa di ben diverso (rileggetevi il sardonico Borges di “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, per capire che cosa voglio dire). Dopo di che, quando si vanno a leggere le pagine interne, qualcosa di montaliano c’è davvero, però si tratta di un Montale bonificato o buonista, privato di ogni fremito d’orrore, risolto in elegante e classicistica maniera.
Insomma, una poesia che potremmo definire consolatoria, una poesia-poesia con tutti i crismi di come la si deve fare, la poesia: il ritmo giusto fatto di endecasillabi ma senza esagerare (quel verso libero che gira comunque intorno a quell’andamento così familiare), le rime elegantemente dislocate, insieme ad allitterazioni e assonanze e consonanze, in modo da formare un tessuto sempre cortesemente risonante. Difficile dire in che cosa consista la nota falsa, in questo misurato nitore.
Tutto risulta più chiaro dopo un po’ che si legge, quando ci si incomincia ad accorgere della piccola morale racchiusa ogni volta dentro alla sequenza dei versi, e quando ci si rende via via conto di come il meccanismo si ripeta costantemente, in ogni singolo componimento, ora in maniera più implicita ora più esplicita. Dopo un poco se ne ricava l’impressione che l’autore sia capace di cavar fuori una morale da tutto, una piccola morale, dolce o amara, ma vera, condivisibile. Forse banale, bisognerebbe dire, se non suonasse dispregiativo.
Il punto è che, in generale, non si chiede alla poesia di esprimere grandi verità. Le rivelazioni, quando davvero sono da fare, è meglio farle in prosa, e in prosa critica: si può essere più chiari e farsi comprendere meglio. La poesia dovrebbe suggerire, semmai, inquietare, e dovrebbe farlo mostrando, non dichiarando. Può tranquillamente parlare di banalità, e persino dire banalità, senza che questo sia di per sé una colpa (mentre lo sarebbe per la prosa), a patto di non dirle in maniera banale, a patto che la maniera di dirle ne metta sul piatto degli aspetti che normalmente non vengono esibiti.
Il problema, quindi, non sta probabilmente in quello che Marcoaldi dice, ma proprio nel come lo dice. Se queste morali banali ci venissero espresse in maniera inquietante, imprevedibile, potrebbero dire ben altro di quello che sembrano a prima vista dire. Invece qui è tutto perfetto, tutto elegante, tutto proprio come ci si aspetta che sia. E la morale conclusiva di ogni componimento emerge di conseguenza nella sua essenza di banale, consolatoria verità.
Forse, questa di Marcoaldi, è una poesia che può piacere ai non lettori di poesia, a chi frequenta la poesia molto saltuariamente, e magari la legge, stavolta, perché gli hanno regalato un volume. Questo tipo di lettore ritroverà in questi versi quello che ha imparato ad apprezzare a scuola, cioè la forma canonica della poesia del novecento, quella incarnata da Montale – che pure, lui, non è stato né banale in questo senso né consolatorio in questo senso. E non vi troverà molto di più; ma questo certamente gli potrà bastare.
Insomma, in molti sensi un libro da regalo. È pure pubblicato da Einaudi: una garanzia.






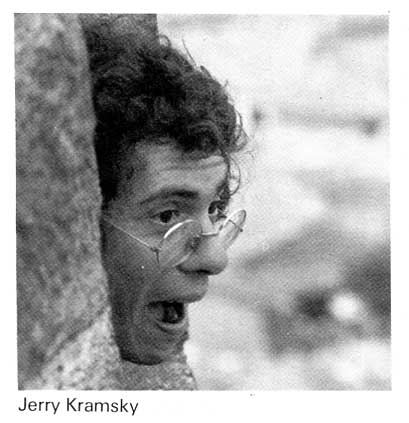



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email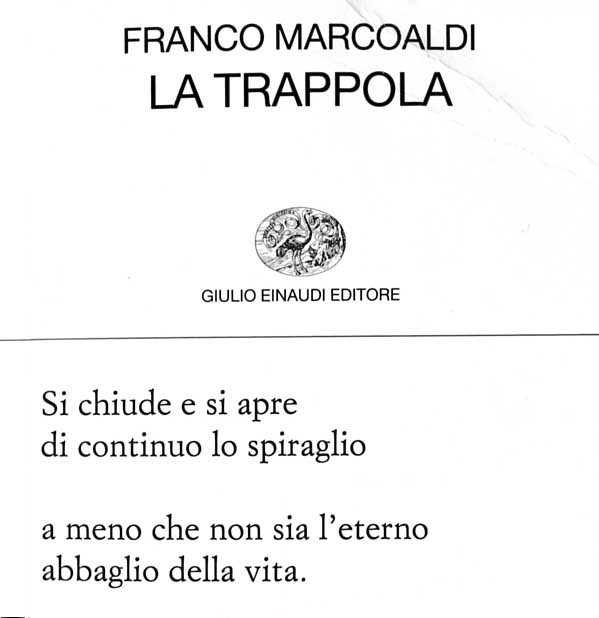
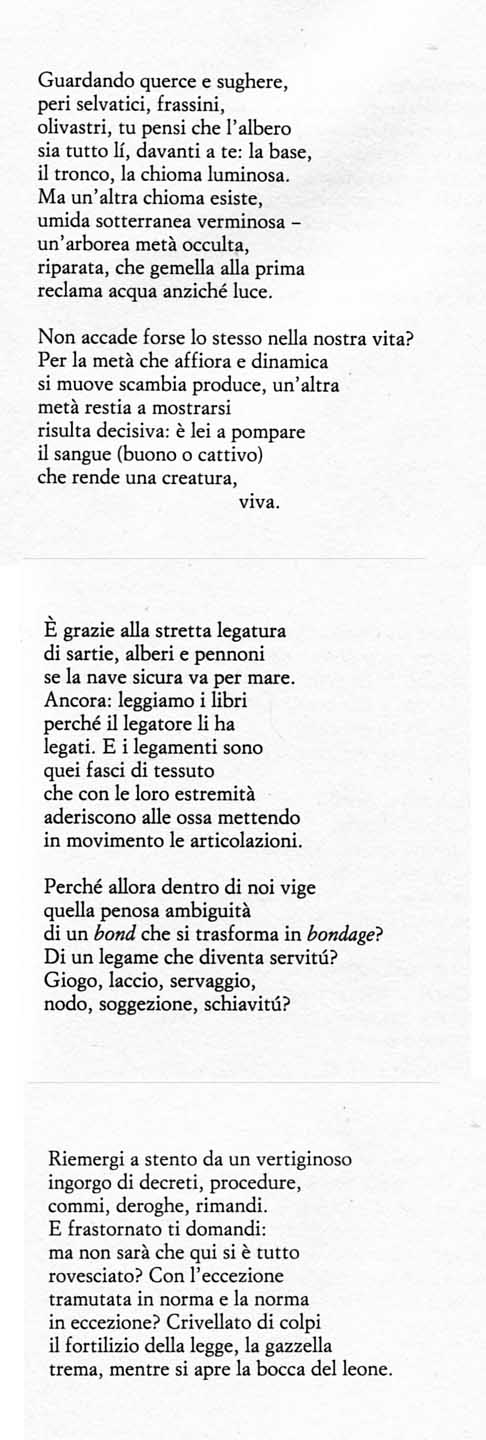
Anche io, leggendo solo i versi di quella copertina, avevo avuto la stessa impressione. Grazie per dire le cose come stanno.
Un applauso. Tutto condivisibile se non perfettamente giusto. Obietterei unicamente sull’idea di “libro da regalo”. Questo perché, nel voler regalare una versificazione novecentesca pur non italiana, propenderei per qualcosa della Szymborska: lettura facile, peso specifico infinitamente più alto. Forse obietterai che Marcoaldi e la poetessa polacca stanno come il giorno alla notte, perché il primo costruisce “morali banali” di un nitore (posso dirlo? ma sì, lo dico) apollineo, mentre la seconda vi insuffla dentro (non sempre, sia chiaro) quel tocco di inquietudine capace di disassare il nostro pensiero di lettori. D’accordo, allora diciamo chiaramente che scrivere può essere una professione. Che a scrivere poesie si può essere anche bravi professionisti. Il dramma sta quando il professionismo ti prende la mano e ti fa scrivere cose ineccepibili dal punto di vista formale, ma vuote di tutto il resto. Inutili o quasi. Marcoaldi è la punta di un iceberg immenso: guardiamoci attorno. Inorridiremmo per quanti altri esempi possiamo fare.
E’ anche vero che, dopo aver letto certe cose premiate ai concorsi di poesia, leggere versi “corretti” è almeno una boccata d’aria.
(Comunque, era una battuta, eh? Sono del tutto d’accordo con quel che scrivi).