Provo a riprendere le fila, o almeno qualche filo, del discorso aperto con Marco Giovenale nel post del 12 settembre. È un discorso complesso, complicato, dove i vari fili si intrecciano e ingarbugliano, e io stesso non sono sicuro di vederci chiaro. Cominciamo dalla fine, cioè dall’ultima parte del commento di Giovenale al mio post, dove dice:
Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.
Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.
Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.
Non vorrei che ci fosse qui un, come dire, abbaglio di prospettiva. La trasformazione sociale c’è stata, non c’è dubbio, e si rispecchia nei nostri discorsi, non c’è dubbio. Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%? Non c’è dubbio che quel 10% sarebbe quello che sentiamo più rappresentativo, più identificante di noi stessi rispetto a chi ci ha preceduto – però resterebbe comunque un 10% (d’altra parte, per fare un’analogia, il 99,99% del DNA di tutti gli umani è identico, e la nostra cruciale differenza individuale si annida nel restante 0,01). Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi che il 90% della poesia contemporanea continui ad esprimersi come quella dei nostri nonni (o bisnonni): non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti. Quel 90% di zoccolo duro resta lì, a fianco del 10%. Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.
In aggiunta, può ben darsi, come suggerisce Giovenale, che vi sia in poesia l’eredità di un’assertività religiosa, o comunque (non sono certo di capire bene del tutto l’uso che lui fa del termine assertivo/assertività) qualcosa di ereditato con forza. D’altra parte, la poesia (e proprio la poesia, non la prosa) viene sentita come qualcosa di particolarmente profondo, qualcosa che, anche se parla della banalità del quotidiano, in verità non si ferma mai alla banalità del quotidiano – quindi qualcosa che ha in comune con la religione un atteggiamento di fondo, io direi una sacralità (che è un concetto che non ha necessariamente a che fare con la divinità). Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.
Questa risposta a due facce è comunque soddisfacente solo in parte. E infatti c’è inevitabilmente dell’altro, che viene già un po’ suggerito dalla seconda faccia. Può darsi che quello che Giovenale sente e che le sue parole esprimono sia proprio la necessità di una sacralità che possa essere trovata nelle forme del presente, quelle del suddetto 10%; poiché quelle del rimanente 90%, per quanto possano essere state a loro tempo autentiche, oggi non lo sono più (e Adorno sta occhieggiando dalla finestra).
Io temo però che ci troviamo di fronte a un altro abbaglio prospettico, che potrei descrivere come segue. La poesia riuscita, che ci piace, che definiremmo bella, è quella che mette in crisi il moi (con la sua assertività, suppongo) e che esprime dunque, in qualche modo, il presente. Questa è un’asserzione che sottoscriverei, a patto di non confonderla con il suo converso, che è questo: la poesia che mette in crisi il moi e che esprime dunque, in qualche modo, il presente, è quella riuscita, che ci piace, che definiremmo bella. Questa seconda, a differenza della prima, è un’asserzione prescrittiva, che ci dice che attraverso questi mezzi possiamo arrivare al fine della buona poesia; ma riduzione dell’io ed espressione del presente non sono mezzi, bensì fini. Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia. Qualche volta potrà sembrare che lo faccia, ma sarà un effetto di superficie: pensiamo a – per fare un esempio di qualche anno fa – le poesie di Sandro Penna. Apparentemente centrate sull’io, sentimentali, banali come lessico e come sintassi; ma appena le si guarda più da vicino complessissime e strapiene di ragioni di interesse – in barba alla complicazione esibita delle poesie ermetiche loro coeve!
Questo mi rimanda all’altro punto cruciale su cui Giovenale insiste nel suo commento, cioè la questione dell’oscurità. Avevo affrontato una questione simile in un post di qualche mese fa (Del diritto della poesia a essere incomprensibile). In quel post distinguevo tra il diritto che la poesia ha all’oscurità (e dei suoi fondati motivi), e l’opportunità di non essere invece oscuri, e arrivavo a dire:
Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.
Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)
Il primo pregio delle poesie di Amelia Rosselli è quello di essere (almeno per me) fortemente coinvolgenti. Esprimerebbero una riduzione dell’io anche se non la tematizzassero; in più la tematizzano, spesso.
Per quanto riguarda Le petit bidon di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…
Dove voglio arrivare non lo so. Quello che mi è ben chiaro è che la poesia è una cosa e le poetiche ne sono un’altra, che sta già sul versante della critica. Per questo la poesia possiede un diritto ad essere oscura che la critica invece non ha. Certo l’oscurità di un testo poetico aumenta la sua probabilità di non poter essere inteso, e senza un’intesa (il gioco di parole è voluto) tra il testo e il lettore non parte il meccanismo che ci permette di entrare nel gioco, di essere coinvolti, di trovare interessante la casa, l’ambiente che ci circonda. Oltre un certo limite di oscurità l’intesa non viene trovata più da nessuno, e il testo poetico è come una casa (magari meravigliosa) di cui nessuno possiede la chiave. Un oggetto inutile, insomma.
(continua – molto molto a lungo, probabilmente)










 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email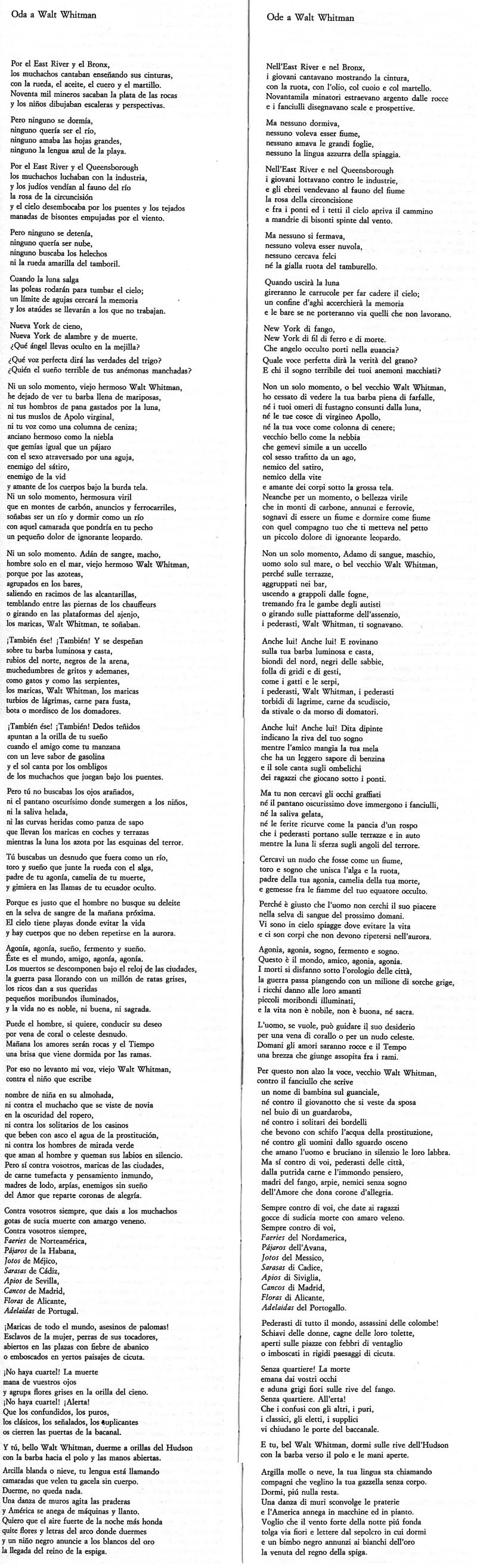




D.: Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%?
M.: e se fosse la percezione di quella “grammatica della complessità” nei discorsi, ad esser cambiata? E se lo è, avrà o no ricadute nei punti meno sguarniti, meno ingenui, meno [utilitaristicamente] *comunicativi* delle regioni del linguaggio, ossia nei territori della produzione di senso che attribuiamo alla scrittura poetica? (o postpoetica che dir si voglia).
D.: non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità.
M.: nemmeno che non possa farlo. (O che il suo pubblico e i suoi autori si debbano comportare e debbano reagire come se chi invece lo fa [=chi “esprime la contemporaneità”] stesse semplicemente dando una mano di bianco a una stanza che *ciononostante* sarebbe sempre la stessa).
D.: non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità.
M.: possiamo in ogni caso riferirci meno a *contenuti* che a *forme*? Mi spiego. NON dico che (e so che non è – o spero che non sia – questo che intendi tu): ||| nelle poesie si deve parlare “di” html e cellulari, per *essere assolutamente moderni*|||. Ma mi riesce difficile non pensare che a monte delle nuove scritture (che a mio avviso sono più semplici e *uomo-della-strada* rispetto ad alcune degli anni Sessanta) non dobbiamo vedere precisamente la nostra percezione di e familiarità con codici e luoghi e oggetti e contesti materiali mutati nel secondo Novecento in modo irreversibile.
D.: non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti.
M.: le esplicitazioni che fai confermano la mia interpretazione: non penso di aver mai scritto che si parla “_solo_ di quello che è nuovo e recente”. E nemmeno direi mai che si parla “_di_ quello che è nuovo e recente”. Mi sembra di aver più o meno sempre sostenuto che si parla *con* percezioni (=essendo radicalmente noi già installati in percezioni) mutate, e tuttavia non parliamo mai *solo* in quel modo. Vedo che ogni volta che si nomina il cambiamento, la risposta è: “ma tu vedi *solo* il cambiamento”. Ho le traveggole o questa è una resistenza? (Psicologica). Chi ha detto che si debba parlare “solo” di/con/per/tra/fra eccetera? E però, allo stesso tempo, confesso a voce alta: a me sembra difficilissimo per un autore avvertito non avvertire l’aria attorno. *Forzarsi*, e non avvertirla. *Fingere* di non avvertirla. E aggiungo: se quell’autore (pur avendola chiaramente percepita, avvertita, pur incarnandola) scrive autoritratti alla Michelangelo, e lo fa volendo *essere* Michelangelo, niente toglie che magari *anche* questo sia nell’aria (o almeno nella *sua* aria). Allo stesso tempo, tornando alla metafora dell’ambiente: se quello stesso autore, finita la poesia michelangiolesca, manda un sms per prendere un appuntamento col suo commercialista, penso pure che egli medesimo oibò dimostra di NON sentire affatto contraddizione tra il linguaggio-contesto in cui vive (il cellulare che usa) e le richieste (gli sms impliciti) che diversamente invia ai suoi lettori scrivendo come scrive. Ebbene: OK. Non glielo impedisco! A che titolo? Mi sembra solo (se lo fa in tutta serietà aspettandosi che io pure indossi i suoi abiti e ardisca di chiedere udienza a Giulio II) fuori sincrono. Almeno un po’. Ma – bon – e boh – …può essere una poetica. (Ne dubito, se inconscia). (Ma chissà).
D.: Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.
M.: vedo che proprio non riesco a spiegarmi! Continua a esser verificata l’idea dell’ambiente. Se non si va insieme in una casa non ci si intende su cosa significa (anzi cosa “è”) uno spazio comune. Dunque. Nei testi dei nuovi autori (francesi, inglesi, perfino italiani) mancano forse queste cose? Mancano le mutande, e la pelle, e i muscoli eccetera? Direi proprio di no, perdindirindina. Ma sarà o no differente dal Tarkos – che infinite volte cito – un autore che accetta di passare sopra alle variazioni di percezione di cui sopra? Continuo a sentire questa differenza. È differenza di ambiente, di orizzonte. Differenza fortissima a partire dagli anni Sessanta in qua, e solo *mascherata*, banalmente occultata dal permanere e tramandarsi di forme e modi e moduli (a mio avviso non per protervo complotto della società letteraria, ma per sua umanissima – non meno che perniciosa – inerzia).
D.: Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.
M.: dissento assai vigorosamente. Ma meno sul termine “sacralità” (pur laico, immagino, nella tua accezione) che sulla “naturalità” (pur virgolettata) delle strutture. A mio avviso [ripeto, insisto, sottolineo, risbandiero, scolpisco, vocalizzo: A MIO AVVISO è difficile considerare che] quelle strutture non sono [non siano] vive se non precisamente nel *mutare* della tradizione. La tradizione sembra (con una certa verificabile costanza) tramandare sì ma a patto di variare. Di solito, come umani, trasmettiamo efficacemente qualcosa nei secoli a patto di tradirla anche un po’. Bon. Ciò detto, ecco: arriva un punto in cui il meccanismo, questo meccanismo del passaggio del mutevole testimone di mano in mano, incontra mutazioni *più grandi* della propria stessa natura (meccanica). E diventa altro. Questo è, A MIO AVVISO, quello che è successo negli anni Sessanta. La tradizione ha continuato a tramandare (a mutare/tramandare “qualcosa” che, per essere tramandato, doveva variare sempre un po’, tanto o poco)… ma a un certo punto il panorama intorno, le percezioni delle persone, gli impliciti negli sguardi e nelle parole, non erano più quelli che potevano far *ingenuamente* funzionare (veder funzionare, fingere che funzionasse) il meccanismo detto, di tradizione, per come era stato fin lì. Leggiamo o ascoltiamo o riascoltiamo le interviste di Alberto Grifi sul cinema, molte sono su youtube: è tutto là. Pensa a *La verifica incerta*, anno 1964 (la stessa data di *Pseudobaudelaire*, di Costa: toh). (Ma com’è che questa storia del cambio di paradigma è così piena di coincidenze?). Grifi mi pare limpidissimo, perfino in annotazioni a proposito di *Anna*: “[quelle di *Anna*] sono scelte esemplari di alcuni pezzi [di vita, filmata] che possono denunciare una grammatica che già puzzava all’epoca, e che stava cambiando” (http://www.youtube.com/watch?v=EYJ1pgXc7BI). STAVA CAMBIANDO (e perciò *poi*, ora, è cambiata). Dunque. Quel che sostengo è: tale grammatica è cambiata quasi ovunque, e ha costituito l’impalcatura (radicalmente nuova) dei codici che nei decenni fino a oggi si sono succeduti, e tuttavia in poesia si stenta ad ammetterlo, nel 90% dei casi (che mi capita di leggere in giro). E attenzione: il cambiamento può anche essere rifiutato, contestato, ribaltato, e si può legittimamente riprendere (come alla grande tutto il cinema sembra fare) i codici e i modi percettivi e le grammatiche precedenti come se nulla fosse successo, come se la nostra mente non funzionasse esattamente e direi fraternamente secondo le grammatiche de *La verifica incerta* o le pause e i *vuoti* pazzeschi in *Anna*. Si può. È, anzi, quello che costantemente vedi (è TUTTO quel che vedi) nel 90% dei siti e blog di poesia in giro. È legittimo. Perché però chiedere di forzare le nostre (le mie) percezioni in un “come se”? Perché, se qualcuno/-a invece dimostra – testi alla mano – che la sua pagina è in sincrono con Grifi e con Rosa Menkman [http://rosa-menkman.blogspot.it/], gli o le si chiede la patente di poeta? (Quando, per altro, lui o lei ha altri documenti… magari di postpoeta! 🙂
D.: Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia.
M.: non è mia intenzione banalizzare l’esempio (che evidentemente vuol essere paradossale), ma: precisamente, il darsi di un cambio di paradigma APRE giusto a questa prospettiva, Daniele: http://slowforward.wordpress.com/2012/09/29/riambientarsi-ma-anche-difendersi. È proprio perché *dopo* il cambio di paradigma mi è difficile vedere le zampe del cavallo come le vedeva Géricault, che posso dipingere (ironicamente, o – per dire – in *modalità flarf*) il cavallo *come* avrebbe fatto Géricault prima dell’avvento della fotografia. Diverso il caso in cui io mi trovi di fronte a un pittore che dipinge *come* Géricault perché *non sa o non vuole sapere che* la fotografia cambia il mio modo di vedere le cose. Se poi addirittura quel pittore vuole che io lo segua in un tempo ante-1839, sarà o no legittimo un mio atteggiamento scettico e dubitoso? [Non ho la stoffa (o l’armatura!) per parlare con Giulio II, mea culpa]. Dipingere coniglietti è precisamente quanto fanno tanti poeti post-paradigma; ma è quel che fanno anche tanti operatori kitsch. Dei due, a chi ci rivolgeremo, se siamo in cerca di occasioni di senso? [Che preferisco al termine “sacralità”, nettamente]
D.: …le poesie di Sandro Penna…
M.: sulla complessità e sul valore dei piccoli gioielli ho detto la mia tante volte. Per esempio in riferimento a Dickinson. Cfr. la mia lettura di questi sei incredibili versi: http://slowforward.wordpress.com/2008/04/03/emily-spring [nb: l’analisi minuta del testo è quasi raddoppiata nella nuova forma che ho dato alla traduzione/lettura sull’ultimo numero di “Semicerchio”, dedicato al convegno di Napoli sulla traduzione: a quel fascicolo rimando] [Infine: l’esistenza di una scrittura *dopo il paradigma* non può certo cancellare i dati di profondità, bellezza, stratificazione, complessità, produzione di senso che stanno nelle scritture precedenti! C’è anzi un qualche dato – precisamente di trasmissione di senso – che permane nel variare e perfino nel *rivoluzionarsi* delle modalità e dei contesti generali di percezione, prima e dopo il paradigma. Ciò non significa che sia alieno da ogni rischio di kitsch un autore che scrivesse oggi *esattamente* ricalcando non dico i testi e le forme di Penna, ma le attese e richieste di feedback che Penna proiettava sul lettore, sul gioco/margine e percorso ermeneutico del lettore verso la sua poesia]
D.: Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)
M.: ma se fosse proprio quel “senso banale” a chiedere di riconfigurare la nostra percezione del fatto letterario? Se fossero, le informazioni che Zaffarano ci dà sulla nascita della scrittura (e che non è mica detto che i lettori, e anche i lettori della poesia, abbiano già), il o un “bello” di quel testo? E se fosse meno importante l’a-capo, la cesura tra “l’invenzione della scrittura” e “è legata a esigenze di amministrazione” rispetto a quanto (frammentariamente) il testo mi sta dicendo? E se potessi (perfino *dovessi*, da lettore di poesia) cogliere qua e là l’arbitrarietà della forma (degli a-capo, delle cesure) non come distacco da una responsabilità autoriale ma proprio come un’assunzione di *altra* responsabilità, indirizzata alla superficie e letteralità (littéralité) del testo rispetto alle proiezioni che il presunto solido “moi” autoriale getterebbe sulle mie reazioni al testo? E se il testo di Zaffarano non volesse rivendicare alcun *fond* e *inconnu* e *nouveau*, ma facesse *uso* di modi delle avanguardie che non vanno semplicemente incasellati nella scatola “modi delle avanguardie” ma pianamente percepiti e apprezzati (se e quando ci piacciono le cose che ne vengon fuori, certo) come modi che già usiamo per fare mille altre cose e comunicare in mille altre occasioni? Se fossero “poesia”, in questo senso, anche certe righe di comunicazione che alcuni videogiochi ci rimandano? (Raos ne usa, nel suo *Le api migratori*, per dire). Lo sapevamo già che “la terza dinastia / di ur aveva oltre trecentomila abitanti”? Se non lo sapevamo, perché al poeta dovrebbe essere interdetto di chiederci un interesse, un ascolto? Mi dirai: ma in cosa differisce allora il poeta dallo storico? Ti risponderei: nel fatto che lo storico ti dà solo il dato, mentre il poeta (o postpoeta) nel darti il dato ti chiede anche di fare un percorso (per altro non complicato/implementato/esaltato da rime metri e altri già noti luoghi della legittima retorica usuale) nel testo, nella pagina. Quello che tu chiedi a Zaffarano è esattamente quello (ma non un “quid”, più un “modus”, un ambiente, non una “cosa”) che lui chiede a te di cercare. Non come un enigma, ma come un’area di senso. A cui però non si accede se non ci si libera dall’ossessione interpretativa, notomizzante, che è naturalmente (non illegittimamente) applicabile e funzionante/funzionale quando in campo sono oggetti “à la Penna” (Dickinson, Carroll, Montale, Gadda ecc.), ossia scritti secondo un certo – ampio ma non indeterminato – paradigma. Non so come altro scriverlo, non so come altro dirlo, e penso che non tornerò più (me lo auguro) sull’argomento… [Se non citando i testi in quanto tali, o meglio un ulteriore, e forse per miei limiti inefficace, brano critico: http://puntocritico.eu/?p=1400%5D
D.: Per quanto riguarda *Le petit bidon* di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…
M.: direi esattamente il contrario. *Le petit bidon* addirittura può *guadagnare* (sul piano del suo “essere ambiente”) una volta visto su pagina. La voce è parte forte e importante della *registrazione* che troviamo in rete, non *anche* (tantomeno *necessariamente*) del testo (che è base e fondamento della registrazione, ma non si esaurisce in questa; così come si può dire che questa retroagisce sul testo e ne esalta alcune caratteristiche, ma non sa sostituirlo). Sempre in http://slowforward.wordpress.com/2012/09/29/riambientarsi-ma-anche-difendersi ho trascritto uno dei brani di Tarkos da *Anachronismes*. Mi dirai: a me quel *Petit bidon* e il brano da *Anachronismes* nel tuo saggetto non dicono niente. Ti dirò: a me non dice niente (se dobbiamo fare per forza “linea dura”) un testo di XY che mi chiede *ancora* di essere letto secondo isotopie, simboli, sapienti enjambements. Ma posso forzarmi e – pur controvoglia spesso – arrivare al luogo dove quel testo di XY mi dà appuntamento, e trovarci come già prevedo e ben vedo le isotopie i simboli i sapienti enjambements, la sua *profondità* (che – spero – eccede quei click retorici), e infine dirmi e dire all’autore: “ok, bello, è profondo & gaudiosamente vi scorgo isotopie simboli sapienti enjambements, ciao, alla prossima”. Ok? Ti assicuro: so farlo, lo faccio costantemente. E per alcuni non è in campo alcuna superficialità: davvero apprezzo scritture “ancora” (come molte mie!) del tutto dentro il paradigma. (Diciamo che però qualche esperienza mi dice che non succederà il contrario: ossia mai [o raramente] accade che quel poeta autore di sapienti eccetera venga, lui, all’appuntamento – senza segnacoli a lui già noti – col *mio* testo). Quell’autore è (spesso) il pittore del cavallo di Géricault, cavallo che vuole essere apprezzato in quanto tale: zampe dritte. Posso farlo anch’io. Credimi, posso apprezzarlo, sono un lettore per 31 anni (quasi tre quarti di vita) affondato nel XX secolo, ma *posso* fare anche altro. Ne avrò facoltà?
D.: Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa
M.: Daccapo non ci capiamo. Se *Le petit bidon* dovesse o volesse essere o presentarsi come “fascinosa metafora” (davvero: “di chissà cosa”!) NON saremmo in uno spazio DOPO il paradigma. Saremmo ancora in uno spazio in cui *va cercato* (e non avvertito con altre antenne) (che ci sono, che abbiamo!) un senso.
Temo di non poter lavorare ancora a ulteriori risposte, per improcrastinabili inaggirabili caos che mi inseguono. Spero ci saranno nuove occasioni di dialogo – testi alla mano – più avanti.
*
post scriptum: http://gammm.org/index.php/2012/05/24/da-tre-lezioni-di-morale-emmanuel-hocquard-1979-lettura-di-michele-zaffarano/
Ringrazio sentitamente Daniele per il beneficio del dubbio sulla mia poesia, che non sta a me qui né difendere né spiegare (grazie a dio, diranno subito i miei piccoli lettori).
Giusto per annotare un paio di *questiones*.
1.
La prima relativa alla frase che dice: « Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo MI APPARE COME UN TESTO VUOTO, NON INTERESSANTE» (il maiuscolato è nostro – mio e di Giulio Cesare).
Volevo esprimere la mia (nostra) totale condivisione con questo punto di vista, che del resto è la stessa cosa che penso io (pensiamo noi) davanti a uno che mi (ci) ferma per strada e mi (ci) dice con fare strafottente: «E = mc2» – è sicuramente uno che sta cercando di darmela (darcela) a bere, ma fortunatamente io (noi) non ci casco (non ci caschiamo) perché sono (siamo) uomo di mondo (uomini di mondo).
2.
La seconda questio vuole formulare la mia totale adesione all’affermazione di Daniele che «non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità».
Io lo capisco benissimo. Anche io, sono anni che mi ostino a credere (e che cerco di convincere tutti quelli che incontro) che questo non è il pianeta Terra (terzo pianeta dal Sole) ma il terzo pianeta da Alfa Centauri. È facile sbagliarsi, è sempre il numero 3. Giulio Cesare, che qui di fianco mi sta facendo dei segni strani e dando colpetti con il gomito, dice di essere d’accordo anche lui (confessione: i primi cinque versi della terza poesia del mio secondo libro li ha scritti lui – a meno che non abbia copiato da Magellano).
Be’, detto così con fare strafottente per strada, E=mc2 può voler dire “Einstein è una Mezza Calzetta 2 volte”, oppure “Enmengalanna Mica Crede A”, o anche “Empoli=mura coronate 2”, o anche molto altro. Quindi bisogna stare davvero attenti a non cascarci.
D’altra parte anche capire di quale stella siamo il terzo pianeta non è cosa da incontro per tutti. E quelli che desiderano non capirlo, perché insistere?
… e infatti.
Seguo il suggerimento,
allora,
e non insisto.
Wow!
Alla fine di tutto questo vostro dialogare se ne esce bruciati!
D’accordo: dopo la bruciatura viene l’incenerimento. Spero non arriviate a tanto. Rimanete invece abitanti del terzo pianeta, qualunque esso sia.
Cordialità.
Rimarremo, anzi rimaniamo. Non ti preoccupare. La bruciatura è virtuale e terapeutica. Poi appena ho tempo rispondo anche a Marco, così la terapia è più intensa.
Ciao
@Marco
Farò solo un paio di precisazioni e un discorso generale.
Mi sembri molto colpito dall’asserzione “non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità”. È ovvio che “nemmeno che non possa farlo”. È ovvio che lo fa. Ed è pure ovvio che certi modi di esprimerla possano apparire ostici o astrusi a qualcuno. Non è questo il punto. Non sto cercando di prescrivere nulla. Sono – a priori – aperto e positivo verso qualsiasi esperimento (sennò non starei a discutere con te e a cercare di capire il tuo punto di vista). E credo che lo si debba essere. Il caso di Sandro Penna lo insegna – poi certo, quello che lui ha fatto nel suo momento non sarebbe esportabile al nostro nemmeno in termini di attese e richieste di feedback proiettate sul lettore: tuttavia, in un momento in cui tutti discutevano di altro, lui ha semplicemente mostrato quanto i termini della questione fossero limitati. Bastava farne un passo al di fuori. Certo, il passo giusto – tutt’altro che facile da fare.
La seconda precisazione è quella che riguarda il “parlare di quello che è nuovo o recente”. Non mi riferisco a ciò a cui fanno riferimento le parole della poesia. Mi è piuttosto indifferente che le parole parlino di amore, di Omero o di cellulari o html. La poesia parla con questi e soprattutto altri mezzi. La superficie lessicale è solo una superficie. Qualunque sia la valutazione che do del testo di Zaffarano, sull’origine della scrittura, non ho il minimo dubbio che sia un testo che parla del presente, anche se il suo oggetto apparente risale a diverse migliaia di anni fa.
Ora veniamo al discorso generale. L’autore che scrive autoritratti alla Michelangelo, nella tua metafora, probabilmente è solo un cattivo autore; o al massimo un Pierre Menard (che magari ti interesserebbe di più – e ci torno tra poco). Ma io non giudico a priori. Se leggendo i suoi testi io li scoprissi interessanti, sarebbe perché ci sto trovando una ragione, perché mi parlano, perché ci ritrovo qualcosa che mi coinvolge. Se sono un filisteo (tanto per tornare a un termine da apocalittici) mi piaceranno testi kitsch, presumibilmente. Ma se sono un filisteo (tanto per riprendere tematiche da apocalittici) non avrò nemmeno un reale interesse a capire, ad approfondire, a sentire. Sarò interessato più al valore economico che a quello simbolico.
Ma torniamo a Pierre Menard. Il racconto di Borges è geniale per vari motivi. In primis perché parla delle meraviglie dell’interpretazione (e questo avvince sempre i semiologi come me); ma in secundis perché sta parlando dell’arte del Novecento, che è in gran parte arte che parla di arte.
Leggendo il tuo testo su puntocritico dove parli delle prose di Broggi, io ho avuto la stessa sensazione che di fronte al racconto di Borges. Solo che là dove Borges si esprimeva nelle forme del paradosso o della parabola, tu mi spiegavi la stessa cosa sul serio rispetto alle prose di Broggi.
Sarà stanchezza. Sarà che Duchamp andava benissimo, perché in quel momento la sua operazione aveva un senso profondo. E Balestrini anche (benché già un po’ meno) perché pure la sua operazione aveva senso nel momento in cui la faceva. Ma io di fronte a questi testi di ora mi ritrovo a guardare degli oggetti che già conosco, trattati attraverso delle operazioni che già conosco – e non provo più nemmeno il brivido intellettuale che mi procuravano Duchamp e Balestrini (e Pierre Menard attraverso le parole di Borges).
Certo, c’è l’esempio di Mimmo Rotella. Anche Rotella lavora con frammenti di discorso consumato. Sarà che gli anni sono ancora quelli di Balestrini, o sarà che l’operazione di Rotella non si limita a esibire, ma lo fa attraverso l’operazione dello strappo, che aggiunge una grande quantità di senso al testo ostentato.
Allora quando leggo Broggi o Zaffarano (finiti quasi per caso, qui, nel mirino – sono esempi, non obiettivi polemici, e mi riferisco solo ai testi che abbiamo citato), o li leggo come dei Pierre Menard, e allora non c’è gusto, o c’è stanchezza (e nessuna contemporaneità, comunque), oppure devo capire qual è l’operazione corrispondente allo strappo di Rotella, che mi rende così affascinanti le sue opere. E l’oscurità (per tornare al nostro tema) è qui. La chiave mi manca. E mi fermo, perché non c’è nessun piacere ad andare avanti: il gioco delle interpretazioni si è chiuso, almeno per me.
Tanto per farmi dei nemici sino in fondo – ma a essere sinceri capita – ho apprezzato molto invece Le api migratori di Raos. Sarà forse che lì ho trovato la chiave, sarà che la modalità dei suoi strappi mi era più evidente. Sarà che c’era anche dell’altro. Ancora non lo so. Ci penserò.
Una nota, per finire. La “fascinosa metafora” io lo so cos’è, al di là del termine ad effetto: un indiretto parlare di. Ma le “antenne”, con cui andrebbe avvertito un senso, a me fanno un po’ paura, e mi sanno di simbolismo. Forse c’erano prima e ci sono anche adesso. Forse non c’è alternativa. In ogni caso non sono post-paradigma, qualunque paradigma sia.
Ciao
su Penna: daccapo, ri-linko quel saggio di lettura su quel preciso (assai penniano) testo di Dickinson.
su Z.: “la superficie lessicale è solo la superficie”, dici. d’accordo: ma è con le superfici che si fabbricano le case. osservare solo le superfici (leggere solo la sequenza senza proiettare in verticale ciò che quella implica) vuol dire perdere o rischiare di perdere di vista la casa.
cito: “Sarà che Duchamp andava benissimo, perché in quel momento la sua operazione aveva un senso profondo. E Balestrini anche (benché già un po’ meno) perché pure la sua operazione aveva senso nel momento in cui la faceva. Ma io di fronte a questi testi di ora mi ritrovo a guardare degli oggetti che già conosco”.
rispondo: non sarà che li ri/conosci perché – esattamente come dico – è l’intero paradigma e contesto attorno a essere cambiato? e non sarà dunque che ci troviamo esattamente nella situazione che descrivo?
cito: “il gioco delle interpretazioni si è chiuso, almeno per me”.
suggerisco: e se si aprisse invece quello delle abitazioni? del riambientamento?
su Tarkos. è proprio Ponge dopo il paradigma! e senza nessun metatesto. dunque ha lasciato alle spalle anche (alcuni versanti di) Tel Quel. ossia: corrisponde esattamente a quello che è: un autore francese di riferimento per la scrittura di ricerca al passaggio tra XX e XXI secolo.
ma comunque.
http://gammm.org/index.php/2006/11/05/curriculum-di-studi-scientifici-johann-wolfgang-von-goethe/
Marco, non sono sicuro di avere capito bene le tue risposte. E, in particolare, nel link alla Dickinson che mi indichi io trovo solo una traduzione e delle (interessanti) note di traduzione – ma nulla che mi risponda sull’esempio di Penna – a meno che tu non voglia semplicemente esprimere il tuo apprezzamento per Dickinson (e Penna). E allora siamo d’accordo.
Sull’opposizione che proponi interpretazioni vs abitazioni (riambientamento), io non la vedo come un’opposizione. Per abitare una casa, per ambientarmici, io la devo capire, cioè devo trovarne un’interpretazione, che sarà parziale, provvisoria, di servizio, mutevole… Ma senza quella io non farei che andare a sbattere continuamente contro i muri: per abitarla devo averne una qualche comprensione – anche se nessuna comprensione esaurirà mai quello che ne posso comprendere. Ma anzi ogni comprensione potrà essere un punto di appoggio per un’altra comprensione, migliore, o anche proprio diversa.
Se dico che il gioco delle interpretazioni si è chiuso, vuol dire che ho rinunciato ad ambientarmi/abitare in quella casa – almeno sino a quando non intervenga qualcosa che me lo faccia riaprire.
(In campo estetico credo che sia sbagliato bocciare qualcosa in maniera definitiva – anche se ci sono testi, a volte, che inducono molto in tentazione – perché è sempre possibile accorgersi che la nostra chiave di lettura era sbagliata. Cerco di non dire, e di non pensare: è brutto. Preferisco dire: non capisco, o , per quanto ne capisco ora, mi sembra banale. Ho già fatto abbastanza errori di cui mi sono pentito, poi.)
sulla Dickinson: come quasi sempre in Penna, anche (non la Dickinson ‘in generale’ ma) in *quel* testo di E.D. – analizzato nei dettagli – si dimostra o si tenta di dimostrare come – a mio avviso – la complessità e la ricchezza del senso possano nascondersi sotto l’apparente linearità limpidezza di rime e l’aspetto ‘aeriforme’, impalpabile (leggero e vagante, sabiano) della pagina. (questo, in una pagina appunto ben ‘prima’ di ogni ipotizzabile cambio di paradigma).
questo riconoscimento aveva questo senso. come altrimenti spiegarmi?
(a replicare, ossia a dire che non ha senso e non è mai stata mia intenzione – figuriamoci, con Penna poi – “bocciare qualcosa in maniera definitiva”).
*
sull’abitare, rimando di nuovo al testo che scrivevi su questo blog tempo fa, proprio sull’entrare in un nuovo ambiente. ma di questo avremo modo credo di parlare più avanti.
http://eexxiitt.blogspot.it/2012/09/spiegazione-della-scrittura-di-ricerca.html
Avremo modo.
Solo sul “bocciare qualcosa in maniera definitiva”. Non mi riferivo a te, Marco, e tanto meno a te su Penna. Mi riferivo alla possibilità di interpretare in questo senso le mie parole “il gioco delle interpretazioni si è chiuso”, perché fosse chiaro che sempre di chiusura temporanea si tratta, in attesa di nuove chiavi (talvolta in seguito si trovano, talvolta no; nel frattempo non si può procedere).
db
🙂
http://slowforward.wordpress.com/2012/10/08/segni-paralleli/
Scusate, ma anche se la discussione è molto articolato e non me ma sento di riprendere tutti i fili, c’è un punto almeno sul quale non riesco a non intervenire. Riprendo un passaggio di Daniele:
“Sarà che Duchamp andava benissimo, perché in quel momento la sua operazione aveva un senso profondo. E Balestrini anche (benché già un po’ meno) perché pure la sua operazione aveva senso nel momento in cui la faceva. Ma io di fronte a questi testi di ora mi ritrovo a guardare degli oggetti che già conosco, trattati attraverso delle operazioni che già conosco – e non provo più nemmeno il brivido intellettuale che mi procuravano Duchamp e Balestrini (e Pierre Menard attraverso le parole di Borges).
Certo, c’è l’esempio di Mimmo Rotella. Anche Rotella lavora con frammenti di discorso consumato. Sarà che gli anni sono ancora quelli di Balestrini, o sarà che l’operazione di Rotella non si limita a esibire, ma lo fa attraverso l’operazione dello strappo, che aggiunge una grande quantità di senso al testo ostentato.
Allora quando leggo Broggi o Zaffarano (finiti quasi per caso, qui, nel mirino – sono esempi, non obiettivi polemici, e mi riferisco solo ai testi che abbiamo citato), o li leggo come dei Pierre Menard, e allora non c’è gusto, o c’è stanchezza (e nessuna contemporaneità, comunque), oppure devo capire qual è l’operazione corrispondente allo strappo di Rotella, che mi rende così affascinanti le sue opere.”
Ora, posto che è del tutto legittimo dire io preferisco un autore ad un altro, preferisco Raos a Zaffarano, ad esempio, questo testo mi convince più di un altro, ecc., trovo nella risposta di Daniele un atteggiamento molto riduttivo, che mi meraviglia in qualcuno come lui che è curioso, attento e appassionato esploratore della poesia.
La prima cosa che mi viene da dire, è che i Pierre Menard popolano la poesia, da ogni latitudine: ci sono Menard leopardiani, pascoliani, sabiani, montaliani, ecc. Quindi l’esempio di Menard non è in nessun modo specifico di poesie in qualche modo imparentate con le avanguardie novecentesche.
Secondo punto. Leggendo Daniele verrebbe da pensare che Duchamp è interessante solo nel suo contesto storico, cosi come Balestrini: “la sua operazione aveva senso nel momento in cui la faceva”. Ora, questo è un’idea condivisa da molti. Per me è un’idea assai oscura. Non so bene che cosa voglia dire. Se questo è vero: tutta l’arte delle avanguardie avrebbe dovuto essere dimenticata subito, in quanto di tutte le produzioni artistiche quelle avanguardistiche dovrebbero essere le più effimere: dagli impressionisti in poi, una quantità di cose dovrebbero essere mandate al macero, perché avevano “senso nel momento in cui sono state fatte”. Come se per Leopardi non si potesse fare un identico discorso.
A me sembra che il punto sia un altro. Certo, c’è qualcosa che è dell’ordine del brivido intellettuale del letto per la prima volta: il cut-up di Balestrini, mettiamo. Ma la faccenda mica finisce li. Non solo Balestrin ha senso nel momento in cui fa il cut-up, ma apre un nuovo universo di senso: crea nuove forme di piacere della lettura. Non è che tutto si risolve con il riconoscimento del procedimento. Significa scambiare i mezzi con i fini. Né si puo’ limitare a considerare solo la pars destruens di questo tipo di operazioni. Li, in quei testi, non è siolo la poesia conosciuta, ufficiale, che viene messa a morte, ma un’altra possibile nasce, dentro quella specifica testualità, che va percorsa pagina dopo pagina.
Dopodiché valgano tutti i giudizi di gusto: preferisco Pagliarani a Balestrini, Costa alla Vicinelli, Mesa a Spatola, ecc. Giudizi che si possono motivare: trovo che l’universo “aperto” da Balestrini, o da Zaffarano “non mi parla” quanto quello apartomi da X e Y; Ma qui siamo nell’ambito dei giudizi relativi. La mossa di Menard, invece, vorrebe squalificare il candidato, ancora prima di aprire il dibattito pubblico sulle preferenze. Perché dice: ma questo “non fa” poesia, questo “non è” nel nostro tempo, non ha i titoli per concorrere.
Spero di essermi spiegato nonostante la necessaria brevità.
Un saluto amichevole
a.
Caro Andrea, Pierre Menard, nel racconto di Borges, non è uno che copia Cervantes cercando di riprodurne l’effetto, come fanno tutti gli emuli leopardiani, pascoliani, sabiani, montaliani ecc. È piuttosto uno che prende il medesimo testo di Cervantes, riproponendolo in un contesto storico e culturale differente, consapevole che le medesime parole dovranno essere rilette con un senso tutto diverso. In questo senso la sua operazione è esattamente la stessa che fa Duchamp, quando prende un oggetto qualsiasi e lo ricontestualizza, costringendoci a reinterpretarlo e a guardarlo con occhi nuovi (e quindi ad attribuirgli sensi che nel contesto originario non poteva avere).
Quanto al secondo punto, non solo Duchamp è interessante solo nel suo contesto storico, ma lo è qualsiasi opera d’arte della storia, a partire da Fidia o da Saffo, le cui opere ci appaiono straordinarie perché avvolte da un’aura di cui è parte consistenza la consapevolezza dell’epoca in cui sono state prodotte. Ne è prova il fatto che un autore che riproponesse oggi quelle forme o sarebbe anacronistico e non significativo, oppure starebbe facendo un’operazione un po’ alla Pierre Menard, costringendoci a reinterpretare le medesime forme in tutt’altro modo. La stessa o una simile aura avvolge il lavoro di Duchamp, come tutti i lavori che la storia ci ha trasmesso come degni di memoria; e ne godiamo ben consapevoli delle condizioni culturali in cui sono nati.
Ora, certamente le nostre condizioni culturali sono ancora abbastanza simili a quelle in cui lavorava Duchamp (certamente molto più simili a quelle di Saffo e Fidia); e questo giustifica l’esistenza e il valore di opere che si ispirino a quella operazione.
Tuttavia, date queste premesse, accade che talvolta io non riesca a vedere nell’opera che ho davanti molto di più di quello che vedevo in Duchamp o Balestrini, e allora il mio interesse si spegne (sempre con la clausola di potenziale apertura, per cui se dovessi in qualche momento trovare una chiave di lettura diversa, sono immediatamente pronto a riaprire il gioco); altre volte, invece, anche se il gioco alla Pierre Menard è presente, mi appare come solo una delle componenti messe in gioco, e, se ce ne sono altre che io trovo interessanti, può essere allora parte di una ricchezza, di un gioco di rimandi. Questo è quello che tu chiami (la nascita di) un’altra poesia possibile.
La mossa di Menard (come la chiami) non intende perciò squalificare il candidato; semmai l’opera, però per il momento e in attesa di eventuali rivelazioni (che mi siano spiegate da altri, o che derivino dall’evoluzione di mie riflessioni personali). Le rivelazioni magari non arriveranno mai, e io resterò della mia idea di partenza. Ma ho già cambiato idea varie volte nella vita, e suppongo che accadrà ancora. Per ora la penso così, in generale e sui testi che ho citato.
Ciao
db
Caro Daniele,
ti rngrazio della precisazione, e comprendo meglio quanto hai inteso dire, citando Borges.
Un punto continua però a rimanere oscuro. Lasciamo tra parentesi la questione del significato storico delle opere. Ci porterebbe lonnao e probabilmente, alla fine, sui principi saremmo grosso modo d’accordo.
Torniamo all’esempio di Zaffarano. (Del cui testo, sia chiaro, nessuno ti vuole convincerti a forza che ti debba piacere :).
Però. Io ci vedo una struttura argomentativa ricorrente. Di fronte a quel testo di Zaffarano tu evochi Duchamp, Balestrini, Rotella. Perché?
Perché, intendo dire, non giustificare il tuo giudizio sul testo di Zaffarano cercando di parlare di quel suo testo, di come funziona, di quel che cerca di fare, e del perché secondo te non riesce a farlo bene, o non ti interessa quello che fa.
Io parlavo di riduzionismo, perché è come se quando ci si trova di fronte a un certo tipo di lavoro, si riportasse sempre tutto a una sola categoria di gesto avanguardista: mettiamo, la disarticolazione sintattica all’interno della frase, oppure l’inserimento nello spazio museale dell’oggetto ordinario. In questo modo sembra che ci sia un identico gesto, che viene ripetuto in diversi momenti del tempo. Ma ripeto: parliamo di che cosa quel gesto ha prodotto, non tanto del suo grado di novità. Il cut-up, ad esempio, può essere un procedimento testuale tra gli altri di produzione di senso. Come il golore gocciolato da parte di un pittore. Non ci si può limitare a dire: ma il colore gocciolato l’ha fatto uuna volta e per sempre Pollock. Da quel momento in poi non interessa più. Si potrebbe dire la stessa cosa della rima interna, o anche dell’endecasillabo sciolto. Ogni volta invece dovremmo andare a vedere come è usato il cut-up in quell’autore, così come il colore gocciolato, la rima interna.
In conclusione, quando scrivi:
“Tuttavia, date queste premesse, accade che talvolta io non riesca a vedere nell’opera che ho davanti molto di più di quello che vedevo in Duchamp o Balestrini.”
Per capire e dare senso a questa frase, dovrei capire ad esempio che cosa nel testo di Zaffarano è una mera ri-produzione di opere di Duchamp e Balestrini. Il che finalmente ci porterebbe a parlare da vicino del testo di Zaffarano e di come funziona.
Vedi, Andrea, il punto è proprio qui. Il mio modo di procedere critico si basa su quella che potrei chiamare una sensibilità estetica. In altre parole, quando un testo mi colpisce, cerco di andare a fondo sia nel testo sia nelle sensazioni che mi ha procurato, per capire le ragioni della sua efficacia (su di me, ma per questo presumibilmente anche su altri). Quello che ne esce non è una dimostrazione della qualità estetica (che non si potrà mai comunque dare) ma una chiave o una serie di chiavi che possano essere utili agli altri per apprezzare il testo in questione.
Se un testo non mi colpisce, io non ho argomenti per dimostrare perché non funziona (qualche volta sì, ma è necessario un chiaro quadro di riferimento, che sia accettabile per me – e non è il caso qui, come non è il caso ogni volta che è evidente che comunque c’è un lavoro sperimentale dietro, e non siamo di fronte a una persona di scarsa competenza): non ho argomenti esattamente perché la mia interpretazione si è bloccata, cioè non ha trovato appigli per proseguire.
Non si può dimostrare perché un testo è brutto – ancora meno di quanto si possa dimostrare perché è bello. Talvolta ci si imbatte nella banalità (non mi sto riferendo agli autori in ballo qui) e la si bolla come tale, perché si ritiene che in generale chi ha un minimo di competenza farebbe altrettanto – ma in verità non si ha mai la garanzia che il testo che abbiamo bollato come banale non potrebbe essere riletto in una nuova chiave, che lo riveli invece interessante.
Detto questo, il tema dell’origine della scrittura è un tema che di per sé mi affascina. L’ho studiato e lo insegno pure, a volte. È un tema tecnico e storico. Le parole di Zaffarano sono molto vicine a quelle che io userei a lezione per raccontarlo. Sono le parole di un testo tecnico e storico.
In più sono divise in versi. Certo, questo crea loro un qualche straniamento, e mi costringe a leggerle in un modo un po’ diverso.
Ma qui il gioco per me si ferma. Se paragono, per continuare l’analogia fatta sopra, la divisione in versi di Zaffarano agli strappi di Rotella, non trovo la stessa ricchezza semantica. L’operazione a me appare fredda, senza valore aggiunto.
Nell’operazione di Duchamp può bastare l’irriverenza del gesto e ciò che comporta. In quella di Balestrini c’è certamente già di più (in Vogliamo tutto, oltre all’oggettività ostentata delle parole dell’operaio, ci sono ovviamente anche le parole stesse dell’operaio): e questo fa la differenza tra Balestrini e Pierre Menard, e non è piccola – benché l’operazione di base non sia dissimile. Balestrini mette a stretto contatto un’operazione molto intellettuale con una realtà presa nel dettaglio; e il contrasto è ricco.
Tuttavia, io non riesco a vedere nel testo di Zaffarano un’analoga ricchezza. Mi si ferma lì. E per questo non posso andare, né dire oltre.
Potrei, al contrario, prendere qualche testo che proviene da un contesto simile, che mi permetta di andare oltre, e cercare di capire poi, su quello, che cosa mi permetta di andare oltre.
Cercherò di farlo in un prossimo post. Il problema è forse che i testi che poi apprezzo io non sono davvero di questo tipo. Ho già scritto (positivamente) sia su testi tuoi che di Marco – ma non li ascriverei allo stesso ambito di quello di Zaffarano, a dispetto della vostra vicinanza programmatica.
Alla prossima
db
Forse due elementi aggiunti alla discussione. Ci provo.
I
Alla frase di Daniele “Se un testo non mi colpisce, io non ho argomenti per dimostrare perché non funziona” penso sia sottesa un’equivalenza invece di un(a possibilità di) bivio.
Si ha cioè (rigorosamente) l’equivalenza “se un testo non mi colpisce” = “non funziona”. Da cui deriva: *mi interrogo per capire perché*.
Suggerisco però di sostituire quell’equivalenza con un bivio o addirittura una diramazione di strade, o con la possibilità del darsi di qualcosa del genere.
ossia:
“se un testo non mi colpisce” *può* essere sia “= non funziona”, sia “= non mi ci ambiento”, sia “= non mi ci ambiento ancora”, sia “= non sono ora nella posizione di metterlo in rapporto con alcuni parametri ai quali sono solito [emotivamente e conoscitivamente] fare riferimento per entrare in sintonia con un testo”, sia “= funziona a mio avviso solo in alcune parti” … eccetera.
A loro volta, tutti questi segmenti possono essere innestati uno nell’altro. almeno un caso: “questo testo non mi colpisce perché non mi ambiento in tutte le sue parti ma solo in alcune”.
Eccetera.
II
Daniele scrive: “non ho argomenti esattamente perché la mia interpretazione si è bloccata, cioè non ha trovato appigli per proseguire”.
Ipotizzo (da un’ottica – mia – di ‘cambio di paradigma’):
e se *proprio* il blocco dell’interpretazione fosse non il temuto/dispettoso inatteso malfunzionamento di una macchina ermeneutica, bensì il segno di un contesto mutato? Non sarà forse un contesto al quale non solo “un” o “quel” tipo di interpretazione difficilmente si applica o applicherebbe, ma proprio il gesto interpretante come lo intendiamo noi?
Se la macchina si ferma, sarà perché il motore non funziona o perché sta cercando di avanzare in un ambiente troppo cambiato per le (per altro funzionantissime) meccaniche usualmente in campo?
Se si tenta di entrare nel lago con l’automobile, anche con gran cautela e in prima e a fari spenti per non far cortocircuito, si potrà constatare che la macchina avanza con difficoltà, poi si ferma, poi imbarca acqua, poi ce la vediamo brutta.
Ecco.
Marco, hai ragione su ambedue i punti.
Posso riformulare “questo testo non mi colpisce” come “non mi ci ambiento (in tutto o in parte)”.
E probabilmente non ho la barca, e la mia macchina nel lago affonda.
Tuttavia, c’è qualcosa che non mi convince. Voglio dire: come lettore di poesia non sono l’ultimo arrivato, nemmeno per quanto riguarda la Neoavanguardia e le sue conseguenze (a suo tempo ci sono cresciuto dentro anch’io). Mi pongo problemi teorici e non ho pregiudizi (o almeno mi sforzo di non averne). Mi sforzo anche di capire. Non c’è qualcosa di strano nel fatto che, nonostante tutto questo, io continui a girare in macchina invece che in barca? E non riesca a farmi un’idea di come possa ottenere una barca?
Se invece che di poesia parlassimo di scienza la soluzione sarebbe forse più semplice: non capisco (poniamo) la Teoria della Relatività perché mi pongo ancora in un paradigma newtoniano; o, se sono Einstein, non capisco la fisica quantistica perché mi pongo in un paradigma deterministico. In parole povere io sono (localmente, cioè rispetto a quello) stupido, o ignorante (cioè, fondamentalmente, ho paura che la mia concezione del mondo si dissolva). Tuttavia persino il paradigma probabilistico della teoria dei quanti non è dimostrato; è solo ampiamente accettato, e potrebbe ancora emergere (in linea di principio – non che lo si debba ritenere probabile) una spiegazione in termini deterministici della probabilità quantistica che dia ragione a Einstein e torto a Heisenberg.
Ora, io sono molto meno legato alle mie posizioni di quanto Einstein lo sia stato al paradigma deterministico. C’è evidentemente in gioco molto meno. Diciamo che se tu fossi Heisenberg potresti provare a fornirmi delle idee per capire il tuo punto di vista (che non mi puoi dimostrare perché di queste cosa non si dà dimostrazione), trovando quindi un molo da cui possa prendere la barca.
Il problema maggiore è che ci ho già provato, e non ho ancora trovato una descrizione convincente di un altro “gesto interpretante”, oppure di qualcosa che lo possa sostituire. Resto però aperto, perché a capire ci si guadagna sempre.
Come vedi, siamo in dialogo, e mi fa piacere.
Ciao
db
🙂 lieto anch’io, Daniele. e mi scuso di postare solo questa (micro)riga!! senza web per un po’, hélas… ciao!
[…] Del cambio di paradigma, della questione dell'io, dell'oscurità in poesia (21) […]
[…] Del cambio di paradigma, della questione dell'io, dell'oscurità in poesia (22) […]