A volte, sull’orlo della notte, si rimane sospesi
e non si muore. Si rimane dentro un solo respiro,
a lungo, nel giorno mai compiuto, si vede
la porta spalancata da un grido. La mano feriva
con una precisione vicina alla dolcezza. Così
si trascorre dal primo sangue fino a qui,
fino agli attimi che tornano a capire e restano
imperfetti e interrogati.
Con questo componimento si apre Quell’andarsene nel buio dei cortili, di Milo De Angelis (Mondadori 2010). Come gran parte di quello che si trova nelle pagine seguenti, questi versi lasciano il segno, almeno su di me. E, proprio come quando di fronte a un meccanismo io devo proprio farmi un’idea perlomeno dei principi di base del suo funzionamento, anche qui provo un bisogno simile di capire come funziona, su di me, questa poesia.
Procedo un po’ a naso. Conto le sillabe dei versi. Non sono versi isosillabici, ma si aggirano comunque intorno alla misura delle 15 sillabe (da 13 a 17), con l’eccezione dell’ultimo, che però è chiaramente un verso residuale. Data questa misura approssimativa, che però definisce già un respiro lungo, il verso si conclude di fatto là dove, per un motivo o per un altro, va posto un accento retorico, un punto di rilievo. Così, alla fine del primo verso si rimane sospesi proprio sull’epressione “si rimane sospesi”; alla fine del secondo c’è invece un punto di (temporaneo) appoggio, e la parola “respiro” è un quasi-anagramma di “sospesi”, con effetto di consonanza-assonanza; il terzo e il quarto verso si chiudono sui due verbi cruciali “vede” e “feriva” (e anche qui, più debole, si presenta un eco fonico); tra il quinto e il sesto verso c’è una vera rima, e, di nuovo, mentre il primo è sospeso il secondo è risolto (temporaneamente); ancora sospeso su “restano” è il settimo verso, in modo da isolare la coppia allitterata finale, tutta giocata fonicamente di i ed e, di attacchi in imp e int, di r, t e doppie.
Tutto questo, di per sé, non vuole dire niente, ma se poi si osserva anche che le conclusioni di periodo non coincidono mai con quelle di verso, ci si accorge che già solo a livello sintattico e prosodico la poesia è animata da una tensione leggera, che impedisce qualsiasi vera fermata, e spinge avanti sino a quell’ultimo verso troppo corto, che sembra quasi contenere quello che avanza in una corsa ansiosa, quando per lo slancio non riesci a fermarti dove vorresti, ma fai ancora un passo o due avanti, necessariamente. Ma qui la corsa, pur ansiosa, è già piena di echi: è un ambiente, magari ansimante, in cui le parole qua e là si rispondono, nella misura lunga del respiro, nelle consonanze e rime, alla fine nelle allitterazioni (attimi, imperfetti, interrogati).
Proprio in mezzo c’è un cambio improvviso di tempo verbale: dopo il si rimane e il si vede, prima del si trascorre, del tornano e del restano, c’è un feriva. Quel feriva è forse l’oggetto del si vede del verso precedente. Una mano che ferisce con una precisione vicina alla dolcezza è forse la mano di un chirurgo. Oppure si tratta di una ferita metaforica, e la dolcezza è magari solo la dolcezza con cui si esegue un gesto preciso, consapevole, studiato. E tuttavia c’è quel grido e quella porta spalancata, col suo gesto improvviso, violento. La violenza del grido contrasta con la dolcezza del gesto che ferisce; e tuttavia è il gesto e non il grido a produrre il sangue che ci sta portando sino a qui.
Ora, da capo, vediamo questo arrestarsi sull’orlo, questo tempo che invece di scorrere (entrando naturalmente nella notte) si trova di colpo a fermarsi, in una posizione impossibile, in una presa di coscienza insieme improvvisa e lunghissima, in cui non riusciamo a morire, perché già morire sarebbe risolvere, sarebbe essere fuori da questa ansia improvvisa, chiusa dentro un solo respiro, il fiato quasi sospeso, col giorno che non riesce a finire. In questa sospensione magica, terribile, emerge il ricordo, al passato (“la mano feriva…”). E poi di nuovo ecco il presente, anzi una rapida ricapitolazione del trascorrere “dal primo sangue fino a qui”, dove sta avendo luogo la presa di coscienza improvvisa, ma anche la consapevolezza della sua natura imperfetta e piena di domande.
Tutto gira insomma attorno a un attimo, che ci viene prima presentato nella sua tensione sospensiva, poi si sprofonda nella consapevolezza e nelle sue immagini, e infine si arriva alla consapevolezza della natura incerta di quella stessa consapevolezza e dell’impossibilità di una comprensione sufficiente. Ma a cosa siamo di fronte? Qual è il male che ci fa gridare? Di che ferita si parla? Non è importante. Anzi è la sua indeterminatezza, la sua ambiguità, la sua irrisolvibilità a rendere più universale la condizione di cui si parla. Qualunque sia stato quel male, è questo stare sospesi sull’orlo della notte, adesso, ciò che angoscia.
Il respiro del verso, così lungo, con la sua non risoluzione (perché i versi non si chiudono mai insieme con i periodi, e in ogni momento c’è sempre qualche struttura incompiuta che spinge avanti), diventa a sua volta la casa di questo “solo respiro, a lungo” dentro cui si rimane. De Angelis non ci sta raccontando del suo momento di ansia: piuttosto, lo sta ricostruendo per noi, ci sta buttando dentro il suo stesso buco. Ci ferma nel bel mezzo del suo respiro per buttarci addosso la porta e il grido, la mano che ferisce e la sua paradossale dolcezza. E poi sembra che stia per tirarci fuori, ma non lo fa, perché lo stesso tornare a capire (e quindi il digerire, il risolvere) è imperfetto e le domande non finiscono.
Tutto questo mi spiega il meccanismo? Un poco sì. Sto un po’ meglio. Ma rimane lo stupore (e l’invidia) per la capacità di De Angelis di costruire questo nodo di ansie. Mi sembra quasi che sia la sua stessa mano, quella del poeta, la mano che è capace di ferire (il suo pubblico) “con una precisione vicina alla dolcezza”: non mancano infatti, alle parole di De Angelis, né la precisione né la dolcezza. È quella che si dice una bella poesia, non c’è dubbio. Ma è davvero adeguata la parola “bello”, per questo? Dov’è il “bello” qui?
E poi, giusto di passaggio, com’è che leggendo e rileggendo questi versi io continuo a sentire questo sapore di Kavafis? Lo sento solo io, per ragioni casualmente personali, o c’è qualcun altro che ha la mia medesima percezione?






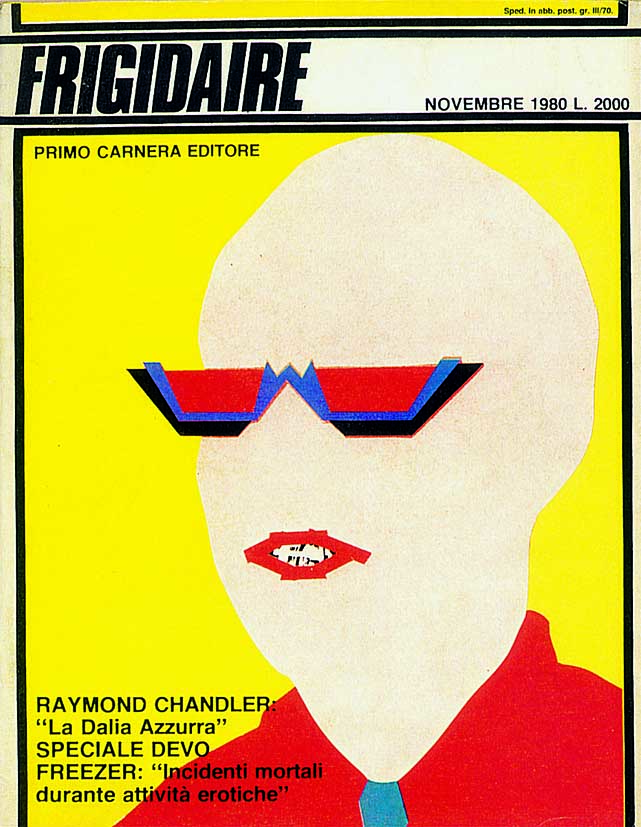
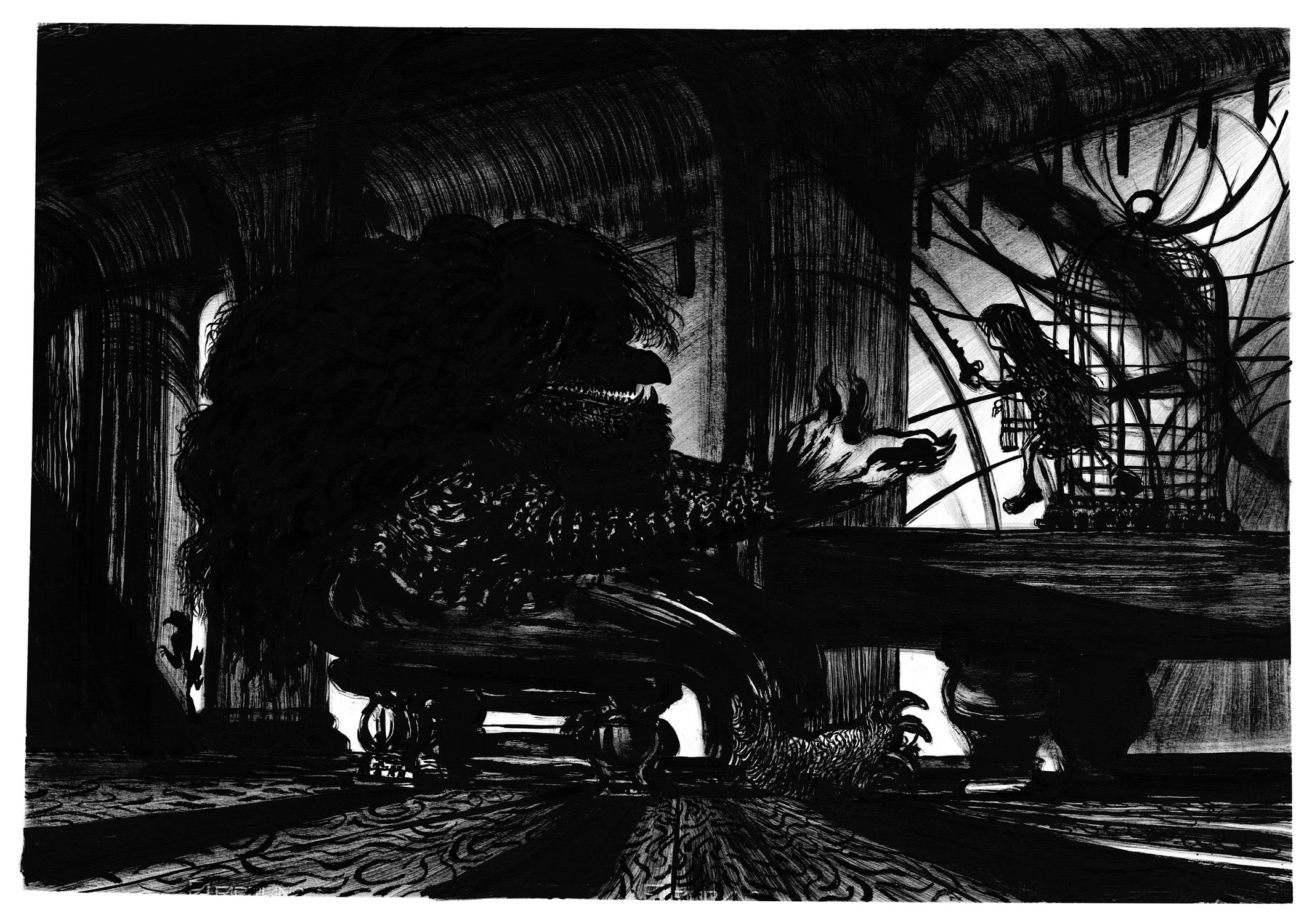



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email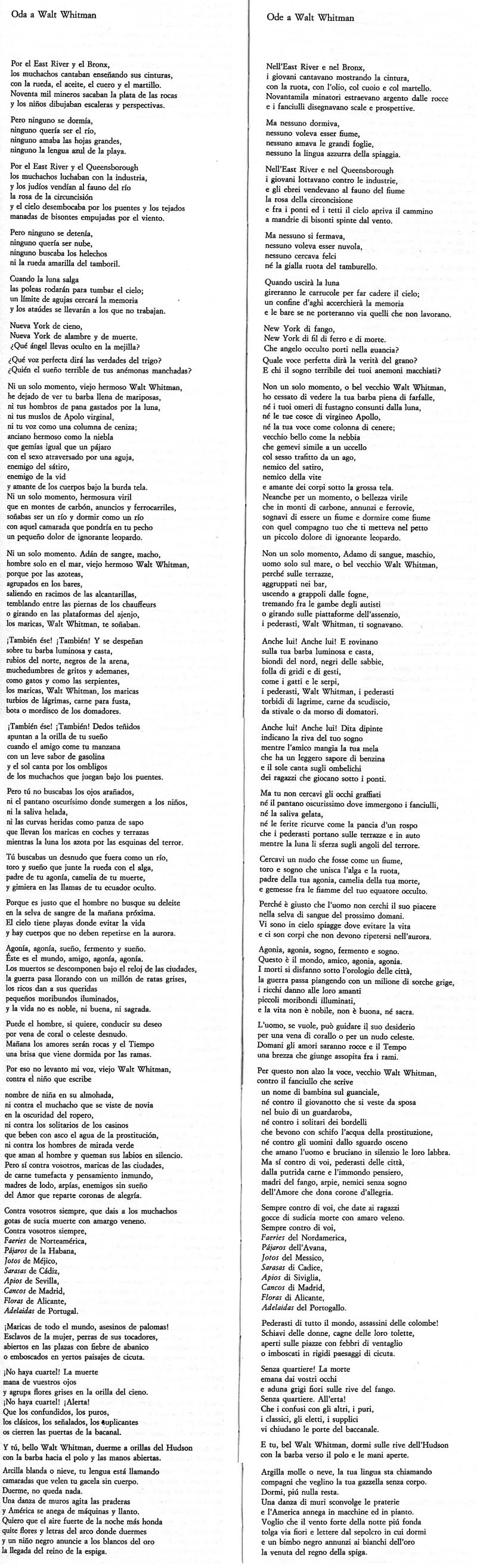




[…] già difeso De Angelis altrove (qui e qui, per esempio), e non è per difendere la sua poesia che ho scritto queste righe. Il punto è che […]