16 Febbraio 2013 | Tags: poesia | Category: poesia | Grazie a Narda Fattori e a Cristina Bove, è qui, e inizia così:
Belle queste poesie; si aprono su un mondo e si chiudono su un altro, con un po’ d’ironia e un po’ di desolazione. Si affidano sia alla visione che al pensiero e impastano un lessico specialistico a quello colloquiale. Barbieri conosce la grande libertà di cui gode la poesia per statuto: libertà di contenuto, di stilemi, di scelte lessicali e retoriche, si accomodano sul versante lirico ma non disdegnano quello narrativo o sapienziale e riflessivo. Dicono l’angoscia ma anche il divertissement, il gioco fonico e assonante.
Nessuno, infatti, è mai riuscito a dare una definizione esaustiva della poesia, essa sfugge ai canoni e ad ogni forma di ingabbiamento eppure ha regole rigidissime che la governano e l’orecchio attento sa discriminare la buona dalla cattiva poesia.
“Il poeta è colui che con le parole incanta l’animo e fa battere il proprio cuore e quello altrui. Anche se non siamo fatti da Dio siamo fatti di Dio. (……………) La poesia è un lungo viaggio nell’ ignoto.” questo dice Roberto Benigni, che molto l’ha frequentata e che forse è lui stesso un poeta che si nasconde.
La prima poesia di Barbieri è un gioco di immagini specchiate… (segue qui)
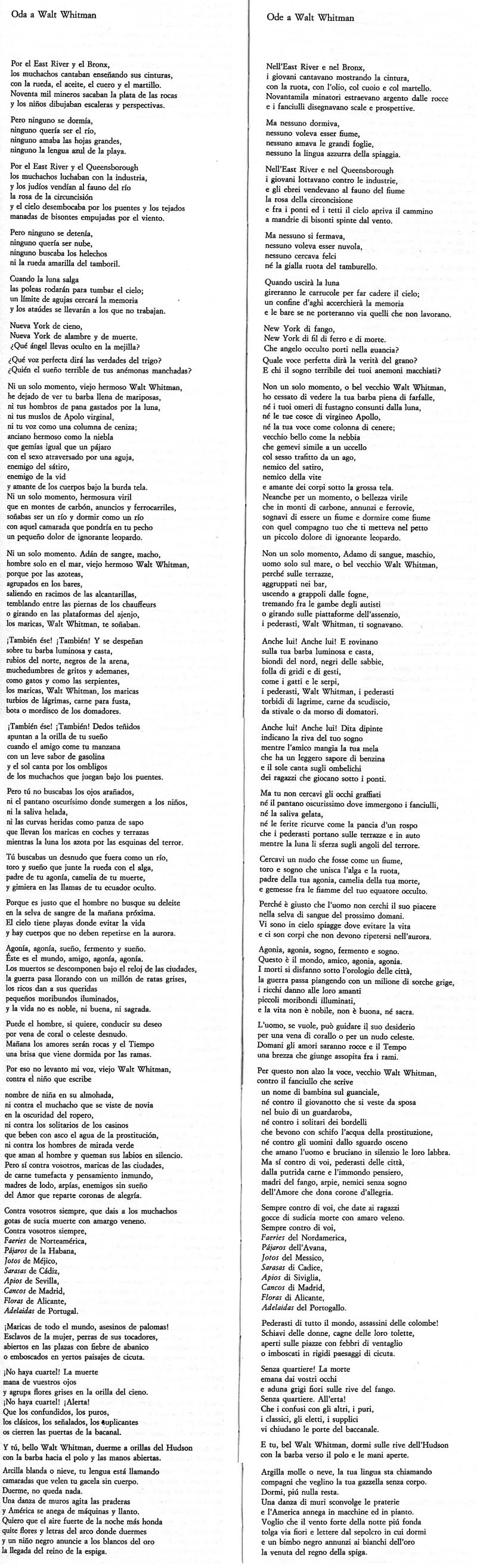 Federico Garcia Lorca – Ode a Walt Whitman (trad. di Vittorio Bodini) 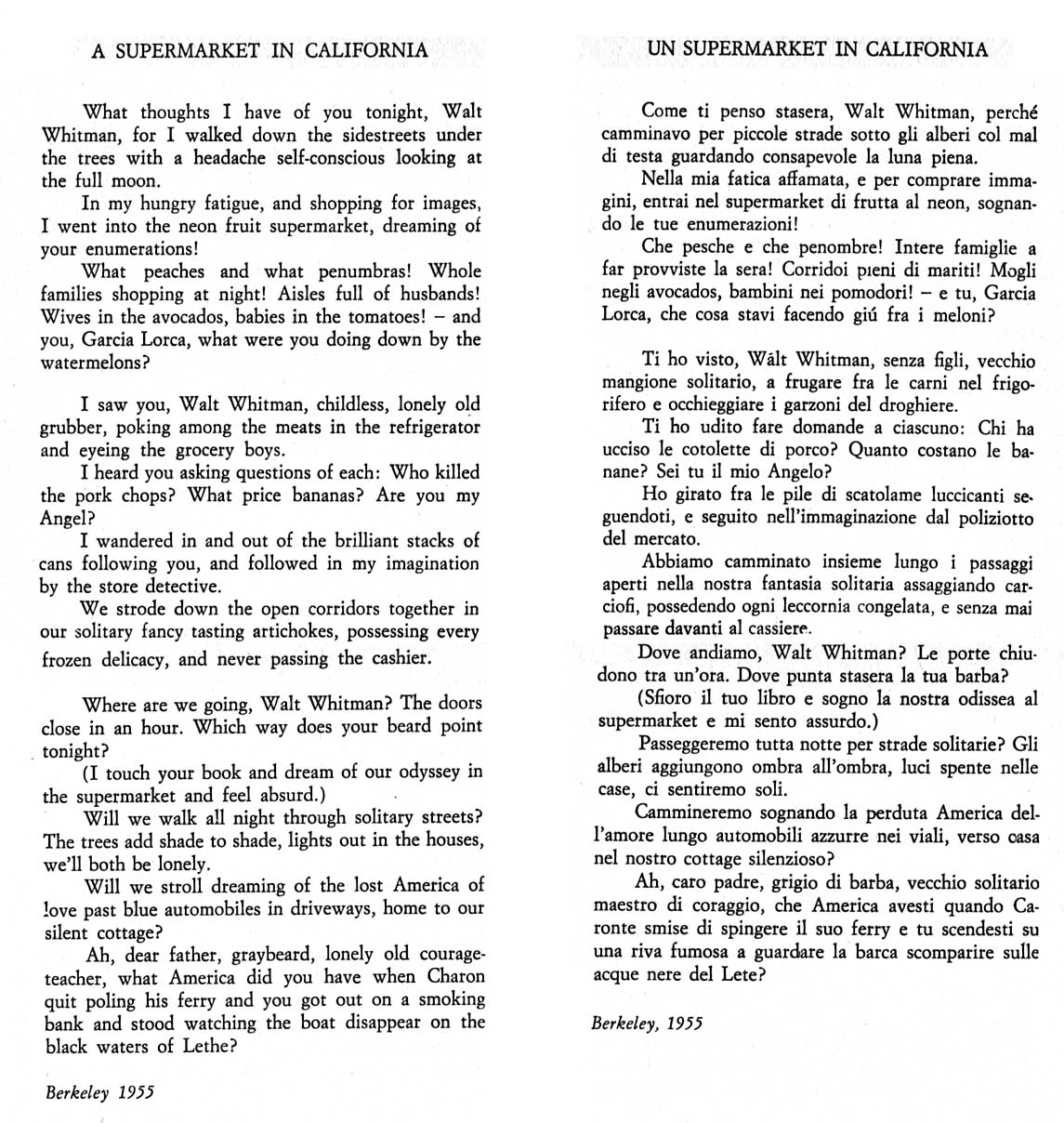 Allen Ginsberg,” A Supermarket in California” (trad. di Fernanda Pivano)
 Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive. Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.
Nell’immagine dell’America dell’Ottocento, il paese dell’avventura, della scoperta e della conquista, in cui la novità viene accolta con l’entusiasmo della giovinezza, può essere giovane anche un vecchio, specie questo vecchio; una sorta di Omero del Nuovo Mondo.
Per lo spagnolo García Lorca, nei primi anni Trenta, Whitman può apparire il simbolo del mondo nuovo, alieno, meraviglioso e terribile, che egli sta scoprendo attraverso le maglie del surrealismo, scoprendo pure quanti debiti il surrealismo stesso mostri nei confronti del vecchio poeta.
Per l’americano Ginsberg, a metà dei Cinquanta, Whitman può apparire il simbolo del mondo ugualmente nuovo, ma ormai ridotto a quotidianità, a commercio, a banalità – eppure magari riscopribile nella sua natura profonda proprio attraverso di lui, capitano oh mio capitano.
Non è certo un caso che il tema dell’omosessualità emerga in ambedue i testi, potente e centrale in García Lorca, con la sua condanna della pederastia; accennato ma comunque rilevante in Ginsberg. Per la vita di tutti e tre i poeti il tema dell’omosessualità è stato rilevante: inconfessabile in Whitman, nascosto in García Lorca, pubblico per Ginsberg. Ma quello che in Ginsberg sembra qualcosa di più o meno risolto, in García Lorca è un profondo dramma di differenze, magari specchio delle medesime confusioni (tra omosessuali e pederasti) di cui egli stesso poteva essere stato vittima.
Metto qui questi testi senza altri commenti, perché sono entrambi testi che ho molto amato da molto tempo, e che per coincidenza mi sono ricapitati sotto gli occhi recentemente, scoprendo che alcune delle immagini che nella mia memoria attribuivo all’uno appartenevano invece all’altro. Tra i miti che costruiscono la poesia, c’è indubbiamente anche la poesia stessa, e gli uomini che la fanno – ma i miti vivono attraverso la memoria, e la memoria, spesso, fa quello che crede.
 Walt Whitman
6 Febbraio 2013 | Tags: Italo Testa, poesia | Category: poesia |  Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva. Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva.
Poi, certo, ogni autore sogna di sfornare il classico, quell’opera che resta sugli scaffali a lungo, al limite per sempre. E questo ci rivela che esiste (almeno) un terzo criterio di durata, che dipende da quanto (e sino a quando) il testo in oggetto esprime qualcosa di cruciale per un numero rilevante di lettori. Non è un criterio generalista né generalizzabile, ma è nondimeno un criterio influente; forse quello, sulla società letteraria, più influente di tutti: le opere che saranno ricordate sono quelle che soddisfano questo terzo criterio, infatti. E, proprio per questo, in fin dei conti questo terzo criterio si trova alla base di ogni presentazione critica di un testo poetico: deprivata di qualsiasi possibilità di successo commerciale, la poesia vive di approvazioni personali e profonde, sogna di incarnare lo spirito del tempo, e che quello spirito possa essere ritrovato a lungo…
Da questo punto di vista, per quanto poco un testo poetico duri, almeno un decennio o due gli spettano di diritto. Per quanto effimero possa essere il suo senso, non decadrà secondo il criterio delle librerie, bensì, semmai, secondo quello del gusto – il quale ha comunque tempi un po’ più rilassati. Proprio per questo motivo, io rivendico il diritto, in quanto critico, di considerare come novità tutti i testi poetici usciti negli ultimi dieci-quindici anni, e di proporli eventualmente qui – magari alternati, se capita, con dei veri classici o anche con dei sospetti classici (i quali potrebbero essere anche più giovani, benché in odore di durata).
Anche La divisione della gioia, di Italo Testa (Transeuropa 2010), come ogni altro testo poetico, ambisce a entrare tra i cosiddetti classici; ma lo fa, mi sembra, anche in un altro senso, quello, per intenderci, per cui esiste una differenza lessicale tra classicità e classicismo. Nel caso di Testa, parlare di classicismo non vuole scomodare l’antichità classica, e nemmeno altri classicismi più recenti, come quello ermetista. Nondimeno, è inevitabile, leggendo la scrittura calibrata, elegante, appassionata, spesso avvincente, di Testa, che si sentano gli echi di una serie di classici del Novecento, da Montale a Sereni a Fortini, a Eliot e all’ultimo Porta, persino al Pavese di Lavorare stanca. È una poesia, potremmo dire, riflettutamente sentimentale, appassionatamente riflessiva, attenta sia alla costruzione metrica che a evitare gli eccessi intellettualistici dei neo-metricisti. Si parla di una storia d’amore, di sesso, di passione e di difficoltà di rapporto; si racconta molto, e anche bene, sempre a cavallo tra il distacco e la partecipazione. C’è una bella storia, con un bel linguaggio, un bel ritmo poetico…
Ma si ha come l’impressione che questa limpidezza sia troppo intenzionalmente classica; e mentre tutti quesi echi costituiscono indubbiamente un pregio per i versi di Testa, ne sono insieme anche il limite. Questa ricchezza, e il bel racconto che la accompagna, finiscono per appartenere, ai miei occhi, a un’altra epoca, un’epoca classica, che non è la mia; e il mio apprezzamento, che durante la lettura c’è, indubbiamente, e ed è anche frequente, a volte persino forte, finisce per essere arginato dalla sensazione di trovarmi altrove – negli anni, insomma, poeticamente meravigliosi, di Montale, Sereni, Fortini…
Non è un peccato subire degli influssi, certamente. Senza influssi non c’è poesia, né nessun’altra creazione artistica. Non è un peccato nemmeno lasciarli vedere. Ma quando la sensazione mi arriva così forte, come lettore io perdo il contatto diretto col testo, o col discorso che gli sta dietro; e vivo la sensazione di non essere io, oggi, il destinatario di quelle parole, bensì un lettore mitico di qualche anno fa. D’altra parte, proprio come ogni autore segue dei miti, allo stesso modo anche ogni lettore lo fa. Io non posso certo escludere che La divisione della gioia possa entrare nel novero dei classici, nel giro di qualche anno (non mancano di sicuro, a quest’opera, le qualità tecniche per meritarlo), ma questo non potrà accadere per mano di lettori che non si possano del tutto riconoscere come i suoi.
Da: La divisione della gioia (sezione II)
I. UN LUOGO QUALUNQUE
o sulle poltrone in prima fila,
davanti a un sipario grigio
segui in allerta la scena vuota,
come una macchia nera in un quadro
lo spazio deserto ti incornicia:
è stato sulle scale, il gradino
lucidato dai passi anonimi,
l’ombra obliqua che taglia lo stipite:
oppure è quando senza preavviso
il chiavistello con uno scatto
scuote l’uomo che dietro la porta
a torso nudo liscia il lenzuolo,
quando la sedia accostata al muro
ha mosso un’ombra dentro la stanza
e i panni inerti sul ripiano
hanno mandato un lampo nel buio:
o è stato mentre risalivi
fino al nostro primo appartamento,
la mano appoggiata al corrimano,
appena il vento ha mosso le tende
contro le assi del pavimento
e hai visto le crepe nella brocca,
ti sei voltata contro il bianco
squarcio del lino sulla parete:
o è stata la mia sete a disfarti,
lo sguardo osceno che getto al mondo
sulle braccia sode di una donna
in vestaglia, di primo mattino,
con la brama del volto coperto,
del taglio aperto lungo le natiche,
e ogni volta che le spalle forti,
ossute, come un quadrante bianco
tornavano a imprigionarmi
nel tempo del corpo sconosciuto,
in un interno spoglio e taciuto:
o è stato in una casa a due piani
sopra la croce di Sant’Andrea,
mentre anch’io nella marea
del desiderio cadevo vinto,
ansimando per la prima volta
preso tra i rami del suo ailanto,
o quando da dentro chiudevamo
le tende, a telefono spento
per sentire sul binario il treno,
senza più un gesto o un pensiero vero,
se da allora il passaggio è precluso
e non posso tornare a ciò che ero:
ma forse anch’io un giorno ho pensato
presto le macchine partiranno,
la casa sarà per noi sbarrata
e io sotto un lampione astioso
sfoglierò altre pagine, altri libri,
o camminerò lungo un parco
e nemmeno la notte potrà
nascondermi, se guarderai sotto
le tue finestre sulla panchina,
o se appoggiata a uno schienale,
nuda, alle undici di mattina
ti toccherai furtiva, e senza
più ben sapere chi siamo stati,
quando la lampada ci cadeva
a lato, e il letto si spostava
dal muro, e l’acqua non bastava:
così, se tutte le cose restano
su se stesse, come le colonne
contente di sopportare il peso,
di opporsi alla gravità che incombe
dalle architravi, dai porticati,
o i ciottoli sparsi sulle piazze,
i coppi scuri, incatramati
tra i lucernai aperti ai venti,
i fori da cui la luce piove,
e poi le griglie sui marciapiedi
impassibili a prender nota
della curvatura delle gambe,
del lino che corre tra le cosce,
come tutta stia nel suo contegno,
e accolga indifferente la luce
nella presa rapace dell’ombra
che cade sulle facciate calme,
sull’intonaco che irride i nostri
sforzi di camminare eretti,
restare fermi a un davanzale,
o i tentativi di imitare
la fissità del cielo, di statue
mute che si tengono i gomiti
nell’aria domenicale, oppure
sotto due fila di luci in fuga
posano gli occhi su una tazza
con i polsi, le labbra serrate,
le dita richiuse con fermezza:
anche così si annega l’ansia
nello specchio marmoreo di un tavolo,
anche quando la vita si piega
tra le imposte, sull’impiantito
verde, o dietro la ghigliottina
che separa il tempo dalla stanza:
nemmeno così sarà redento
questo agitarsi, questo andare
esposti a ogni buffo di vento,
o nella luce artificiale
di un neon credere che la notte
non sia notte, il verde non scintilli
immune da ogni nostro sguardo,
le merci esposte nel silenzio
di una vetrina siano lo sfondo
del nostro tranquillo sovrastare,
del dominio saldo della specie:
e quando nelle insegne luminose
che ritmano i grani dell’asfalto
hai visto il segno certo, il richiamo
ribattuto da ogni nostro passo,
o in una vetrina, controluce
hai scorto sul ripiano le pose,
le ossa spigolose del suo corpo
segnarti senza più un riparo,
come il giorno che stesa sul letto
ti sei girata, tranquilla, e hai visto
le grate che spartivano il vetro,
e alzandoti di scatto hai detto
che non sarebbe successo niente,
che tutto era ancora intatto
e mentre ti guardavo in silenzio
sei sparita nell’angolo cieco:
allora ho visto che nulla torna,
che la fragilità ci insidia
dall’interno, dentro le giunture,
s’insinua nelle vene, riveste
la piega opaca dei discorsi,
allora, chiamandoti in disparte
a fianco del letto avrei atteso,
la pelle a toccare il marmo freddo,
che tutto fosse tornato a posto,
il braccio nascosto tra le gambe,
la luce sulle mie cosce nude,
la mano a coprirti il pube:
- Io vidi dal ponte della nave
- I colli di Spagna
- Svanire, nel verde
- Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando
- Come una melodia:
- D’ignota scena fanciulla sola
- Come una melodia
- Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola…
- Illanguidiva la sera celeste sul mare:
- Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale
- Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…
- Lontani tinti dei varii colori
- Dai più lontani silenzii
- Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave
- Già cieca varcando battendo la tenebra
- Coi nostri naufraghi cuori
- Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.
- Ma un giorno
……..
 Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914). Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914).
Al di là della sua straordinaria qualità poetica, è un testo importante perché imposta nella poesia italiana un certo modo di utilizzare il verso libero, rifacendosi direttamente a Walt Whitman, di cui Campana era appassionato lettore. Il modo di costruire tanto gli andamenti sonori quanto quelli descrittivo-narrativi è estremamente originale. Molto si può imparare sul linguaggio poetico da un’analisi di questo testo.
A “Viaggio a Montevideo” ho dedicato qualche anno fa un capitolo di trenta pagine all’interno del mio libro Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004). In quelle pagine cercavo di analizzare in maniera molto puntuale il gioco ritmico e tensivo (per entrambi sia al livello del suono che al livello del senso) costruito da questi versi. Campana lavora in maniera estremamente musicale, e questo non è troppo difficile a percepirsi al livello fonetico – ma la sua musicalità riguarda anche (e moltissimo) il livello dei sensi, e la macrostruttura.
Il componimento è una specie di brano in quattro movimenti: la partenza, la sosta alle isole Canarie, la traversata, l’arrivo. Ogni movimento si contrappone al precedente, e sviluppa i propri temi, a volte ricollegandosi all’indietro. Questa dinamica riguarda sia l’andamento degli accenti e delle sonorità, sia l’avvicendarsi delle parole e delle situazioni descritte/narrate. Ma soprattutto, nel corso del testo, certi sensi si trovano associati a certi suoni, e questa associazione produce sistemi di aspettative nel seguito del testo, aspettative su cui il testo stesso gioca (ora confermandole, ora anticipandole, ora dilazionandole o contraddicendole…).
Quello che cercherò di tirar fuori da questo testo (dopo un breve, ma necessario, inquadramento storico) sarà proprio il dettaglio delle strategie di scrittura di Campana. In particolare, cercherò di approfondire questi aspetti:
– la scelta del verso libero per Campana
– il rapporto tra l’organizzazione dei versi e l’organizzazione sintattica
– la tipologia delle ripetizioni, il loro senso e la costruzione di un tessuto sonoro e semantico
– la macrostruttura: la costruzione del discorso/racconto per blocchi.
Se siete interessati a leggere in anticipo il capitolo su Campana del mio libro (e visto che il libro è ormai di difficile reperibilità) potete contattarmi al solito indirizzo guardareleggere@gmail.com.
23 Gennaio 2013 | Tags: Loredana Magazzeni, poesia | Category: poesia | Tentativi di seduzione della poetessa che invecchia
Volevo essere Jeanne Hébuterne
posare per quei ritratti di donna dai lunghi colli
inseguire la notte nelle cantine di Montparnasse
alle costole dell’artista famoso e maledetto.
Volevo essere io l’eletta, l’amata del suo cuore,
la pluriritratta, l’intima amica, la divina
piccola Musa ispiratrice. Volevo
essere la mai delusa, che non resse
la morte improvvisa del suo amore,
non accettò di sopravvivere a un sogno,
di farsene una ragione. Jeanne Hébuterne, tu
la più amata, donna dal lungo collo e dalla calda
coscia levigata, Jeanne dagli occhi
di carbone o azzurri specchi d’acqua, avrei
voluto leggere le tue divine lettere a lui,
se solo avessi potuto, avessi saputo, sopravvivergli.
 Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa. Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa.
Ho riletto molte volte questi versi, cercando di ricostruire gli echi che ci sento dentro, consapevole che, qui come – in forma più evidente – in altre poesia della medesima raccolta, i riferimenti ci sono, e che certamente parte del fascino che questi versi producono deriva dalla loro capacità non solo di raccontare una situazione, ma anche di buttare noi stessi dentro, in qualche modo, al contesto di quella medesima situazione, o almeno di farcene rivivere qualche suo elemento significativo.
Ci ritrovo alcune parole chiave, persino ripetute, a volte: amata, divine, Musa ispiratrice, artista maledetto… Sono parole che, già di per loro, costruiscono l’atmosfera di quegli anni, con i suoi echi inevitabilmente dannunziani – e poco importa che l’arte di Modigliani fosse assai più moderna, perché comunque il terreno su cui nasceva era quello. Ma D’Annunzio, a differenza della sua epoca, è in verità lontano dall’atmosfera di questi versi.
Quello che invece non ho potuto fare a meno di sentirci, almeno nella maggioranza di loro, e certamente in quasi tutti salvo che, forse, verso la fine, è una cesura verso il centro del verso, che fa un poco assomigliare il loro ritmo a quello dell’alessandrino, il verso principe della poesia francese, il verso di Baudelaire e dei poeti maledetti. Non che siano veri alessandrini, questi; in verità quasi mai gli emistichi sono davvero dei settenari. Non è una regola metrica quello che interessa all’autrice; le è sufficiente costruire degli echi. E così:
Volevo essere | Jeanne Hébuterne
posare per quei ritratti | di donna dai lunghi colli
inseguire la notte | nelle cantine di Montparnasse
alle costole dell’artista | famoso e maledetto.
L’io poetico che avrebbe voluto essere la donna francese innamorata dell’italiano si esprime con un ritmo da poeta francese, nella lingua italiana – ed è, in questo, inesorabilmente un po’ lui, l’artista famoso e maledetto, mentre, ancora e molto di più, è una lei innamorata del profumo delle arti di quegli anni. E, soprattutto, è un io capace di riprodurre e trasmetterci questo profumo.
Vogliamo definire sentimentale questa poesia? Vogliamo leggerla come una dichiarazione malinconica di amore, l’espressione di un desiderio impossibile dell’io, l’inseguimento di un sogno e di un mito? Naturalmente possiamo, e fa parte del gioco il poterlo fare. Ma l’ironico titolo ci avverte che di un gioco si tratta, e che, pur avendo il diritto di giocare, non possiamo accontentarci di credere che finisca lì. Questa sapiente retorica, questo avvolgimento nelle spire di una seduzione da anni parigini (quella stessa che ci raccontava divertito anche Woody Allen un paio di anni fa) è insieme pure un calcolato esercizio di stile e di distanza.
È solo quando ci accorgiamo di questo duplice gioco, di questo attraversare contemporaneamente il sentimentale e la sua negazione, che possiamo riflettere sul fatto che non necessariamente lo sperimentalismo poetico passa attraverso la paratassi e lo stravolgimento dei nessi grammaticali e semantici. Se voglio descrivere il sentimento devo permettere al lettore in qualche modo di entrarci, altrimenti lo sto soltanto nominando; ma se poi voglio renderlo oggetto di un discorso critico (poeticamente critico, si intende qui), allora ho bisogno del distacco – ma non c’è il distacco senza l’evocazione della presenza. E pure la presenza continua ad avere le sue ragioni, persino quando la riduzione dell’io è necessaria.
Insomma, io non posso negare di essere sensibile “al lungo collo” e “alla calda/coscia levigata”, così come alle “divine lettere” e all’amore, e nemmeno al ritorno delicato, sparso qua e là, delle rime (a loro volta allusive di una poeticità di quegli anni). Se pure posso riconoscere l’identità personale, l’io, come un’illusione, non posso però negare i sentimenti che le sono negati. Nell’esprimermi in poesia dovrò trasmettere questa contraddizione, dovrò ammettere che avrei voluto vivere le passioni di Jeanne Hébuterne, e insieme manifestare la consapevolezza dell’artificio culturale che sta dietro a questo. L’una cosa non è meno vera dell’altra; ciascuna smaschera l’altra e ne è smascherata. L’ambivalenza è l’ambiente in cui viviamo e sentiamo.
E non è questa la sola delle poesie della raccolta di Loredana Magazzeni a esprimere questa duplicità di sentimento e costruzione. Mi capiterà, a quanto pare, di parlarne a voce sabato prossimo, il 26 gennaio, presentando questo libro alla libreria delle Moline, a Bologna. Maggiori informazioni cliccando qui.
Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sulla poesia che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.
Leggete e diffondete!
Il linguaggio della poesia
Corso privato tenuto da Daniele Barbieri
L’analisi di cinque opere del novecento (alcuni componimenti singoli, alcune opere più strutturate) vuole essere l’occasione non soltanto per osservare da vicino alcuni testi, attraverso gli strumenti dell’analisi, ma anche per utilizzarli come esempi di altrettanti modi di costruire il poetico.
L’uso della parola, delle figure retoriche, del metro e del ritmo, la costruzione o la distruzione della sintassi, il ruolo delle sonorità, il rapporto con la tradizione, la costruzione del discorso ed eventualmente del racconto: sono tutti elementi, questi, che devono essere affrontati, inquadrati nel loro ruolo testuale e nel contesto storico che li genera.
Comprendere un componimento poetico non consiste solo nel comprenderne il senso, talvolta persino non consiste affatto nel comprenderne il senso, se non in un modo estremamente trasversale. La ricerca del senso è solo uno (magari spesso – ma non sempre – il principale) dei modi in cui un componimento poetico ci induce a seguire un percorso tensivo, e solo attraverso questa esperienza può avvenire una reale comprensione. Della poesia non si dà riassunto, e nessuna spiegazione critica risolve interamente un testo poetico.
Gli autori che abbiamo scelto per questa prima serie di incontri costruiscono questo percorso tensivo in maniera molto differente tra loro. Quello che cercheremo di fare, volta per volta, sarà cercare di comprendere la loro specifica modalità costruttiva, il gioco dei sensi e dei suoni, e anche delle forme visive sulla pagina bianca.
Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alla poesia. Non richiede competenze precedenti, se non una qualche familiarità con la lettura dei poeti. Non è però un corso di base: la sua pretesa è quella di dire cose diverse dal solito in forma semplice.
Eventuali edizioni future affronteranno altri autori.
Temi degli incontri: 15 febbraio: Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, da Canti Orfici; 1 marzo: Amelia Rosselli, La libellula; 22 marzo: Giuliano Mesa, Tiresia; 12 aprile: Milo De Angelis, Tema dell’addio; 10 maggio: Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Lamento per Ignacio Sánchez Mejías).
Daniele Barbieri è poeta e autore di diversi testi sulla poesia: la raccolta La nostra vita, e altro (Campanotto 2004); i saggi Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004) e Il linguaggio della poesia (Bompiani 2011); il volume sulla poesia dell’antologia scolastica per il biennio delle scuole superiori Segnalibro (Bompiani Scuola 2006); vari articoli su riviste specializzate.
Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 21.15 alle 23.15. Il costo per cinque incontri è di 100€. Per informazioni e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.
Il numero dei posti è limitato. Il corso si terrà a condizione che sia raggiunto un numero minimo di partecipanti.
—————————————————————————
P.S. Con questa cadenza, il corso è rivolto inevitabilmente ai soli bolognesi e dintorni. Se ci fosse pubblico interessato, lo si potrebbe però replicare, per esempio intorno a metà aprile, concentrato in un solo fine settimana (sabato pomeriggio e domenica) in modo da facilitare chi vive altrove e verrebbe apposta (approfittando dell’occasione per un fine settimana bolognese). Se c’è qualcuno interessato a questa seconda possibilità, me lo può segnalare? Se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti, si fa.
 Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti. Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti.
Ciò che caratterizza il simbolico, nella posizione di Eco (posizione che, in generale, sostanzialmente condivido), è il fatto che il simbolico cresce come una sorta di escrescenza su di un testo che avrebbe già un significato accettabile a livello letterale (o anche metaforico – ma in questo è differente dall’allegoria o dalla metafora, che di solito rivelano la propria presenza e la necessità di un’interpretazione traslata proprio perché quella diretta, di base, non avrebbe senso). Inoltre, ogni interpretazione simbolica ha alle spalle una teologia – ci dice Eco: in altre parole, poiché si tratta comunque di un uso del testo, le interpretazioni simboliche sono infinite, e possono prendere le vie più particolari; per questo, un’interpretazione simbolica, più che parlare del testo, parla della concezione del mondo che la alimenta. In particolare l’arte basa le proprie costruzioni simboliche su sistemi linguistici assestati e tradizionali, e ne è perciò indirettamente rivelazione – ma attraverso di loro è anche rivelazione di noi stessi (che abitiamo e viviamo questi sistemi).
Nel passaggio che il simbolico fa dal misticismo all’arte si inserisce però un’importante differenza, mi sembra. Mentre il misticismo pretende ancora di parlare di una verità, l’arte ha abbandonato del tutto la problematica della verità. Non dimentichiamo che l’arte non è una cosa sempre esistita e universale, ma semplicemente il prodotto di una concezione occidentale del mondo che non arriva ad avere quattro secoli. Non che prima non si facessero cose belle, ma venivano realizzate con un senso diverso da quello che noi oggi attribuiamo all’arte – o nello specifico alla poesia.
Nel passaggio dal misticismo all’arte (in senso moderno quindi) si perde la rilevanza della verità perché si passa da un valore collettivo e condiviso (in cui il mistico dice qualcosa che, tendenzialmente, deve essere creduto da tutti) a un valore individuale e scambiato (in cui il poeta non è tenuto a dire cose vere, perché non è quello il suo ruolo: deve piuttosto emozionare, commuovere, stupire…).
All’arte (alla poesia) è richiesto di dire la verità solo in un senso molto superficiale; diciamo a livello letterale (o di prima metafora). Tuttavia la dimensione in cui la poesia è davvero poesia non è quella letterale, bensì quella simbolica, e a livello simbolico parlare di verità è molto pericoloso – almeno sinché si intende la verità come corrispondenza tra il concetto espresso e il mondo. Detto in altro modo: se le diverse derive simboliche di un testo sono virtualmente infinite, come si può valutare la verità del testo nei loro termini?
Di fatto, la poesia non è fatta per dire particolari verità, se non a livello banale – e in effetti le verità che la poesia davvero dice sono in generale banali. Ma la poesia non è tale solo per quello che esplicitamente dice. La poesia è un tipo di testo che è fatto, che nasce, all’esplicito scopo di fomentare interpretazioni di carattere simbolico (e, nel dire “simbolico” non bisogna pensare solo al Simbolismo, e ai suoi simboli sublimi: il correlativo oggettivo eliotiano/montaliano è un esempio evidente di simbolo, e l’interpretazione simbolica può tranquillamente mirare anche al basso e al quotidiano). Potremmo arrivare a dire che una poesia riuscita (un’opera d’arte riuscita) è una poesia che ben si presta a numerose e affascinanti interpretazioni simboliche.
A portare questa tesi sino in fondo, salta fuori, però, che, allora, l’eventuale verità letterale delle parole di un testo poetico è davvero qualcosa di poco rilevante, almeno quanto lo è la “verità” di una successione di note in musica. Ma se questa verità è irrilevante, allora, in verità, ci importerà di sapere quale sia l’argomento di un componimento non perché esso possa dire al proposito qualcosa di vero, ma semplicemente perché ciò di cui un testo poetico parla (insieme al modo in cui lo fa) è la base letterale di tutte le possibili interpretazione simboliche – le quali a loro volta ci interessano non perché possano essere più vere di altre (e in questo sta la differenza col misticismo) ma perché nello stesso processo interpretativo che mettiamo in atto leggendo, ci inoltriamo in un percorso, che è un percorso di suggestioni ed emozioni. La poesia, insomma, non asserisce (se non al livello letterale, di base) ma suggerisce – e suggerisce (al livello simbolico) collegamenti e visioni che poi richiedono di essere eventualmente verificati in altri modi.
Tuttavia, se il problema della verità è così marginale in poesia, non si vede perché il testo poetico la debba veramente perseguire al suo livello di base – né si capisce perché la critica debba cercare di estrapolare delle verità dei testi stessi, piuttosto che occuparsi delle modalità del percorso di interpretazione simbolica. Come ho avuto modo di sostenere una volta, la poesia ha il diritto di essere incomprensibile, perché, se il problema della verità resta tagliato fuori, anche la comprensibilità al livello di base condivide la sua sorte.
Sin qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di paradigma riguarderebbe proprio un cambio di atteggiamento interpretativo (che, naturalmente, permetterebbe anche un cambiamento nella poesia stessa in direzione della non assertività) dalla poesia come oggetto chiuso da contemplare nel suo insieme ben definito, alla poesia come percorso da attraversare, senza che essa sia necessariamente dotata di una coerenza a livello letterale.
Ho tuttavia due ordini di obiezioni a questa posizione che attribuisco a Giovenale (sperando di non aver dato del suo pensiero un’interpretazione troppo “simbolica”). La prima è che la poesia è sempre stata impicitamente interpretata così (“sempre” è una parolona che va comunque relativizzata alla storia recente, non più vecchia di quattro secoli; più si va indietro e più bisogna farle la tara); per cui non vedo in gioco un cambio di paradigma, bensì una semplice presa di coscienza da parte della critica di qualcosa che di fatto veniva agito già da molto tempo. La seconda è che, anche abbandonando la questione della verità, quella della comprensibilità rimane viva.
Giovenale ha detto più volte (perdonatemi, non trovo i riferimenti, e cito a memoria – e quindi in maniera imperfetta) che la poesia deve far lavorare interpretativamente il lettore. Un componimento tranquillamente assertivo non produce questo genere di lavoro; ed è quindi poco interessante. Guardando le cose sotto la luce del modo simbolico, la prima asserzione appare vera (un testo che non fa lavorare il lettore non è nemmeno un testo poetico, secondo me), ma la seconda no, perché anche da un testo banalmente assertivo è possibile far partire una catena infinita di fascinose interpretazioni simboliche (l’esegesi biblica insegna). Quello che forse si potrebbe sostenere, come aveva fatto Jacques Geninasca (in La parola letteraria), è che un testo che si lascia facilmente interpretare a livello letterale non spinge a cercare nuove interpretazioni; come invece fa un testo che a livello letterale apparirebbe insensato. Bisogna però, per dar ragione a Geninasca, immaginare un lettore disposto comunque a interpretare, cioè a dar fiducia al testo, cioè a scommettere che quel testo ricompenserà il faticoso lavoro interpretativo che gli chiede, senza facili soddisfazioni intermedie.
Il punto, io credo, è proprio quello della fiducia, e della scommessa che, come lettori, siamo disposti a fare.
Un primo elemento di questa scommessa è, per esempio, la fiducia che abbiamo nell’autore: per esempio, ho già avuto modo di apprezzare la poesia di xy, lo stimo, mi aspetto che produca altre cose di valore; quindi mi fido e mi impegno nel lavoro interpretativo (non per cercare verità, ma suggestioni, suggerimenti, evocazioni, senza nemmeno un requisito di coerenza complessiva: già questo mi basta e avanza).
Ed è sulla base di una fiducia di questo genere che ho affrontato proprio la raccolta In rebus, del medesimo Marco Giovenale (Editrice Zona, 2012). Certo, il titolo va letto alla latina, nelle cose, ma non si può fare a meno di leggerlo anche all’italiana, con riferimento all’enigmistica, e alla decifrazione. Un riferimento che diventa più forte quando poi si vanno a leggere le poesie al suo interno. Rispetto a La casa esposta, a Shelter, la sensazione è che il gioco dell’evitare qualsiasi possibilità di definizione chiara del senso si sia fatto qui più duro, più estremo.
Cito, dalle ultime pagine:
albula corrente, piccola già dal nome
minibocca di acqua bruciata
dici piccola ma sei il “ne” atomo
la particella pronominale
da A-Z, niente che chiama
si dà il caso non si dia caso
qui tra i platani del “qui tra i platani”
di vocare, vociare, chioma –
l’albula prolunga, prosegue, pre-clara
dichiara avanti, antecede, ant anta continuata
per i milioni, di anni, animali, eoni,
vascelli alfa, enti ini, i leoncini
Non c’è niente di neodadaista o di conceptual qui (temi di una mia recente piccola polemica con Giovenale). Non ho obiezioni alla formula. Di Giovenale apprezzo anche la scrittura. Qua e là questi versi iniziano pure a prendermi. Ma poi subito dopo smettono.
Continuano piuttosto a darmi la sensazione che l’autore, ogni volta che tocca un tema potenzialmente evocativo, invece di svilupparlo, lo abbandoni al più presto, come se permettere la costruzione di un senso, anche simbolico, fosse un peccato, e si dovesse sempre costringere il lettore (e il primo lettore è l’autore stesso) ad andarlo a trovare più lontano, più lontano, ancora più lontano. Le paronomasie, le allitterazioni, le rime o quasi-rime sono qui spesso forzate, apparentemente gratuite. In un autore tutt’altro che ingenuo come Giovenale questa insensatezza non può che essere apparente; deve per forza nascondere un gioco, deve per forza essere un invito a non fermarsi lì.
Ma poi, per quanto io provi ad andare avanti, io resto sempre lì. Può darsi che il mio universo simbolico (la mia teologia di riferimento, per dirla con Eco) sia troppo diverso da quello necessario per leggere questi testi. Di fatto io arrivo a un punto in cui la sensazione più forte che vivo è quella che l’autore non faccia che evitare di permettermi un qualsiasi percorso – e quando questa sensazione diventa troppo forte, la mia fiducia in questi testi crolla, e io smetto di cercare.
La sensazione, analizzandola un poco più a fondo, è che l’autore stia cercando di evitare di commettere un peccato, il peccato dell’assertività. E poiché si può asserire in molti modi, e non c’è limite ai modi subdoli e incosapevoli in cui le parole possono arrivare (per via metaforica o anche simbolica) ad asserire qualcosa, tutta l’attenzione dell’autore sta nel cercare di evitarlo – arrivando, se necessario, quanto più vicino possibile all’irraggiungibile puro vuoto del senso, il grado zero della parola, il nulla (un classico delle avanguardie, dallo Zero di Porta agli Zeroglifici di Spatola).
In questo senso, allora il lavoro di Giovenale mirerebbe ad avvicinarsi a quelli (in questo senso nichilisti) di Broggi e Zaffarano, sui quali ho già discusso proprio con lui su queste pagine (sempre nello stesso post già menzionato). Eppure, che Giovenale continui a scrivere in senso pieno, inventando, invece di riportare e collegare tra loro frammenti di discorso alienato, mi sembra che sia un indizio a favore della possibilità che la sua ricerca del grado zero sia in verità contrastata e complessa. Sappiamo bene non solo che non c’è bisogno di poesia perché vi sia interpretazione simbolica, ma anche che qualsiasi oggetto del mondo ne è potenziale istigatore, nelle giuste condizioni. Datemi un cavolfiore, una ruota di bicicletta, il sole, o un angolo di marciapiede, e io ve ne ricaverò verità profonde e insondabili per pochi soldi (o per molti, se preferite). La mia sensazione è che Giovenale intuisca il pericolo di ridurre la sua poesia a un cavolfiore, e non intenda davvero arrivare a nullificarla così; per cui la sua poesia resta poesia, in fin dei conti, ma è poesia che cerca di negare il proprio stesso senso.
Insomma, anche se non riesco ad apprezzare davvero queste poesie, apprezzo Giovenale perché non arriva sino in fondo, continuando ad aggirarsi pericolosamente in un’area ai confini del senso – e qualche volta il senso risulterà attingibile, in qualche modo, e qualche volta no. Giusto per evitare fraintendimenti: ripeto che non sto parlando né di verità né di assertività, ma solo della possibilità di trovare un percorso, di vivere questi testi come se fossero paesaggi, in cui sono io a dar loro un senso (mentre li attraverso e senza neppure il requisito di una coerenza complessiva).
9 Gennaio 2013 | Tags: musica, oralità, poesia, poesia orale | Category: musica, poesia |  Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”. Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”.
E, certo, tutto questo porta acqua al mulino dell’appello iniziale di Lello Voce, che reclama uno spazio anche critico per l’oralità in poesia – istigandomi alcune riflessioni.
Sul fatto che la poesia metta in gioco un accordo collettivo, e quindi un collettivo fare (non soltanto di carattere intellettuale/interpretativo) non ho molti dubbi. Gran parte del mio libro Il linguaggio della poesia si basa proprio su considerazioni di questo tipo, e sul fatto che la poesia scritta viva comunque di una dimensione sonora virtuale ed evocata di cui non può in ogni caso fare a meno.
Tuttavia, nella ricostruzione virtuale della voce che il lettore privato, individuale, di poesia è tenuto a compiere, proprio perché virtuale, interiore, non si realizzano certi aspetti di spettacolarità che mi pongono qualche problema nella poesia veramente vocalizzata. Mi spiego, perché la cosa non è affatto ovvia. Non sto condannando la spettacolarità in quanto tale, ma la sto contrapponendo alla partecipazione rituale. In altre parole, il bravo lettore privato di poesia scritta è costretto a vocalizzare il testo che legge, almeno intimamente, per comprenderlo; e, nel fare questo, egli lo sta in qualche modo vivendo, e interpretando nel senso in cui un pianista interpreta uno spartito (oltre a interpretare nel senso in cui si interpreta – ovvero si fornisce una comprensione a – un testo). Il bravo lettore privato, nel fare questo, sta cioè partecipando al rito del ricreare la magia orale nascosta nelle parole scritte.
Quando il performer fa la stessa cosa di fronte a un pubblico è tuttavia lui solo quello che vive e interpreta (nel senso musicale), mentre al pubblico non resta che recepire e interpretare (nel senso semantico). La partecipazione non c’è più nello stesso modo: c’è invece lo spettacolo, un’azione a cui non partecipiamo ma assistiamo, non un fare ma un percepire/conoscere.
È paradossale che la poesia nasca, storicamente, come oralità ponendosi come momento culminante di una situazione rituale compartecipata e agita da tutti, per ritrovarsi oggi a rinascere come oralità ponendosi fondamentalmente come spettacolo, ovvero negazione dell’azione collettiva, mentre quest’ultima si ritrova – certo in forme più pallide – semmai nella fruizione individuale mediata dalla scrittura. Evidentemente quell’azione che potrebbe apparire la stessa (declamare versi, o comunque parole ritmate) viene resa differente dalla trasformazione del contesto che la contiene.
Certo c’è l’analogia con la musica, e il fatto che, a determinate condizioni e entro certi limiti, quest’ultima è ancora in grado oggi di costruire una situazione rituale e collettiva (anche se molta musica, specie quella colta, è prima di tutto spettacolo, cioè discorso rivolto al pubblico). Ma la partecipazione collettiva, nella fruizione musicale, si basa sostanzialmente sul moto corporeo, cioè sul fatto che con qualche parte del corpo (o magari tutte, se si arriva alla danza vera e propria) chi ascolta partecipa, fa.
Questa componente partecipativa non svanisce mai del tutto in musica, e ne restano elementi persino nella musica più intellettuale e “discorsiva”. In questo senso, la musica colta rappresenta sempre un percorso tra dimensione partecipativa (collettiva) e dimensione discorsiva (da chi fa a chi ascolta, cioè spettacolare); e, tutto sommato, anche la musica più popolare costituisce un percorso di questo genere, solo molto più spostato dal lato della partecipazione.
Io credo che anche la poesia viva di un analogo percorso tra partecipazione e discorso. E nel momento in cui noi leggiamo privatamente un testo poetico dobbiamo ri-farlo vocalmente (almeno con la voce interiore) mentre al tempo stesso ne comprendiamo il discorso. Se saltiamo una delle due fasi non stiamo fruendo poesia, bensì prosa, oppure musica.
Il problema della poesia vocalizzata è che non necessariamente essa gode del medesimo privilegio compartecipativo di cui gode la musica. Non è detto che essa infatti spinga i nostri corpi a muoversi, a seguire il ritmo, a danzare. Paolo Giovannetti fa notare nel suo articolo che i tipi di oral poetry che il pubblico sembra apprezzare di più sono quelli fortemente ritmici, o per una ritmica del suono (posizione degli accenti, delle rime, in generale del battito, come nel rap), o per una ritmica del senso (parallelismi, antitesi, figure retoriche chiare del livello del senso). Credo che il punto sia proprio questo: le performance poetiche di questo tipo permettono al fruitore di partecipare attraverso il ritmo, di essere a propria volta attivo, di fare con il proprio corpo, di accordarsi a un sentire collettivo.
Ma una poesia che funzioni bene in questo senso non è necessariamente una poesia che funziona bene anche per una fruizione personale e privata. La fruizione visiva, ottica, pur se accompagnata dalla voce interiore, si trova attratta da aspetti diversi da quelli da cui si trova attratta la fruizione acustica.
In altre parole, per quanto io ami la poesia di Montale (tanto per fare un esempio tra mille ugualmente legittimi), troverei mortifera una pubblica lettura di testi suoi della durata di un’ora – a meno che già io non li conosca un poco a memoria, quei testi, o a meno che contemporaneamente non li possa avere sotto gli occhi. Montale (come quasi nessun poeta italiano da qualche secolo a questa parte) non ha scritto per essere ascoltato, bensì per essere letto (e magari poi, e insieme, anche ascoltato); nello scrivere, aveva la sua poesia sotto gli occhi, non nell’aria attorno a lui sotto forma di vibrazioni sonore.
La poesia sonora/orale non può dunque essere semplice poesia scritta ben recitata. È piuttosto un linguaggio diverso, qualcosa che si deve basare su pertinenze diverse, perché richiede un’attenzione differente. Paradossalmente, la sua scrittura dovrebbe essere chiaramente marcata come una semplice partitura per l’esecuzione orale, per non confondersi con la poesia scritta, la cui scrittura non è semplicemente una partitura, bensì il suo modo principale (seppur non esclusivo) di essere.
Il problema, dal punto di vista della fruizione, è che la poesia sonora/orale, almeno da noi, non ha tradizione; cioè non ha tradizione recente: quella antica e nobilissima è di fatto dimenticata, se non da pochi, e magari ricordata solo virtualmente e accademicamente. Il fatto di non avere tradizione si paga in vari modi: prima di tutto, il pubblico non sa bene come ascoltare questa roba (è poesia? è musica? cos’è?) e si attacca a ciò che riconosce (come spiega bene Giovannetti); in secondo luogo, quella parte privilegiata di pubblico che è la critica si trova nella medesima situazione, ma fatica ad ammetterlo, e continua a giudicare con gli strumenti che possiede, sempre a cavallo tra musica e poesia di tradizione scritta – strumenti che spesso si rivelano del tutto insufficienti (proprio come coloro – perdonatemi il paragone – che condannano il fumetto perché il suo disegno con è comparabile alla pittura e la sua scrittura non è comparabile al romanzo; peccato che il fumetto, benché apparentato con entrambi, sia una terza cosa).
Sia per il pubblico che per la critica la costruzione di strumenti atti a recepire e/o a valutare non può essere il prodotto di un atto volonteroso. Le tradizioni si creano per stratificazione, non per costruzione volontaria. Quello che volontariamente si può fare è contribuire al formarsi di una tradizione, sospendendo o attenuando il giudizio sino a quando non ci si ritrova finalmente dentro – ma ci possono volere decenni, secoli…
In assenza di una tradizione di riferimento, è persino difficile distinguere i livelli di qualità, separare il grano dal loglio. Forse in questa fase dovremmo ascoltare tutto, tollerare tutto, anche quello che non capiamo. Questo probabilmente non è davvero possibile, ma si tratta di una prospettiva da tenere presente comunque, nell’ascoltare oral poetry, specie quando riteniamo che non ci piaccia.
Io non so se la poesia sonora/orale avrà futuro, però da quando l’epoca dell’oralità primaria è finita, questa è la prima epoca in cui le condizioni sociali e tecniche ne potrebbero permettere una rinascita. Ma non è il passato che ritorna: è una cosa nuova, per noi del tutto nuova, e come tale, io credo, siamo tenuti a considerarla.
5 Dicembre 2012 | Tags: Leila Falà, poesia | Category: poesia | Tutto bene grazie
Ciao come stai? Tutto bene grazie.
Proprio oggi volevo suicidarmi un po’
e poi mi è mancato il coraggio.
O la voglia di pensare a come fare.
Non mi suicido per pigrizia?
Oltretutto a un certo punto
mi han telefonato – “Ciao, sono Patrizia”.
Voleva vendermi servizi telefonici
e mi sono così offuscata che alla fine
non ci ho più pensato.
Poi è tornato mio marito,
e così il suicidio è finito.
Da qualche tempo per colpa sua
non riesco mai a combinare niente.
Puzzle
Quando poi sei diventato grande
tu pensi che ora che sei in fondo
il tuo puzzle dovrebbe avere la sua forma
che ormai dovrebbe comparire il disegno
di te con la tua vita amici e amori affianco
un affresco composito complesso
di serenità.
O di certezze almeno.
Invece ora tutto si confonde
ho gruppi di tessere qua e là
con forme, ma non si lega niente.
Tanta gente
ma accanto a me nessuno.
Tra un pezzo e un altro un buco
che non so quando si è formato.
Né se ci sia sempre stato.
Tra tutte queste tessere
buttate dappertutto
la mia figura infine non compare.
L’altro giorno ho trovato
un pezzo con un occhio.
Mi guardava.
Ma non era neanche il mio
era un ricordo e basta
e non di un fatto ma
di un film soltanto
o di uno spot pubblicitario
forse.
Non ho capito dove mi sono persa
forse avrei dovuto scrivere un diario
oppure tornare piccola
a domandare, se lo sa Arlecchino
che di quei pezzi almeno
si era fatto un vestito.
Anzi l’abito. Ecco
di certo so dove abito.
L’ho scritto ieri in fondo a un documento
dove chiedo che mi venga lì inoltrata
ogni evenienza.
Ci vado, questa sì è un’idea.
Magari suono. Educatamente aspetto.
Con calma.
Vediamo se rispondo.
(Leila Falà, inediti)
 Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo. Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo.
Torno a casa, comunque, anche con alcune esperienze positive. E di una do testimonianza qui, attraverso tre dei componimenti presentati.
Mi viene da pensare, leggendo questi versi leggeri (ma non troppo) di Leila Falà, che, per fortuna, non tutta la poesia aspira a porsi come modello universale, o come proposta per le maniere della poesia del futuro. Non c’è nessun vaticinio, qui, nessuna scoperta di verità profonda, nessun suggerimento di una profondità abissale del senso – o perlomeno, queste cose non appaiono, ma certamente, visto che si tratta di poesia, qualcuno (e io pure, volendo) sarebbe in grado di trovarvele.
Personalmente, ne apprezzo a prima vista il tono dimesso e colloquiale, in cui le rime e i giochi di suoni si inseriscono con un guizzo leggero da filastrocca, che arriva qua e là sino al palazzeschiano elenco di banalità (quelle che associano quotidianità e inquietudine un po’ angosciata – un po’ come nelle fotografie preoccupanti di Diane Arbus).
C’è quindi un profilo basso, poeticamente, con l’uso della battuta umoristica che ancora di più lo abbassa (anche se, certo, la poesia ironica ha pur una sua tradizione – ma fa così fatica a esser presa sul serio!) e l’effetto di rime assonanze e paronomasie, le quali in questo contesto rimandano immediatamente all’universo a sua volta basso della filastrocca, piuttosto che a quello alto della poesia.
Si tratta però di un inganno. Basta un poco di attenzione per accorgersi che questa è solo la superficie del gioco, mentre ciò che le sta sotto non ha più molto di basso. Anche questa superficie è partecipe comunque del gioco, e continua a invitarci a non prendere troppo sul serio nemmeno la profondità.
Mi trovo a domandarmi come mai nelle avanguardie questa medesima leggerezza sia così difficile da incontrare. Il mio sospetto è che la leggerezza ironica presupponga una sorta di dolce scetticismo di fondo che mal si accorda con la propositività avanguardistica. L’ironia delle avanguardie è distruttiva (nei confronti del nemico), oppure è essa stessa programmatica, quindi non leggera. Oppure forse, più banalmente e generalmente, la leggerezza svanisce sempre da un testo quando si pretende di interpretarlo troppo a fondo, magari anche solo per dargli valore, per consegnarlo alla Storia, per renderlo influente. Sarebbe colpa della critica, insomma.
Sarà davvero così? Nel caso, per favore, almeno per stavolta, lasciatemi divertire!
Natale
È vero che hai smesso di studiare?
Come stai a Barcellona?
Come stai a Milano?
È vero? hai ripreso a studiare?
Com’è la tua nuova casa?
Tutto all’IKEA! Proprio brava.
Assecondi ancora tuo padre?
Da tanto hai rinunciato a capirlo.
Discuti ancora con tua madre?
Credi ancora che dovrebbe capire.
Tu preferisci il panettone con le gocce di cioccolato
e lasci i canditi sul bordo del piatto.
Giochi a spararvi con il cuginetto?
Siete l’esercito dei baci.
Va sempre bene il tuo lavoro di architetto?
Sei troppo magra.
Sei troppo grassa.
Avevi le mani più belle.
Le tue dita non erano nodose.
Perché non volevi che facessero l’albero?
 Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno. Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno.
Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento.
Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi.
Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione.
Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio.
I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato.
Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei.
L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene.
Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla.
21 Novembre 2012 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Fuori dal laboratorio.
La terra esplodeva, ancora una volta. Sono milioni di millenni
in piena, per completa frantumazione
si riversano per terra – esplode, esplosa:
“nella dolcezza, nell’amore,
né la dolcezza né l’amore
stanno – non sopporta più niente,
la vita, non sopporta niente”
“venite, attraversiamo” – traversando
“volo d’animali,
l’immenso il più disteso
non ho mai visto un altro fiume” – con l’amore
come l’acqua, com’è acqua,
colma di leggera, come fuga
a malapena, a stento volo, che non vuole,
che non prende il volo. Sprofondano dentro la terra,
cascate di roccia che la roccia, voragine che dentro la voragine,
da quella stretta che, dentro, alleva,
morso dalla morsa della pietra:
“trasvolando che sento, che cadrò”.
La roccia si solleva, esplode il suolo,
si fa lava, bolle, folle:
è trasvolando che cadendo, sciame dopo sciame,
tutto passa.
Ed ora che passato
passava tutto, intero, per intero,
e su ciò che diventa, si avventa:
l’orso piccolo strappato, che confuso, dalla madre,
alla madre, ombra,
l’orso da poco nato che spaventa
ancora il mondo (che da adulti rende muti senza spaventare, è lì e
basta, è cosa che succede, uccide),
che zampetta e uggiola un po’ debole, un po’ mite – è via
dalla madre
ombra, d’ombra
“ti ho sognata ma eri già morta,
ti ho sognata ma non eri niente, un agitare
di follicoli, estinzioni, di parentesi”
cosa, oh cosa di sangue e di niente, ad annerire ora,
cosa significa restare in vita?
che cosa strazia ora questa
mano, mano che non tiene? questa gola?
capivi che ne usciva suono, nel frastuono,
non perché la vibrazione arriva,
non vedi il battere
e ribattere laringe, strepito –
è il corpo intero che si chiude esplode,
ricontrae, riesplode, nel riaccelerare che il respiro,
per respirare, spira, che i polmoni,
nel vibrare, emettono, riemettere
con tutta la carne che li chiude
mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)
e nuovamente, intanto,
affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti
– l’orso piccolo, già morto, muore ancora,
cosa nasce?
l’ape pazza che attraversa, il corpo,
cosa non nasce?
sono soli, ora, il vuoto, accerchia l’erba,
verso cui, già piega, verso dove
la terra serba il pianto che le spetta,
cosa nasce e non nasce?
allontana, l’allontanarsi altrove, il numero
di api-sciame, innumerevole –
cosa né nasce né non nasce?
“Non posso, pure, non passare, vero?”
 È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo. È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo.
Per chi li conosce, non è difficile sentire in questi versi gli echi degli oggetti violenti e crudi di Antonio Porta, o delle paronomasie di Giuliano Mesa. Da loro Raos ha indubbiamente ricavato molto. Ma quella lingua e quegli oggetti sono qui gli elementi per costruire questa sorta di vortice, questa quasi ronzante ripetizione di frammenti e di suoni in cui gli eventi si incastonano quasi per caso, quasi confusi, come percepiti attraverso una percezione che non è la nostra, una percezione collettiva di queste api, o di questi api.
Quest’effetto di frantumazione, di complessità, molteplicità percettiva si ottiene attraverso la sintassi spezzata dall’abbondanza delle virgole e degli a capo, con il discorso che salta da un tema all’altro, e poi ritorna, riprende, si interrompe per lasciare riprendere un altro tema – e in questo succedersi di percezioni differenti si ripetono invece i suoni, con rime, assonanze, allitterazioni, paronomasie, bisticci: “milioni di millenni”, “Esplode, esplosa”, “nella dolcezza, nell’amore,/né la dolcezza né l’amore”, “attraversiamo – traversando”, “Come l’acqua, com’è acqua, /colma di leggera, come fuga”, “a stento volo, che non vuole,/che non prende il volo”, “morso dalla morsa della pietra”, “si fa lava, bolle, folle”, “tutto passa./Ed ora che passato/passava tutto, intero, per intero,/e su ciò che diventa, si avventa”…
E poi, l’uccisione del piccolo orso che si trova al centro di questo frammento non è detta ma quasi vissuta da dentro (con tutta la carne che li chiude/mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)/e nuovamente, intanto,/affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti) (li, al maschile, può riferirsi agli api, spessi qui declinati al maschile), in un continuo straniamento che non può (né vuole) tuttavia, essere totale. Il punto di vista umano riemerge a sua volta a tratti, ora identificandosi con quello degli api ora contrapponendovisi, con l’effetto di una sorta di polifonia – la quale a sua volta alimenta la sensazione di molteplicità, di plurivocità dello sciame.
È una sorta di grande epica, quella che Raos costruisce in queste pagine, ma un’epica del male inconsapevole, dall’arma/arnia sfuggita al controllo umano, eppure cantata dall’uomo (da lui, da noi) – una distopia con sfumature apocalittiche in cui ci si trova immersi dalla parte dell’orrore stesso, e in cui la consapevolezza umana si mescola e si contamina con l’inconsapevolezza della natura deviata distruttrice. Leggendo, non si può che essere, insieme, l’una e l’altra cosa. Si vive un male che non è male perché per noi è semplicemente natura, ma che è insieme anche evidentemente male perché non possiamo mai essere api sino in fondo.
Queste pagine sono state realizzate da Corrado Costa (di cui abbiamo parlato già giovedì scorso), poeta legato alla Neoavanguardia italiana (e avvocato di Soccorso Rosso) e pubblicate su Alter Alter nei numeri di giugno e agosto del 1977. La didascalia dice “Lettura in trasparenza”, e in effetti per leggerle efficacemente dovreste stampare ogni coppia di pagine fronte-retro, curando l’allineamento delle linee sui due lati, e poi guardare controluce – proprio come erano presentate su Alter Alter.
Vi accorgereste allora che le traiettorie delle pallottole bucano la carta, e quelle che si vedono nette da un lato proseguono in trasparenza dall’altro, e viceversa. Voltando pagina, ovviamente, la situazione si inverte.
Si crea in questo modo una sorta di visione stereoscopica, dove il prima sta da un lato (il secondo) e il dopo sta dall’altro (il primo); ma poi, coppia di pagine dopo coppia di pagine, il gioco si complica. Nella seconda coppia ci sono dei proiettili che arrivano da chissà dove. Nella terza il gioco dell’alto e del basso è mescolato, volutamente innaturale.
A Corrado Costa piaceva giocare, e non solo con le parole. In questo piccolo gioco è contenuta una riflessione sul raccontare storie, sul tempo e sulle convenzioni di stampa. Al tempo stesso queste stesse riflessioni non sono dette, ma sono implicite nella forma stessa di questo singolare fumetto – secondo certe modalità espressamente poetiche piuttosto tipiche della neoavanguardia.
Insomma, possiamo considerare questo strano oggetto come un esplicito esperimento di poetry comics senza parole?
24 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, Corrado Costa, lirica, poesia | Category: poesia | PSEUDOBAUDELAIRE
Quando per una circolare o rapporto segreto del-
le superiori potenze, suo figlio non riconosciuto
nasce – a Dio, cagna gelosa nei cieli randagi
coi pugni proclamati, con un linguaggio che
ricorda l’epoca dei suoi amori staliniani, ringhia
la madre e le materne creature amanti
combattenti associati, neo-intransigenti di carriera
speakers, cavie, chele nei fondi del diluvio
donne da funerale – palchettiste
Quando la vocazione, per aspetti segreti oppure altri
motivi del rapporto, ha per tema il disgelo: da
che rami feriti viene il vento, da che crocefissione
sono nate le stigmate ai credenti, per quale errore
hanno aggiogato un popolo ai persecutori d’innocenti:
contro di lui – elemento deviato e condannato – intere
voci di muti chiedono la parola, intere nevi
sentono il dovere di proclamare la primavera,
intatti fantasmi chiedono il realismo.
La recente insistenza di Marco Giovenale su Corrado Costa qualche frutto lo dà, almeno su di me. E così, mi trovo a ripercorrere antiche letture, e a riscoprire questo gioiellino, del 1964, primo componimento della raccolta omonima, Pseudobaudelaire, ora disponibile anche in rete per le edizioni di Biagio Cepollaro.
Nel titolo di questi versi ne viene esplicitata anche la chiave, o meglio, una chiave di lettura. Non è infatti difficile accorgersi della relazione che lega i versi di Corrado Costa a quelli di una delle poesie intitolate Spleen. La relazione sarebbe individuabile anche senza questa indicazione, ma il fatto di tematizzarla attraverso il titolo le dà evidentemente un peso particolare per la lettura; qualcosa come un invito a leggere i versi di Costa tenendo ben presente quelli di Baudelaire.
Spleen
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;
Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrément.
– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Gli elementi su cui si fonda la somiglianza sono vari. C’è l’attacco in quando, con la successiva ripresa, e il conseguente effetto sospensivo sino all’arrivo delle clausole di risoluzione. Costa ripete il quando due sole volte, contro le quattro di Baudelaire, ma ottiene lo stesso un effetto analogo attraverso l’insistenza dell’elencazione di elementi disforici, e una posticipazione ancora più lunga della risoluzione. Verso la fine, le voci di muti di Costa corrispondono poi ai funerali, senza tamburi né musica, di Baudelaire.
La titolazione, Pseudobaudelaire, dichiara pertinenti queste somiglianze. Nel momento in cui il lettore riconosce il riferimento, è come se questa poesia si intitolasse a sua volta Spleen, e si presentasse come una parodia (nel senso etimologico del termine) del testo originale, cioè un testo secondo, che sfrutta alcuni elementi strutturali del testo originale, e il loro senso riconosciuto e assestato, per giocare sulle diversificazioni, sugli elementi di diversità. Non è parodia nel senso di presa in giro, perché qui non c’è nessun attacco polemico nei confronti di Baudelaire ; ma è parodia nel senso di canto collaterale, sulle stesse note dell’originale, per produrre un effetto diverso (ma non del tutto diverso).
Ecco quindi che, in questo modo, si trovano sottolineate le differenze. In generale, all’angoscia esistenziale di Baudelaire, Costa sostituisce una sorta di angoscia politica, in cui anche i riferimenti a motivi religiosi si trovano inquadrati in questo senso, accostati provocatoriamente a espressioni come associati, carriera, con evidenti riferimenti al rampantismo di un mondo corporate. Lo spleen di Costa è lo stesso di Baudelaire, ma ha contenuti differenti. Quelli di Baudelaire potrebbero essere visti come contenuti tradizionali dell’espressione lirica; per contrasto, dunque, quelli di Costa si propongono come antilirici, opportunamente realistici, e non privi di una diffusa ironia.
Insomma, parole e riferimenti esplicitamente antilirici all’interno di una cornice dichiarata esplicitamente lirica, con tanto di progressione conclusiva basata sulla ripetizione allitterativa intere-intere-intatti (che probabilmente non per caso segue la comparsa dell’unica sequenza rimica: vento-credenti-innocenti), che riproduce il tono di Baudelaire pervadendolo però di sarcasmo.
Insomma, in fin dei conti la parodia (nel senso consueto di presa in giro) c’è, anche se non dei versi di esplicito riferimento. La parodia riguarda la lirica in generale e le sue possibilità espressive; non Baudelaire ma la poesia che oggi lo imita e non riesce ad allontanarsi da quel modello.
Non possiamo tuttavia ridurre il componimento di Costa a questa sola componente. Non c’è dubbio che, come tutta la poesia dell’avanguardia, e buona parte dell’arte del XX secolo, questa poesia parla anche di poesia e si rivolge ai poeti. In questo starebbe solo in parte il suo interesse, e molto di più il suo limite, anche se spesso questo è proprio ciò che foraggia il discorso critico, che trova un facile appiglio in questa dimensione in sé critica della poesia contemporanea (e immagino quanto a lungo si potrebbe ragionare sulla comparsa del termine realismo nell’ultimo verso, in un momento storico in cui la polemica tra la Neoavanguardia e Pasolini si sta facendo sempre più virulenta).
Anche se non posso trascurare questi elementi, perché fanno comunque parte del discorso costruito da questi versi, quello che mi affascina qui è piuttosto la dimensione contraddittoria, o ambivalente, in cui la loro lettura è costretta a dipanarsi. Gli elementi lirici sono chiaramente presenti nell’andamento prosodico e versale, nell’uso di allitterazioni e rime, nella costruzione delle ripetizioni e dell’andamento sospensivo; ma il fatto di essere così esplicitamente focalizzati per mezzo del titolo li rende a loro volta oggetto del discorso, pur senza annullarli.
È come se Costa stesse dichiarando l’inevitabile fascinazione della tradizione lirica e delle sue costruzioni formali, mentre insieme dichiara anche l’impossibilità di assumerla pienamente, e l’irrealizzabile necessità di allontanarsene. Forse è proprio perché si colloca su questo drammatico crinale, ed esprime una condizione che ci rappresentava allora come ancora ci rappresenta oggi, che questi versi mi colpiscono.
Poi, tanto per restare all’interno di altre ricorrenze, sembra di sentire qui la stessa tensione che muoveva Adorno ancora in quegli stessi anni, quando dichiarava l’impossibilità, oggi, di un arte innocente, e pure lasciava capire quanto questa innocenza rimanga vagheggiata, desiderata, necessaria, pur nella sua impossibilità.
Infine, tutte queste mie parole non sono e non vogliono essere la chiave, forse neanche una chiave, per entrare nei versi di Corrado Costa. Diciamo che vorrebbero essere, nel loro insieme, la proposta per una lettura che parta con alcune consapevolezze, ma che le sfrutta non per cercare una verità del testo (verità che la poesia non possiede, né vuole possedere – è la saggistica che cerca la verità, semmai) me per avere degli strumenti per sopravvivere, per muoversi, in quell’ambiente in parte alieno che è il testo poetico. Il testo poetico va prima di tutto vissuto, materialmente attraversato. Costituisce la possibilità di un esperienza vissuta. Non è un messaggio da decifrare. Il suo significato è ciò che ci lascia l’esperienza del suo attraversamento – che sarà, certo, tanto più intensa e profonda quanto più possediamo gli strumenti per capire quello che ci circonda.
Chissà se è questo ciò che Marco Giovenale chiama cambio di paradigma? Ma, se è questo, le cose stavano così anche prima. La svolta degli anni Sessanta lo ha solo messo più chiaramente in luce.
10 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Un po’ me la prendo, in effetti, con l’avanguardia. Potrei fingere che non esiste, e parlare di altro. Invece mi accanisco, e ci torno sopra, e discuto con chi ne sostiene le ragioni (il che non implica, di per sé, che ne faccia parte – non so nemmeno se sia corretto dire che un’avanguardia esiste, in Italia oggi; quello che esiste è comunque l’idea di avanguardia, e l’atteggiamento avanguardista). Il semplice fatto di non condividerne le posizioni non basta a spiegare perché me la debba prendere così. Sarebbe molto più semplice ignorare il problema, e dichiararlo, così facendo, di fatto finito. Ma non è così; e soprattutto, evidentemente, non è così per me.
Il problema non è certo la sperimentazione in sé. Non si fa poesia, non si fa nessun prodotto culturale di valore senza ricerca e senza esperimenti. E un buon numero di esperimenti falliti è il prezzo naturale da pagare. D’altra parte, anche le avanguardie hanno i loro prodotti riusciti, che non ho problemi ad apprezzare. Apprezzo i prodotti, e apprezzo la sperimentazione; ma mi resta l’avanguardia come problema.
Sì, confesso che provo una qualche irritazione quando qualcuno si lamenta che in verità chi fa quel tipo di sperimentazione non è amato dai festival e dai premi letterari. C’è del vero nel fatto che il mercato culturale ha di solito difetti assai peggiori di quelli delle avanguardie. Però non si può negare che i fasti ormai passati della Neoavanguardia italiana abbiano lasciato comunque dei privilegi critici alle posizioni che le sono vicine; e questo fa sì che comunque gli spazi non manchino (nella generale scarsità) a chi fa parte dell’ambiente. Ma non è davvero questo il problema! Non ho nessuna posizione di scuola o di cordata da difendere. Mi irrita qualunque lamentela di questo genere, che provenga dall’avanguardia o dalla retroguardia. Sembra sempre di dover piangere una qualche miseria per colpa di qualcun altro; e gridare tu hai avuto abbastanza, lasciane un poco anche a me!
Il problema ha piuttosto a che fare con l’etica. Un’avanguardia è un gruppo che si muove attorno a un’idea, politica o artistica che sia. In campo politico le versioni estreme delle avanguardie sono i fondamentalismi (quello bolscevico fece la Rivoluzione d’Ottobre, in una Russia dove la Rivoluzione c’era già stata, e lo Zar era già stato deposto; quello islamico ha fatto l’Iran di oggi). In campo artistico magari i fondamentalismi ci sono lo stesso, ma siccome non sono particolarmente pericolosi, non ci importa di definirli come tali – e non mi interessa parlarne qui.
Le avanguardie che mi turbano sono quelle che vivono attorno a un’idea che io trovo, in linea di principio, condivisibile. Per esempio, che la poesia debba esprimere la banalità dei discorsi della società di massa, o che debba esprimere le tensioni o le emozioni politiche, o lo sdegno per l’ingiustizia sociale… sono tutte cose con cui non posso che trovarmi d’accordo. Il problema è semmai che, quando una di queste idee diventa l’unico o anche solo il principale motore di una produzione artistica, si scopre d’improvviso che non è del tutto compatibile con le altre; e soprattutto che non è del tutto compatibile con altre cose che continuiamo ad aver bisogno di esprimere, ma che non sono sostenute da un afflato ideale, perché sono più semplicemente legate alla normalità quotidiana, o magari al dubbio e alla diffidenza verso le idee che si pongono con troppe certezze.
Se io fossi un personaggio letterario, sarei Amleto, sempre in preda al dubbio. Credo che la mia posizione sia corretta, e porto avanti la mia piccola battaglia contro la critica prescrittiva e contro chi ritiene di sapere che cosa si debba fare in campo artistico (contro le ideologie; non contro le opere, che vanno sempre valutate indipendentemente dalle ideologie vicino a cui nascono). Ma siccome a dubitare si dubita anche di sé, mi vengono dei dubbi etici, e mi chiedo se non sto esagerando, se non sto perseguendo l’ideologia della non ideologia, e questo non mi condanni all’immobilismo.
Rimprovero alle avanguardie di avere messo l’etica davanti all’estetica anche là dove non lo si dovrebbe fare. L’etica è importante, anche più dell’estetica. Ma se non lasciamo qualche campo anche in noi stessi alle idee diverse dalle nostre, finiremo per essere dei fondamentalisti di qualche tipo, senza rendercene conto. L’estetica è il campo dove queste idee possono presentarsi e germinare. Questo campo deve essere libero dall’etica, perché è da questo campo che proviene la possibilità di cambiare idea, di trasformare le nostre ideologie. Tuttavia proprio per questo è un campo pericoloso, e a lasciargli troppo spazio nessuna idea, nessuna prospettiva etica può davvero avere forza.
Io percorro le strade dell’estetica cercando suggerimenti etici. Ma non ho mai la certezza che non sto esagerando. Non posso mai essere certo che avrei già dovuto fare una scelta, optando risolutamente per quella. L’atteggiamento avanguardistico è quello di chi questa scelta l’ha fatta. Per questo mi affascina, benché lo ritenga estremo e sbagliato. Per questo probabilmente lo devo esorcizzare scrivendone. Il fantasma di Adorno mi perseguita, come il fantasma di un padre giustamente assassinato; e continuo a ritrovare sulla mia strada tanto i suoi errori quanto le sue intuizioni corrette, grandi gli uni quanto le altre.
(su Adorno, e la sua concezione etica dell’arte, avevo scritto qualche anno fa su Tempo Fermo. Ora lo si può leggere qui)
 Marino Neri, “La coda del lupo”, Canicola 2012, pp 24-25 La coda del lupo, di Marino Neri, è un bel libro a fumetti, molto ben raccontato, molto ben disegnato. Potrei parlare di come Neri reinterpreta liricamente il segno di Micheluzzi, o di come sappia giocare di tinte bianche e nere molto nette, ma anche di tessiture graffiate, irregolari, dal segno grosso – grosso come tutti i segni delle sue vignette, quasi a lasciare appositamente il mondo come poco definito, irreale, sognato (il che è anche, un po’, il tema della storia).
Potrei parlare di quello e invece parlerò d’altro, perché voglio prendere il libro di Neri per proseguire il discorso sulla poesia a fumetti, o poetry comics (per i precedenti, vedi qui e qui). Ho detto negli interventi precedenti che nel fumetto non distinguiamo tra poesia e prosa come si fa tradizionalmente nella letteratura verbale; non distinguiamo non perché non lo si possa fare, ma perché non c’è gran motivo di farlo. Detto questo, ci sono certamente fumetti che mostrano, proprio come la poesia rispetto alla prosa, un’attenzione alle componenti formali che va al di là della loro efficacia per raccontare la storia. Non si tratta di un pregio in sé: ci sono fumetti bellissimi che sono tranquillamente prosastici, in questo senso (Hergé, primo tra tutti, insegna; Pratt, non ultimo, pure). Si tratta solo di una caratteristica, e indagarne gli aspetti può far luce su quello che abbiamo chiamato poetry comics, sui suoi limiti e sulle sue possibilità.
Mi interrogo su La coda del lupo perché al momento, pur avendolo molto apprezzato, non so davvero se posizionarlo tra la prosa, la poesia o in un’ampia zona intermedia, e perché spero che, riflettendoci, questo mi porti a capire qualcosa di più sulla questione. Non ho scelto Toppi o McCay (che ho già portato come esempio), perché nel loro caso so che cosa mi invita a metterli dal lato della poesia: ed è l’architettura della tavola, e anche, nel caso di Toppi, il ritmo della sequenza delle tavole. Sia l’architettura della tavola che il ritmo complessivo influiscono certamente sull’efficacia del racconto, ma non si risolvono in questo: posso godere di quelle composizioni visive anche senza sapere cosa raccontano; e anche se non posso sentire il ritmo se non capisco il racconto, è il respiro epico quello che ne salta fuori, quasi come una grande musica di fondo, indipendentemente da quello che si sta raccontando.
Ma ne La coda del lupo non ci sono queste cose. I disegni, pur singolarmente belli, non sembrano comporre architetture grafiche di per sé notevoli; non parliamo poi del ritmo di Toppi, che è una cosa praticamente solo sua… Ne dovremmo concludere che Neri fa (ottimamente) il narratore e basta? Forse sì, ma non ne sono convinto del tutto.
Mi è già capitato di parlare di quello che ho chiamato battito-vignetta-evento, e del fatto che in questa unità ricorrente del raccontare a fumetti ci sia qualcosa di simile al ricorrere del verso in poesia (ne ho parlato in questo post). Questa caratteristica è comune a tutti i fumetti, e indipendente dal racconto. Diciamo che saper raccontare a fumetti significa saper organizzare in vignette una storia, e saper costruire visivamente le vignette – un po’ come ai tempi di Omero saper raccontare (e si raccontava solo in versi) significava saper organizzare per versi una storia, e saper costruire sonoramente i versi. Questo permetterebbe al fumetto in generale di presentarsi come una sorta di epica moderna, e quindi un genere poetico – fatta salva, ovviamente, la differenza tra un’unità verbo-sonora come il verso e una sostanzialmente visiva (più, a volte, un po’ di testo) come la vignetta.
Nel senso appena detto La coda del lupo è poesia, ma lo è come ogni altro fumetto, con l’aggiunta che magari qui il tema ha qualcosa di epico, anche se un’epica dell’interiorità, del rito di passaggio dell’adolescenza – cioè, insomma, un’epica moderna, senza eroi. Non riusciamo però ad andare più in là?
Allora faccio un’ipotesi, così, per cercare di spiegare la sensazione che il libro di Marino Neri possa stare un po’ di più dalla parte della poesia che da quella della prosa. La storia scorre benissimo, nella sequenza di Neri; però questi disegni così netti, così forti, così scanditi, sono molto significativi anche individualmente. È vero che questo, come ho osservato altre volte rispetto al disegno di José Muñoz, contribuisce a rallentare la lettura, conferendo una certa solennità al ritmo complessivo – e quindi c’è certamente una funzionalità a una migliore resa del racconto. Però è come se queste vignette si imponessero anche, una per una, nella loro icasticità, proprio come i versi di un poema, che si fanno sentire come versi mentre al tempo stesso raccontano. Tuttavia, facendosi sentire, permettono l’emersione di altre relazioni, come le rime, le allitterazioni e altri fenomeni fonetici e sintattici tipici della poesia. Qui, qualcosa di questo genere finisce per succedere rispetto a queste forme nere (e bianche, e tessute) che sono così poco o così faticosamente naturalistiche (insomma, poco definite, rispetto a un’idea di disegno realistico) da costringere l’occhio a vedere echi e rispondenze nelle forme tra una vignetta e l’altra, tra una pagina e l’altra.
Così, insieme alla storia, si snoda in questo libro una sorta di sinfonia di forme nere e di forme bianche, e di tessiture scarabocchiate e quasi incerte, in modo che ne ricaviamo l’impressione di stare aggirandoci in un universo di forme astratte (e un po’ inquietanti) che si ripetono. Questo ha a sua volta effetto sulla storia, giustamente, ma funziona pure di per sé – come il suono dei versi di Omero.
Un maggiore naturalismo grafico non avrebbe pregiudicato la storia (anche se forse certi effetti sarebbero stati meno intensi), ma avrebbe attutito o addirittura nascosto questo senso di ripetizione modulata di qualcosa che appartiene a ciò che si sta vedendo, al disegno, non a ciò che è raccontato, non a ciò cui il disegno rinvia.
Insomma, poetry comics? Forse non proprio, però parecchio da quel lato, a quanto pare.
Provo a riprendere le fila, o almeno qualche filo, del discorso aperto con Marco Giovenale nel post del 12 settembre. È un discorso complesso, complicato, dove i vari fili si intrecciano e ingarbugliano, e io stesso non sono sicuro di vederci chiaro. Cominciamo dalla fine, cioè dall’ultima parte del commento di Giovenale al mio post, dove dice:
Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.
Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.
Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.
Non vorrei che ci fosse qui un, come dire, abbaglio di prospettiva. La trasformazione sociale c’è stata, non c’è dubbio, e si rispecchia nei nostri discorsi, non c’è dubbio. Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%? Non c’è dubbio che quel 10% sarebbe quello che sentiamo più rappresentativo, più identificante di noi stessi rispetto a chi ci ha preceduto – però resterebbe comunque un 10% (d’altra parte, per fare un’analogia, il 99,99% del DNA di tutti gli umani è identico, e la nostra cruciale differenza individuale si annida nel restante 0,01). Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi che il 90% della poesia contemporanea continui ad esprimersi come quella dei nostri nonni (o bisnonni): non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti. Quel 90% di zoccolo duro resta lì, a fianco del 10%. Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.
In aggiunta, può ben darsi, come suggerisce Giovenale, che vi sia in poesia l’eredità di un’assertività religiosa, o comunque (non sono certo di capire bene del tutto l’uso che lui fa del termine assertivo/assertività) qualcosa di ereditato con forza. D’altra parte, la poesia (e proprio la poesia, non la prosa) viene sentita come qualcosa di particolarmente profondo, qualcosa che, anche se parla della banalità del quotidiano, in verità non si ferma mai alla banalità del quotidiano – quindi qualcosa che ha in comune con la religione un atteggiamento di fondo, io direi una sacralità (che è un concetto che non ha necessariamente a che fare con la divinità). Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.
Questa risposta a due facce è comunque soddisfacente solo in parte. E infatti c’è inevitabilmente dell’altro, che viene già un po’ suggerito dalla seconda faccia. Può darsi che quello che Giovenale sente e che le sue parole esprimono sia proprio la necessità di una sacralità che possa essere trovata nelle forme del presente, quelle del suddetto 10%; poiché quelle del rimanente 90%, per quanto possano essere state a loro tempo autentiche, oggi non lo sono più (e Adorno sta occhieggiando dalla finestra).
Io temo però che ci troviamo di fronte a un altro abbaglio prospettico, che potrei descrivere come segue. La poesia riuscita, che ci piace, che definiremmo bella, è quella che mette in crisi il moi (con la sua assertività, suppongo) e che esprime dunque, in qualche modo, il presente. Questa è un’asserzione che sottoscriverei, a patto di non confonderla con il suo converso, che è questo: la poesia che mette in crisi il moi e che esprime dunque, in qualche modo, il presente, è quella riuscita, che ci piace, che definiremmo bella. Questa seconda, a differenza della prima, è un’asserzione prescrittiva, che ci dice che attraverso questi mezzi possiamo arrivare al fine della buona poesia; ma riduzione dell’io ed espressione del presente non sono mezzi, bensì fini. Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia. Qualche volta potrà sembrare che lo faccia, ma sarà un effetto di superficie: pensiamo a – per fare un esempio di qualche anno fa – le poesie di Sandro Penna. Apparentemente centrate sull’io, sentimentali, banali come lessico e come sintassi; ma appena le si guarda più da vicino complessissime e strapiene di ragioni di interesse – in barba alla complicazione esibita delle poesie ermetiche loro coeve!
Questo mi rimanda all’altro punto cruciale su cui Giovenale insiste nel suo commento, cioè la questione dell’oscurità. Avevo affrontato una questione simile in un post di qualche mese fa (Del diritto della poesia a essere incomprensibile). In quel post distinguevo tra il diritto che la poesia ha all’oscurità (e dei suoi fondati motivi), e l’opportunità di non essere invece oscuri, e arrivavo a dire:
Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.
Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)
Il primo pregio delle poesie di Amelia Rosselli è quello di essere (almeno per me) fortemente coinvolgenti. Esprimerebbero una riduzione dell’io anche se non la tematizzassero; in più la tematizzano, spesso.
Per quanto riguarda Le petit bidon di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…
Dove voglio arrivare non lo so. Quello che mi è ben chiaro è che la poesia è una cosa e le poetiche ne sono un’altra, che sta già sul versante della critica. Per questo la poesia possiede un diritto ad essere oscura che la critica invece non ha. Certo l’oscurità di un testo poetico aumenta la sua probabilità di non poter essere inteso, e senza un’intesa (il gioco di parole è voluto) tra il testo e il lettore non parte il meccanismo che ci permette di entrare nel gioco, di essere coinvolti, di trovare interessante la casa, l’ambiente che ci circonda. Oltre un certo limite di oscurità l’intesa non viene trovata più da nessuno, e il testo poetico è come una casa (magari meravigliosa) di cui nessuno possiede la chiave. Un oggetto inutile, insomma.
(continua – molto molto a lungo, probabilmente)
 William Blake, pagina originale dai Songs of Experience, con The Tyger A conclusione del dibattito di Pordenonelegge su fumetto e poesia (vedi qui e qui per le puntate precedenti), mi è venuto in mente una cosa che avevo scritto su Guardare e leggere (il libro, non questo blog), a proposito di una poesia che io amo moltissimo, “The Tyger” di William Blake (qui la traduzione italiana di Giuseppe Ungaretti). Certo, far passare Blake per un fumettista sarebbe eccessivo, ma l’immagine contenuta in questa pagina ha qualche aspetto in comune con le immagini del fumetto.
Andiamo per gradi. Nel corso della sua vita, William Blake è stato molto apprezzato dai suoi contemporanei come illustratore e incisore, ma pressoché ignorato come poeta. Dopo la sua morte, gradatamente, la situazione si è abbastanza ribaltata, e “The Tyger” si è affermata come probabilmente il più famoso componimento poetico in lingua inglese, ancora più citata e studiata delle incisioni del suo autore. Blake è perciò diventato, per tutti, un poeta, tendendo a far dimenticare spesso, con questo, la sua altra e già più valutata attività. Inoltre, poiché la poesia pertiene agli studi letterari e l’incisione a quelli di storia dell’arte, studiosi diversi si sono occupati delle due attività di Blake, come se fossero due mondi diversi e non comunicanti.
“The Tyger” viene perciò normalmente letta nella versione tipografica, separata dal contesto visivo in cui il suo autore l’aveva inserita per la pubblicazione, nella quale si trovava integrata, come vedete qui sopra, in un’unità di parola calligrafica e immagine (i colori sono dati a mano dall’autore sulle singole copie).
L’immagine che qui circonda il testo verbale non è, in senso stretto, un’illustrazione. L’illustrazione costituisce normalmente un commento (benché talvolta cruciale) a un testo verbale che esiste autonomamente da lei. In altre parole, il testo verbale di riferimento esiste e ha significato anche indipendentemente dall’illustrazione; e quest’ultima è una sorta di chiosa, di commento visivo. Nel fumetto, l’immagine ha invece una funzione narrativa, e non se ne può fare a meno, poiché agisce congiuntamente con la parola (quando c’è) a costruire il senso complessivo.
Esiste anche, specie nei libri per bambini, un tipo di illustrazione, meno canonica, che, pur non essendo fumetto, agisce come l’immagine del fumetto, contribuendo al senso del testo in maniera sostanziale. Potremmo dire che l’illustrazione canonica è fatta di immagini commentative, mentre quella non canonica è fatta di immagini narrative. Il fumetto, in questo senso, si costruisce attraverso una sequenza di illustrazioni non canoniche accompagnate da testi verbali (cioè immagini narrative – poi c’è dell’altro, ma per semplicità sorvoliamo).
Tornando a “The Tyger”, il problema è se dobbiamo considerare l’illustrazione che l’accompagna come canonica oppure no. Se riteniamo che la versione solo tipografica della poesia sia quella vera (come oramai assestato da tradizione) allora stiamo implicitamente considerando l’immagine che la contorna come un’illustrazione canonica, cioè un commento di cui si può anche fare a meno. Ma è davvero così?
Laggetevi ad alta voce i primi quattro versi, sottolineando gli accenti (e da questo punto di vista, Ungaretti ha davvero rovinato tutto):
Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?
I primi tre versi sono (per la metrica inglese) tetrametri trocaici (accenti sulle sillabe 1, 3, 5 e 7), pressoché identici ritmicamente all’ottonario italiano; il quarto è un tetrametro giambico (accenti su 2, 4, 6 e più debole sull’8). Benché la combinazione di tetrametri trocaici e giambici sia permessa dalla metrica inglese, non si può comunque non notare la forte rottura ritmica che caratterizza l’andamento del quarto verso rispetto ai primi tre. Aggiungiamo inoltre che dopo la forte rima baciata dei primi due versi, ci si aspetta una rima altrettanto forte nei secondi due. E qui, invece, c’è solo una rima per l’occhio, una sorta di inganno, dove la medesima lettera y suona in maniera differente – un inganno a sua volta permesso dalla metrica, ma non per questo meno evidente.
Insomma, proprio sulla parola symmetry viene a rompersi per due volte la simmetria, sia in senso ritmico che rimico. Qui il semiologo che è in me inizia a drizzare le orecchie.
Ora prendiamo la parola fearful, che Ungaretti traduce con agghiacciante. Agghiacciante è una bellissima parola, che si confà molto alla tigre, però, come traduzione di fearful ha un difetto. Fearful infatti significa pauroso, che è una traduzione più debole e meno efficace, ma conserva l’ambiguità del termine inglese: pauroso (come fearful) è infatti sia ciò che produce paura che chi prova facilmente paura, cioè si spaventa facilmente.
Osservate adesso la tigre dell’immagine, quella che nelle versioni tipografiche del componimento non c’è. Vi pare più qualcosa che produce paura o qualcuno che prova facilmente paura? (tenete presente che Blake era uno che conosceva bene il mestiere di disegnatore e incisore, e quindi non ci sono dubbi sul fatto che ciò che vediamo esprima le sue intenzioni). Più che una belva feroce, questo sembra (a me) un pupazzo spaventato, e dunque pauroso nel secondo, e non nel primo senso. Solo osservando l’immagine, tuttavia, ci possiamo accorgere dell’importanza del secondo senso di fearful!
Andiamo avanti. Guardate quante volte la coda delle lettere y si allunga e piega a imitare una coda animale, a partire dall’occorrenza nel titolo stesso! Ora, perché Blake ha scritto Tyger e non Tiger? La forma di questa parola che porta la y è una forma antica e desueta già quando la poesia viene scritta; la parola normale, oggi come allora, è tiger, non tyger. Non sarà magari perché la y di Tyger è anche la y di symmetry, una parola con ben due y, e una parola chiave, come abbiamo visto (le due y di Tyger Tyger, quasi a ribadire un altro livello di simmetria)?
L’interpretazione diffusa del componimento di Blake è che si tratti di una poesia sulla creazione, in cui il poeta si stupisce del fatto che Dio, il Creatore, abbia potuto mettere insieme, creando la tigre, tanta bellezza e tanta ferocia. Ma ci accorgiamo ora, guardando la versione originale, nella quale la componente visiva gioca un ruolo decisamente importante (lo possiamo ben dire, a questo punto!) che Blake letteralmente dissemina il suo lavoro di indizi ironici: il gioco su symmetry, le code delle y, la tigre impaurita, e poi, ancora: le orecchie da gatto della g nel titolo, la minuscola nella parola he (che dovrebbe riferirsi a Dio, e che invece evidentemente non Gli si riferisce), nel verso Did he who made the Lamb make thee?, dove invece Lamb porta la maiuscola… Se non a Dio, a chi si riferisce qui Blake? Magari a qualcuno che ha fatto non the lamb, bensì the Lamb, cioè – per esempio – una poesia che porta questo titolo? Gli indizi ironici potrebbero rinviare al fatto che si sta parlando sì della creazione, ma non di quella divina, bensì di quella poetica: il poeta parla di sé, e della propria opera: Colui che ha scritto the Lamb ha scritto anche te?
Si può continuare, e rileggere tutto il testo in questo senso. Ma ci fermiamo qui. Quello che abbiamo osservato è sufficiente per capire che qui l’immagine, la componente visiva, ha una funzione narrativa proprio come succede nel fumetto, e, come nel fumetto, se non la si tiene presente non si può interpretare correttamente il testo. Quello di Blake non è un fumetto perché l’immagine è una sola, e non c’è sequenza – e, naturalmente, perché il fumetto all’epoca non esisteva ancora. Però è qualcosa di molto vicino ai poetry comics di cui siamo andati discutendo a Pordenonelegge.
Qualche anno dopo “The Tyger”, Blake sarà tra i primi poeti europei a sperimentare il verso libero. Qui sperimentava già una forma di poesia verbo-visiva, che ha bisogno del suono (nel ritmo) così come dell’immagine per essere compresa. La specializzazione accademica ci ha reso invisibile per due secoli l’innovazione di Blake.
 Dibattito su fumetto e poesia a Pordenonelegge 2012
Ci sono altre cose che ho detto venerdì scorso a Pordenonelegge, nel dibattito su poesia e fumetto (con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo) di cui ho iniziato a parlare nel post precedente. Cose che magari sono riuscito a dire solo in parte, perché i tempi erano ristretti, e alle quali posso dare qui una seconda possibilità di espressione.
Intanto, mi ero portato come ripasso, da rileggermi in treno, il Pasolini di Davide Toffolo, che è un libro molto bello, anche meglio di come lo ricordavo. Non è in nessun senso un esempio di poesia a fumetti, però è un bel libro di prosa fumettistica che parla di un poeta. E così mi è venuto da pensare agli interventi in versi che Pasolini pubblicava su Paese Sera negli anni Sessanta. Erano interventi politici, spesso provocatori, e quindi discutibili tanto quanto interessanti, a cui il fatto di essere in versi non aggiungeva certo qualità. Anzi, come versi davvero non erano memorabili. Niente a che spartire con Le ceneri di Gramsci.
Al di là delle opinioni politiche di Pasolini, che non sono pertinenti per il discorso che sto facendo qui, quello che c’era di interessante in quei versi era proprio il fatto che fossero versi, inseriti in un contesto in cui il verso normalmente non trova posto. Con questa operazione, Pasolini centrava due obiettivi, entrambi provocatori. Da un lato, in un contesto – come quello del giornale – in cui la parola conta solo per il significato che trasmette, l’inserimento del verso (che sottolinea invece la natura anche sonora della parola, e la storia del suo uso in contesti poetici, e quindi in cui l’aspetto formale è sempre stato importante) focalizzava l’attenzione sulla parola stessa, sulla sua retorica intrinseca – anche a costo di diminuire l’efficacia del discorso trasmesso. Dall’altro, la parola poetica, inserita in questo modo in un contesto assolutamente prosastico, perdeva di colpo gran parte della sua sacralità.
Il primo obiettivo era ovviamente quello più evidente e di maggiore impatto (non foss’altro perché i lettori di quotidiani e le persone interessate agli interventi politici sono molte di più di coloro che hanno a cuore le sorti della poesia). Ma è il secondo quello che ci interessa qui, perché è sul senso di sacralità del discorso poetico che si fonda una delle principali differenze tra poesia e fumetto. In altre parole, benché i lettori di poesia siano in Italia un’infima minoranza, il prestigio culturale di cui la poesia gode resta altissimo, almeno virtualmente – ma resta comunque molto più alto di quanto sarebbe giustificato (in una pura logica di mercato) dall’esiguo numero di lettori. Questo prestigio e questa sacralità fanno sì che chi fa e chi legge poesia si trovino a operare con i piedi di piombo sia nel fare che nel giudicare – e che, di conseguenza, sia difficile innovare davvero, al punto che ogni presunta innovazione debba essere accompagnata da fiumi di giustificazioni critiche.
Il mondo del fumetto non possiede né la stessa sacralità né un prestigio paragonabile, ma proprio per questo finisce per essere molto più vivace e in trasformazione di quello della poesia. Ci sono meno regole storicamente sedimentate, e la posta in gioco si presenta come più bassa: l’autore (e il lettore con lui) rischia meno, o almeno vive la sensazione di rischiare meno. Quando dico regole storicamente sedimentate non faccio riferimento alla metrica o al modo di usare il linguaggio; penso piuttosto a regole nel gioco di ruolo della società, in cui la poesia occupa un posto sancito dalla tradizione, con il quale ci si deve confrontare comunque (sia che lo si voglia confermare, sia che – alla Pasolini – si stia cercando di modificarlo).
Per mettere altra carne al fuoco, e capire meglio il contesto in cui si può parlare di poetry comics, non bisogna poi trascurare un’altra differenza importante, che riguarda i materiali da costruzione. La poesia fa uso di parole, cioè di un materiale che noi tutti siamo bravissimi ad utilizzare, almeno nella comunicazione quotidiana. Il fumetto fa uso di immagini disegnate, cioè un materiale per produrre il quale è necessaria una capacità che si acquisisce solo dopo un lungo training, anche ai livelli più di base.
Da un lato, quindi, il linguaggio di un testo poetico, oltre a confrontarsi con il linguaggio di tutti gli altri testi poetici, si confronta pure con l’uso quotidiano, strumentale o affettivo, della lingua. Dall’altro, il linguaggio (visivo-verbale, ma soprattutto visivo) di un testo a fumetti si confronta solo con il linguaggio visivo di altri testi, soprattutto a fumetti, ma non solo: non, in ogni caso, con un qualche materiale comunicativo quotidiano (se non per la sua componente verbale, che qui è però inserita in un contesto grafico assai più importante).
Questa non è una differenza né piccola né scarsamente rilevante. Una delle tensioni potenzialmente presenti nel testo poetico è quella prodotta dalla maggiore o minore distanza tra il suo uso della lingua e quello della prosa letteraria e quello della quotidianità. Quando si parla di fumetto, invece, si parla di un contenitore generale che contiene sia testi più prosastici che testi più poetici (nel senso che si era descritto nel post precedente), senza nessuna distinzione esplicita tra loro, e senza nessun possibile riferimento a una qualche quotidianità: non vi è possibile perciò il tipo di tensione di cui stiamo parlando per la poesia.
Il fumetto ha altre tensioni, che a sua volta la poesia non può possedere, che derivano, per esempio, dal rapporto tra parola e immagine. Non è un problema di potenzialità espressive maggiori o minori. Non si sta facendo una gara. Si stanno solo sottolineando differenze.
È anche per questo che la strada della comics poetry è difficile, per nulla scontata. Ma il fascino delle commistioni sta anche nella componente di sfida che portano con sé.
—————————————
A margine, la mia rilettura del Pasolini di Toffolo durante il viaggio ha avuto un’altra conseguenza. Mi ha riportato così presente alla mente la figura del poeta e cineasta e polemista e tutto quel che è stato, che quando, a Mestre, ho guardato le informazioni sul mio treno per Pordenone e ho scoperto che la fermata dopo la mia sarebbe stata Casarsa, ho avuto un fremito. Casarsa, fino a quel momento, era stato per me soltanto un nome, quello mitico del luogo friulano di Pasolini, della sua esperienza come maestro e delle sue prime poesie. Insomma, un luogo letterario, un luogo simbolico.
Non che dubitassi della sua esistenza, certo; però, trovarmelo spiattellato lì, prosaicissimamente, sull’orario ferroviario, insieme con l’informazione implicita che avrei potuto allungare appena un poco il mio viaggio e ritrovarmi là, come fa lo stesso Toffolo personaggio di se stesso che va a cercare le tracce del poeta… insomma, vedermi quel nome calato di colpo nel mondo normale è stato davvero per un attimo qualcosa di inquietante – quasi come incontrare oggi il signor Pasolini di persona, nonostante sia morto nel 1975, quando appena l’avevo visto a un convegno, a Bologna, tanto tempo fa.
24 Settembre 2012 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, poetry comics, semiotica, Winsor McCay | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, semiotica |  Winsor McCay, Little Nemo, tavola del 22.10.1905 Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire.
Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano.
Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è.
Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è.
In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato.
Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio.
La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono.
Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto.
Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto.
Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa.
Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale.
(prosegue, spero)
19 Settembre 2012 | Tags: Milo De Angelis, poesia | Category: poesia | DONATELLA
La danza fiorisce, cancella il tempo e lo ricostruisce
come questo sole invernale sui muri
dell’Arena illumina i gradoni, risveglia insieme agli anni
gli dei di pietra arrugginita. “C’è Donata De Giovanni?
Si allena ancora qui?” “Come no, la Donatella,
la velocista, la sta semper da per lé.”
Mi guardava fisso, con l’antica dolcezza milanese
che trema lievemente, ma sorride. “Eccola, guardi,
nella rete del martello… la prego… parli piano…
con una mano disfa ciò che ha fatto l’altra mano.”
“Chi è costui? Un custode, un’ombra, un indovino…
quali enigmi mi sussurra?” Si avvicinò
a Donata, raccolse una scarpetta a quattro chiodi.
“La tenga lei, signore, si graffia le gambe…
… povera Donata… è così bella… Lei l’ha vista…”
“Forse il punto luminoso della pista
si è avvitato a un invisibile spavento, forse
quest’inverno è entrato nella gola insieme al cielo:
era sola, era il ventuno o il ventidue gennaio
e ha deciso di ospitare tutto il gelo”
“O forse, si dice, è successo quando ha perso
il posto all’Oviesse, pare che piangesse
giorno e notte… per non parlare di suo padre…
i dottori che ha chiamato… mezza Milano”
“Io, signore, sbaglierò, le potrà sembrare strano
ma dico a tutti di baciarla, anche se in questo
quartiere è difficile, ci sono le carcasse dell’amore
c’è di tutto dietro le portiere. Sì, di baciarla
come un’orazione nel suo corpo, di baciare
le ginocchia, la miracolosa forza delle ginocchia
quando sfolgora agli ottanta metri, quasi al filo
e così all’improvviso si avvera, come un frutto”
“Lo dica già stasera, in cielo, in terra, dappertutto
lo dica alle persone di avvicinarsi: ne sentiranno
desiderio – è così bella – e capiranno che la luce
non viene dai fari o da una stella, ma dalla corsa
puntata al filo, viene da lei, la Donatella.”
da Biografia sommaria, di Milo De Angelis, 1999
Ho riletto questa poesia nel corso del dibattito su De Angelis seguito al post di poesia2punto0 di cui ho già parlato due settimane fa. C’era chi la citava in quanto inserita in un’antologia scolastica, e chi la irrideva come esempio di patetismo. Una bella citazione da Manacorda faceva osservare come Biografia sommaria sia in ogni caso un’opera di passaggio, non del tutto riuscita; testimonianza comunque di un processo di trasformazione dell’autore.
Non è certo tra le mie poesie preferite di De Angelis. A una prima superficiale lettura sembra davvero trasudare sentimentalismo e patetico, e giustificare le accuse di patetismo (seminascosto dalla difficoltà interpretativa, nei versi delle raccolte precedenti, ma impossibile poi da nascondere qui, dove il discorso si è fatto più semplice). Se si ha un partito preso contro De Angelis, si può anche dar credito a una lettura così banale – ma bisogna proprio, mi pare, arrampicarsi sugli specchi per sostenere un simile livello di sempliciotteria in un autore che non è mai apparso per nulla sempliciotto.
Non ci vuole molto per accorgersi infatti che in questo ritorno delle rime frequenti, al posto giusto, echeggiano non solo il sentimentale, ma anche il luogo principe del sentimentale nell’espressione poetica in lingua italiana, cioè il melodramma. È infatti proprio nel melodramma che la rima bella-stella-Donatella avrebbe la sua casa più propria.
Tuttavia, non solo De Angelis non scrive per il Donizetti del momento, ma non sembra aver avuto molte inclinazioni nei confronti del melodramma, né prima né dopo Biografia sommaria. Il che ci fa sospettare che ci possa essere un’intenzione ironica nelle sue parole. Non ironia nei confronti del dramma della Donatella, che è autentico e sentito, ma nella possibilità di esprimerlo in poesia senza diventare patetici.
E questo ci rimanda all’altra eco che si sente in questi versi, che è quella (a sua volta ironicamente melodrammatica) di Guido Gozzano, nella cui poesia il sentimento e i toni patetici non mancano affatto, ma sono l’oggetto di uno sguardo distaccato e smagato, che non riesce a non vederne i limiti e la natura, appunto, patetica (nel senso più corrente del termine). Ma d’altra parte non riesce nemmeno a fare altro, condannato in tutta la sua produzione a parodiare l’universo in cui lui stesso vive, perché non ce n’è uscita.
Tuttavia, è proprio questa natura discorsiva e costruita razionalmente del suo discorso che rende Gozzano così apprezzato da Edoardo Sanguineti, il quale fa osservare che, pur di sottrarsi al sublime dannunziano, Gozzano si condanna volentieri a questa medietà borghese, a questo patetismo ironico ma senza scampo.
Ora, a cosa o chi si vuole sottrarre il De Angelis di “Donatella”? Forse al proprio stesso sublime, a quello della sua produzione precedente, a quello delle proprie stesse (spesso magnifiche) grandi oscurità. Ci sarà anche Cucchi di mezzo (come di nuovo suggerisce Manacorda) e la sua vena narrativa, ma De Angelis, molto più di Cucchi, è sempre stato un poeta di emozioni – e continua a esserlo qui come continuerà nelle (migliori) raccolte successive.
Io credo che sia questo il punto, e il modo di trovar senso a questo componimento non tra i più riusciti di De Angelis. È, insieme con diversi tra quelli che lo accompagnano in quel volume, l’esperimento di un diverso modo di avvicinarsi all’emozione, senza cadere nel patetico, rendendo – alla Gozzano – il patetico stesso una parte del discorso. È un messaggio al sublime – compreso quello delle avanguardie, che si esprime in loro in altro modo, ma non è meno presente. Non è certamente la vena migliore di De Angelis, e io non l’avrei messo come esempio in un’antologia scolastica (testi ugualmente godibili dagli studenti, ma molto più interessanti, si trovano con facilità, per esempio, in tutto Tema dell’addio – ma magari non era ancora stato pubblicato quando l’antologia è nata); se non altro perché un quindicenne non ha nessuna chance di cogliere certe sottigliezze (sottigliezze che, a quanto pare, nemmeno vari lettori adulti di poesia arrivano a cogliere).
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|


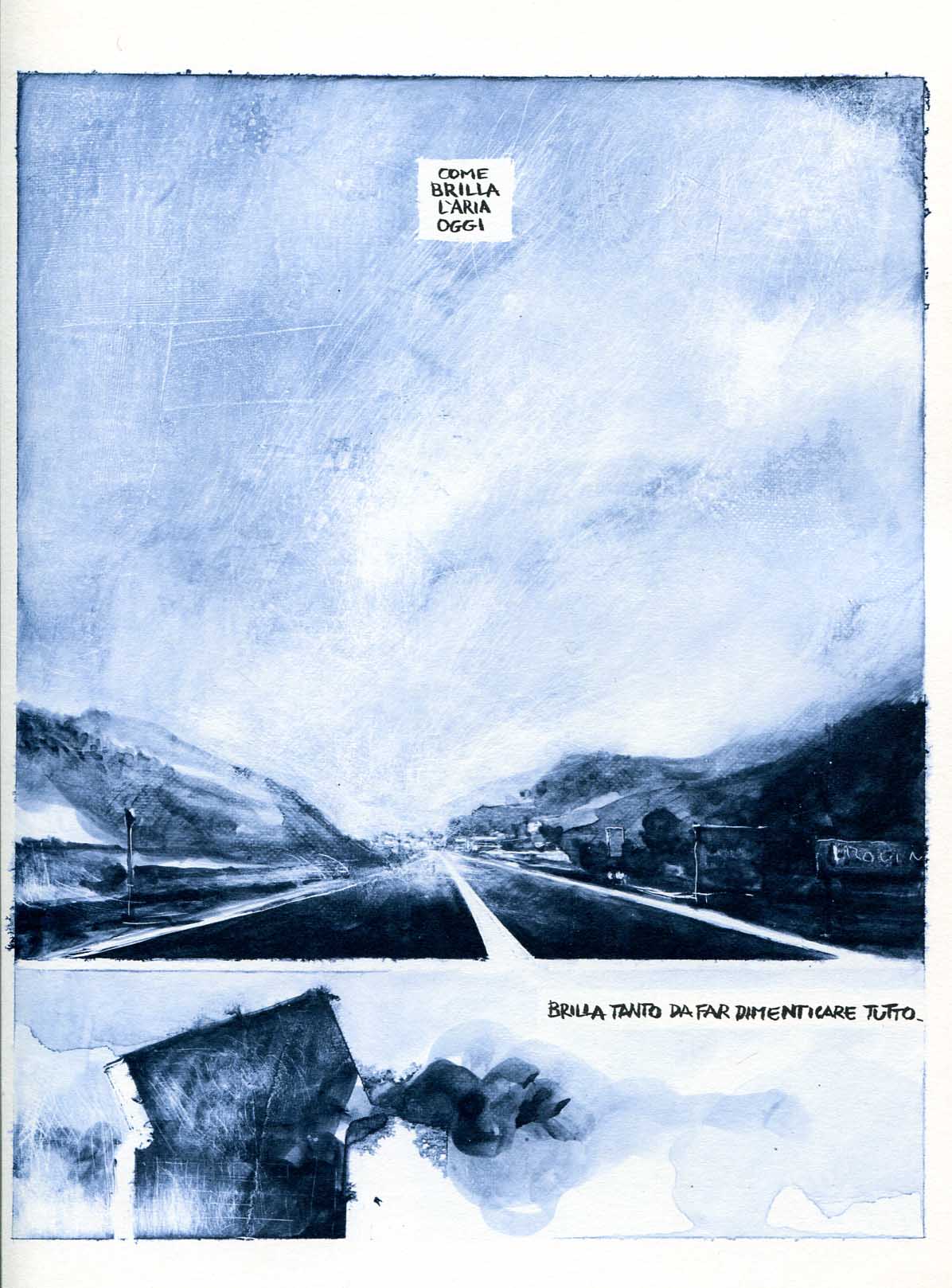

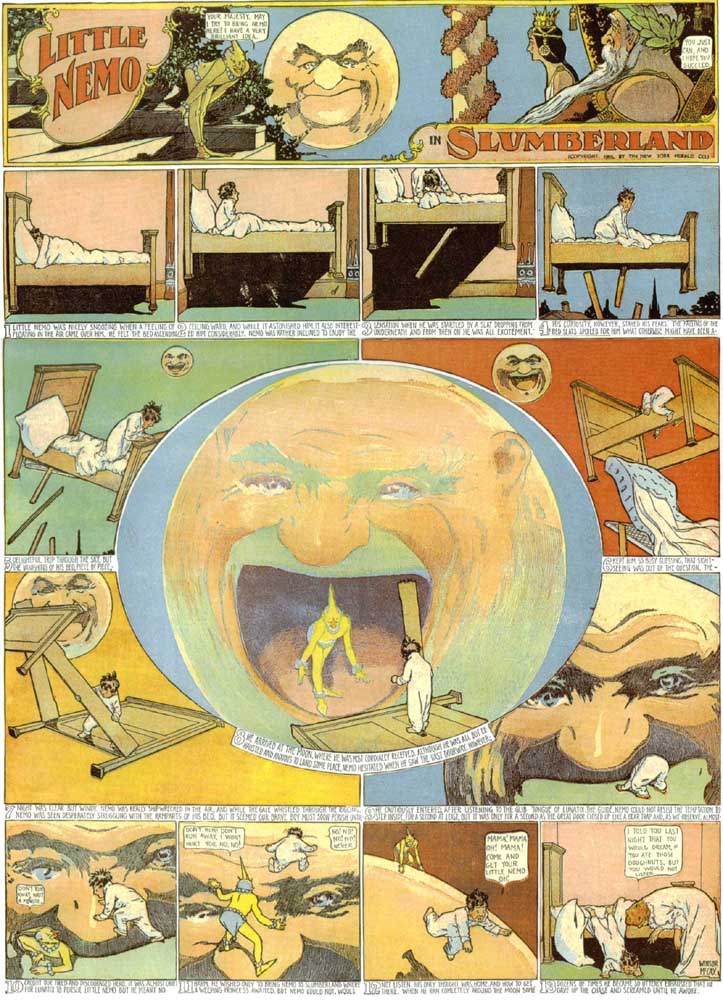
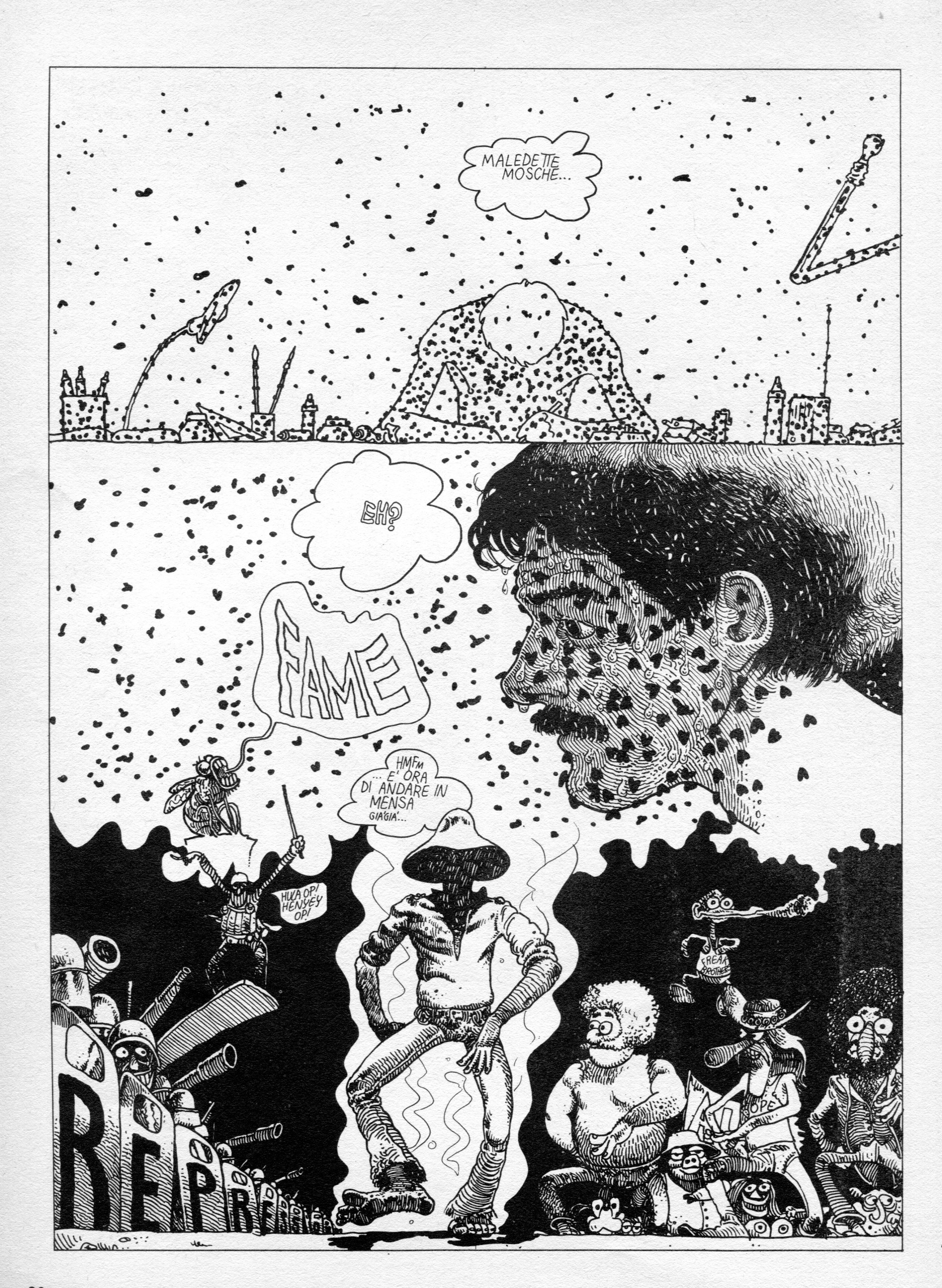




 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email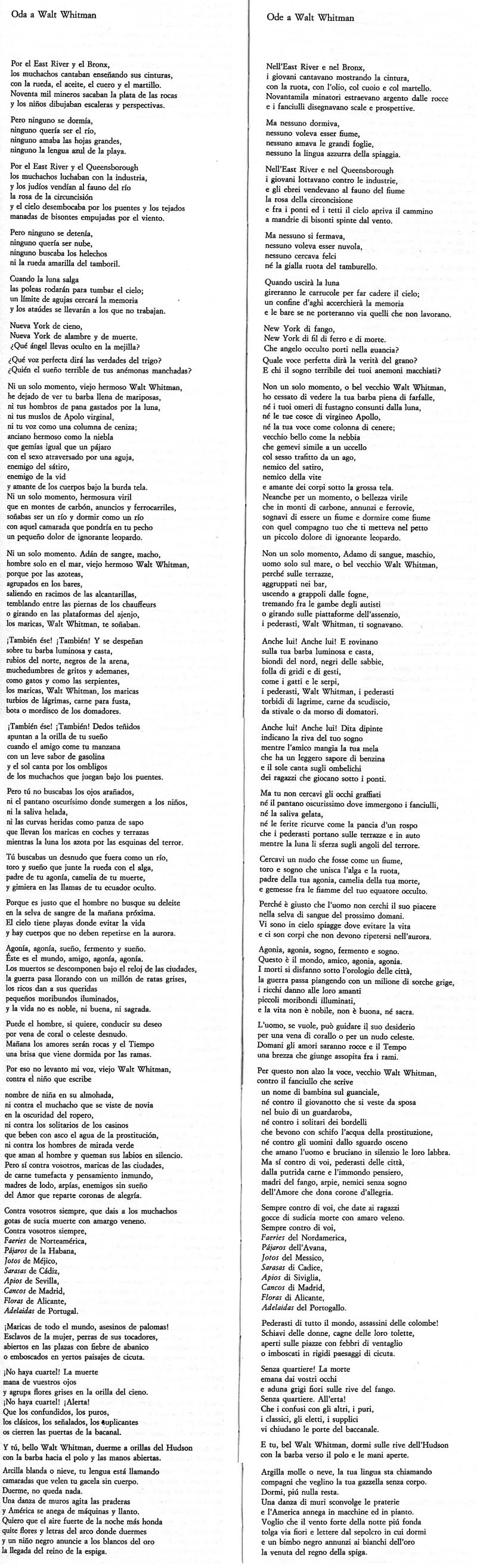
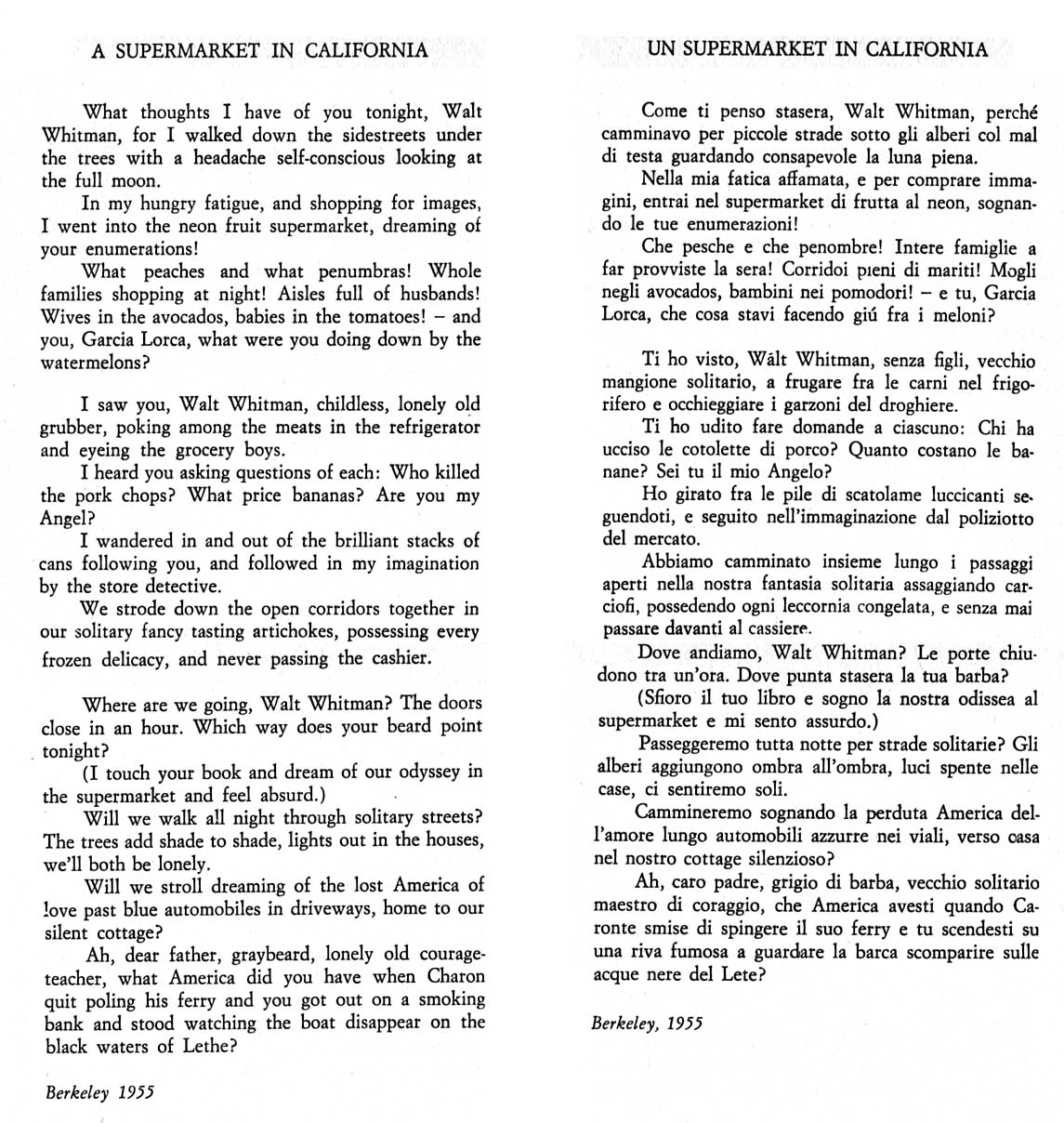

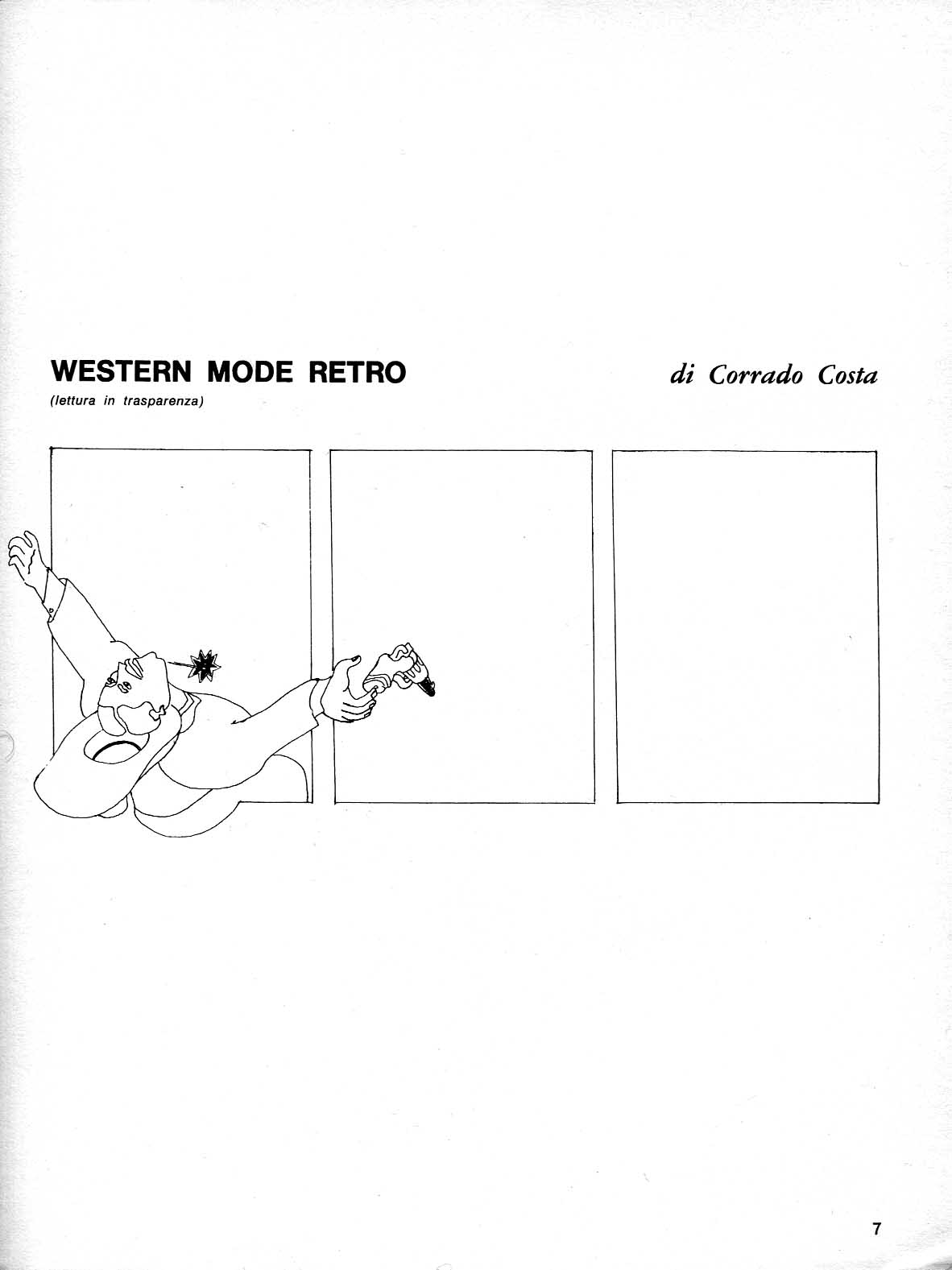
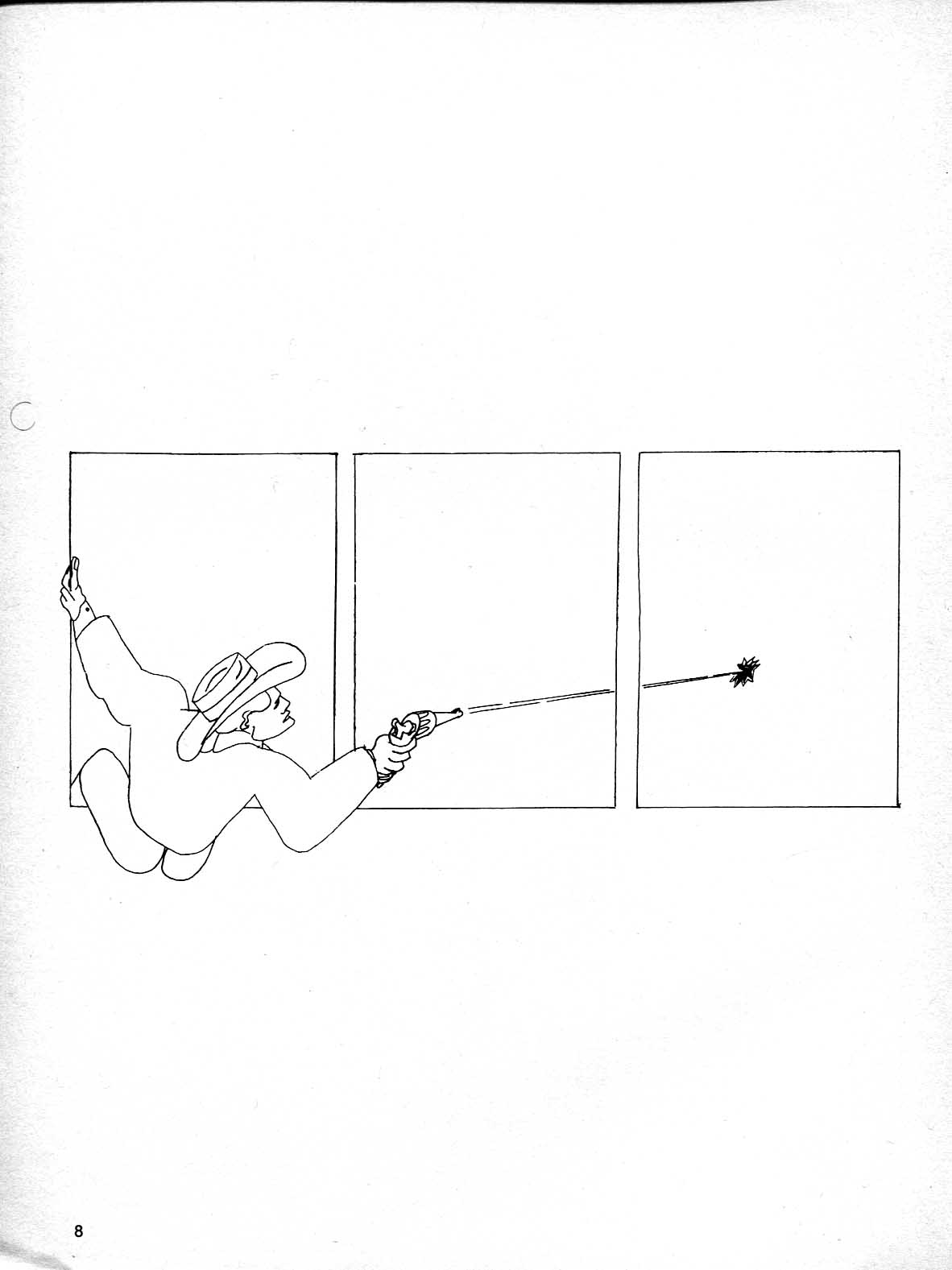
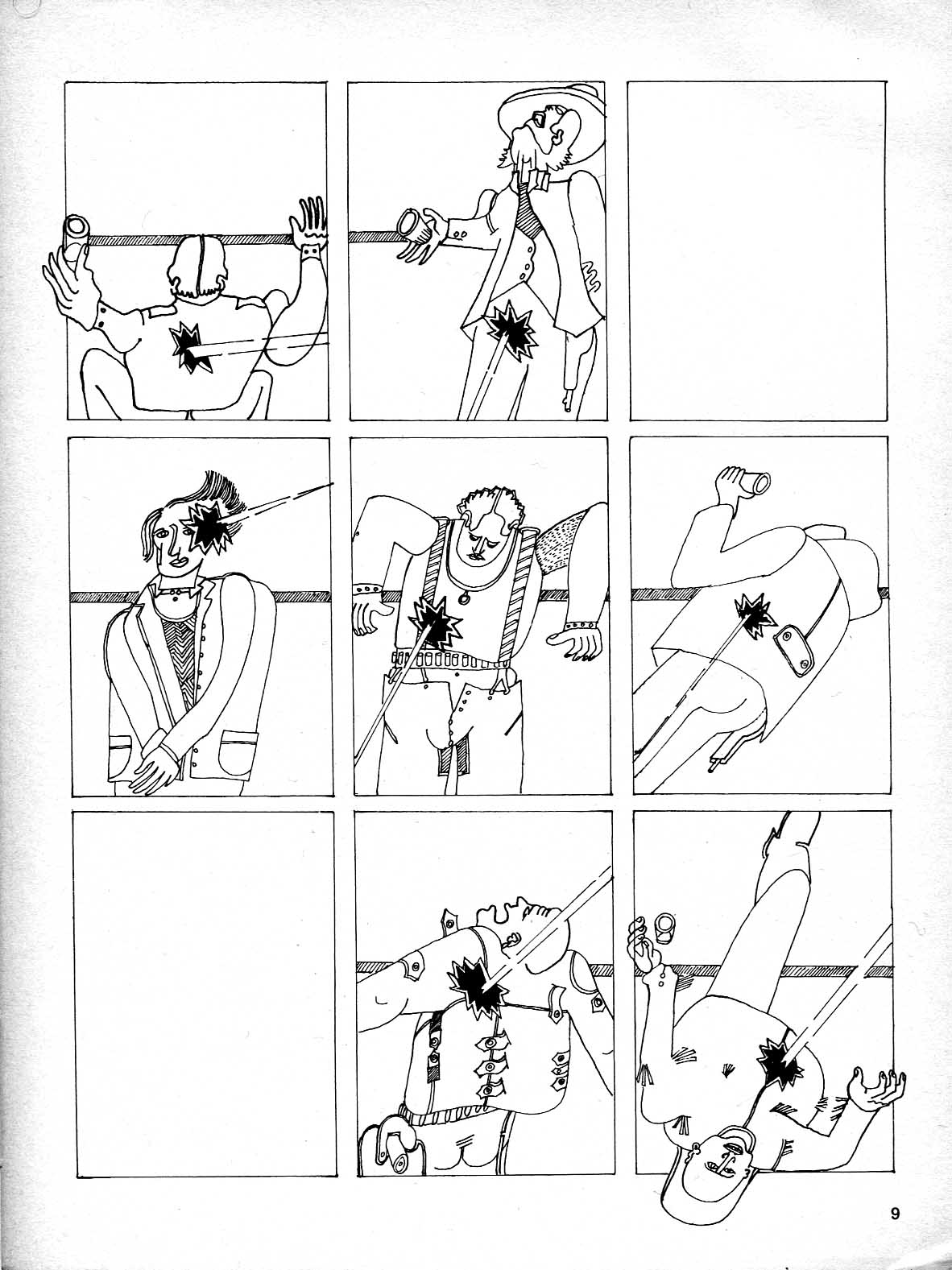
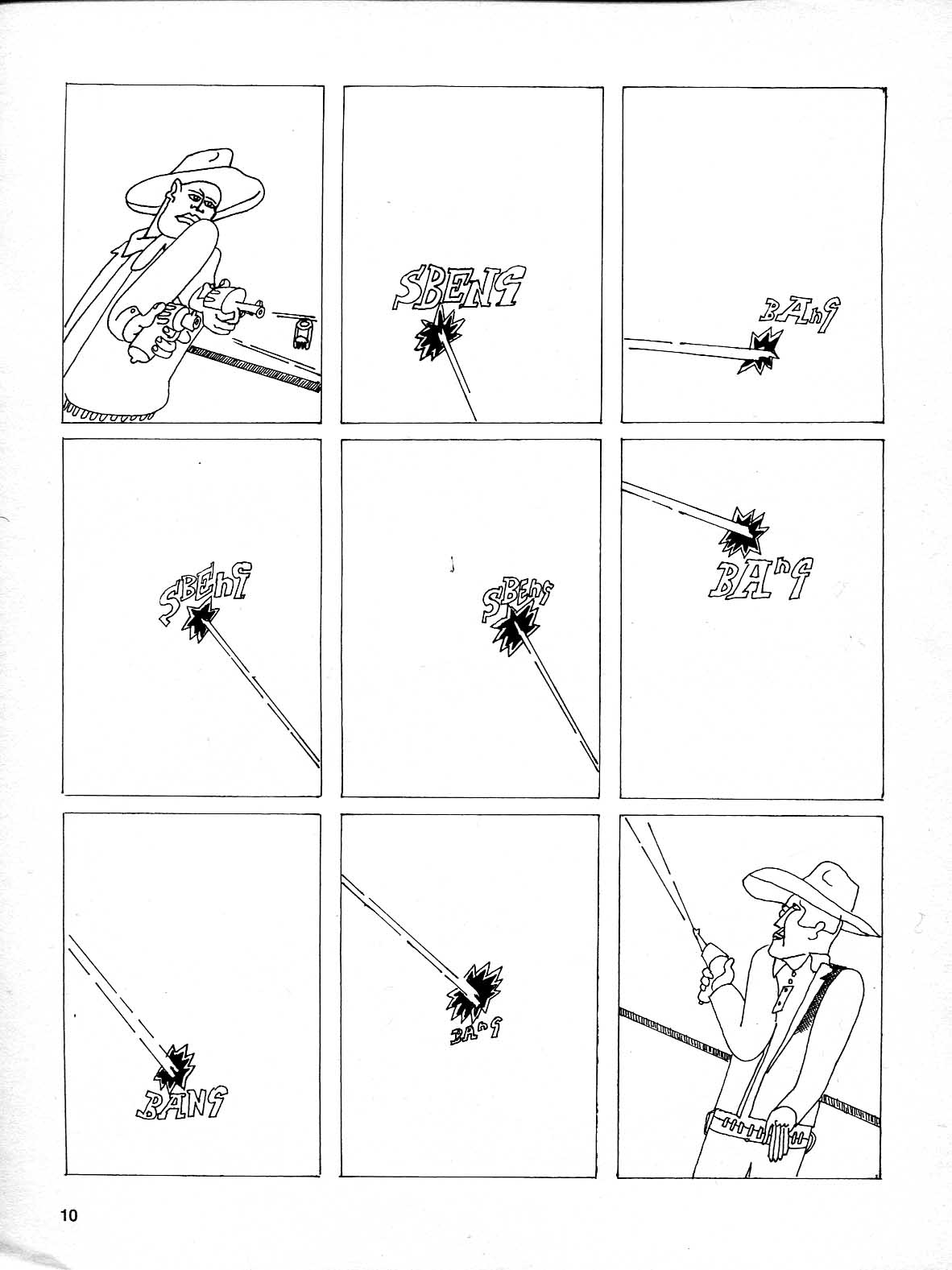
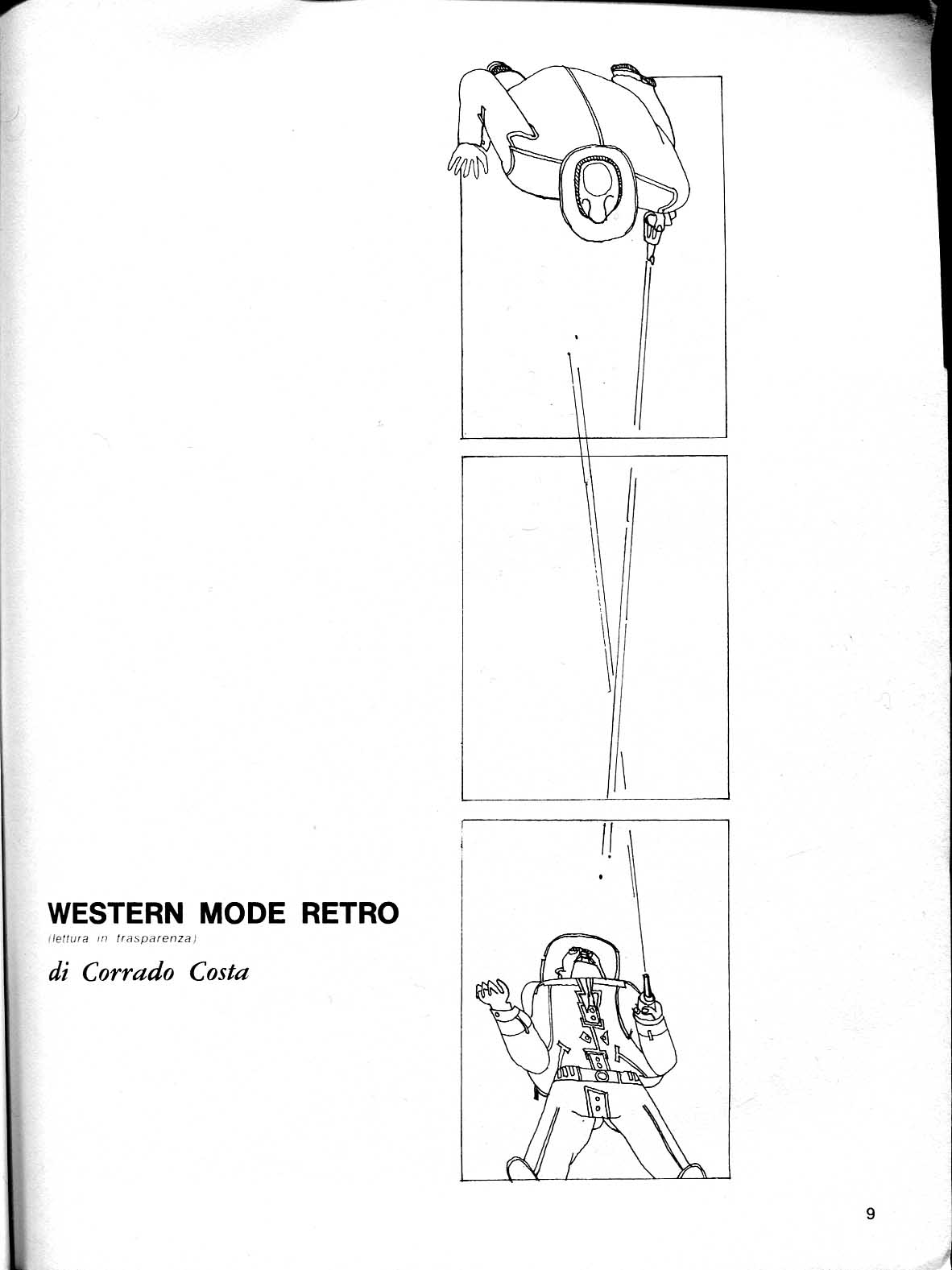
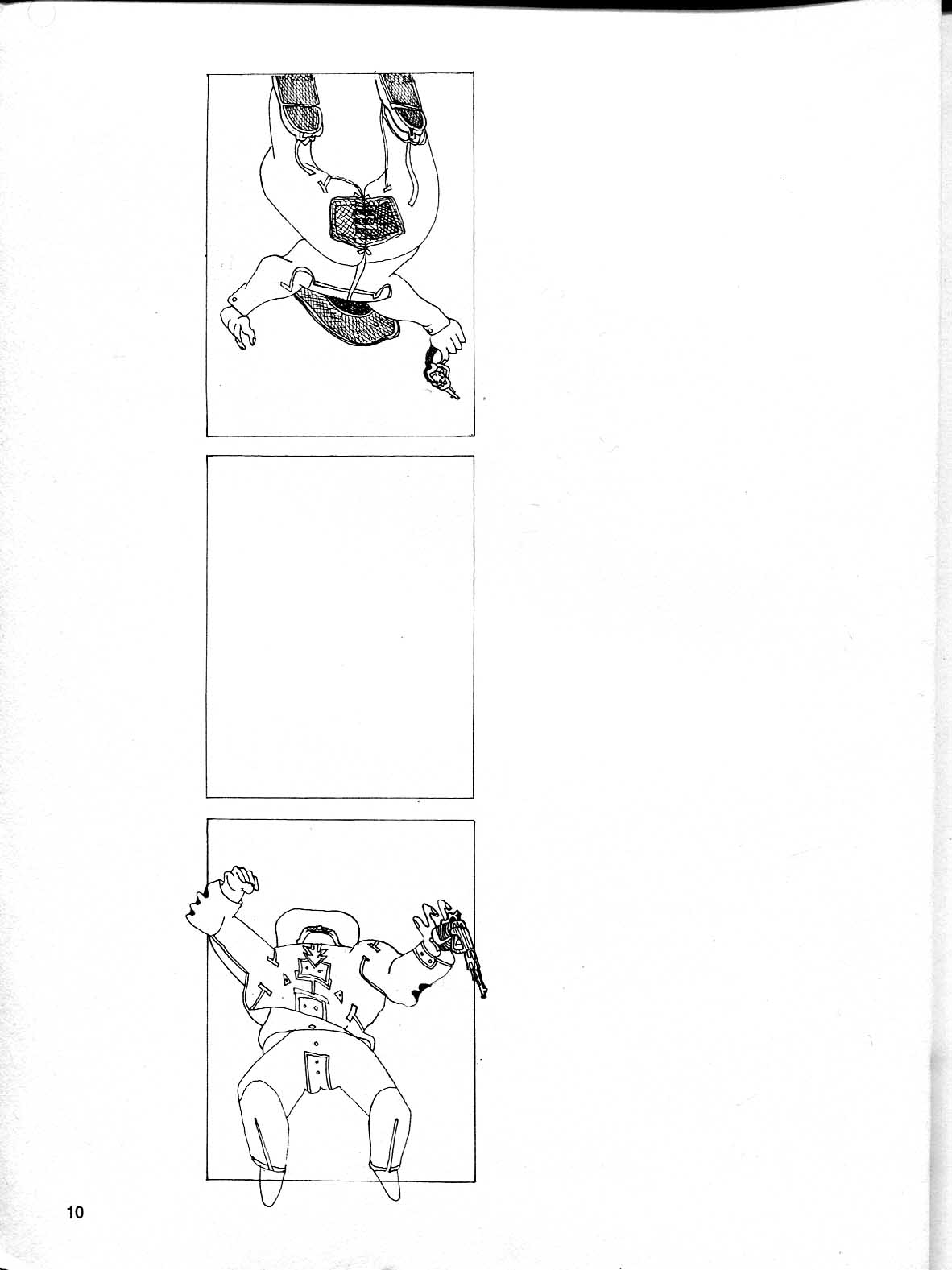
























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco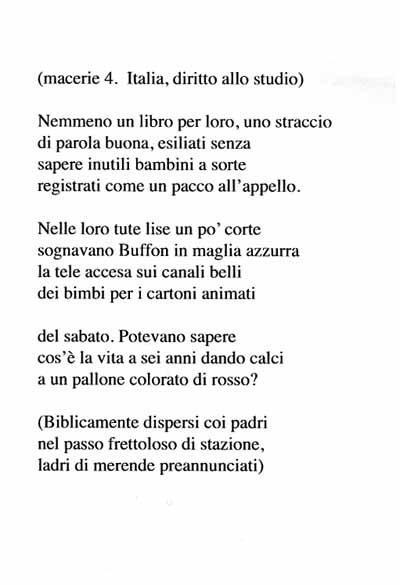






Commenti recenti