Voy a dormir
Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas: bájala un poquito.
Déjame sola: oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvides… Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido…
Vado a dormire
Denti di fiori, cuffia di rugiada,
mani di erba, tu, mia dolce balia,
tienmi pronte le lenzuola terrose
con il piumino di muschi strappati.
Vado a dormire, balia mia, preparami.
Metti una lampada sopra il mio letto;
una costellazione; quella che vuoi;
van bene tutte: abbassala un pochino.
Lasciami sola: senti i bocci che erompono…
ti culla dall’alto un piede celeste
e un uccello ti accenna qualche nota
perché dimentichi… Grazie. Ah, un incarico:
se lui chiama di nuovo per telefono
digli che non insista, sono uscita…
.
Non sono di certo, io, uno di coloro che pensano che si debba saper tutto della vita di un autore, per capire o per apprezzare la sua opera. Certo, una qualche idea di dove sia stato scritto/disegnato/composto un certo lavoro la devo avere, e tanto più questa idea è precisa meglio è. Ma si tratta di una competenza, diciamo così, sociologica o antropologica, non certo psicologica.
Insomma, mi serve capire il contesto di produzione e ricezione di un’opera, ma non mi interessano le motivazioni psicologiche che hanno spinto l’autore: se un lavoro è buono, è perché trasmette qualcosa a coloro cui è destinato; è perché esprime in qualche modo uno spirito del tempo (e ce ne sono sempre tanti, ma non infiniti). Che l’autore stesse davvero raccontando le proprie turbe, o che si stesse inventando tutto, poco m’importa: l’io letterario (poetico o narrativo – in romanzi, fumetti, film…) è una costruzione testuale, e fa parte del gioco. La letteratura ha valore perché ci muove ci insegna ci turba ci spiega; non perché testimonia gli stati del suo autore.
Certo, testimoniare gli stati del suo autore può essere un buon modo per arrivare a muoverci insegnarci turbarci spiegarci, ma è un modo che ottiene buoni risultati quanto un altro, e solo il Romanticismo gli ha attribuito particolari privilegi.
Per questo sono molto colpito dal fatto che non riesco a smettere di rileggere questo sonetto di Alfonsina Storni (1892-1938), né a separarlo dall’idea del suo suicidio, avvenuto di fatto, per annegamento nel Mar del Plata, due giorni dopo aver spedito questi versi al giornale su cui pubblicava.
La poesia è molto bella (e spero, in questo mio tentativo di traduzione, che lo sia anche in italiano), ma quello che colpisce (me come tutti, credo) è quel dettaglio alla fine: quando il percorso di trasformazione sembra compiuto, è come se lei si risvegliasse per un attimo, ricordandosi di un lui, importante abbastanza per ricordarsene, non abbastanza per dirgli la verità. Un dettaglio di solitudine: tutta l’armonia trovata con la natura serve solo ad accettare con meno dolore la solitudine che emerge in questi ultimi versi.
Senza contare l’understatement dell’ultimissima clausola: “sono uscita”. All’apparenza una comunicazione banale, quello che si fa dire al telefono, o che si dice comunque tutti i giorni. Salvo che qui questa significazione banale ne nasconde un’altra, quella drammatica, dove “sono uscita” sta per “sono uscita di scena”, cioè non ci sono più.
Qualità dell’opera o meno, il collegamento con il suicidio della Storni è senz’altro la ragione principale della notorietà di questa poesia. C’è anche una canzone molto nota in ambiente latinoamericano, Alfonsina y el mar, dedicata all’episodio e a questi stessi versi.
Le morti drammatiche ci colpiscono sempre. E questo succede perché appartengono tematicamente all’universo stesso della letteratura. Una morte drammatica rende una vita degna di essere raccontata (per fortuna non è l’unica cosa che lo fa), e avvicina la realtà al mondo della fiction, che è un mondo di princìpi morali e di mitologie. Il suicidio della Storni proietta lei, per noi (certo non per lei stessa), nel medesimo mondo a cui appartiene la sua poesia. Ed è per questo che, a dispetto delle nostre opinioni in materia, non riusciamo a distinguere del tutto i suoi versi e la sua vita; tuttavia, paradossalmente, non sono interessanti i suoi versi perché testimoniano la sua vita, ma è la sua vita che è interessante perché testimonia i suoi versi.
Per i miei amici che amano i fumetti, se sapete (e chi non lo sa?) come è morto Andrea Pazienza, riuscite mai a leggere Pompeo senza proiettarvi quello che sarebbe successo di lì a poco?
30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.
L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!
Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.
E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.
Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.
Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.
Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.
Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…
I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.
Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).
E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.
(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)
 Herb Lubalin, Mother & child, 1966 Sto dando, in questi giorni, gli ultimi ritocchi al mio prossimo libro, che si chiamerà, guarda caso (salvo sempre possibili ripensamenti), Guardare e leggere. Principi di comunicazione visiva (lo pubblicherà Carocci intorno a gennaio). L’argomento ve lo lascio ipotizzare. Ci saranno al suo interno anche alcune pagine dedicate al rapporto tra poesia e comunicazione visiva; e proprio rispetto a questo tema, mi è caduta l’attenzione su un libretto curato da Arrigo Lora-Totino dal titolo (e sul tema) Poesia concreta (Editoriale Sometti, Mantova 2002).
 Eugen Gomringer, Silencio, 1954 Ci si può fare un’idea (se già non l’avete) di che cosa la poesia concreta sia, dalle immagini che accompagnano questo post. Ho scelto quelle che a me sembrano più interessanti, ma ce ne sono anche altre nel volume che varrebbe la pena di vedere. Il punto non è se questa forma d’arte, o meglio di comunicazione visiva, sia degna di interesse o meno: come in tutti i campi, ci sono lavori più riusciti e altri meno. Quello che mi colpisce, semmai, è il suo autodefinirsi poesia, seppur concreta. Imparo, da una nota del curatore, che il volumetto riprende, con esempi nuovi, una pubblicazione addirittura del 1964. Gli esempi sono nuovi, ma i testi utilizzati come introduzione sono gli stessi di allora. Quando ho aperto il libro, infatti, prima di incontrare la nota di Lora-Totino, ho fatto un salto nel leggere il nome dell’autore del primo testo introduttivo: Max Bense, che a me risultava scomparso da almeno vent’anni.
 Adriano Spatola, collage, 1980 Bense è stato il teorico di un’estetica matematizzata, basata sulla teoria dell’informazione e sulle frequenze, ed è stato autore lui stesso di testi di poesia concreta. Questa aria da anni Sessanta corre per tutto il volume, anche quando gli esempi riportati sono più recenti. E c’è anche, nell’aria, una strana confusione (essa stessa molto anni Sessanta) tra comunicazione artistica e comunicazione pubblicitaria: sembra quasi che da un lato la comunicazione funzionale (di cui quella pubblicitaria è un sottoinsieme) costituisca davvero l’ultima frontiera, a cui anche l’arte deve tendere; ma, dall’altro, questa medesima comunicazione funzionale appare anche un po’ come il male, altrimenti questi autori farebbero i grafici, e non i poeti.
 Ladislav Novak, Gloria, 1959 Io credo che la poesia concreta sia declinata e oggi sostanzialmente scomparsa proprio perché non ha saputo superare questa ambiguità. Quando un testo visivo, come quelli esemplificati qui, viene usato per un manifesto, un logo, o un qualsiasi altro tipo di comunicazione funzionale, è il contesto stesso a completare il gioco, ad arrotondare il senso, a riempire i vuoti di significato. Mostrati così, invece, avulsi da qualsiasi contesto, spesso questi oggetti ci lasciano perplessi: magari ne apprezziamo il gioco testuale-tipo-grafico, ma è come se mancasse il perché, il senso di fondo.
 Franz Mon, rotor, 1963 Paradossalmente, l’esempio di gran lunga più bello riportato nel volume di Lora-Totino è quello che ho messo qui in apertura, di Herb Lubalin. È curioso che nelle note biografiche in fondo al volume, il curatore ammetta di non sapere nulla di Lubalin, e di avere trovato questo esempio in una precedente antologia, realizzata da altri. Il fatto è che non si tratta affatto di una poesia concreta, bensì di un marchio, e Lubalin non è stato un poeta concreto, bensì un grafico, americano, uno dei maggiori dello scorso secolo. Lora-Totino si salva in corner, è vero, commentando “e poi, che differenza c’è tra un buon logotipo e un poema visuale?”.
 Pedro Xisto, Epithalamium, 1969 Secondo me, la differenza c’è, ma non è di carattere estetico, bensì etico. Il logotipo realizzato da Lubalin è bellissimo, ma non è un discorso autonomo come le poesie concrete pretendono di essere; nel suo uso di fatto, è semplicemente parte – anche se parte importante – del discorso della rivista di cui costituisce la testata. Il nostro giudizio etico riguarderà il discorso complessivo, cioè quello compiuto dalla rivista. Valutare autonomamente, come opera d’arte, il lavoro di Lubalin, non è solo sbagliato: piuttosto, è un esplicito falso. E le cose stanno così anche se il discorso di Lubalin mi appare molto più complesso, ricco e interessante di tutti gli altri riportati qui.
Forse questi oggetti si chiamano poesia concreta perché la parola poesia deve attribuire loro una qualche aura di nobiltà artistica, e anche perché in questo modo è possibile rivendicarne l’autonomia in quanto discorsi. Purtroppo, con poche eccezioni, si tratta di discorsi molto poveri.
Questi succhi
.
Questi succhi
del paradiso che urla ancora
nutrono un’intera ciurma e anche
il più decrepito, pozzanghera della
propria valle, si farà giustizia
nessuno declina
l’invito
sono nati
per tutto l’inverno, con una bocca
in guerra e una bocca perfetta, vicinissime
al pane
e
nei pazzi giungerà l’universo,
quel silenzio frontale dove erano
già stati.
(Milo De Angelis, da Millimetri, 1983)
.
A proposito di cose che la poesia cerca di esprimere anche se le parole non le possono dire, ecco una poesia di Milo De Angelis. Il suo nome è sconosciuto ai più, perché la poesia stessa lo è; ma De Angelis è forse il maggiore poeta italiano vivente, molto, molto meglio di una Merini che ha dovuto la sua fama probabilmente più a una follia giocata mediaticamente molto bene, che non alla sua reale originalità poetica.
Non è una lettura facile. Se ci limitiamo a leggere la sequenza delle parole come se fosse un normale discorso, non capiamo nulla, e troviamo solo una sequenza di immagini senza connessione tra loro. Possiamo azzardarci a un’interpretazione metaforica o allegorica, e allora, faticosamente, qualcosa tireremo fuori – perché qualcosa, in questo modo, si tira fuori da tutto, anche dalle poesie fatte come proponeva Tristan Tzara, estraendo parole a caso da un sacco – ma sarà qualcosa che potrebbe benissimo essere anche qualcos’altro, e dunque, nonostante lo sforzo, di scarsa attendibilità. Insomma, se cercheremo qualcosa di unitario che questa poesia dica, un centro del suo discorso verbale, qualcosa a cui riassumerla, non troveremo nulla: continueremo a percepire tanti frammenti che dicono ciascuno per conto proprio, ma il testo nel suo insieme, quello proprio non si capisce cosa stia dicendo!
Nonostante questo, si tratta di una poesia molto bella, e che a dispetto del suo discorso incomprensibile mi turba. Se anche non dice esplicitamente, evidentemente questa poesia qualcosa esprime, altrimenti non sarei turbato, ma semplicemente annoiato o disinteressato.
Togliamo quindi di mezzo l’idea che la poesia nel suo insieme ci debba trasmettere un messaggio, ci debba dire qualcosa, e proviamo a pensare all’esperienza di leggerla come a un viaggio. Da un viaggio non ci aspettiamo un discorso compiuto, bensì un percorso attraverso realtà singolari e interessanti, magari ciascuna con il proprio discorso (ma spesso nemmeno), che producano in noi una trasformazione e un arricchimento. Viaggiare vuol dire costringerci a un rapporto con l’ignoto, che richiede un continuo nostro lavoro di comprensione, e questo lavoro stesso ci trasforma: nel comprendere, infatti, ci siamo già trasformati, e questo ci permette di comprendere meglio e di più quello che vediamo nel viaggio – ma ci costringe anche, una volta tornati a casa, a rivedere con occhi diversi i luoghi della quotidianità, già dati per scontati.
Se concepisco il testo come un territorio, un ambiente, e la lettura come un viaggio, forse posso cavar fuori qualcosa di più dalle parole di De Angelis. Posso accorgermi, per esempio, di quell’aria montaliana ed ermetica che spira in un testo che non è, tuttavia, né montaliano né ermetico, perché non ha né il filosofeggiare poetico di Montale né la politezza alessandrina di Luzi e degli ermetici. Ma questo richiamo funziona lo stesso, specie nel confrontarsi con parole dure come “urla”, “ciurma”, “decrepito”.
Mi verrebbe da dire che l’operazione di De Angelis ricorda quella di Balestrini, quando prende le parole abusate della comunicazione di massa per assemblarle in un testo poetico. Ma l’operazione di Balestrini è glaciale, lucidamente intellettuale, e palesa il disprezzo per il materiale utilizzato. De Angelis, analogamente e insieme diversamente, prende parole e frasi già usate; queste parole e frasi sono però quelle della tradizione poetica, o del discorso affettuoso, o di quello emotivo; parole consumate, ma ugualmente amate, parole che bisogna sottrarre al vaniloquio, al luogo comune, per rimetterle in gioco. Questo amore per queste parole amorose, emotive, si sente nei versi di De Angelis, li percorre continuamente.
Ed è questo che questi versi esprimono, per cui nel nostro viaggio dove riconosciamo frammenti di mondo ma non siamo in grado di dargli un senso complessivo, percepiamo comunque costantemente questa affettività, ora tenera e ora violenta. È ovvio che non ci sono solo pezzi di Montale e di Luzi in questi versi, ma c’è tutto quello che siamo in grado di sentirci. Il fatto è che ogni verso è pieno di echi, anche nel ritmo, e nel modo in cui è tagliato e va a capo, o in cui lascia il discorso per un attimo sospeso.
Non chiediamo a un brano di musica di dirci qualcosa di preciso, di essere un discorso compiuto. Quello che chiediamo alla musica è di farci fare un viaggio, dove luoghi significativi diversi si giustappongono, e alla fine il nostro umore, il nostro stato emotivo dipende dal percorso su cui siamo stati trasportati. Perché dovremmo chiedere alla poesia qualcosa di diverso? Perché siamo abituati diversamente, forse, e quindi ci appare più facile. Sicuramente ascoltiamo molta più musica di quanta poesia leggiamo, per non parlare della musica che udiamo soltanto, senza ascoltarla. La musica sembra dirci di più di quanto ci dica questa poesia di De Angelis. Magari è solo questione di competenza precedente, di saper riconoscere i temi, le allusioni, i passaggi.
Alla fine, comunque, dopo tutto il percorso del viaggio, se lo abbiamo effettuato con attenzione, e magari ripetuto, e ripetuto ancora, sembra quasi che un discorso emerga davvero dalle parole di De Angelis, proprio come quando ripensiamo a un viaggio vero, compiuto qualche tempo fa. Ogni luogo ha una sua personalità, come ogni musica; ce l’ha senza la chiarezza del dire – anche se faticosamente possiamo poi provare a descriverlo; ce l’ha come ce l’ha un profumo, o il suono del clarinetto (tanto per citare Wittgenstein).
Per fortuna, non tutto è dicibile. Ma ci sono altri modi per esprimerlo.
(Se tuttavia mi si concede una piccola nota polemica, è davvero necessaria questa difficoltà per ottenere questa qualità? Anche in un viaggio, la difficoltà non è in sé indice di qualità, è solo il prezzo che ci ritroviamo a dover pagare. A pari qualità – che è ciò che conta – vale davvero la pena di pagare un prezzo più alto?)
Prima dell’invenzione o dell’adozione della scrittura la prosa non esisteva. C’era solo la poesia. La poesia era un modo per organizzare le parole in modo da favorire la memorizzazione, attraverso le ricorrenze metriche, sintattiche e semantiche. Associato alla natura metrica di questo strumento di memorizzazione, c’era il racconto, un altro potente strumento per aiutare la memoria. E naturalmente la poesia era cantata, così che la melodia sostenesse ulteriormente la memoria: ancora oggi i testi delle canzoni si ricordano più facilmente di quelli delle poesie, per non dire della prosa.
Jesper Svenbro (Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991) ci ricorda che nell’antica Atene persino le leggi venivano cantate, e non mi stupirebbe scoprire che non avevano la forma imperativa che assumono dalla romanità in poi, ma erano magari una sorta di racconti esemplari. In fondo gli stessi poemi omerici non erano soltanto i canti delle gesta degli eroi, ma anche un grande catalogo della conoscenza pratica e sociale dei greci.
Con la scrittura il potere mnemonico del verso diventa meno rilevante, e persino presso i Greci nasce la prosa. La poesia non scompare, però, inevitabilmente, ridefinisce (e riduce) il suo campo – come sempre succede quando viene messo in gioco un medium nuovo. Il legame stretto con la musica (almeno in Europa) si rompe solo nel XIII secolo, non del tutto disgiuntamente dal fatto che da non più di un paio di secoli si stava diffondendo l’abitudine di leggere la scrittura senza articolare la voce, cioè solo con gli occhi. Da quel momento, la poesia diventa (in Europa) un fenomeno colto, sdegnosamente separato da forme popolari analoghe che ancora mantengono il legame con la musica – o, al massimo, cautamente ricongiunto in certi momenti con forme particolari di musica colta, come il madrigale.
Sino ai primi dell’Ottocento il verso viene ancora utilizzato per diversi generi, tra cui teatro e poema (epico, didascalico, eroicomico…). Poi, il Romanticismo pone termine alla loro agonia, sancendo la coincidenza tra l’universo della poesia e quello di uno solo dei suoi generi, la lirica. Ancora nel corso del secolo, nelle scuole italiane si insegnava a scrivere componimenti in versi, di argomento vario. Oggi la cosa ci fa sorridere: ci sembra l’insegnamento di una competenza inutile (a chi interessa saper scrivere in versi una relazione di lavoro?), o che manca il bersaglio (ovvero la capacità di colpire nel segno, esprimendo gli affetti, che è tipica della buona poesia come la intendiamo noi). Il Novecento fa piazza pulita di tutti questi residui.
La rivoluzione della metrica che impazza soprattutto tra Francia e Italia a cavallo dei due secoli (anche se i primi versi liberi sono tedeschi e inglesi, e il loro profeta, Walt Whitman, è americano) sancisce definitivamente il modo nuovo di intendere la poesia; e nel momento in cui la poesia coincide con la lirica, inizia ad avere senso parlare anche di poesia in prosa, come quella delle Illuminations di Rimbaud o dei Canti Orfici di Campana. Ha senso perché quando si dice poesia si intende ormai lirica, e dunque l’espressione poesia in prosa va intesa come lirica in prosa, e non come composizione in versi senza versi.
La coincidenza tra il significato del termine poesia e quello del termine lirica è ormai per noi così forte, che ci sentiamo imbarazzati a definire poesia, per esempio, un indovinello, che pure è in versi; mentre non abbiamo problemi a definire poetico un racconto o un film, dove di versi non ce n’è nemmeno l’ombra.
Potremmo dire che la lirica è l’ultima linea di resistenza della poesia, in un mondo sempre più dominato dalla scrittura e dalla sua razionalità. E la poesia si è rifugiata nella lirica perché l’intimità personale è forse l’ultimo ambito rimasto che reputiamo inattaccabile dalla razionalità scientifica. In altre parole, una scrittura che vada al punto, che voglia essere razionale e precisa nelle sue descrizioni, non ha bisogno del verso, il quale è piuttosto espressione di una scrittura che non si separa dagli echi del significato; e il significato cresce nel tempo per accumulazione, senza liberarsi mai del tutto dai suoi strati precedenti.
In questo senso, la scrittura poetica è più vera, perché testimonia continuamente il processo che ci porta a essere quello che siamo. Non è una verità come quella della scienza, in termini di adaequatio rei et intellecti, di cartesiana chiarezza e distinzione, perché quest’ultima presuppone che vi siano già degli scopi cognitivi ben chiari; privilegiare il processo rispetto allo scopo significa al contrario accettare che pure gli scopi possano essere incerti.
“Superare la lirica” sembra essere il motivo diffuso tra molti poeti e critici del momento. E tuttavia è singolare che un’antologia, come quella di Enrico Testa, che porta il titolo emblematico di Dopo la lirica (Einaudi 2005) sia per metà fatta di poeti come Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Volponi, Erba, Orelli, Giudici, Ripellino… Posso forse trovare un senso al dichiarare antilirici poeti come Pagliarani e Sanguineti. Ma di nuovo mi ritrovo imbarazzato nel ritrovare arruolati dopo la lirica la Rosselli, Raboni, Loi, Baldini, Bellezza, persino la Merini.
Senza proseguire l’elenco, alla fine la sensazione che rimane è che l’antiliricità di cui si parla non sia che un obiettivo di facciata, e, in fin dei conti, semplicemente un modo per affermare che i poeti presenti nella raccolta sono bravi. Si suggerisce, in fin dei conti, che la generalizzazione (innegabile) del lirismo nei media abbia resa applicabile l’equazione lirismo oggi = paccottiglia, e che, di conseguenza, se una poesia è buona allora non è lirica. In poche parole, siccome molto lirismo è paccottiglia allora tutto il lirismo è paccottiglia, e poiché questi poeti non scrivono paccottiglia allora questi poeti non sono lirici!
Non credo che su questa strada si possa andare molto in là. Non mi pare nemmeno che il problema sia la lirica. Semmai lo è quella parodia della lirica che argutamente Sanguineti definì il poetese. Ma condannare la lirica nel suo insieme in nome della cattiva lirica mi pare una vera operazione demagogica, non dissimile da quella dei leghisti che sostengono che tutti gli immigrati sono criminali (visto che qualcuno, indubitabilmente, lo è).
“Riduzione dell’io” è un’altra vecchia parola d’ordine, collegata (ma non equivalente) al superamento della lirica. Era la parola d’ordine dei Novissimi, quella che permetteva di contrapporre l’intellettualismo storicista di Sanguineti al crepuscolarismo intimista di Pasolini (a dispetto del suo impegno politico). Tuttavia, in fin dei conti, tra gli stessi Novissimi, gli unici che davvero l’abbiano messa in opera sono stati Pagliarani e Balestrini. Sanguineti ha sempre giocato a cavallo tra io e non-io. Giuliani e Porta sono rimasti – vittoriosamente, specie Porta – di qua.
A questo punto viene da domandarmi se davvero vi sia contrapposizione tra lirica e poesia civile, tra lirica e correlativo oggettivo o tra lirica e poesia che mette in primo piano le cose. Questo soggetto che sembra venire sbattuto fuori dalla porta nelle poesie (appunto) di Porta, non rientra forse dalla finestra? E se non ci ritrovassimo le nostre personali vite e il nostro personale rapporto con il mondo e con le cose, davvero apprezzeremmo Pagliarani e Balestrini e le cose in primo piano messe da Porta?
E allora l’opposizione alla lirica cos’è? Forse nascondere il soggetto, l’io, dietro l’angolo, far finta che non ci sia?
Ho assistito qualche giorno fa (il 17 giugno, a S. Lazzaro di Savena) a una presentazione del volume collettivo Prosa in prosa (Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Andrea Raos, Michele Zaffarano; Fuori Formato, Le Lettere 2009). Certo, sin dal titolo dell’antologia si gioca sull’assenza della poesia; ma è un’assenza molto presente: non si parla di prosa, nell’uso corrente, se non per contrapposizione alla poesia (altrimenti, e di solito, si parla di romanzo, di critica, di diario, di giurisprudenza, di manualistica o di qualsiasi altro specifico genere). Prosa in prosa, come titolo, vuole andare un passo più in là di poesia in prosa, che verrebbe inesorabilmente letto come lirica in prosa. Il secondo prosa del titolo afferma l’assenza dei versi, mentre il primo afferma l’assenza della lirica.
Eppure – sarà per deformazione mia – quando trovo interessanti gli elenchi di azioni e/o oggetti che costituiscono i microtesti di questa antologia, è perché ci riconosco un’io nascosto, in azione e in espressione. Insomma, nella misura in cui quei testi mi colpiscono è perché ci ritrovo semplicemente della lirica in prosa, in una linea che arriva da Pagliarani e Porta.
Alla fine dei conti, la mia sensazione è che quando si esce davvero dal campo della lirica (quella buona, non la paccottiglia) si sia comunque già fuori dal campo della poesia – mentre il converso non è vero, perché la lirica comprende ormai anche frange di prosa e di cinema e di fumetto e di altri mondi ancora. Le sperimentazioni (che sono doverose) producono spesso oggetti complessi, ma non siamo capaci di definirli poesia (che esse abbiano i versi o meno) se non possiamo ricondurle in qualche modo a quel modello, quello della lirica (magari con l’io nascosto e le cose in primo piano). Persino quel poco di epica che si è prodotta in decenni recenti (a cui La ragazza Carla, e La ballata di Rudy appartengono) è un’epica comunque lirica: magari se si togliesse loro il verso e li si riducesse a prosa parte di questo lirismo se ne andrebbe – ma non a caso Pagliarani ha scritto in versi, e non in prosa.
Il problema dunque, io credo, non è né ridurre l’io né superare la lirica. Il problema è semmai quello di fare una lirica che non sia paccottiglia, in cui l’io esprima un rapporto con le cose e con gli altri in cui ci si possa riconoscere, in cui sia presente il mondo e siano presenti le sue emozioni e ci sia una verità – non l’impressione del già detto, del rifritto, del costruito a tavolino per vendere, del falso-romantico con la sua strabordanza dell’io! Anche l’avanguardia ha prodotto la sua paccottiglia, e ha le sue dinamiche di successo. Ma l’avanguardia è finita. Dopo la lirica c’è soltanto la lirica, quella buona – almeno sino a quando non scomparirà pure questa ultima forma di poesia.
24 Giugno 2010 | Tags: Alberto Salinas, Carlos Gomez, comunicazione visiva, Dago, estetica, fumetto, ritmo, rito, Robin Wood | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto |  Carlos Gomez, Dago Riprendo questo tema che ha lanciato Harry qui, e l’ha poi ripreso qui, dopo un mio commento in cui gli chiedevo di spiegarmi perché anch’io leggo così volentieri Dago. Intendiamoci, si parla delle storie contenute nel mensile Dago Ristampa (che contiene le ristampe delle storie già pubblicate sui settimanali della Eura/Aurea), scritte da Robin Wood e disegnate da Carlos Gomez – e non confondiamolo col mensile Dago, che pubblica storie nuove, scritte e disegnate da altri apposta per il mercato italiano, di qualità mediamente molto bassa, e di cui non varrebbe affatto la pena di parlare (e nemmeno di leggerlo, in verità). A vantaggio di chi si è perso quello che è uscito sin qui, dal 2008 è iniziata anche la ristampa della ristampa, a colori, nella Collezione Tuttocolore.
Il mistero è questo: Dago è un fumetto seriale. I disegni, prima di Alberto Salinas e in seguito di Carlos Gomez, sono di ottima qualità. Le storie, a giudicare dalla passione con cui io stesso e tanti altri le leggiamo, pure: ma i temi ormai si ripetono, e anche prima che all’interno della serie si ripetessero erano noti e stranoti, puri stereotipi di genere, strabordanti di un moralismo che in altre circostanze io troverei stucchevole, popolati di personaggi già conosciuti mille volte. Inoltre, se uno ha praticato un po’ il fumetto argentino, tutto questo appare ancora più vivido, e più ossessivamente ricalcato.
Insomma, la mia testa mi dice che, se devo giudicare da questo, Dago non è che un ennesimo prodotto seriale che non fa che ricalcare percorsi già pesantemente calcati da altre mille storie, roba buona per lettori poco esperti, o dal palato grezzo. Eppure, a dispetto di questo, mi ritrovo ogni tanto a domandarmi quando uscirà il prossimo numero; e poi, quando torno a casa dall’edicola dove ho fatto incetta di nuove uscite, la mia prima lettura è inevitabilmente Dago. Di conseguenza, o il mio palato fumettistico è davvero grezzo, oppure in quello che la mia testa mi dice c’è qualche errore o mancanza.
Harry suggerisce questo:
Ma osservando da un altro punto di vista la risposta è antropologica: Wood sa raccontare la vita nei suoi bisogni primari. Prima ancora che tecnico, è un successo basato sulla sensibilità artistica dello sceneggiatore. Wood mette a nudo le dinamiche primarie che muovono le esistenze. Il filtro della guerra in forma di dramma svela gli attaccamenti, il desiderio sessuale, il bisogno di affermazione, la crudeltà, la fame, la vendetta, la sacralità della vita, e così via. Di questo Wood sa raccontare alla perfezione. E ogni tassello, ogni ritorno, ogni variazione, offrono un’opportunità di comprensione. Il gioco funziona, insomma, per forza dell’occhio con cui Wood osserva e della sua forza evocativa. Doni rari.
Tutto questo è vero, ma in realtà non mi basta. Ci sono tanti fumetti che affrontano questi temi e non hanno certo la qualità di Dago. Però quello che Harry dice è ugualmente utile a circoscrivere meglio il problema: ovvero, dunque, come fa Wood a mettere a nudo così bene queste dinamiche primarie? In che cosa consiste la sua perfezione?
Voglio approfittare anche di un suggerimento che proviene da un altro lettore appassionato di Dago, cioè Umberto Eco, che nell’introduzione al convegno La linea inquieta, nel 2004, diceva:
Cito Dago come caso interessante perché in esso si manifestano tre fenomeni molto ben distinti: (i) la rivisitazione visiva sia della tradizione rinascimentale che della tradizione dei grandi illustratori moderni come Gustavino; (ii) la sapienza narratologica di Robin Wood nel realizzare una combinatoria infinita di vari topoi romanzeschi, da quelli picareschi a quelli neogotici e romantici; (iii) l’assoluta banalità stilistica del discorso verbale, che si attiene a una retorica da feuilleton ottocentesco, e senza alcuna ironia sottintesa. Aggiungerei che dal punto di vista sociologico è forse proprio questa strana commistione che giustifica il successo popolare della serie, ma ecco che si vede come un’analisi sociologica debba sovente essere preceduta da una valutazione critica molto rigorosa.
Anche qui non andiamo molto al di là di qualche intuizione, però trovo che sul fuoco ci sia già più carne. Intanto vi si osserva che non è che Salinas e Gomez siano semplicemente bravi disegnatori, ma che in questa bravura è presente una competenza iconologica che ci permette di collegare continuamente Dago a una serie disparata di tradizioni, da quella rinascimentale (epoca di ambientazione delle vicende) a quella otto-novecentesca degli illustratori (epoca in cui si forma la nostra competenza visiva di lettori).
La banalità stilistica del racconto verbale è quello che potremmo definire il basso continuo della serie: una specie di accompagnamento necessario, senza il quale non si comprenderebbero le vicende, ma che è il più banale e scontato possibile proprio perché non deve attirare l’attenzione: si legge e scorre via. L’accento è su altro.
E poi c’è la combinatoria infinita dei topoi romanzeschi, presi dalle tradizioni più diverse, che corrisponde, sul piano narrativo, alla competenza iconologica su quello visivo. È come dire che il lettore di Dago ritrova continuamente il già noto, però intrecciato in combinazioni non necessariamente note.
Di nuovo, tutto questo è vero, ma ancora non basta. Ci avvicina un po’ alla soluzione, ma non ce la dà.
E allora proverò a esplorare dentro di me, a capire quali sono le sensazioni che mi tengono avvinto a queste storie, senza escludere neanche le più banali.
Così, intanto, c’è l’ambientazione storica. La prima metà del Cinquecento è un periodo già di per sé affascinante (per me in particolare, anche prima di Dago): l’Europa è ricca, piena di artisti e di entusiasmo, ma è già scivolata in un’epoca di guerre feroci e di contrapposizioni religiose, che la stanno portando molto vicina al disastro. Da questo punto di vista la documentazione di Wood è davvero rigorosa; è ovvio che la storia di Dago è fantastica, però ogni tanto si incrocia con eventi e personaggi storici: ho fatto diversi controlli, ma non sono riuscito a cogliere Wood storicamente in fallo.
Poi, c’è la ricchezza dei temi: è vero che i temi si ripetono e che si rifanno sempre a un qualche modello noto, però sono tantissimi, e di conseguenza è multiforme la loro combinatoria. Non so se si possa dire che Wood è capace di sottigliezza psicologica: i personaggi appartengono tutti a casistiche abbastanza ben definite, di provenienza follettonistica. Però sono combinati così intelligentemente con la storia in cui agiscono che anche nel rispetto dello stereotipo appaiono credibili, convincenti, molto umani.
Poi c’è la questione del moralismo. Certo, in Dago il bene è bene e il male è male, però c’è anche un’ampia zona intermedia, e non è detto che il bene trionfi sempre pienamente. Lo stesso Dago, il protagonista, sempre pronto a battersi per cause giuste, porta nel cuore un desiderio sanguinoso di vendetta. Complessivamente i morti sono tantissimi sia dalla parte del bene che da quella del male. Lo potremmo definire un moralismo amaro, e pieno di comprensione per le debolezze della vita. Insomma, anche qui, qualcosa di sufficientemente complesso da non essere sentito come banale.
Infine, collegato a tutto questo, c’è la questione dell’epica. Per certi versi Dago è un romanzo cavalleresco popolare, fatto di schemi e stereotipi come già pure quelli del Pulci e dell’Ariosto, che erano i capolavori che erano anche a ragione di questi schemi e stereotipi.
In fin dei conti, la mia idea è che il piacere che Dago produce nella lettura sia una questione di ritmo, e di rito. Senza componenti rituali (di cui il ritmo è comunque la base) non si producono testi con qualità estetiche. Nella nostra cultura, alla componente rituale si deve associare una componente di originalità e di novità; ma non è sempre stato così. O meglio, la rilevanza della componente innovativa è diversa da epoca a epoca, da luogo a luogo, da genere a genere, da attività a attività. Nel rito vero e proprio, come quello religioso, la componente innovativa è nulla. Nelle produzioni estetiche, viceversa, è ciò che tiene vivo il nostro interesse, permettendoci di trovare piacere nel frattempo anche in quel ritorno del già noto che crea ritmo e rito. Così, il piacere delle produzioni estetiche ha due tipi di fonte: da un lato quello della scoperta (dovuto alla novità), dall’altro quello della conferma e sicurezza (dovuto al ritmo).
Credo che Wood (con Salinas e Gomez) abbia trovato una via inedita per riproporre quell’idea antica di racconto popolare di cui il poema cavalleresco è stata anche a suo tempo espressione, e che è il modello anche del mito: tutto quello che succede ci è in qualche modo già noto e i valori espressi sono i qualche modo i nostri; e tutto è rassicurante, ma non perché sia banalmente positivo, ma semplicemente perché rispecchia, anche nel male, l’idea che abbiamo della vita e del mondo.
Dago è una sorta di rassicurante liturgia, che si legge volentieri perché non mette in questione nulla, fondamentalmente, però ci porta alla mente tante cose diverse. È, in questo senso, una telenovela d’alto bordo, dai contenuti tutt’altro che banali. Non dobbiamo aspettarcene nessuna proposta particolarmente originale, perché Wood è sempre attento a tenersi eticamente e psicologicamente sul generico – e la distanza storica aiuta. Ma il suo gioco è comunque affascinante e confortante.
Tutto questo forse non svela del tutto il mistero di Dago, però qualche passo avanti mi sembra di averlo fatto.
21 Giugno 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, comunicazione visiva, design industriale, estetica, graphic design, narrazione per immagini, rito, sacro, sublime, William Morris | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Già molti decenni fa (ma io l’ho imparato solo in questi giorni, leggendo il suo Come interpretare un’opera d’arte, Milano Rusconi 1977) Ananda K. Coomaraswamy faceva osservare che la parola arte, tradizionalmente, nelle culture europee, non fa riferimento a oggetti o a una categoria di oggetti (le opere d’arte), bensì a un modo di operare. Per capire cosa questo voglia dire basta far caso al fatto che quest’uso della parola arte è ancora ben presente nell’italiano di oggi, quando si dice, per esempio, che qualcosa è fatto ad arte, o che qualcuno lavora con arte. Come è ovvio, pure la parola artigiano deriva da arte, intesa in questo senso; mentre la parola artista sembra che indicasse, in origine, semplicemente qualcuno che eccelleva nella propria arte (ovvero abilità costruttiva), qualunque essa fosse.
Coomaraswamy fa anche notare che anche il fatto di considerare le arti come oggetto di un’estetica è un’invenzione occidentale e recente. La parola estetica deriva da aisthesis, ovvero sensazione, e che la riflessione sull’arte abbia nome estetica tradisce l’idea di base che il campo dell’arte sia quello della sensazione, nello specifico quello della sensazione piacevole. L’invenzione dell’estetica avrebbe dunque deviato verso il campo della sensazione quello che prima apparteneva al campo della conoscenza.
Credo (io, non Coomaraswamy) che questa deviazione sia parallela allo sviluppo di un’idea di conoscenza razionale esclusiva, che sfocia ai primi del Seicento nella concezione cartesiana della scienza. Dove la conoscenza debba essere fatta di idee chiare e distinte non c’è più posto per una conoscenza tradizionale su base rituale, con una forte componente religiosa. Progressivamente (perché queste cose richiedono secoli, e né Cartesio si è inventato tutto da un giorno all’altro, né dal giorno dopo l’enunciazione delle sue idee il pensiero occidentale è cambiato di colpo) una serie di cose che prima erano sentite come centrali per la vita e la conoscenza del mondo vengono relegate a un ruolo più marginale. Nella misura, poi, in cui esse sono anche legate al culto religioso, secondo il nuovo criterio illuminista finiscono per ritrovarsi nel campo della superstizione.
La parola estetica, usata in senso moderno, è settecentesca; ma l’idea dell’arte come qualcosa che riguarda la sensibilità piuttosto che la conoscenza la precede. Potremmo dire che l’invenzione dell’estetica come tale, nel Settecento, è il tentativo illuminista di dare un posto decoroso all’arte all’interno di un sistema cognitivo che la lascia fuori. Alla fine di questa lunga trasformazione, siamo passati da un sistema in cui la pittura, la scultura, l’architettura e la musica erano modalità rituali (o collegate a situazioni rituali) di conoscenza del mondo, a un altro sistema in cui queste medesime attività sono diventate testimonianza dell’espressione dell’io, e al tempo stesso manifestazioni del sublime – con questa particolare e interessante coincidenza di due estremi, entrambi tenuti ai margini di un mondo sempre più dominato da una conoscenza di tipo razionalistico e dalla sua applicazione attraverso una tecnica che per sua natura esclude l’arte, cioè l’abilità manuale.
Dobbiamo a William Morris e alla sua utopia neoumanistica della seconda metà dell’Ottocento l’idea del design industriale, ovvero l’idea che l’arte (intesa come cura della qualità) possa essere applicata anche ai prodotti della tecnologia. E gli dobbiamo, in qualche modo, anche l’idea del graphic design, ovvero l’idea che pure i prodotti della comunicazione possano essere progettati con cura e con arte.
Ma Morris non poteva cambiare, evidentemente, le regole di fondo. In una società deritualizzata, o in cui i nuovi riti sono effimeri e sempre collegati a una razionalità produttiva, le nuove arti (in senso antico) inventate da lui non possono ricoprire lo stesso ruolo che avevano nel mondo fortemente ritualizzato al cui interno si erano sviluppate. Benché sia figlio della cura dell’artista medievale (ovvero colui che eccelleva nella sua arte), e sia in questo senso ciò che davvero potrebbe legittimamente essere definito arte, il design non può godere della stessa considerazione sociale di cui godeva nel medioevo l’arte: gli manca quel legame con il sacro che allora era parte di qualsiasi opera, di qualsiasi operazione, anche quotidiana.
Nella nostra cultura, quel legame è diventato appannaggio dell’Arte (con la A maiuscola, cioè nel senso corrente dell’espressione), la quale, però, ha dovuto separarsi in maniera radicale dalla tecnica, dalla produzione di buoni oggetti d’uso, e relegarsi nel campo di un tipo particolare di comunicazione, quella espressiva – cercando di ricostruire, solo con i propri mezzi, delle situazioni rituali a cui la società concede diritto di esistere a patto che non riguardino il campo del sapere, e si limitino a quello del bello, dell’aisthesis, della sensazione. L’Arte finisce per diventare, in questo modo, solo una forma più complessa (magari più colta) di intrattenimento – e il sacro stesso finisce per essere oggetto di aisthesis.
Dobbiamo avere nostalgia per come era prima, o per come sarebbe altrove? Non so. Non so quanto prima fosse meglio. Non mi interessa seguire Coomaraswamy in questo. Non credo che sia questo il punto. Quello che è importante, piuttosto, è capire bene quanto fossero diverse prima le cose, e che il senso in cui Giotto era un artista era molto diverso dal senso in cui lo definiremmo tale oggi. Giotto era (di gran lunga) il più bravo a esprimere visivamente quello che la collettività sentiva; a raccontare per immagini quello che tutti sapevano e intorno a cui tutti si raccoglievano.
Non esiste niente di simile a questo, oggi. I presupposti sono cambiati. Il nostro stesso sentire e il nostro stesso conoscere sono differenti.
 Edward Weston, Nudo, 1934 Ci sono diversi modi per guardare questa foto di Edward Weston, scattata nel 1934. Si può osservare la composizione, non dissimile da quella di molta pittura astratta che si poteva vedere in quegli anni – quasi un Mondrian curvilineo, o un Malevich con più chiaroscuro. Si può vedere una singolare architettura naturale, una sorta di corta grotta di sasso liscio, con le sue ombre e qualche accenno di passaggio verso il buio delle sue cavità. O si può, ovviamente, vedere un corpo nudo femminile, colto, così da vicino, in un’intimità conturbante, quasi odorosa di pelle.
Ma se si vedono tutte queste cose, poi, non è più possibile separarle. Certo, come nell’esempio classico del coniglio-anatra della psicologia della Gestalt (o di Wittgenstein, a seconda di dove l’abbiamo incrociato), non possiamo vedere le diverse cose contemporaneamente: nello stesso istante, o si vede la pelle o si vede il sasso o emerge la composizione astratta. Tuttavia, se possiamo passare dall’uno all’altro – ed è così che facciamo – è perché queste diverse forme sono tutte contemporaneamente presenti alla nostra consapevolezza. E questo è insieme, per noi, un corpo un po’ conturbante di donna e un gruppo di sassi vicino al mare e una composizione suprematista o funzionalista.
D’altra parte, non solo la bellezza artistica, ma anche l’eros funziona così: qualcosa ci attrae perché è insieme se stesso e qualcos’altro, e produce l’improvvisa sensazione, in noi, di poter avere insieme il corpo e il mito, il piacere e il mondo. Sarà un’illusione, non c’è dubbio. Ma allora la realtà, cos’è?
 Lorenzo Mattotti, illustrazione da "Hänsel e Gretel", Orecchio Acerbo 2009 C’è qualcosa di ironico nel fatto che il premio Andersen di quest’anno sia andato a una fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm illustrata da Lorenzo Mattotti. Da un lato, è evidente una certa coerenza nel fatto che un premio intitolato a un autore di fiabe sia andata all’edizione di una fiaba scritta da altri autori di fiabe. Dall’altro, bene ha fatto la giuria del premio a giustificare la propria scelta iniziando con le parole: “Per essere un libro illustrato veramente ‘per tutti’”.
Il premio Andersen è infatti il principale premio italiano per il libro per ragazzi, ma né Andersen né i Grimm né tantomeno Mattotti sono mai stati davvero degli autori per ragazzi. Mi colpisce questo fatto, proprio mentre, riguardandomi il volume illustrato da Mattotti, penso che il premio l’ha davvero meritato – e che va benissimo che il premio sia intitolato ad Andersen, mentre insieme faccio fatica a vederci un prodotto per l’infanzia. “Per tutti” va bene; ma il problema è che andrebbe altrettanto bene per il medesimo Andersen e per i fratelli Grimm, che operavano raccogliendo fiabe e favole avendo in mente un recupero della letteratura popolare come espressione di un’epica, di un mito – con forti caratteristiche nazionali.
Possiamo giustamente lasciar perdere l’aspetto nazionale, e le sue conseguenze nazionalistiche, poiché le fiabe hanno valore indipendentemente da quello. Ma l’epica e il mito sono basilari, e mi conducono a loro volta a un’altra domanda: come mai un’altra epica e un altro mito, quelli greci antichi, non sono mai stati toccati dalla riduzione all’infanzia che ha toccato le fiabe? E non vale rispondere: ma come! si vede che le fiabe sono per ragazzi e i miti greci no! Ma si vede perché questo è ciò che ci hanno insegnato, e siamo cresciuto pensando che questa sia la norma.
Non vale nemmeno la risposta: perché i miti greci hanno Omero, e le fiabe no. Solo alcuni miti greci, di fatto, hanno Omero. Per tanti altri non c’è stato nemmeno un Andersen.
Piuttosto, riflettiamo sul modo in cui i miti greci e le fiabe sono arrivati all’universo della cultura “alta”: da un lato c’è un recupero che è stato cólto fin da sempre, e da sempre legato al fascino degli antichi; dall’altro c’è la scoperta, in secoli recenti, dell’esistenza di una cultura popolare, e il tentativo della sua riabilitazione. Ma questo tentativo, evidentemente, si è scontrato con qualcosa, con un qualche pregiudizio troppo forte da sradicare, e così la letteratura popolare non è stata considerata epos, o mito, ma è stata assimilata alla letteratura per bambini, utilizzando un’equazione implicita del tipo popolare=immaturo.
Al fumetto, guarda caso, nel suo arrivare in Europa, è successa la stessa cosa. Solo in America poteva nascere davvero una forma di letteratura popolare che non venisse immediatamente assimilata alla letteratura per l’infanzia! E questo poteva succedere proprio perché la tradizione cólta americana era ovviamente più debole, meno paludata, più disposta a differenziarsi da quella della madre Europa.
Un secolo è passato da allora, e molte cose sono cambiate. Ma al fondo il pregiudizio rimane, e Mattotti resta, per la cultura “alta”, un autore per l’infanzia, o comunque destinato a un consumo in qualche modo “immaturo”. Il problema non riguarda dunque esclusivamente il fumetto: i pregiudizi nei confronti del fumetto non sono che una delle applicazioni nei confronti di tutto quello che ha radici popolari più prossime – indipendentemente da quanto maturo, raffinato, colto, complesso sia oggi.
A saper guardare le figure di Mattotti sul racconto di Grimm, ci si accorge facilmente di quanto più “alta” sia in realtà questa cultura di quella di tanta letteratura verbale osannata dai giornali e dai media, e che riempie i dibattiti culturali dei nostri giorni.
Ci sono delle eccezioni, ed è interessante valutarle: non è successa la medesima cosa per la musica, per esempio. Perché?
Sto scrivendo un articolo sull’horror a fumetti, per un’iniziativa di cui presto si saprà di più. Mi sono ripercorso a grandi linee le diverse stagioni dell’horror di qua e di là dall’oceano (solo l’Atlantico: per il Pacifico non avrei avuto spazio) e ho fatto alcune scoperte. Lasciando perdere i casi isolati, le stagioni principali dell’horror occidentale a fumetti, viste da qui (Italia, 2010), mi sembrano le seguenti:
- la stagione E.C., dal 1950 al ’54, tarpata dalle fisime del dr. Wertham
- la stagione Warren, dai tardi Cinquanta in poi, comprensiva di Vampirella (dal ’69)
- i porno-horror italiani anni Settanta (tipo Jacula, Sukia e Cimiteria)
- un po’ di Argentina sparsa, dal Mort Cinder di Breccia e Oesterheld in poi
- Dylan Dog e il post-Sclavi, dall’effimera esplosione horror italiana del ’90 ai successivi prodotti Bonelli, da Magico Vento a Brendon a Dampyr
- quello che potremmo chiamare il neo-gotico americano, ovvero Swamp Thing e discendenti più o meno diretti (Hellblazer, Sandman ecc.)
La domanda è: quanto di questo horror è fatto per fare davvero paura? Naturalmente, in quanto horror, tutto è fatto per fare almeno un po’ paura. Però, se lo osserviamo da vicino, ci accorgiamo che il più delle volte la paura è abbondantemente condita con altri ingredienti, che nell’impasto risultano assai più salaci.
Per esempio, tutta la produzione E.C. è giocata sul grottesco, ovvero su uno humor nero sarcastico e mortifero: e anche quando si sobbalza per lo spavento c’è sempre una voce più o meno fuori campo che propone di riderci su (magari amaramente – ma pur sempre riso è).
La produzione Warren degli anni Sessanta ripropone (con meno vivacità) esattamente lo stesso modello, ma si riscatta con Vampirella – su cui lavoravano fior di sceneggiatori e disegnatori. Con Vampirella entra in gioco una sorta di erotismo gotico, e anche una qualche dose di superomismo. Vampirella potrebbe forse fare davvero più paura, se non fosse che la protagonista è troppo carina e svestita, e il tutto troppo fantastico e buonistico.
L’erotismo di Vampirella è il punto di partenza per i porno-horror italiani, ma qui già la definizione dice tutto: l’horror è una scusa per condire meglio il sesso, attraverso la tradizionale combinata sesso-grandguignol.
Dylan Dog trova un altro modo, assolutamente originale, per esorcizzare la paura. Lo si capisce benissimo sin dal primo numero, quell’Alba dei morti viventi che è una citazione già nel titolo: l’horror diventa gioco intellettuale, un gioco che è spesso praticabile anche da chi abbia una cultura massmediatica popolare, ma non meno gioco e non meno intellettuale per questo. La paura non può essere vera, in questo contesto: sarà necessariamente un gioco di citazione, pure lei!
Sin qui dunque (e abbiamo già fatto fuori, quantitativamente, il grosso dell’horror a fumetti) di paura vera ce n’è stata poca. Proviamo a domandarci perché.
Ho accennato in altri due post (qui e qui) della nascita del romanzo gotico nell’Inghilterra del Settecento, e di quanto sia legata questa nascita alla diffusione della nozione di sublime, che, guarda caso, è la stessa che sta dietro alle concezioni Romantica e moderna dell’arte. Il romanzo gotico, ovvero il primo horror, rappresenta l’esito più popolare (ma non solo) di questa diffusione: il mistero e l’orrore sono la manifestazione più semplice ed evidente di quello che è soverchiante e incontrollabile.
La cultura alta ha spesso riso di questa manifestazione bassa dei propri medesimi ideali, anche se più volte vi ha attinto a piene mani (come si può leggere, tra l’altro in un intrigante volumetto di Renato Giovannoli, Il vampiro innominato. Il “Caso Manzoni-Dracula” e altri casi di vampirismo letterario, Medusa 2008). Del resto non è difficile trovare occasione di ridere di cose di questo genere, che diventano molto facilmente troppo poco credibili, persino in un’ottica di fiction.
Il grottesco, l’erotismo, il citazionismo sono quindi altrettante strategie per permettere di tollerare questa natura volgarissimamente sublime che è propria dell’horror. Insomma: fare davvero paura, e avvicinarsi in questo modo al sublime stesso, è cosa molto, molto difficile – quando non si possiedono gli strumenti realistici del cinema (fotografia, ovvero pseudo realtà, movimento e sonoro) e la comprensione dei fatti è inevitabilmente mediata da una serie di ricostruzioni intellettuali (decifrare i disegni, metterli in sequenza, ricostruire la dinamica, collegare le parole…). È più facile, e spesso anche più efficace, giocare in vario modo con gli stereotipi e con quel poco di paura che comunque essi si portano attaccata.
Non è però sempre così, e il nostro elenco iniziale non è stato del tutto esaurito. Resta fuori certamente Breccia e anche una parte del fumetto argentino (mentre tanto altro rientra in qualche modo nei casi già visti); resta fuori una parte della produzione Bonelli post-Sclavi, come nel caso di Dampyr, in cui il citazionismo è marginale rispetto ad altro, assai più pauroso; e resta fuori quello che ho chiamato neo-gotico americano, ovvero le conseguenze della ripresa compiuta da Alan Moore, nel 1984, di Swamp Thing.
È tra questi esempi che troviamo dei fumetti horror che fanno davvero paura. È evidente che appartengono a culture diverse e anche a momenti storici diversi. Che cos’hanno in comune, sempre che lo abbiano?
La mia personale suggestione è che le storie che questi fumetti mettono in scena parlano di me e del mondo in cui vivo – mentre tutte le altre storie di cui abbiamo parlato, di buona o cattiva qualità che siano, parlano sostanzialmente di mostri immaginari. Il male che circonda Swamp Thing nelle storie di Moore ha sì la faccia tradizionale dei non-morti, ma è evidentemente un male molto più vero e vicino a noi: è la bomba atomica, è la discriminazione sociale, è la voracità capitalistica, è la stupidità, l’arroganza, il potere che non vuole limiti…
Solo a queste condizioni la nostra paura può rinascere davvero. E solo una vera paura può generare una paura letteraria che non sia puro gioco. La paura vera può essere sublime, in qualche caso. Il gioco è invece gioco: può essere intelligente, di alta qualità, ma è un’altra cosa.
23 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, filosofia, Gianluca Capuano, Guillaume Dufay, Johann Sebastian Bach, musica, musica contemporanea, optocentrismo, Pierre Boulez, Platone, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, filosofia, musica, sistemi di scrittura | Percorsi vari di riflessione e di studio mi riconducono a un bellissimo libro che avevo letto qualche tempo fa: I segni della voce infinita. Musica e scrittura, di Gianluca Capuano (Milano, Jaca Book 2002). Il tema del libro è la scrittura, in relazione al suono – quello della parola, certo, ma soprattutto quello della musica. La tesi principale del libro è che il nostro modo di concepire le cose è vincolato a quello che Capuano chiama optocentrismo, ovvero una centralità della dimensione visiva (ottica) in relazione alla quale vengono valutate (e spesso svalutate) anche le conoscenze che noi ricaviamo dagli altri sensi. L’optocentrismo trova le sue origini, per quello che riguarda l’Occidente, nella filosofia di Platone, ma poi rimane pressoché indisturbato nella sua posizione dominante sino a oggi – anche perché al centro del privilegio della visione si trova certamente la scrittura, in quanto parola (cioè pensiero) che si vede. Nella prima parte del libro, Capuano ci illustra la posizione di Platone, e poi, nella seconda, il modo in cui il privilegio accordato alla visione è sfociato durante il Medio Evo nell’invenzione di una scrittura per la musica, la quale ha assunto un ruolo via via più importante non solo nella trasmissione, ma anche nella concezione della musica stessa, sino a trasformarla intimamente – anzi, fino a diventare, per gran parte delle persone che si occupano di musica, il mezzo principale per studiarla, produrla e analizzarla.
Voglio partire da qui per fare in questo post alcune riflessioni sulla scrittura e sulla comunicazione visiva in genere, specie quando applicate a una dimensione così diversa come è quella del sonoro.
In primo luogo, credo che l’optocentrismo sia di parecchio anteriore a Platone, anche se è stato certamente lui a farne il cuore di tutta la filosofia a seguire. Se riflettiamo sugli usi consueti del linguaggio, ci accorgiamo che le nostre metafore cognitive sono in generale di carattere visivo: si parla di idee (dal greco eidos, cioè forma), di osservazione (scientifica), di vedere le cose come stanno, di vedere lontano; e certamente non di ascolto (scientifico) o di udire le cose come stanno, né tantomeno di udire lontano. Queste ultime espressioni, anzi, ci appaiono grottesche, insensate. Parliamo piuttosto di ascolto interiore, o di sentire, per riferirci alla propriocezione, specie se emotiva.
Certo, questo nostro uso potrebbe essere una conseguenza della diffusione anche a livello popolare delle concezioni platoniche, tuttavia, di nuovo, l’etimologia ci suggerisce che la vicinanza concettuale tra il vedere e il sapere precedesse Platone. Il termine latino video (cioè vedo) è legato etimologicamente all’inglese witness (cioè, il testimone, colui che sa perché ha visto) e wisdom (saggezza), ma anche al tedesco wissen (sapere, conoscere) e ai termini sanscriti veda (vedere, comprendere, sapere, ma anche la denominazione dei libri della saggezza induista, risalenti almeno al 1000 a.C.) e vidya (conoscenza intuitiva, diretta). L’optocentrismo è dunque presumibilmente un pregiudizio molto antico tra gli indoeuropei – ma non mi stupirei di scoprire che di questo pregiudizio soffrono tutti gli umani del pianeta. In fin dei conti, la vista è davvero il più raffinato e potente dei nostri sensi, e gli studi sull’oralità primaria mostrano una serie di caratteristiche comuni alle culture che non conoscono la scrittura, che tendono comunemente a perdersi una volta che la scrittura sia acquisita.
Il tema è sconfinato. Voglio limitarmi a una curiosità, relativa proprio al rapporto tra musica e scrittura – che la dice lunga, a mio parere, sull’importanza che la dimensione visiva ha assunto anche per il mondo della musica. E racconterò una storia.
Questa storia ha inizio verso la fine del Medio Evo, quando la notazione musicale ha già diversi secoli di vita, e ha raggiunto un livello di notevole sofisticazione. Questo livello è richiesto anche dalla complessità che la musica ha raggiunto, a sua volta resa possibile dal fatto di poter essere scritta. I maestri della musica polifonica di quegli anni sono soprattutto fiamminghi, anche se poi molti di loro vengono a lavorare per le corti italiane. Nel 1436 Guillaume Dufay compone il mottetto Nuper Rosarum Flores, in occasione dell’inaugurazione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, progettata da Filippo Brunelleschi. È un fatto noto che Dufay struttura il mottetto secondo delle proporzioni matematiche, anzi geometriche, cioè spaziali: che sono quelle stesse che reggono il cupolone del Brunelleschi, e sulla base delle quali l’architetto ha edificato la sua (per l’epoca) incredibile costruzione.
Ma come si colgono all’ascolto queste proporzioni visive che avvicinano il mottetto di Dufay alla cupola di Brunelleschi? In realtà non si colgono, anche se, certo, se ne sente l’effetto. Al semplice ascolto non c’è modo di comprendere che il mottetto contiene quelle relazioni. E allora, se non si sentono, a che servono?
Per rispondere, bisogna tenere presente che, per l’ascoltatore dell’epoca, c’è sempre, oltre a lui, un altro ascoltatore privilegiato, che è in grado di cogliere immediatamente qualsiasi proporzione nascosta, perché la vede immediatamente, anzi l’ha già vista: quell’ascoltatore è ovviamente Dio, a cui qualsiasi mottetto è prima di tutto dedicato. Il fatto che un brano musicale (ma in generale una qualsiasi opera d’arte) contenga un messaggio nascosto, e comprensibile solo a Dio, è per l’epoca un fatto normale e normalmente apprezzato.
Però c’è un altro fruitore privilegiato del mottetto di Dufay, che è il musicista che legge la partitura. Anche lui può cogliere le relazioni matematiche (mentre ulteriori segreti rimangono nascosti, destinati al solo Dio), non perché le sente ma perché le vede.
 Baude Cordier, Tout par compas, Codex Chantilly, ca. 1400  Baude Cordier, Belle Bone Sage, Codex Chantilly, ca. 1400 Questo criterio di una visibilità importante quanto e più dell’udibilità è cruciale per moltissime composizioni del Quattrocento fiammingo, sino al punto di incentivare la creazione di partiture esse stesse con forme particolari, come quella famosa a forma di cuore (anche citata da Capuano) contenuta nel codice Chantilly (intorno al 1400). Senza arrivare a questi estremi, in quest’epoca le inversioni speculari (inverso, cioè le stesse note con i rapporti invertiti, e retrogrado, cioè le stesse note a partire dall’ultima verso la prima) stanno già giocando da tempo un ruolo importante: e parlare di speculare significa già mettere in gioco una dimensione visiva, che l’ascolto non è in grado autonomamente di riconoscere. Il bellissimo e famoso rondeau di Guillaume de Machaut “Ma fin est mon commencement” prevede tre voci: tra le prime due c’è un canone retrogrado (ovvero la seconda canta una melodia che è il retrogrado della prima), mentre la terza canta la propria melodia prima per moto retto e poi retrogrado. (Qui poi, persino il testo concorre al gioco speculare, come si può vedere a questo link).
L’idea di Dio come fruitore privilegiato si perde tra Cinque e Seicento, però mai del tutto. E anche le arditezze geometriche dei musicisti medievali vengono tendenzialmente abbandonate con il tramonto della polifonia. È un declino progressivo e mai totale, che trova un fantasmagorico ritorno di fiamma nell’opera del vecchio Bach, Johann Sebastian.
È un fatto ben noto, infatti, che i suoi contemporanei gli preferirono di gran lunga i figli, specialmente Johann Christian e Carl Philipp Emmanuel. Johann Sebastian era troppo difficile, troppo geometrico, troppo fuori moda, per gli azzimati e superficiali ascoltatori del Settecento. Lo si apprezzava più per la complessità del contrappunto che per la qualità del melodista. E d’altra parte, lui stesso, da bravo luterano, componeva sostanzialmente a maggior gloria di Dio, seguendo il proprio spirito e poco curandosi (però anche curandosi) del piacere dei propri ascoltatori.
Al di là della visione di lui che potevano avere i suoi contemporanei, Johann Sebastian rappresenta davvero una singolare combinazione: da un lato uno straordinario inventore di motivi e di melodie, dall’altro un matematico della musica, il più straordinario gestore di ars combinatoria che sia mai vissuto. Attraverso questa incredibile combinazione di passato e di presente, la musica di Johann Sebastian attraversa il proprio tempo, e lo supera quasi dimenticata per circa un secolo: quasi dimenticata, perché anche se nessuno l’ascolta più, tutti i musicisti la studiano, perché lì stanno le risposte a tutti i problemi del contrappunto.
Poi, Bach viene riscoperto almeno due volte. La prima dal romantico Felix Mendelssohn, che – pur così affascinato dal rigore geometrico da scrivere a propria volta i propri preludi e fughe – ne ripropone soprattutto l’aspetto di melodista e orchestratore: il Bach delle Messe, delle Passioni e delle Cantate, insomma. La seconda, ancora un secolo dopo, quando la sua fama è già piena, da Arnold Schoenberg, che fa del contrappunto di Bach il modello per la propria nuova tecnica compositiva: la dodecafonia.
Siamo negli anni Venti del Novecento. Schoenberg sta cercando un metodo compositivo che lo liberi dai vincoli della tonalità. Lo trova per mezzo di un espediente geometrico, con l’invenzione del concetto di serie dodecafonica, ovvero una serie di dodici note, in cui compaiano tutti (e dunque una sola volta) i dodici toni in cui è divisa la nostra scala. Invece di basare le proprie composizioni musicali sul concetto di tensione tonale, come si era fatto sino a quel momento, Schoenberg inizia a fare uso di questa tecnica, che ha al centro la serie dodecafonica e le sue permutazioni, con particolare risalto di quelle speculari: l’inverso, il retrogrado e l’inverso del retrogrado.
Se si leggono gli scritti teorici di Piet Mondrian di quei medesimi anni, vi si trova il medesimo spirito in una forma ancora più estrema. Mondrian arriva proprio a teorizzare una musica così antinaturalistica e così astrattamente geometrica quale Schoenberg non arriverà mai a comporre. D’altra parte, Mondrian lavora proprio in quel campo del visivo da cui la musica dovrebbe essere lontana.
E invece la tendenza della scuola di Vienna sarà proprio quella, prima con il grande allievo di Schoenberg, Anton Webern, e poi con gli esiti della scuola di Darmstadt del dopoguerra, quando Pierre Boulez arriverà a teorizzare un serialismo integrale, applicato non solo all’armonia ma a tutti parametri della composizione musicale.
Questo trionfo di una concezione geometrica, e quindi di base visiva, della musica segnerà tutta la musica colta della seconda metà del Novecento. La tendenza diventerà regola, così imperativa da sollevare persino le proteste di alcuni tra i musicisti più sensibili, pur appartenenti alla medesima scuola – perché di questo tipo sono le osservazioni che Gérard Grisey muove nel 1980 alla nozione di ritmi retrogradabili promossa trent’anni prima da Messiaen, definendoli risultato di una utopia basata su una “visione spaziale e statica del tempo”.
 Sylvano Bussotti, Siciliano (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002)  R. Moran, Four Visions (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002)  A. Logothetis, Odyssee (immagine tratta da Andrea Valle, La notazione musicale contemporanea, Torino, EDT 2002) Non c’è da stupirsi se, all’interno di questa concezione visiva della musica, l’aspetto visivo della partitura ritorni a guadagnare importanza, come già era accaduto nel Quattrocento. Complice l’idea di musica aleatoria, ovvero basata in parte sul caso, o sulle scelte dell’interprete, le partiture finiscono per essere talvolta più delle immagini di carattere evocativo, destinate a stimolare l’immaginazione dell’esecutore, che non notazioni musicali vere e proprie, oppure una combinazione delle due. Come dire che la musica nasce, in tutto o in parte, dall’immagine: il trionfo definitivo del visivo sul sonoro. L’optocentrismo platonico portato alle sue estreme conseguenze.
Era un vicolo cieco. La musica colta contemporanea di oggi lo sa.
Altre strade che ha seguito la musica, nei medesimi anni, l’hanno invece portata molto più lontana dalla dimensione scritta di quanto non accadesse nella tradizione pre-schoenberghiana. In un mondo in cui per i critici musicali e i musicologi la musica si identificava con la partitura, ovvero con la sua dimensione scritta, questa non era una direzione facile. Ne parla un altro bel libro che affronta questi temi, quello di Davide Sparti che ha per titolo Il corpo sonoro. Oralità e scrittura nel jazz (Bologna, Il Mulino 2007), dove si capisce davvero quanto poco del fascino delle sonorità di John Coltrane possa essere ricondotto all’universo visivo. Per quanto comunque il riferimento al visivo e alla scrittura ci sia, e non possa ormai che esserci, almeno in una qualche misura: la musica non potrà mai più essere un fatto sonoro puro.
7 Aprile 2010 | Tags: Bauhaus, carattere tipografico, caratteri lineari, comunicazione visiva, estetica, Futura, Georg Kurt Schauer, graphic design, James Mosley, Paul Renner, Romanticismo, sistemi di scrittura, sublime, tipografia | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design, sistemi di scrittura | Anche studiando la storia della tipografia si fanno strane scoperte sui percorsi di senso delle forme di cui facciamo quotidianamente uso. Prendiamo i caratteri lineari, o senza grazie (variamente chiamati, a seconda della lingua o tradizione o periodo, sans-serif, grotesque, antiqua, gothic o anche egyptian). Il dibattito tra i professionisti della grafica sulla loro leggibilità è tuttora in corso, senza che si possano assegnare vantaggi decisivi né a chi sostiene che i caratteri aggraziati sono comunque più leggibili, né a chi sostiene il contrario – salvo che per quanto riguarda la lettura su monitor, rispetto alla quale è largamente accettata la posizione secondo cui, a causa della bassa risoluzione, i caratteri lineari sarebbero più leggibili di quelli aggraziati. E questa è una delle ragioni per cui state leggendo queste medesime parole in un Verdana anziché in un Times New Roman.
Ma non è di leggibilità che voglio parlare. Un’altra posizione largamente condivisa è che i caratteri aggraziati siano, in linea di massima, più tradizionali, e quelli lineari più moderni. Di conseguenza l’uso dei caratteri lineari sarà in generale preferibile in tutte quelle situazioni in cui l’impostazione grafica vuole trasmettere un’idea di contemporaneità e di progresso. Si noti che ho insistito sull’“in linea di massima” e sull’“in generale”, perché ovviamente vi sono font di caratteri specifici e situazioni specifiche in cui il principio generale può trovarsi del tutto ribaltato. Inteso come un principio generale, comunque, quello della maggiore modernità dei caratteri lineari è praticamente un luogo comune – ormai talmente diffuso e acritico che non mi stupirei se si trovasse oggi sul punto di essere ribaltato.
Come si è arrivati a questo luogo comune? In altre parole che cos’hanno i caratteri lineari che li renda più moderni di quelli aggraziati? La strana scoperta si fa proprio quando si va a esplorare l’origine di questa concezione. Mi fa da conduttore un bellissimo saggio di James Mosley, “La ninfa e la grotta. La rinascita dei caratteri senza grazie”, contenuto nel volume Radici della scrittura moderna (Stampa Alternativa & Graffiti, 2001).
Per molto tempo si è ritenuto che il carattere lineare faccia la sua prima uscita moderna intorno al 1816, data attribuita alla sua più antica testimonianza tipografica. Da quel momento e per circa un secolo la sua sorte è legata unicamente ai contesti di segnaletica, insegne e manifesti. Solo con l’inizio del Novecento qualcosa nel suo destino inizia a cambiare.
 L'iscrizione lineare del Grotto di Stourhead (circa 1750) trovata da Mosley Mosley ci mostra invece come, al suo ingresso nell’universo tipografico, il carattere lineare sia già presente nella scrittura da oltre sessant’anni, soprattutto in ambito britannico, come carattere lapidario. Lo si trova nelle iscrizioni funerarie, ma anche in certi fregi architettonici, così come nei frontespizi di volumi che fanno riferimento a quei medesimi contesti.
Visto così, questo ingresso in scena del carattere lineare appare ancora più strano. Il carattere lapidario per eccellenza è infatti, nella nostra tradizione, quello romano classico, con tutte le variazioni moderne sul modello della capitale traianea: non solo un aggraziato dunque, ma il prototipo stesso del carattere con le grazie.
Se aggiungiamo che il periodo in cui avviene questa trasformazione è anche il periodo del ritorno in voga degli stili classici, nella forma – appunto – del neo-classicismo, l’ingresso in scena dei caratteri lineari può apparire ancora più incomprensibile.
 Thomas Banks Iscrizione funeraria, 1791 Non è però un caso che gli eventi di cui stiamo parlando avvengano sostanzialmente in Inghilterra. Nel mio post del 17 febbraio ho raccontato come il concetto di sublime abbia trasformato il modo di considerare l’arte nell’Inghilterra del Settecento e poi in tutta Europa sino a noi. C’è un altro aspetto importante di quella trasformazione, a cui là non ho accennato: si tratta dell’arcaicismo, del primitivismo, della ricerca di forme anticlassiche (quella stessa che porta, alla fine del secolo, a preferire l’anticlassico Michelangelo al classicissimo Raffaello). Questa tendenza si sposerà facilmente con l’imminente recupero del gotico, e già si sposa in quegli anni con la moda del romanzo gotico, ovvero dell’horror settecentesco.
Insomma, l’Inghilterra del Settecento si presenta come un laboratorio dei temi che poi esploderanno con il Romanticismo al volgere del secolo. Per quanto singolare possa apparire, il carattere lineare, con la sua povertà e geometricità, appare in questo contesto come un carattere dotato dei pregi di primitività e arcaicità – e quindi non di rado adeguato a esprimere lo spirito nuovo. I riferimenti sono le scritture lapidarie greche classiche, quelle etrusche e quelle romane antiche, precedenti alla grandiosità imperiale. Ma c’è un singolare riferimento anche alla scrittura egiziana: Egyptian vengono infatti definiti questi nuovi caratteri, nonostante di egiziano non possano ovviamente avere nulla.
A questo proposito fa notare Mosley come la moda dell’Egitto stia in quel periodo imperversando in Europa, e di come i francesi, ritornando in Grecia dopo la spedizione egiziana del 1802, si stupiscano di ritrovare l’arte greca deludente, dopo l’esperienza diretta dei semplici e massicci templi egizi, così dotati di “una nobile semplicità, e una maestosità che riempie lo spirito” (Description de l’Egypte, 1809-28). I caratteri lineari condividono con l’architettura egiziana questa medesima nobile semplicità, e il medesimo spirito arcaico.
Anche per questo, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, essi diventano di moda. Non entrano ancora nei libri (al massimo, raramente, nei frontespizi) perché comunque si tratta di caratteri ancora troppo grezzi per competere con quelli tradizionali, ma si impongono in una molteplicità di combinazioni pubbliche. Così, paradossalmente, il fatto di essere considerati forme arcaiche diventa il motivo della loro modernità: arcaismo e modernità si fondono, nel comune anticlassicismo. Ecco come conclude Mosley il suo saggio, con una citazione da Georg Kurt Schauer (che ritiene comunque l’ispiratore della sua ricerca):
Questi caratteri senza grazie possono ben essere stati pensati per scopi puramente accademici, ma una tale evidenza delle forze elementari del passato deve aver avuto un fascino assai diverso per la Sensibilità coltivata dagli ammiratori dei poemi di Ossian e da quel primo Romanticsmo che era un anelito al ritorno a un passato puro, semplice e forte. Le richieste della pubblicità, la ricerca del sensazionale e la spinta commerciale alla novità possono ben essere state le ragioni immediate per la realizzazione dei caratteri tipografici “lineari”, senza grazie e a grazie squadrate; ma queste sono osservazioni superficiali, che oscurano piuttosto che rivelare le vere cause sottostanti. Il rifiuto della leggerezza e dell’armonia classiche è un impulso romantico. Lo spirito romantico considera la sobria semplicità un valore positivo. La forza barbarica è da ammirare, e così l’assenza di decorazioni superficiali. L’essenza del Romanticismo è nel desiderio di purezza e di forza. Queste qualità, che non possono essere trovate nel presente, vengono cercate nei movimenti arcaici, o in ogni passato per quanto lontano, assunto come più elementare. La rozzezza primitiva, nella sua lotta per il ritorno alla natura, era per i romantici tanto eccitante quanto era invece offensiva per chi aveva attitudini ortodosse e civilizzate. (Schauer, Über die Herkunft der Linearschriften, 1959)
Questo richiamo alla semplicità come valore ricorda facilmente l’equiparazione tra ornamento e delitto operata da Adolf Loos nell’inaugurare l’architettura e il design del Novecento. Non è difficile osservare come la storia successiva dei caratteri lineari si ponga tutta su questa linea, sia nella versione avanguardista (ispirata, più o meno da vicino, dal Bauhaus) di Paul Renner, Max Miedinger e Adrian Frutiger sia in quella umanistica di Edward Johnston ed Eric Gill.
 Paul Renner, il carattere Futura, 1927 È forse più difficile accorgersi di come l’idea del sublime continui a operare in queste creazioni, specialmente in quella di Renner. Il carattere Futura (1927), da lui disegnato, è infatti la migliore realizzazione in campo tipografico dell’utopia del Bauhaus e dei funzionalisti, l’idea di forme che siano al tempo stesso pubblicamente utili e graficamente semplici, senza bisogno di alcun riferimento alla tradizione. Una sublime semplicità, insomma, che esprime l’utopia del progetto di un’umanità non condizionata del proprio passato: primitiva dunque, almeno nel senso di un’umanità che può essere nuova, che può ricominciare di nuovo la propria storia.
Non posso comunque non essere colpito da questa singolare contiguità tra piramidi, horror e funzionalismo, che da questa storia salta fuori. E dovremmo aggiungerci pure la pubblicità, che dei caratteri lineari è stata poi di fatto la principale beneficiaria – quasi a farsi gioco di quella medesima utopia a cui essi devono l’esistenza.
5 Aprile 2010 | Tags: Alan Moore, Algirdas J. Greimas, ermeneutica, estetica, fumetto, poesia, principio del parallelismo, Roman Jakobson, semiotica, Watchmen | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Sia riflettendo sul testo poetico che su quello fumettistico mi ritrovo ricorrentemente di fronte a quel principio formulato da Roman Jakobson che va sotto il nome di principio del parallelismo. Jakobson afferma al proposito che la funzione poetica “proietta il principio di equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa al grado di elemento costitutivo della sequenza”. In parole più povere, per Jakobson quelle relazioni di equivalenza e somiglianza che nell’uso normale del discorso agiscono soltanto come substrato di riferimento delle nostre scelte (ovvero si ritrovano solo a livello paradigmatico), si ritroverebbero in poesia anche a livello del discorso stesso, che sarebbe in parte organizzato secondo queste stesse relazioni (che quindi si ritroverebbero anche al livello sintagmatico). Le equivalenze fonetiche o prosodiche (rime e ritmi) sarebbero dunque parallele a equivalenze semantiche, e andrebbero interpretate in questo senso, riempiendo la poesia di una straordinaria densità di sensi allusivi. E ancora: “La concezione che Valéry ha della poesia come hésitation prolongée entre le son e le sens, è molto più realistica e scientifica di tutte le forme d’isolazionismo fonetico”.
L’idea di Jakobson è cruciale, e si manifesta magistralmente, per esempio, nell’analisi realizzata insieme a Claude Lévi-Strauss del sonetto Les Chats di Charles Baudelaire, dove si espone bene la grande complessità di rimandi che l’organizzazione dei suoni produce. Nonostante questo, anche nel leggere le pagine di quell’articolo mi rimane la sensazione che Jakobson (o, forse, i suoi esegeti) abbia generalizzato troppo, e che si possa continuare a prendere per buone le parole di Valéry anche senza dover cogliere continuamente una relazione tra i parallelismi (prosodici, fonetici, lessicali, semantici…) e il senso di quello che viene detto là dove il parallelismo si manifesta.
La poesia è più antica della prosa. Lo è per le ragioni ben spiegate da Eric Havelock di migliore memorizzabilità in un mondo in cui la scrittura non esiste o è comunque troppo poco diffusa. Ma questa maggiore antichità mal si concilia con la sua maggiore complessità – e non è che Omero sia particolarmente più elementare di Baudelaire, nonostante i duemilacinquecento anni e passa che li separano.
Voglio provare a vedere le cose in un modo un poco diverso, un modo che giustifichi un’applicazione meno compulsiva di un principio comunque importante come quello del parallelismo.
Supponiamo di trovarci in un ambiente naturale, per esempio in montagna, di fronte a un’ampia veduta. Si tratta di qualcosa che di solito apprezziamo, anche se non pensiamo che quello che vediamo e in generale percepiamo debba avere per forza un significato. Naturalmente la dimensione del significato rimane lo stesso profondamente in gioco, ed è proprio per questo che ciò che stiamo percependo ci appare bello: osserviamo le cose e le relazioni tra loro, vi sono cose simili che avvicinano luoghi diversi, vi sono cose che ricordano altre cose viste altrove, vi sono cose che rinviano a discorsi fatti, ad altre esperienze vissute, vi sono relazioni di somiglianza o dissomiglianza tra cose che a loro volte rinviano a discorsi fatti o a esperienze vissute. E così via, in una rete inesauribile di significati, senza che tutto questo debba per forza coagularsi in una dimensione unitaria di discorso, cioè in un significato unitario, in un “messaggio”.
Se questo medesimo paesaggio fosse dipinto, o anche solo fotografato, avremmo invece ragione di pensare che un discorso, e quindi un senso unitario, ci sia; perché anche solo la scelta di dipingere (o fotografare) quel pezzetto di mondo è già un inizio di discorso, per non dire di tutte le altre scelte che il pittore (o il fotografo) fa. Tuttavia, io credo che sbaglieremmo nel risolvere tutta la ricchezza semantica della fruizione ambientale nella strumentalità al discorso da parte del pittore (o del fotografo). Certo, non c’è dubbio che l’artista abbia utilizzato strumentalmente il paesaggio per trasmettere il proprio discorso, e che dunque sia possibile anche interpretarlo così, ma in molti casi la nostra ammirazione per l’artista (in particolare se si tratta di un fotografo) sta soprattutto nel suo aver saputo cogliere un dettaglio di mondo così di per sé significativo, e di averci detto: eccolo! A volte, il discorso dell’autore si può risolvere semplicemente in quell’eccolo!
Se interpretiamo in quest’ultimo modo, stiamo considerando il testo un po’ come un ambiente, e non solo come uno strumento. Non che l’autore scompaia, ma è sicuramente un po’ meno ingombrante, e il suo ruolo non è quello di chi ci trasmette un profondo messaggio, ma semplicemente quello di chi ci dice: guarda qui, questo sembra interessante!
Noi siamo abituati a pensare al linguaggio in maniera strumentale, come un modo per trasmettere messaggi. Ma questa razionalità funzionalista presuppone un contesto in cui gli scopi comunicativi siano già chiari; e, certo, nella misura in cui gli scopi sono chiari, il linguaggio può davvero essere utilizzato funzionalmente, come uno strumento per raggiungerli. Tuttavia, a monte di qualsiasi altro scopo, il linguaggio ne ha uno che di solito, pur onnipresente, non ha alcun bisogno di essere chiaro: si tratta di uno scopo fatico, di contatto. A questo scopo, il guarda lì è già sufficiente, nella misura in cui chi parla e chi ascolta vengono avvicinati dalla comune attenzione.
E il guarda lì può anche essere semplicemente un guarda qui, ovvero guarda (o meglio, ascolta) come questa successione di suoni è armoniosa, come quello rimanda a questo, come quello ricorda quell’altra cosa là, e come il rapporto tra questo e quello ne ricordi un’altra ancora. Il testo può essere fruito come un ambiente, ancor prima che nella sua funzione strumentale, e anche indipendentemente da quella.
La poesia è ovviamente il luogo tradizionale in cui fenomeni di questo genere accadono, il luogo in cui chi parla (o scrive) non sta solo dicendo qualcosa, ma anche dicendo guarda qui: le mie parole non sono interessanti solo per quello che dicono, ma anche perché sono interessanti di per loro, come gli aspetti di un paesaggio. Va bene che se ne cerchi un significato complessivo unitario, ma va anche bene che agiscano come un semplice ambiente, al di là di qualsiasi funzionalità espressiva. Solo il lettore che entri in sintonia con questo paesaggio verbale coglie davvero il fascino di quello che c’è dentro, e allora l’ammirazione per il poeta non sarà per colui che dice cose straordinarie, ma per quella persona che mi sa indicare le cose giuste, le quali significano poi per conto proprio, a dispetto del fatto che un significato complessivo e unitario magari non ci sia, o che sia così difficile da trovare da lasciarci perplessi.
Una versione debole (e per me accettabile) del principio di Jakobson è che tutte le relazioni presenti in un testo poetico siano significative. Quello che trovo problematico è che tutte siano da ricondurre a un nucleo semantico fondamentale – ma questo è forse già più Greimas che Jakobson, e magari proietto la lettura dell’uno sulle parole dell’altro.
Pensare i testi come ambienti non ci impedisce di vederne la natura strumentale (di strumenti comunicativi) ma ci aiuta a non risolverli in quella. Ci invita a visitarli più che a farne un’ermeneutica, ma anche a capire i limiti stessi dell’ermeneutica.
In termini diversi, questo discorso vale anche per il romanzo. Trascuriamo, per semplicità, la rilevanza degli aspetti fonetici e prosodici (che comunque ci sono anche lì), e facciamo finta che la parola, nel romanzo, abbia davvero una funzione puramente strumentale, come veicolo del racconto. Si potrà osservare che, in un romanzo ben costruito, la fruizione ambientale, esclusa dal livello del significante, si ripresenta al livello del racconto. In altre parole, nel leggere un buon romanzo non ci domandiamo continuamente cosa stia volendo dire l’autore con quelle vicende narrate: sostanzialmente vi ci immergiamo, proprio come nel paesaggio, e diamo all’autore il ruolo di colui che ce le ha messe sotto gli occhi, essendogliene grati.
La differenza tra poesia e prosa narrativa è dunque una differenza di livello; ovvero sino a che punto è possibile considerare come ambiente quello che abbiamo sotto gli occhi: sino al livello del racconto o sino a quello della sequenza delle singole parole?
Nel campo del fumetto non c’è una distinzione di genere così netta come quella che esiste tra poesia e prosa, ma possiamo trovare ugualmente queste differenze tra testi leggibili come ambienti a livelli differenti. In gran parte del fumetto popolare, per esempio, il disegno e l’articolazione delle parti grafiche e verbali sono del tutto (o quasi) funzionali al racconto, e solo a questo livello il lettore può avere (e di solito ha) una fruizione di tipo ambientale.
Ma ci sono anche testi a fumetti in cui le cose funzionano nel modo opposto. Prendiamo Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons, per esempio. Sappiamo tutti benissimo quanto questo testo sia costruito, fitto di riferimenti interni, di rime grafiche e narrative, di riferimenti esterni. Tutti aspetti che contribuiscono radicalmente al fascino straordinario che ne promana.
Certo, potremmo ricondurre tutti questi aspetti al racconto, e vederli come efficacissimi condimenti di una storia che è una metafora amara del potere, persino quando questo potere sia utilizzato con le migliori intenzioni del mondo. Questo si può fare, e va fatto.
Però potremmo anche seguire la strategia inversa e immergerci nel testo, lasciandoci attraversare da questa rete inesauribile di rimandi, e considerare che il racconto nel suo insieme non sia che uno di questi elementi – magari più grande e importante degli altri, ma non quello a cui tutto va ricondotto! Se leggiamo Watchmen così, ne perdiamo forse la morale, però lo stiamo percorrendo da dentro, abitando, vivendo come un’esperienza condotta dal suo autore, che ci indica, via via, che cosa è significativo: ci dice, continuamente, guarda qui!
Non per questo, è ovvio, Watchmen va considerata come un’opera di poesia. La poesia è un genere di scrittura verbale. Non esiste la poesia a fumetti. Esiste però un modo di fare fumetti che esibisce lo stesso livello di complessità e di ambientalità della poesia.
1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.
Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.
Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)
Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.
Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.
Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.
Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.
E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.
1. La parola poetica e la sua natura collettiva
È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:
Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.
La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.
La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.
L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.
La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.
Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.
Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:
Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.
Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.
D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.
Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.
Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.
Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.
Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.
Spulciando nei blog di poesia, mi colpisce il fatto che la grande maggioranza dei commenti contengono sostanzialmente dichiarazioni di accordo con quello che la poesia dice (al massimo con l’aggiunta: “Come lo dici bene!”). Ho sempre trovato la cosa piuttosto irritante, sino a quando, con qualche riflessione, non ne ho capito il perché.
La cosa è irritante perché in questi commenti la poesia viene trattata come se fosse l’espressione di un’opinione, di un punto di vista; o come se rivelasse qualche verità nascosta. In altre parole, un post di poesia viene commentato esattamente come se fosse un post qualsiasi, proprio come questo che state leggendo (e rispetto al quale, se vi trovate d’accordo, io sarei ben contento che mi scriveste che lo siete). Ma queste parole che state leggendo ora sono state pensate per una relazione di scrittura-lettura parzialmente reciproca, dialogica, come quella di un blog; mentre la poesia non nasce per stare all’interno di una conversazione (piuttosto diretta) di questo tipo, e si trova pubblicata su un post semplicemente perché quello è un modo per pubblicarla – e potrebbe trovarsi pubblicata in mille altri modi (anche migliori, come sulle pagine di una raccolta a stampa).
Per dire la cosa in un altro modo, e con un paragone irriverente, è come se io raccontassi una barzelletta, e gli amici invece di ridere mi dicessero, con aria serissima, di trovarsi del tutto d’accordo con me (e che l’ho raccontata proprio bene!).
È invece più difficile da spiegare perché la mia irritazione al leggere questi commenti debba essere contenuta (e i commenti di approvazione tematica delle poesie debbano essere tutto sommato accettati). Una spiegazione che si basa su un’analogia interessante mi è balzata agli occhi stamattina, dopo che, attraverso Google Reader, mi erano arrivate due interessanti poesie, una dal blog specifico della sua autrice, l’altra citata da Luisa Carrada con sorpresa e complimenti.
Proviamo a pensare alla situazione di visitare un luogo condotti da un’altra persona. Se il luogo è davvero interessante possiamo tollerare anche che chi ci accompagna non lo sia ugualmente; se lo è, tutto è meglio, ma l’interesse del luogo in sé può essere sufficiente. Viceversa, se la persona che ci conduce è davvero interessante, può capitare che riesca a farci apparire a sua volta interessante persino un luogo che altrimenti non lo sarebbe; anzi può darsi che riesca a farci apparire interessante persino un luogo che conosciamo già benissimo, e che ritenevamo in precedenza privo di interesse proprio per questo.
Il luogo, nella nostra analogia, è ciò di cui un testo parla. In un testo di prosa critica (proprio come questo post) quello che cerchiamo è l’interesse del tema e delle riflessioni al proposito: il modo in cui è scritto (ovvero, nella nostra analogia, chi ci accompagna) può aiutare o può respingere, ma l’attenzione di chi legge non è rivolta lì. I testi poetici, viceversa, ci mostrano non di rado luoghi (cioè temi) che conosciamo benissimo (e sappiamo tutti perfettamente che è bello ricordare quando eravamo bambini e correvamo in giro, e chi scrive sa benissimo quali siano i propri entusiasmi e i propri scoramenti), ma è la scrittura che ci accompagna laggiù a fare tutta la differenza: è la scrittura a farci percepire come nuovi e interessanti quei luoghi stranoti!
È molto più facile commentare dei luoghi che della scrittura. Dire, nel commento di un post, che siamo d’accordo è come dire che quel luogo ci piace. Chi scrive poesia, viceversa, si aspetta che sia apprezzata la propria conduzione, la propria scrittura, il proprio stile. Ma la maggior parte dei commentatori vedono solo il tema, e si sentono d’accordo con quello. Spesso nemmeno si accorgono che quel medesimo tema, espresso con altre e meno interessanti parole, non avrebbe sollevato in loro il minimo interesse: sono capacissimo anch’io – si direbbero – di ricordare la mia infanzia, e di comprendere le mie emozioni di scrittore!
Bisognerebbe lodare l’accompagnatore, e invece si celebra il luogo. Ma noi che leggiamo quei commenti dobbiamo capire che il luogo è piaciuto perché chi vi ha portato il lettore ha saputo mostrarglielo come il lettore non l’aveva mai visto.
Peccato che talvolta i medesimi apprezzamenti vengano espressi dai lettori nei confronti di versi dove ci sarebbe davvero poco da apprezzare! Magari in quei contesti si loda il luogo semplicemente per non doversi esprimere sull’accompagnatore? E come distinguere allora questo caso dal precedente?
L’analogia, sviluppata qui sulla contrapposizione tra prosa critica e poesia, è facilmente allargabile alla prosa letteraria, al raccontare a fumetti, al cinema, e così via. Chi sa usare il proprio linguaggio, e sa far sì che i propri segni (verbali o visivi che siano) mostrino un’altra faccia delle cose, può davvero raccontare qualsiasi cosa, e farne emergere i motivi di interesse!
Mi sto domandando qual è il mio modo di ascoltare la musica. Scorrendo un mio curriculum vitae, mi sono accorto infatti che la maggioranza delle mie pubblicazioni accademiche degli ultimi due anni ha come argomento proprio la musica, ed è stata prodotta per incontri di carattere musicologico – in almeno un caso co-organizzati da me. Eppure io non sono un musicologo, anche se, evidentemente, qualche competenza in materia ce l’ho. Dunque: perché e come ascolto la musica, io?
Sono un frequentatore (non assiduo, ma costante) di concerti, di musica di vario tipo, durante i quali l’ascolto è ovviamente attento e concentrato. Se non sono impegnato in attività intellettuali, ho spesso la musica come sottofondo. Ascolto sempre musica se viaggio in macchina. A volte ascolto musica per sentire un determinato pezzo, e in questo caso la fruizione è attenta; ma anche quando la musica mi fa da sfondo, può accadere che lo sfondo passi sul primo piano, e che la mia attenzione sia concentrata su di lei piuttosto che su quello che sto facendo. In macchina questo è una condizione normale (e per fortuna gli automatismi dell’automobilista mi hanno tenuto in vita sino ad oggi).
Ascoltare la musica con attenzione e concentrazione piena significa considerarla come una sorta di discorso – ovviamente differente da quello della parola, però comunque un discorso, ovvero una comunicazione che va da chi la produce a chi la riceve, trasmettendo un qualche contenuto (emotivo, informativo, narrativo…). Ma la musica non è nata per essere ascoltata. Questa affermazione potrà sembrare paradossale finché non riflettiamo sul fatto che prima della musica come cosa che si ascolta c’è stata la musica come occasione per ballare, come occasione per cantare insieme, come commento (accompagnamento) a una situazione (tipicamente cerimoniale, ma non solo). In tutti questi casi la musica non è una cosa che sta di fronte a noi per l’ascolto, ma qualcosa che viene vissuto da dentro, qualcosa che ci avvolge e di cui facciamo parte, ballandola, cantandola o vivendo il rito di cui essa è parte. Sino a qualche secolo fa questi tipi di fruizione costituivano la totalità dei modi di fruire la musica.
L’ascolto frontale, distaccato, è un’invenzione moderna. Possiamo, a essere generosi, risalire al Rinascimento, ma prima del Seicento in verità la pratica teatrale del concerto, in cui si va semplicemente ad ascoltare qualcuno che suona, non è affatto diffusa. E, naturalmente, anche quando si diffonde, non soppianta affatto le altre pratiche.
Inoltre, anche se il diffondersi dell’ascolto frontale permette il formarsi di uno specifico discorso musicale (ovvero la musica impara a trasmettere al suo ascoltatore un discorso, emotivo, informativo, narrativo ecc.), la musica non perde mai la sua natura coinvolgente, di esperienza immersiva. Di questo facciamo esperienza tutti facilmente quando, nell’ascoltare (frontalmente) un concerto, sentiamo il nostro piede che batte il tempo (ovvero balla), la nostra voce che interiormente riproduce l’andamento musicale (ovvero canta), e vediamo che il contesto in cui ci troviamo è trasformato dalla semplice presenza della musica.
Insomma, quello che credo è che anche la musica da concerto oggi (a qualsiasi genere appartenga) debba possedere sia la natura frontale che le permette di esprimere un discorso (e quindi di essere interessante anche per un ascolto concentrato) sia la natura immersiva che ci permette di partecipare al suo evento (e quindi di riconoscerci nella comunità – danzante, cantante, vivente – dei presenti). In questo senso, certamente la musica è parente stretta della poesia, che vive delle medesime componenti, anche se magari in diversa misura.
Qualche tempo fa, in una tra tante discussioni conviviali con Luca Francesconi, il discorso era andato sul rock, sul jazz e sulla musica colta contemporanea. Ricordo che a un certo punto Luca disse che se il rock ha uno spessore così (facendo il segno con due dita di uno spessore di qualche centimetro), allora il jazz ce l’ha così (e il segno rappresentava ora uno spessore del doppio o del triplo) e la musica contemporanea ce l’ha così (e ora le sue mani si allargavano ad abbracciare il massimo spessore possibile). Lo spessore in questione era quello che Francesconi definirebbe (credo) lo spessore semantico, ovvero la possibilità di trasmettere un discorso articolato e complesso.
Assumiamo che Francesconi avesse ragione, e che la musica colta contemporanea sia davvero in grado di trasmettere un discorso tanto più articolato e complesso di altri generi musicali (è un’assunzione facile da condividere, in sé). Questo comporta dunque una qualche superiorità della musica colta? Dal punto di vista della complessità senz’altro: è proprio questo il suo specifico! Ma davvero dovremmo essere tutti tifosi di Luciano Berio, e, per questo, disprezzare Miles Davis e i Beatles?
In altre parole: il fatto che esista della musica fatta per essere principalmente un discorso, lasciando decisamente in secondo piano gli elementi immersivi, dionisiaci, corali, ci deve indurre a disprezzare la musica in cui questi elementi rimangono forti? Rispondere positivamente a questa domanda vuol dire ritenere che il destino della musica debba essere quello di costituire discorsi (e in questo senso sembrano andare sia le famose conferenze di Anton Webern sull’esaurimento delle possibilità della musica tonale, sia gli scritti di Theodor Adorno sull’invecchiamento della musica contemporanea): in questa prospettiva saremo portati a vedere, come mi sembra che faccia lo stesso Francesconi, tutta la musica principalmente come discorso. E, certo, se accettiamo questo punto di vista, Francesconi ha ragione, non è possibile dagli torto.
Ma le mie consuetudini di ascolto (e io sono uno che ama sia Luciano Berio che Miles Davis che i Beatles, e anche la musica stessa di Francesconi) mi dicono che le cose non stanno così. Se la musica deve ridursi a discorso, allora esiste già uno strumento molto più potente di lei per trasmettere discorsi: ed è la parola, tanto più se scritta. Il potere della poesia non sta nei discorsi che fa (tanto spesso riconducibili a un piccolo gruppo di stereotipi), ma nel fatto che attraverso i propri strumenti di carattere immersivo e dionisiaco, la poesia riesce a farci vivere quei discorsi e insieme a farci sentire parte di una sensibilità comune, collettiva, umana.
Chi difende la musica contemporanea mi dirà che essa fa proprio questo, però deve prendere le distanze da tutto quello che è mercificato, banalizzato dal consumo. Il problema è che in un mondo in cui tutto è mercificato e banalizzato dal consumo, dovremmo prendere le distanze da tutto: e questo è proprio quello che almeno certa musica contemporanea ha l’aria di fare. Tuttavia così facendo ha anche tagliato i ponti con la partecipazione immersiva e, paradossalmente, persino con la possibilità di trasmettere il proprio discorso: se l’ascoltatore non ha motivo per sentirsi partecipe, non ha neanche motivo di ascoltare la musica – e un discorso che non si può trasmettere è come se non ci fosse.
Ritrovo nelle mie stesse consuetudini di ascolto le conseguenze di tutto questo. Di fatto, quasi non riesco più ad ascoltare la musica colta contemporanea; a volte mi annoia, a volte mi irrita. Mi irrita quel tono da appartenenti a una casta di eletti che essa frequentemente esprime.
D’altra parte, non posso nemmeno ascoltare quegli autori contemporanei di tradizione classica che non seguono la linea marcata da Darmstadt. Meglio sicuramente Boulez, o Berio o lo stesso Francesconi piuttosto che John Adams o Michael Nyman: non ho dubbi su questo. Il sospetto che questi altri autori abbiano mancato o volutamente ignorato un momento cruciale della storia è troppo forte.
E allora? Allora forse c’è un problema a monte. Magari è la musica colta contemporanea che non ci rappresenta più, e rimane un vestigio della grande tradizione classico-romantico-novecentesca, che viene perpetuato per poter sostenere che le orchestre e le strumentazioni tradizionali (con tutto l’apparato teatrale che le accompagna) non sono solo un retaggio che ci viene dal passato. In altre parole, la musica colta contemporanea servirebbe a farci sentire la continuità con un passato che noi sentiamo (e del tutto a ragione) come grande.
Ma questo è sufficiente a farla esistere?
Nel mio piccolo ho dei problemi ormai ad ascoltare questa musica. Mi sento più rappresentato da Miles Davis, oppure, magari, da Mozart o da Stravinsky. Lo so che c’è qualcosa che non quadra: ma l’epoca dell’ideologia è finita (purtroppo e per fortuna), e non credo più che le avanguardie abbiano ragione perché sono avanguardie.
Non essendo un musicologo, e non essendo tenuto a teorizzare sulla musica, mi sfogo esplorando musiche di altre tradizioni, come quella (straordinaria) dell’India. Posso però teorizzare sull’ascolto, o almeno sul mio.
17 Febbraio 2010 | Tags: Arte, arti, comunicazione visiva, Edmund Burke, estetica, fantascienza, fantasy, generi, graphic design, horror, Immanuel Kant, Michelangelo, mistery, misticismo, Nicolas Boileau, Nicolas Poussin, Pseudo-Longino, Raffaello, sacro, Salvator Rosa, Samuel H. Monk, Settecento, sublime | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Ho letto da poco un bel libro di Samuel H. Monk: Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del Settecento (Genova, Marietti, 1991). È un libro scritto negli anni Trenta, il primo che affronta questo tema storiografico. È interessante perché racconta la nascita e diffusione di un concetto destinato a trasformare per sempre la nostra concezione dell’arte.
Quello di sublime è un concetto antico. Proviene da un testo di incerta datazione (Peri Hypsous, I secolo d.c., secolo più, secolo meno) e ignota paternità. Poiché tradizionalmente lo si attribuiva a Cassio Longino, oggi ci riferiamo al suo (ignoto) autore come Pseudo-Longino. Lo riprende Nicolas Boileau, uno studioso francese della fine del Seicento, che per primo pubblica nel 1674 un trattato di arte poetica ispirato allo Pseudo-Longino, aprendo la strada, assai più di là che di qua dalla Manica, a un dibattito che, decennio dopo decennio, cresce sempre più, e finisce per imporre un’idea dell’arte basata sul lampo di genio e sull’imponderabile, piuttosto che sul rispetto delle regole e sulla capacità di modularne le possibilità.
Ovviamente, è l’Enquiry di Edmund Burke il testo cruciale del secolo, che impone a partire dal 1757 il nuovo paradigma. Già nel 1764, Kant (che era notoriamente un appassionato di cultura inglese) pubblica le sue leggere Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, testimoniando la presenza del dibattito anche in Germania, e il suo debito con Burke. Qualche decennio più tardi farà del sublime uno dei capisaldi della sua teoria estetica.
Il dibattito che si sviluppa nel Settecento inglese è di grande interesse perché testimonia il passaggio tra una concezione dell’arte come rispetto (intelligente e creativo) delle regole, a una concezione dell’arte come furore creativo, prodotto di un’ispirazione di tipo divino, quella sorta di misticismo non religioso che sarà il pane quotidiano del Romanticismo, e che ancora oggi ci induce a pensare all’Arte (con la A maiuscola) come qualcosa di particolarmente elevato, che attinge comunque alla sfera del sacro (anche quando questo sacro non ha niente a che fare con la religione). Insomma, se a inizio Settecento l’ideale della pittura è per gli inglesi Raffaello, a fine secolo sarà Michelangelo; se a inizio secolo il paesaggio ideale è per gli inglesi quello classicistico di Nicolas Poussin, a fine secolo sarà quello selvaggio e sublime di Salvator Rosa.
Non è difficile vedere gli effetti di questa trasformazione nella concezione dell’Arte ancora oggi dominante. Per noi, l’opera d’Arte è quella cosa che in qualche modo ci travolge, ci porta con sé, e sembra schiuderci di colpo nuovi orizzonti di comprensione. L’artista è il genio, magari immortale, che ha saputo forgiare questo oggetto così straordinario. Anche se la parola sublime non è molto di moda (ha smesso di esserlo già ai primi dell’Ottocento) siamo talmente addentro a una visione dell’arte come sublime che facciamo addirittura fatica a capire come prima del XVIII secolo si potesse concepire l’Arte in maniera differente, e cerchiamo conforto nel fatto che, tutto sommato, non è difficile trovare il sublime in Michelangelo come in Dante, in Fidia come in Saffo: tutto sommato, dunque, l’Arte sarebbe stata sempre sublime, anche prima che qualcuno arrivasse ad accorgersene.
Si tratta però di un errore di prospettiva, come se ritenessimo che, poiché noi vediamo le cose da un certo punto di vista, non si possa che vederle da quello. Forse un’idea dell’arte come adeguamento (creativo e intelligente) alle regole ci può apparire più comprensibile se la confrontiamo non con l’idea diffusa oggi dell’Arte, bensì con l’idea diffusa oggi di che cosa sia la comunicazione visiva, nelle sue espressioni, per esempio, del graphic design e della pubblicità.
Nessuno va a scomodare il sacro per parlare della bellezza di un’impaginazione, di una copertina o di un cartellone pubblicitario. Piuttosto, parliamo di efficacia comunicativa, di gioco tra rispetto e trasgressione delle regole, di opportunità nei confronti di ciò che si desidera comunicare. Questa non è naturalmente la stessa cosa che i teorici pre-sublime dicevano dell’arte, ma ci va sufficientemente vicino da permetterci di capire che l’estetica del sublime si contrappone a un’estetica funzionale dell’arte, che la vede come una tecnica (creativa) di prodotti di consumo comunicativo, non così lontana dal graphic design di oggi. Una visione di questo genere non esclude, ovviamente, che anche all’interno di un’arte funzionale non possano nascere opere sublimi: succedeva con Michelangelo e Salvator Rosa assai prima che il requisito diventasse essenziale, e succede ancora oggi nel lavoro di tanti comunicatori visivi che pure non operano all’interno del campo dell’Arte.
Del resto che i confini tra arti e Arte siano labili è cosa sufficientemente evidente, e la presenza o meno di aspetti sublimi (o sacri, in senso laico) mi produce semmai differenze di valutazione, ma non necessariamente di campo di appartenenza – salvo quando i sacerdoti dell’Arte non decidono di ammettere nel proprio recinto qualcuno che, per il modo in cui lavora, ne dovrebbe presumibilmente star fuori, come il Toulouse-Lautrec cartellonista, o El Lisitskij. La mia sensazione è che la distinzione tra arti e Arte, che corrisponde storicamente all’entrata in gioco del sublime, sia legata alla diffusione della razionalità illuministica, che mette in crisi il sentimento religioso: poiché del sacro l’uomo non può comunque fare a meno, a un sacro di carattere religioso come quello tradizionale, l’Arte sostituisce un sacro laico, un misticismo del bello e dell’elevato, che diventa cruciale in un campo in cui magari esso era già presente, ma con un ruolo molto più marginale.
C’è un secondo motivo di interesse nel libro di Monk. Come sempre succede quando si diffonde un’idea nuova, se ne cercano tutte le applicazioni possibili e non di rado si esagera. Poiché il sublime è legato all’idea dell’ignoto e del mistero, le estetiche inglesi della fine del Settecento vedono la sua massima espressione nella letteratura cosiddetta gotica: il mistery, l’horror, il fantastico. L’idea dura abbastanza da produrre il grande successo del più riuscito falso della storia della letteratura, i Canti di Ossian, ma è sufficientemente balorda da non durare troppo a lungo, travolgendo il termine stesso sublime (ma non i suoi effetti) nel proprio tramonto.
Quando tramonta l’idea dell’horror come massima espressione del sublime, non tramonta però l’horror, né il fantastico, né i loro figlioletti (il poliziesco, la fantascienza, il supereroico, il fantasy…), i quali proseguono, con alterne ma mai misere fortune, sino a noi. È divertente osservare come l’Arte (con la A maiuscola) e questi generi che tipicamente vivono ben al di fuori dai suoi confini, abbiano la medesima origine. La Storia procura sempre un sacco di sorprese.
15 Febbraio 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Ho tenuto un blog sul fumetto per quattro anni, dal 2004 al 2007. Ho smesso per stanchezza, e probabilmente la stanchezza era anche dovuto al fatto che ormai mi andava stretto.
Il mio interesse per il fumetto è un (fortunato) capitolo del mio più generale interesse per la comunicazione. Lavoro più spesso sulla comunicazione visiva, ma mi occupo anche di poesia e di musica, e, in generale ho interessi filosofici nel campo dell’estetica, che è la disciplina che si occupa non solo di cosa sia il bello, ma anche di che cosa significhi percepire, comprendere il mondo attraverso i sensi. Nel campo della poesia non mi limito alla teoria. Rimando al mio sito per saperne di più, e anche per scaricare testi pubblicati.
In questo spazio vorrei discutere i temi che mi stanno a cuore con chiunque abbia voglia di leggermi, senza un progetto a priori specifico (come si usa con i blog) ma senza nemmeno un necessario legame con l’attualità (come invece non si usa con i blog).
A scopo indicativo posso provare a buttar giù un elenco di categorie, a cui magari se ne aggiungerenno altre (e magari qualcuna resterà vuota, chissà): semiotica, estetica, musica, poesia, comunicazione visiva, a sua volta declinata in: fumetto, sistemi di scrittura, graphic design, Web e multimedia.
Chi mi ha letto a proposito del fumetto non si deve spaventare: si parlerà anche di quello. Non solo non ho smesso di occuparmene, ma ho pubblicato in realtà più libri e articoli su questo tema da un anno a questa parte di quanto abbia fatto in qualsiasi altro periodo della mia vita. Però per me il discorso sul fumetto è da sempre integrato in un discorso più ampio sulla comunicazione, visiva e non solo, ed è di questo che vorrei parlare qui.
Tutto questo è sufficientemente specifico come argomento per un blog? Direi che lo deciderete voi. Personalmente, io lo vivo come un tema solo.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|





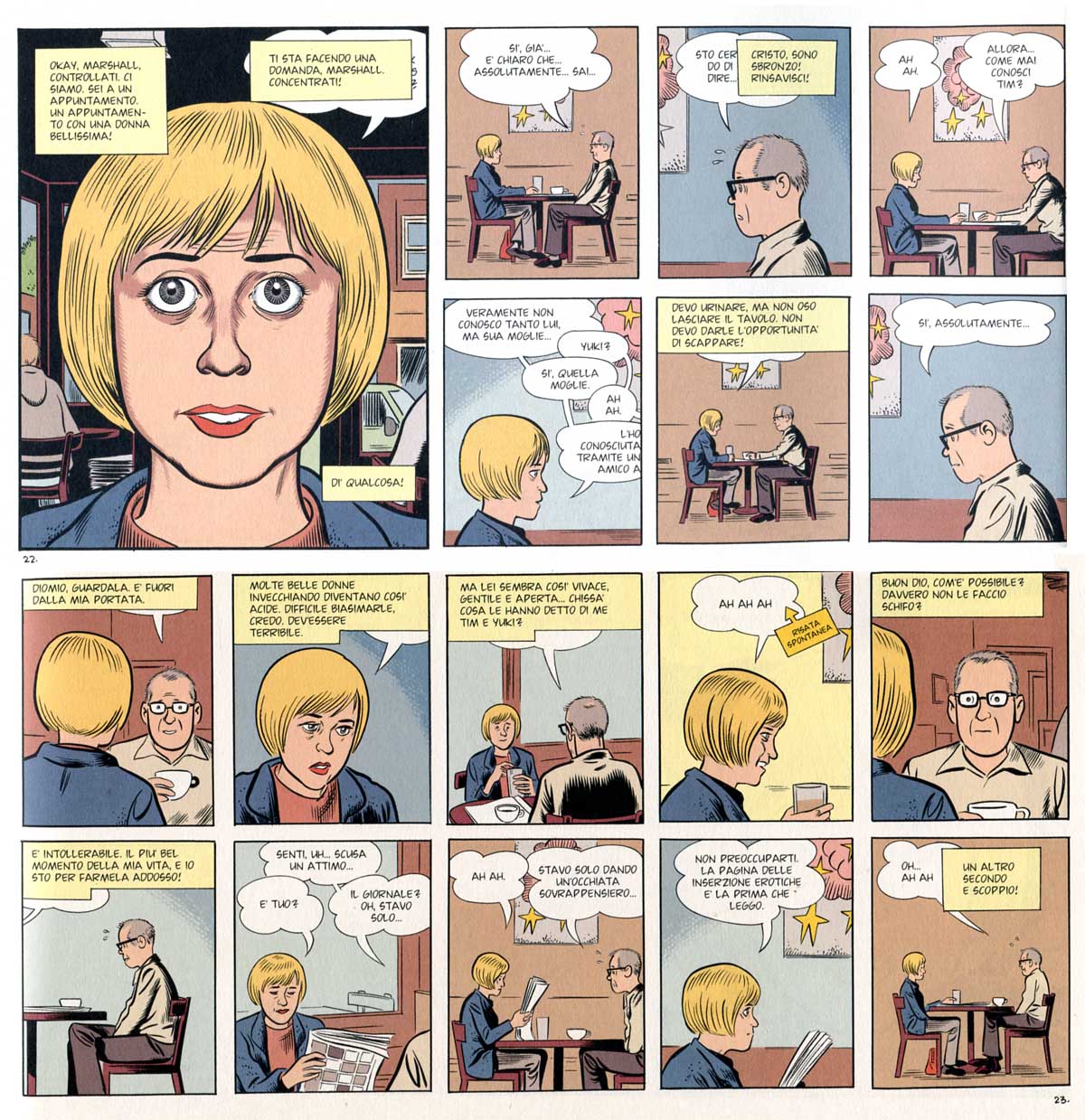






 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco
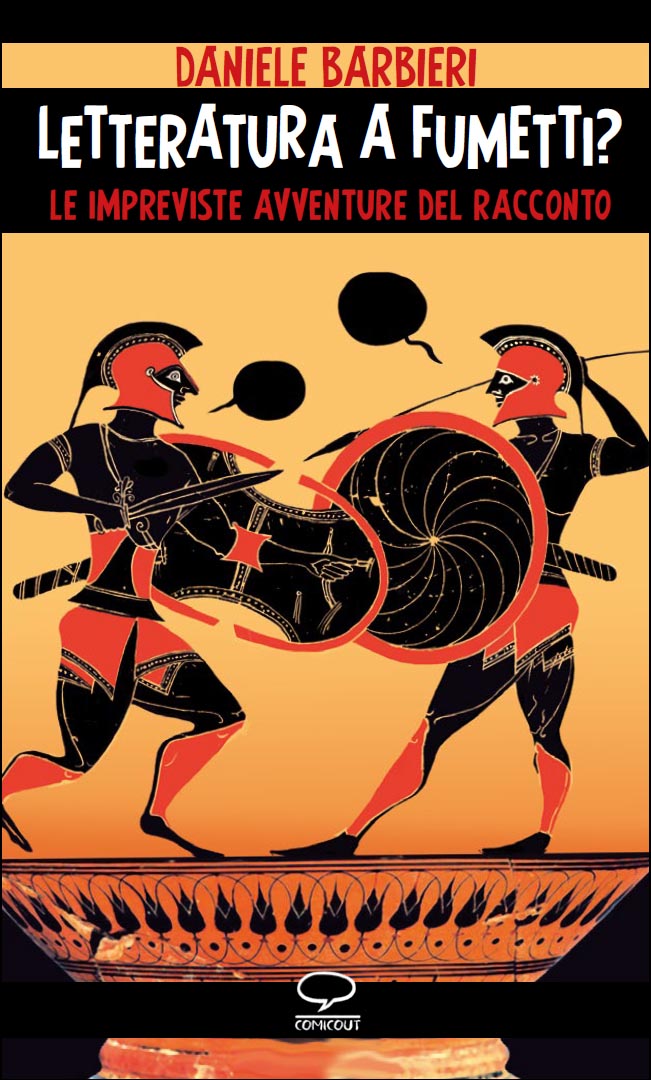




Dei commenti sul contenuto (nei blog e altrove)
Spulciando nei blog di poesia, mi colpisce il fatto che la grande maggioranza dei commenti contengono sostanzialmente dichiarazioni di accordo con quello che la poesia dice (al massimo con l’aggiunta: “Come lo dici bene!”). Ho sempre trovato la cosa piuttosto irritante, sino a quando, con qualche riflessione, non ne ho capito il perché.
La cosa è irritante perché in questi commenti la poesia viene trattata come se fosse l’espressione di un’opinione, di un punto di vista; o come se rivelasse qualche verità nascosta. In altre parole, un post di poesia viene commentato esattamente come se fosse un post qualsiasi, proprio come questo che state leggendo (e rispetto al quale, se vi trovate d’accordo, io sarei ben contento che mi scriveste che lo siete). Ma queste parole che state leggendo ora sono state pensate per una relazione di scrittura-lettura parzialmente reciproca, dialogica, come quella di un blog; mentre la poesia non nasce per stare all’interno di una conversazione (piuttosto diretta) di questo tipo, e si trova pubblicata su un post semplicemente perché quello è un modo per pubblicarla – e potrebbe trovarsi pubblicata in mille altri modi (anche migliori, come sulle pagine di una raccolta a stampa).
Per dire la cosa in un altro modo, e con un paragone irriverente, è come se io raccontassi una barzelletta, e gli amici invece di ridere mi dicessero, con aria serissima, di trovarsi del tutto d’accordo con me (e che l’ho raccontata proprio bene!).
È invece più difficile da spiegare perché la mia irritazione al leggere questi commenti debba essere contenuta (e i commenti di approvazione tematica delle poesie debbano essere tutto sommato accettati). Una spiegazione che si basa su un’analogia interessante mi è balzata agli occhi stamattina, dopo che, attraverso Google Reader, mi erano arrivate due interessanti poesie, una dal blog specifico della sua autrice, l’altra citata da Luisa Carrada con sorpresa e complimenti.
Proviamo a pensare alla situazione di visitare un luogo condotti da un’altra persona. Se il luogo è davvero interessante possiamo tollerare anche che chi ci accompagna non lo sia ugualmente; se lo è, tutto è meglio, ma l’interesse del luogo in sé può essere sufficiente. Viceversa, se la persona che ci conduce è davvero interessante, può capitare che riesca a farci apparire a sua volta interessante persino un luogo che altrimenti non lo sarebbe; anzi può darsi che riesca a farci apparire interessante persino un luogo che conosciamo già benissimo, e che ritenevamo in precedenza privo di interesse proprio per questo.
Il luogo, nella nostra analogia, è ciò di cui un testo parla. In un testo di prosa critica (proprio come questo post) quello che cerchiamo è l’interesse del tema e delle riflessioni al proposito: il modo in cui è scritto (ovvero, nella nostra analogia, chi ci accompagna) può aiutare o può respingere, ma l’attenzione di chi legge non è rivolta lì. I testi poetici, viceversa, ci mostrano non di rado luoghi (cioè temi) che conosciamo benissimo (e sappiamo tutti perfettamente che è bello ricordare quando eravamo bambini e correvamo in giro, e chi scrive sa benissimo quali siano i propri entusiasmi e i propri scoramenti), ma è la scrittura che ci accompagna laggiù a fare tutta la differenza: è la scrittura a farci percepire come nuovi e interessanti quei luoghi stranoti!
È molto più facile commentare dei luoghi che della scrittura. Dire, nel commento di un post, che siamo d’accordo è come dire che quel luogo ci piace. Chi scrive poesia, viceversa, si aspetta che sia apprezzata la propria conduzione, la propria scrittura, il proprio stile. Ma la maggior parte dei commentatori vedono solo il tema, e si sentono d’accordo con quello. Spesso nemmeno si accorgono che quel medesimo tema, espresso con altre e meno interessanti parole, non avrebbe sollevato in loro il minimo interesse: sono capacissimo anch’io – si direbbero – di ricordare la mia infanzia, e di comprendere le mie emozioni di scrittore!
Bisognerebbe lodare l’accompagnatore, e invece si celebra il luogo. Ma noi che leggiamo quei commenti dobbiamo capire che il luogo è piaciuto perché chi vi ha portato il lettore ha saputo mostrarglielo come il lettore non l’aveva mai visto.
Peccato che talvolta i medesimi apprezzamenti vengano espressi dai lettori nei confronti di versi dove ci sarebbe davvero poco da apprezzare! Magari in quei contesti si loda il luogo semplicemente per non doversi esprimere sull’accompagnatore? E come distinguere allora questo caso dal precedente?
L’analogia, sviluppata qui sulla contrapposizione tra prosa critica e poesia, è facilmente allargabile alla prosa letteraria, al raccontare a fumetti, al cinema, e così via. Chi sa usare il proprio linguaggio, e sa far sì che i propri segni (verbali o visivi che siano) mostrino un’altra faccia delle cose, può davvero raccontare qualsiasi cosa, e farne emergere i motivi di interesse!